L'insediamento umano L'insediamento, modi di abitare
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'insediamento umano L'insediamento, modi di abitare
1
LEZIONE 6
L’insediamento umano
L’insediamento, modi di abitare
Modi di abitare (rurale / urbano) Cultura immateriale + Cultura materiale Accentrato (villaggio), nuclei e sparso Protezione, sicurezza, individualismo, indipendenza
Elementi influenti: Fisici: Presenza d’acqua, rilievi, Società rurale Gestione delle campagne
«Il più importante elemento espressivo della cultura materiale è senz’altro l’abitazione» [Dagradi, 2003
Case SparseUnicellulareAd elementi sovrappostiAd elementi giustappostiAd elementi separatiCasa a corteMaso, Masseria,FORME E SEGNI DELL’INSEDIAMENTO RURALE EMILIANO E ROMAGNOLO
Dal villaggio alla cittàVillaggio (essenzialmente agricolo)Borgo (con parte notevole della popolazione non legata alla terra)Città (con attività extra-agricole)La città- è il luogo delle funzioni amministrative e culturali, di scambi e di servizi- è un nodo di relazioni, un punto di incontro tra uominie di merci, un crogiolo di idee e punto discambio delle innovazioni- non è autosufficiente
Progetto di sviluppo (?)1
2
Le funzioni urbaneEconomiche Industria Commercio Turismo FinanzaSociali Pubblica amministrazione Scuole Strutture sanitarieD’irradiamento Diffusione dei modi di vita, delle innovazioni Informazione, cultura (teatri, associazioni, media, etc.) Materiale (connessioni stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali)
Genesi della cittàCittà spontanee espansione di centri minoriCittà fondate espressione di una volontà di un capo o di una comunità
Classificazione OCSE aree urbaneSmall urban areas, with a population below 200 000 people;Medium-sized urban areas, with a population between 200 000and 500 000;Metropolitan areas, with a population between 500 000 and 1.5million;Large metropolitan areas, with a population of 1.5 million or more.
EvoluzionePrima generazione (divisione del lavoro, mercato, moneta,trasporti)Mesopotamia, EgittoPolisCastrum (accampamento), Oppidum (città fortificata),Forum (Centro politico e commerciale), Urbe
« Mentre i Greci consideravano di aver raggiunto la perfezione con la fondazione di città, preoccupandosi della loro bellezza, della sicurezza,dei porti e delle risorse naturali del paese,i Romani pensarono soprattutto a quello che i Greci avevano trascurato:il pavimentare le strade, l'incanalare le acque, il costruire fogne che potessero evacuarenel Tevere tutti i rifiuti della città.
2
3
Selciarono le vie che percorrevano tutti i territori [conquistati], tagliando colline ecolmando cavità, in modo che i carri potessero raccogliere le mercanzie provenienti dalleimbarcazioni; le fogne coperte con volte fatte di blocchi uniformi, a volte lasciano ilpassaggio a vie percorribili con carri di fieno.Tanta è poi l'acqua che gli acquedotti portano, da far scorrere interi fiumi attraverso lacittà ed i condotti sotterranei, tanto che ogni casa ha cisterne e fontane abbondanti,grazie soprattutto al gran lavoro e cura di Marco Vipsanio Agrippa, il quale abbellì Romaanche con molte altre costruzioni. »(Strabone, Geografia, V, 3,8.)
La pianta della città ideale ellenicaIppodamo di Mileto probabilmente teorizzò e rese sistematico nella pianificazione di nuove città, l'applicazione dello schema ortogonale. concezione della struttura a griglia le strade che si intersecano ad angolo retto, delimitando ordinatamente Isolati residenziali di forma quadrangolare, riferisceanche l'aspetto più politico del pensiero di Ippodamo che prefigurava nonsolo l'ordine urbanistico, m anche l'ordine sociale di una sorta di cittàideale che avrebbe dovuto ospitare al massimo 10.000 abitanti,divisi in tre classi: artigiani, agricoltori e armati (i difensori) L’agorà (piazza ---> mercato, scambio idee, funzioni politiche e religiose.
La città romana(1) Principia (quartier generale) Forum;(2) Via Praetoria/Decumanus maximus (est-ovest);
(3) Via Principalis/Cardo maximus (nord-sud);(4) Porta Principalis Dextra;(5) Porta Praetoria (est);(6) Porta Principalis Sinistra;(7) Porta Decumana.
3
4
EvoluzioneSeconda generazione (medievale)Manifesta l’importanza della religione (chiesa madre: duomo o cattedrale)Affacciata insieme al Palazzo del Comune sulla piazza del Mercato, dalla quale si diramano a raggiera gli assi stradali che portano alle porte
EvoluzioneTerza generazione (industriale)Città nei PVSCittà principesche, new town, parchi tematici, etc.
La localizzazione dei servizi e la città
MODELLO DELLE “LOCALITA’ CENTRALI” ( CHRISTALLER )Approccio: funzionalismoSCOPO: SPIEGARE LA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI ALLE FAMIGLIEIPOTESI:◦ PIANO ISOMORFO◦ CONCORRENZA PERFETTA◦ LA DISTANZA CHE LA CLIENTELA E’ DISPOSTA A PERCORRERE E’ CONNESSA AL LIVELLO DEL BENE
Cosa c’è dentro il “terziario”?Servizi alle famiglie◦ istruzione, sanità, cultura, tempo libero, divertimento◦ assistenza domiciliare bambini-anziani◦ attività commercialiServizi alle imprese◦ di tipo statico: frutto della divisione del lavoro e della specializzazione produttiva◦ prima interni alle imprese (terziario implicito)◦ poi svolti all’esterno (R&D, marketing, servizi finanziari, formazione,ecc.),◦ di tipo dinamico: de-materializzazione della produzione◦ servizi di tipo strutturale volti a promuovere l’innovazione tecnologica e gestionalePubblica Amministrazione◦ Government: comune, regione, Stato, ecc.◦ Governance: partiti politici, sindacati, organizz.coop, assoc.impresa, ecc
Dinamica dell’occupazione nei servizi4
5
automazione spinge al calo occupazione nelle attività fisiche e di produzione◦ anche nei servizi: trasporti, logistica ecc.concorrenza tra beni durevoli e servizi alle famiglie◦ trasporti pubblici vs/ privaticresce l’occupazione nei servizi alle imprese◦ esternalizzazione: fare o far fare?crescono (e si modificano) i servizi alle famiglie*◦ il ruolo della donna◦ la struttura della famiglia e della parentela◦ i differenti costumi sociali: età parto, separazioni, invecchiamento, ecc.la PA tra spinte all’efficienza e pressione della D di lavoro
Diversi criteri di classificazione delle attività terziarieNCriterio merceologico :Trasporti e comunicazioniCommercioCredito e assicurazioniServizi per le imprese.......Criterio funzionale :Servizi per le famiglieServizi per la collettivitàServizi per le impreseAttività quaternarieIn base al raggio geografico dell’utenza e alla frequenza con cui si accedeal servizioI servizi comuni: quelli ai quali accedono con frequenza giornaliera o settimanalebuona parte delle famiglie e delle impreseI servizi di livello medio: quelli ai quali si accede con frequenza mensile-annualeI servizi rari: quelli ai quali si ricorre eccezionalmente
Concetti ChiaveSoglia: la distanza corrispondente al numero di utenti minimo necessario affinché i fornitori di beni e servizi operino in modo dacoprire i costi di vendita o di produzione e ottengano un normale marginedi profitto (perimetro di un bacino d’utenza)◦ Venditore : N° MINIMO DI CLIENTI NECESSARI PER SVOLGERE L’ATTIVITA’
5
6
◦ Cliente : MASSIMA ACCESSIBILITA’Portata: distanza massima che un utente è disposto a percorrere per accedere ad un bene o servizio offerto da una località centrale,oppure, dal punto di vista del venditore, il raggio dell’area di mercato più grande all’interno della quale egli sarà in grado diattrarre i consumatori◦ Venditore : N° MASSIMO DI CLIENTI CHE SI POSSONO SODDISFARE◦ Cliente : LIMITE DELLA ACCESSIBILITA’PREZZO EFFETTIVO = COSTO BENE + COSTO TRASPORTORANGO: LIVELLO DEL SERVIZIOGERARCHIA: ORDINE DEI CENTRI SECONDO IL RANGOI SERVIZI SI POSSONO “ORDINARE” SECONDO IL RANGO E IL TIPO DI FREQUENTAZIONE
Diversi criteri di classificazione delle attività terziarieLe attività terziarie tendono a distribuirsi sul territorio secondo una logica gerarchicaCentri che posseggono un elevato numero di attività del settore quaternario o i servizi delterziario superiore più specializzati e strategici (es. New York, Parigi …)Centri provvisti di un terziario comune (centri con meno di 3.000 abitanti)L’organizzazione gerarchica di un centro non corrisponde alla quantità dipopolazione residente, ma alle funzioni terziarie di diverso livello che vi si esercitano
Il punto in cui la quantità domandata diventa pari a zero (nel piano zero)individua la "portata" del servizio, ossia il limite massimo oltre il quale non cisarà domanda del bene da parte dei consumatori.◦ Ad esempio nelle aree di estrema periferia e lontananza dal centro il prezzo del bene inclusivo dei costi di trasporto diventa proibitivo o poco competitivo rispetto ai beni sostituti.Nell'analisi geoeconomica del mercato non esiste un prezzo unico per una merce ma infiniti prezzi pari ai punti del raggio originato dal luogo centrale fino allafrontiera della portata del servizio.
Il Modello delle “località centrali” di Christaller (1933)Oggetto: L’organizzazione spaziale degli insediamenti nella Germania Meridionale
6
7
Risultato:Spiegare la distribuzione geografica dei centri in funzione dell’offerta di servizi alla popolazione del territorio circostanteIl modello si fonda su alcune ipotesi semplificatrici :Lo spazio è isotropico ed isomorfo, il costo degli spostamenti è proporzionale alla distanza fisica ed è a carico delconsumatore; il territorio è uniformemente pianeggiante;Vi è una distribuzione omogenea della popolazione e del potere d’acquisto (stesso reddito), la loro domanda di beni e serviziè uguale;Tutte le zone di questa ipotetica pianura debbono essere servite da unalocalità centrale che provvede alla fornitura di beni, servizi efunzioni amministrative a beneficio del territorio circostante;Gli agenti economici hanno un comportamento razionale:- I consumatori cercano di ridurre il più possibile le spese di trasportoacquistando prodotti/servizi nella località centrale più vicina;- I fornitori cercano di massimizzare i profitti localizzandosi sul territorio in modo tale da disporre del mercato più vasto possibile ponendosi, quindi, alla maggiore distanza possibile l’uno dall’altro.
Il Modello delle “località centrali” di Christaller (1933)Teoricamente ogni Località centrale dispone di un’area commerciale di forma circolare ….. ma “spazi vuoti” non serviti.La tendenza nella distribuzione/fornitura dei vari servizi sarà, secondo Christaller, quella di coprire il mercato il più possibile tanto che le varie aree di mercato finiranno con il sovrapporsi e con lo partirsi ‘equamente’ gli spazi residui..
Il Modello delle “località centrali” di Christaller (1933)….. di fatto, la distribuzione delle Località centrali si presenta come un susseguirsi di coni di domanda di forma esagonale, Le Località Centrali che riescono ad erogare un numero di servizi maggiori vengonodefinite come Centralità di rango superiore (il rango di un servizio è direttamente proporzionale alla sua portata). > Maggiore è il rango migliore sarà la posizione della centralità nella scala gerarchica delle relazioni urbane Ogni Centro produce il bene relativo al suo livello gerarchico e tutti i beni di ordine inferiore; Per ciascun Centro di ordine superiore esistono, a cascata, una pluralità di centri di ordine inferire, fino a raggiungere le agglomerazioni di livello più basso
LOCALITA’ CENTRALE
7
8
E AD ESSA SI RIVOLGERA’ LA CLIENTELA DEI CENTRI VICINI CHE ESSENDO DOTATIDI UNA OFFERTA MENO QUALIFICATA SONO DI RANGO INFERIORESI DICE ALLORA CHE LA SUA POSIZIONE NELLA SCALA GERARCHICA E’ N° 1 (CITTA’ PRIMATE)IN OGNI AMBITO TERRITORIALE (REGIONE) E’ COSI’ POSSIBILE INDIVIDUARE LA GERARCHIA URBANA E PERCIO’ VERIFICARE SE VI E’ UNA ADEGUATA OFFERTA DI SERVIZI (“COPERTURA URBANA”).
Le critiche al Modello di Christaller Non è applicabile a tutti gli insediamenti perché prende in considerazione solo i centri di servizio e nontiene conto del ruolo sociale di altre attività come l’industria manifatturiera e l’agricoltura Non è realistico, là dove rappresenta i centri distribuiti in modo geograficamente equilibrato Non tiene conto delle differenze rurali e storiche dei territori, né dell’evoluzione e delle trasformazionisocio-economiche Non è realistica l’assunzione che consumatori e fornitori abbiamo un comportamento sempre razionale Non vengono considerati i fenomeni di agglomerazione ed urbanizzazione che, attraverso processicumulativi di crescita, hanno accelerato lo sviluppo di determinati centri, a scapito di altriLösch (1940) e Isard (1956) riprendono il modello di Christaller perfezionandolo
Le Teorie della DiffusioneHudson (1969) cercò di spiegare il modello di insediamento della Iowa orientale nel periodo 1860-1960, con l’obiettivo principale di combinare le teorie della diffusione con quella delle località centraliHudson individuò tre fasi di diffusione degli insediamenti1. la colonizzazione: dispersione degli insediamenti nel nuovo territorio2. l’espansione: la crescita della densità della popolazione crea nuclei di insediamento e genera una pressione sull’ambiente fisico e sociale3. la competizione: conferisce regolarità al modello di insediamentoEgli dimostrò che gli insediamenti crescevano con una certa regolarità, soprattutto in quelle parti del mondo dove la distribuzione non è regolata da pianificazione esterna.
Strutture urbane: evoluzione dei rapporti centro-periferiaCittà industriale - dominazione◦ poli di sviluppo > centri di crescita
8
9
◦ attività motrici, legami intersettoriali◦ centro > periferia54Silvia Grandi ©
Città commerciale - gerarchia– località centrale– dimensione del servizio offerto– Periferia > centro
LEZIONE 7
La sviluppo una definizione sfuggente nell’era dell’incertezza
significati che cambiano a seconda del contesto culturale di riferimentoe delle idee politiche evoca un’aspirazione dell’uomo verso qualcosa di maggiormente desiderabile rispetto al tempo di riferimento dibattito sempre aperto ed in continua evoluzione concezione sostanzialmente filosofica, politica e relativa potrebbe non esserci una definizione corretta di sviluppo o di “sviluppato” per un’area del mondo(Hodder,2000) la rappresentazione dell’immagine della società, delle sue traiettorie evolutive, sia desiderate idealmente sia effettivamente percorse. Lo sviluppo quindi, nell’accezione moderna ispirata al lavoro di Karl Polanyi, The Great Trasformation, implica un cambiamento della società intenzionale in linea con degli obiettivi espliciti (Hettne, 2009).
Sviluppo & PotereL’approccio allo sviluppo influenza la politica la politica influenza lageografia(Agnew, 2002) >la geografia politica moderna e la Geopolitica
Sviluppo, Cultura e Geografia PoliticaGli aspetti di cambiamento sociale, economico e ambientale pervasivo integrati tra scala locale e globale, danno allo sviluppo una dimensione geopolitica e politico economica in quanto le scelte in questo campo influiscono sugli equilibri tra nazioni e stati (Hettne, 2009). I soggetti, gli agenti, non sono solo gli Stati ma anche le forze che agiscono dall’alto come le Organizzazioni Internazionali, dal basso come i regionalismi e dai lati (ad esempio: i fondamentalismi transnazionali oreligiosi e la finanza internazionale), pertanto la cooperazione allo
9
10
sviluppo in senso lato è un tema centrale nella costruzione delle relazioni tra territori
Molte questioni relative allo sviluppo, soprattutto riguardanti le componenti socio-politica ed economica, sono radicate nella concezione e nel riconoscimento o meno delle aggregazioni socio-politiche nel territorio: Etnia >la comunità fondata su una stessa lingua e propria cultura materiale e spirituale, cementata da una coscienza o consapevolezza di formare un’unità originale distinta dagli altri gruppi Nazione >un popolo aggregato intorno alla volontà di essere o di diventare un soggetto politico autonomo arteficedella propria storia Stato >si riferisce a una parte di territorio in cui risiede una porzionedi umanità ed in cui agisce una sovranità organizzatrice
Stato & Nazione ESEMPINazioni senza Stato Palestinesi , Curdi, MinoranzeStati plurinazionali Regno Unito, Belgio, Spagna, Russia, etcStati senza nazioneSan Marino, creazione «artificiale» di statiNazioni vs nazionalismi*; comunità immaginate;*idee, dottrine e movimenti che sostengono l'importanza del concetto di identità nazionale e di Nazione, intesa come collettività ritenuta depositaria di valori tipici e consolidati del patrimonio culturale e spirituale di un popolo/etnìa, essendo tale patrimonio la risultante di uno specifico percorso storico
Geografia politica moderna & GeopoliticaGli Stati sono in competizione tra loro per l’acquisizione dello “spazio vitale”La geografia politica si interessa della distribuzione spaziale dei fenomeni politici e della loro influenza sui fattori geografici (fondatore Ratzel, 1897)La geopolitica studia la relazione inversa: cioè l’influenza dei fattori geografici, sia fisici che umani, sulle analisi, le scelte, le azioni politiche in relazione a quelle degli altri soggetti politici operanti nel medesimo territorio (fondatore politologo svedese Rudolph Kjellen, 1899)
10
11
Il tema dello sviluppo individuato come “le leggi della crescita” si trova già nel 1897 in Politische Geographie di Friedrich Ratzel(1844-1904).
Ratzel esplicita suggestioni del rapporto tra i temi geografici e quelli che caratterizzano alcune delle questioni sullo Sviluppo
lo spazio degli Stati cresce al crescere della sua popolazione;la crescita territoriale è conseguenza dello sviluppo degli altri aspettilo stato cresce assorbendo Stati minorila frontiera non è permanente;Durante la crescita lo stato assorbe territori politicamente utili;la spinta a crescere è conseguenza dello sviluppo civile;la tendenza alla crescita si trasmette da stato a statofusioni territoriali possono avvenire tra popoli che perseguono lo stesso processo di crescita (visione deterministica)
La concezione dello sviluppo
lo sviluppo come conquista, lo sviluppo come modernizzazione,lo sviluppo come progressolo sviluppo come crescita economica,lo sviluppo umano,lo sviluppo sostenibile, Lo sviluppo alternativo (post-sviluppo; anti-sviluppo; decrescita; etc.)
EVOLUZIONE STORICA MA ANCHE COESISTENTISviluppo vs Crescita“crescere” significaaumentare di dimensione, prevalentemente per aggiunta di materia, mentre svilupparsi sottende l’espansione o la realizzazione della potenzialità di raggiungere una condizione migliore (Vallega, 1994, pp. 10-11). crescita aumento quantitativo sviluppo soprattutto un miglioramento qualitativo, accompagnato, eventualmente, anche da un più modesto o più graduale e duraturo processodi crescita.
L’attenzione alla questione Nord-Sud e ai PVS
11
12
La carestia del Biafra del 1968 è stata la prima occasione in cui l’attenzione dei media si è rivolta alla questione della geografia della fame scatenando un’onda di interventismo umanitario che è un’eredità duratura.
Sviluppo Umano“un processo di espansione delle libertà reali godute dagli esseri umani” (Amartya Sen, 1999)“ l’obiettivo dello sviluppo è espandere le possibilità di scelta delle persone[…] ambente ove le persone possano godere di un vita lunga, in salute e creativa”(MahbubulHaq, 2009) “un processo di ampliamento delle possibilità umane che consenta agli individui di godere di una vita lunga e sana, essere istruiti e avere accesso alle risorse necessarie a un livello di vita dignitoso” nonché digodere di opportunità politiche(UNDP, 2009)
L’indice di Sviluppo Umano(ISU) o Human Development Index (HDI nell’acronimo inglese) composto dai seguenti indicatori: –lo standard di vita, rappresentato da un reddito “decente”, sintetizzato dal prodotto interno lordo (PIL) pro capite; –il livello di salute, rappresentato dalla speranza di vita alla nascita;–la conoscenza, calcolato in base all’indice di alfabetizzazione degli adulti e dal numero effettivo di anni di studio.
Dichiarazione del millenniodell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e relativi obiettivi (MilleniumDevelopment Goals-MDG):
ridurre della povertà (e quindi una più equa distribuzione della ricchezza); garantire la sicurezza alimentare e la salute; continuare a diffondere l’educazione primaria nell’infanzia e rafforzare il ruolo della donna nella società
Oltre al PIL: indicatori di benessere, progresso sociale e felicitàle misure dovrebbero includere una maggiore attenzione alla distribuzionedel reddito, ai redditi delle famiglie e al consumo di beni e servizi fondamentali; settori come la sanità, l'istruzione, l'ambiente, i cambiamenti climatici e la felicità vengono indicati come componenti dello sviluppo. unsistema orientato sulla misurazione della produzione ci si dovrebbe spostare verso uno incentrato sul benessere delle generazioni attuali e future. Inoltre, tra le raccomandazioni viene indicato come sia necessario spostare l’attenzione verso il reddito ed il consumo in sede
12
13
di valutazione del benessere materiale (Stigliz, Sen e Fitoussi, 2009). Felicità Interna Lorda o FIL (in lingua inglese Gross National Happiness—GNH)-La felicità così intesa va oltre ad una concezione materiale, è basata su valori spirituali del credo tradizionale, radicata al patrimonio culturale e all’Heritage della popolazione, così come lo “sviluppo individuale, la sacralità della vita, la compassione degli altri, il rispetto per la natura, l'armonia sociale el'importanza del compromesso. Lo sviluppo è quindi inteso come un equilibrio tra lo sviluppoeconomico e la felicità e la pace, lasciando a quest’ultime la preferenza in caso di conflitto”(Ezechieli, 2003).
Conferenza ONU sull'Ambiente Umano di Stoccolma
L'inizio del percorso culturale e politico relativo allo sviluppo sostenibile Nasce il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (United Nations Environment Programme-UNEP) Si afferma l'opportunità di intraprendere azioni tenendo conto non soltanto degli obiettivi di pace e di sviluppo socio-economico del mondo, per i quali «la protezione ed il miglioramento dell’ambiente è una questione di capitale importanza», ma anche avendo come «obiettivo imperativo» dell'umanità «difendere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future».
Nel 1983 viene istituita dall'ONUl aCommissione Mondiale su Sviluppo e Ambiente presieduta dall'allora premier norvegese Gro Harlem Brundtland, Nel 1987 venne pubblicato il cosiddetto RapportoBrundtland «Il nostro futuro comune» “per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri” [Rapporto Brundtland, OurCommon Future, 1987]
Due modi di intenderlo:Sostenibilità Debole•Ogni generazione potrebbe quindi degradare gli ambienti a patto di rimpiazzarli con ricchezza capitale prodotto dall’uomoSostenibilità Forte•È imperativo che la generazione corrente lasci alle future lo stesso insieme di capitale naturale e questo non può essere sostituito con capitale artificiale prodotto dall’uomo
1992 Summit Mondiale della Terra (RIO)ha consolidato il principio dello sviluppo sostenibile attraverso la sua formalizzazione negli atti adottati a conclusione del Vertice:
13
14
la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, l’Agenda 21 la Dichiarazione sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste. Trattati ambientali aperti alla firma a Rio: la Convenzione sui cambiamenti climatici (entrata in vigore nel 1994 e lostrumento attuativo della Convenzione è ilProtocollo di Kyoto, che verrà sottoscritto nel 1997 la Convenzione sulla biodiversità (entrata in vigore nel 1993).
Misurare la sostenibilitàlivello di cambiamento tollerabile a livello locale (Carrying Capacity) o globale (Ecological Footprint) da esso generato. capacità di carico degli ecosistemi può essere definita come la capacità naturale che un ecosistema possiede di produrre in maniera stabile le risorse necessarie alle specie viventi che lo popolano, senza rischi per la sopravvivenza. impronta ecologica misura la “porzione di territorio” (sia essa terra o acqua) di cui una popolazione necessita per produrre in maniera sostenibile tutte le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti. L’impronta ecologica di qualsiasi popolazione (dal livello individuale fino al livello di città o di nazione) è il totale della terra e del mareecologicamente produttivi occupati esclusivamente per produrre tutte le risorse consumate e per assimilare i rifiuti generati da una popolazione.In analogia sono stati sviluppati i concetti di Socio-CulturalCarryingCapacitye diLimits for AcceptableChange(LAC)per evidenziare la capacità di una comunità di assorbire un cambiamento o il limite di accettabilità di un cambiamento, ad esempio sotto la pressione dell’attuazione di un intervento di sviluppo turistico (Mansfelde Jonas, 2006; Mansfeld, 2009).
L’impronta ecologicaIndicatore utilizzato per valutare il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle.
2002 –Rio+10 Summit Mondiale della Terra a Johannesburg (Sud Africa)Ha rafforzato il ruolo dell’elemento sociale e dell’inclusione nello sviluppo sostenibile Riduzione della povertà (Obiettivi del Millennio) Piano di attuazione Tuttavia non ha dato gli esiti sperati
2012 –Rio+20 Summit Mondiale della Terra a Rio (Brasile)
14
15
Il più grande evento mondiale partecipato anche dal basso Riconoscimento del ruolo sostanziale della società civile Presa d’atto del ruolo della Green Economy Documento “Il futuro che vogliamo” -sette tematiche: lavoro, energia, sostenibilità nelle città, sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile, acqua, oceani, catastrofi naturali. Prepara le basi per gli obiettivi post 2015 Dagli Obiettivi del Millennio agli Obiettivi ai Sustainable Development Goals(e relativi indicatori) Tuttavia anche in questo caso non ha dato gli esiti sperati
Altre conferenze & impegni internazionaliil programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari (Programma d'azione di Barbados) e la Strategia delle Mauritius per l'ulteriore attuazione del programma di azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari. Programma di azione per i paesi meno sviluppati per il decennio 2011-2020(Programma di Azione di Istanbul), il Programma d’azione di Almaty: affrontare le esigenze dei Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, la Dichiarazione politica sui bisogni dello sviluppo in Africa e la nuova collaborazione per lo sviluppo africano. la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite(2000) il Documento mondiale conclusivo del vertice del 2005, il Monterrey Consensus della Conferenza Internazionale sul finanziamento per lo sviluppo, la Dichiarazione di Doha sul finanziamento per lo sviluppo, il documento finale della riunione plenaria di alto livello dell’Assemblea generale sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, il programma d’azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, Il programma d’azione della Conferenza internazionale sulla popolazione esullo sviluppo, la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino
Non tutto è sviluppo sostenibile ciò che è verdeDal 2008, con l'inizio della crisi, questo fenomeno è cresciuto del 1000%. La domanda di terra vola. Gli investitori cercano dove coltivare cibo perl'esportazione, o semplicemente per fare profitto. Si assiste al fenomenodi LAND GRABBING. Secondo le recenti previsioni fatte dall'International Energy Agency(IEA) sul consumo di biocarburanti, per il 2040 si stima che saranno necessari allaloro sussistenza 100 milioni di ettari agricoli. Ciò si tradurrà in un aumento del 333% della terra impiegata per la produzione di agro-energie in appena quarant'anni.
15
16
Competizione dell’uso del suolo
Le critiche allo sviluppo sostenibile & altre vie per il futuroSviluppo contro Crescita Green washing–«Lavar col Verde» Correnti post-sviluppiste (Latouche& La decrescita) Paradigma scientifico-tecnologico Paradigma economico-finanziario
la cassetta degli attrezziAnalisi, Valutazioni, Life CycleAssesment, Normative, Controlli Incentivi & schemi PPP («chi inquina paga») Etichettature, Certificazioni, Bilanci di sostenibilità Educazione & Informazione Programmi e progetti dedicati Ricerca & Sviluppo Consapevolezza & Moralsuasion È un modo di pensare
Cooperazione Internazionale allo sviluppo: principi, attori e metodi
Gli obiettivi futuri dei donatori(L’agenda di Roma, 2003):Armonizzazione◦Semplificazione◦Condivisione delle informazioni◦Programmi congiuntiAllineamento◦Alle priorità dei paesi beneficiari◦Adattamento agli usi dei sistemi localiPiù ownership dei paesi in via di sviluppo◦SVILUPPO ENDOGENO VS ESOGENOUS BOTTOM-UP (dal basso verso l’alto) VS TOP-DOWN (dall’alto verso il basso)
AttoriRecipients(“riceventi” o “recettori” o “beneficiari”)
Donors (Donatori):Organizzazioni BilateraliIstituzioninazionali(Ministreri, Agenzie)Istituzioni Regionali e locali
16
17
Multilateral Organisations (Organizzazioni Multilaterali):Sistema Nazioni UniteBanche di SviluppoAltriNon-Governative Actors (ONG)Società civile e ONGFondazioni Private(es: Gates’ Foundation) Altri:DAC –Development Assistance Committee (OCSE) Networks
Le ONGHanno assunto una rilevanza centrale soprattutto a partire dagli anni Novanta sono le NGO-Non Governamental Organisationo ONG-Organizzazioni Non Governative.Queste sono organizzazioni legalmente costituite, create da persone fisiche o giuridiche di natura privata, quindi senza partecipazione o forme di rappresentanza di qualsiasi governo +ONG internazionale «qualsiasi organizzazione internazionale che non è fondata con un trattato internazionale»(UN)In base alla scala territoriale di riferimento si possono identificare leONG, nazionali e locali (o community-based)ONG operativa-scopo primario progettazione e realizzazione di progetti disviluppo,ONG d’opinione(AdvocacyONG)-difendere e portare avanti cause specifiche
Organizzazione delle Nazioni Unite,ONU
La più estesa organizzazione internazionale, comprendendo la quasi totalità degli Stati del pianeta (192membri) La sede principale è New York e il Segretario Generale è BanKi-Moon. Nata tra il 1944 e il 1945. Ne gettarono le basi le potenze anti-naziste(Unione Sovietica, Regno Unito, Stati Uniti,e Cina). Sistema delle Nazioni Unite (org.Nate sulla base dell’ONU: esempi UNDP, UNIDO, UNEP, FAO, etc.)
Scopi e Principi della Nazioni Unite1.mantenere la pace e la sicurezza internazionale; 2.promuovere la soluzione delle controversie internazionali e risolvere pacificamente le situazioni che potrebbero portare ad una rottura della pace; 3.sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base del rispetto del principio di uguaglianza tra gli Stati e l'autodeterminazione dei popoli; 4.promuovere la cooperazione economica e sociale;
17
18
5.promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali avantaggio di tutti gli individui; 6.promuovere il disarmo e la disciplina degli armamenti; 7.promuovere il rispetto per il diritto internazionale e incoraggiarne losviluppo progressivo e la sua codificazione.
Le organizzazioni di Bretton WoodsLa Conferenza di Bretton Wood si tenne nel 1944 (delegati di 44 nazioni delle nazioni alleate. Si preparò:la politica monetaria e finanziaria (presentati il piano White e Keynes,prevalse il primo; dollaro agganciato al valore dell’oro gold Exchange standard–finì nel 1971)
le basi per il GATT (Accordo generale sulle tariffe e sul commercio internazionale)
Decisione di istituire:Banca Mondiale Fondo Monetario Internazionale WTO –Organizzazione Mondiale per il Commercio (1995)
OECD (OCSE)Nacque per gestire il Piano Marshall, poi convertita negli anni ‘60 come forum dei governi democratici volta a svolgere studi economici per i paesi membri. Questi sono i paesi sviluppati aventi in comune un sistema di governo di tipo democratico ed un'economia di mercato. L'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva che consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per larisoluzione dei problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali ed il coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi membri. Membri: Australia, Austria, Belgium, Canada, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, the Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States. Recenti: Israele, Cile,Estonia e Slovenia
La cooperazione allo sviluppo in italia: governativa e decentrata
QUADRO EVOLUTIVO ITALIANO
18
19
Alcune tappe evolutive ◦Le leggi sulla Somalia◦La collaborazione tecnica con i PVS (1962)◦La legge “Pedini” sul volontariato◦Legge per la “Cooperazione tecnica con i PVS” (1971)◦Legge “Ossola” (1977) Crediti finanziari per la cooperazione internazionale◦Cooperazione allo sviluppo (L.38/1979), nascita del DIPCO◦Intervento straordinario, il FAI (L.73/85)
QUADRO EVOLUTIVO ITALIANOLa L. 49/1987 -La cooperazione allo sviluppo è◦“parte integrante della politica estera dell’Italia e persegue obiettividi solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo, ispirandosi ai principi sanciti dall’ONU e dalle convenzioni CEE-ACP◦“finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari ed in primo luogo alla salvaguardia della vita umana […] alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all’attuazione ed al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno ed alla crescita economica, sociale e culturale dei PVS […] al miglioramento della condizione femminile, dell’infanzia ed al sostegno della promozione della donna”
Attori e Ruoli operativiDonatori /Finanziatori Paesi riceventi Programme manager Project manager Expert Evaluator
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ATTUALEComprende attività pubbliche e private impostate ed attuate nei modi previsti dalla legge e collocate prioritariamente in programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazionegeografica Inclusi sono gli interventi straordinari destinati a fronteggiare eventi di calamità, situazione di denutrizione e carenze igienico sanitarie che
19
20
minacciano la sopravvivenza di popolazioni (“EMERGENZA”). I finanziamenti non possono essere usati direttamente o indirettamente per finanziare attività di carattere militare
Programma e Progetto
Un progetto è un insieme non divisibile di operazioni da realizzare in tempi definiti e con risorse prestabilite che produce flussi durevoli di benefici a favore di un definito destinatario Un programma è un’insieme di progetti tra loro coordinati
LA COOPERAZIONE DECENTRATA"L'azione di cooperazione allo sviluppo svolta dalle Autonomie locali italiane, singolarmente o in consorzio fra loro, anche con il concorso delle espressioni della società civile organizzata del territoriodi relativa competenza amministrativa, attuata in rapporto di partenariato prioritariamente con omologhe istituzioni dei PVS favorendo la partecipazione attiva delle diverse componenti rappresentative della società civile dei paesi partner nel processo decisionale finalizzato allo sviluppo sostenibile del loro territorio."
(Linee di indirizzo e modalità attuative -D.G.C.S. del M.A.E.; marzo 2000)
SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE DECENTRATAM.A.E.Autonomie locali(Regioni,Provincie autonome, Enti Locali)U.E.Amministrazioni localiAssociazioni del settore privato con interessi localiSindacati e CooperativeChiese e ONG
La cooperazione a scala europeaSviluppo nell’UENell’ambito delle politiche europee il tema dello sviluppo è ricorsivo e ingrediente fondamentale del progetto politico dell’Europa. Significatosi declina in varie sfumature in base agli ambiti tematici, geografiche settoriali di riferimento. Nella strategia Europa 2020 si auspica una “Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” uno slogan che rappresenta emblematicamente la sintesi della mediazione politica tra le linee teoriche di sviluppo quella tecno-economica, quellasostenibile e umana.
La cooperazione UE20
21
Anche la parola cooperazione presenta di fatto significati variabili, soprattutto in relazione a confini interni o esterni. In particolare la cooperazione dell’UE può essere classificata in tre categorie principali e due posizioni intermedie in base alla “vicinanza” ai processi di europeizzazione o ai confini dell’Europa: –cooperazione interna, essenzialmente basata sulla declinazione delle politiche di coesione socio-economica, sviluppo tecnologico e tutela ambientale, tra cui la cooperazione territoriale europea rappresenta l’esempio più significativo in termini geografici; –cooperazione esterna allo sviluppo che l’UE intrattiene con paesi terzi in via di sviluppo; –cooperazione con i paesi in accessione, volta all’acquisizione dell’aquiscomunitarie dei paesi che hanno siglato gli accordi di pre-accessione e accessione all’UE e la cooperazione con i paesi vicini non in accessione,ma comunque confinanti per via terrestre o marittima con l’Unione e in cui questa esercita o vorrebbe tendere ad aver un’influenza geopolitica forte.
LEZIONE 8
RuraleNON URBANOUOMO NATURA AGRICOLTURA & ALLEVAMENTO ATTIVITA’ PRIMARIA DELL’UOMO RITI e CREDENZE PAESAGGIO RURALEPALINSESTO DELLA STORIA MILLENARIA [Dagradi]
Bibliografia Lucio GambiL. Gambi,(1949), L’insediamento umano nella regione della bonifica romagnola,CNR, Bologna Reprint Bologna 2008 L. Gambi,(1950), La casa rurale nella Romagna, Centro di studio per la geografia etnologica, Firenze. Reprint Bologna 2011
Il Paesaggio HUMBOLT SUSCITÒ L’INTERESSE GEOGRAFICO SUL PAESAGGIO PORTANDOLO DAL LINGUAGGIO COMUNE A SENSO SCIENTIFICO, RIFACENDOSI A CONCETTI ESTETICI LETTERARI E DELLE ARTI FIGURATIVE RIPORTANDOLI ALL’INDAGINE GEOGRAFICA
Paesaggio –definizione istituzionale «“Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors»
21
22
Possibile traduzione«Zona o territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto o carattere derivano dalle azioni di fattori naturali e/o culturali (antropici)»
Per la geografia culturale, gli aggregati di interesse principali sono:Genere di vitaRegionePaesaggio
Il paesaggio per la geografia culturale è:Finestra attraverso cui è possibile esplorare come possa avere luogo unarappresentazione del territorio su base semiotica
L’arena per ragionare sia sul rapporto che lega: il simbolo con il referente (oggetto, realtà territoriale) forte contenuto metaforico (il simbolo à qualcosa di vago, incerto che sta al posto di qualcos’altro Il simbolo con il significato i simboli radunati attraverso il discorso che ne fa il soggetto diventano la visione esistenziale che ne fa il soggetto, esprime l’emozione, reazioni psichiche ai processi sensoriali
Approccio culturale spiritualista:«Osservare il paesaggio, non con il distacco oggettivo […] ma con la partecipazione di tutto il patrimonio culturale, tenendo ben presente che per accostarsi a quel paesaggio è necessario un atteggiamento storico e spirituale che riporti l’osservatore nel pathos temporale dal quale esso trasse origine e del quale tramanda le emozioni»
[Andreotti, 1996]
22
23
Fondamenti della società rurale«le società rurali hanno quasi sempre mirato a fondare la sussistenza sull’armonico accostamento di piante attraverso una precisa ripartizione dei terreni e dei lavori. I sistemi colturali si ripetono con rigidità per secoli ed entrano nel folclore: su questi sistemi rurali il contadino modella le opere e i giorni, ad essi collega usanze e pregiudizi.» [Dagradi, 2003]
Attività possibile1.Prendere in considerazione uno spazio di cui si abbia una buona conoscenza personale e di farne un oggetto di indagine 2.Identificare i luoghi rilevanti per la presenza di simboli che rimandano alla relazione con natura, società e trascendenza ◦Per ogni luogo si identificano i simboli e i significati (valori, narrazioni, credenze, etc) cui essi conducono testuale, ove si considerano opere (testi letterari, musicali, arti figurative, monografiegeografiche, etc.) che contengano indicazioni al riguardo ◦Livello contestuale ◦Livello, compiendo un’esplorazione del territorio ed eseguendo rilevazioni 3.Elaborare una carta generale dei valori simbolici avendo cura soprattutto della dimensione estetica e spirituale del paesaggio 4.Predisporre un testo d commento
LEZIONE 9
Turismo & Modelli Turistici
ObiettivoCos’è il turismo?Evoluzione e perché?Classificazione (caratteri e motivazioni)Principali indicatoriarrivi, presenze, spesa
23
24
permanenza media (presenza/arrivi)Modelli principaliItinerari culturaliL’immagine dei luoghi
Breve storia del turismoORIGINIOtium romanoVilleggiaturaPellegrinaggiGrand TourTurismo TermaleDisponibilità di un surplus di tempo libero e di denaroturismo di massa (‘900)
Cos’è il turismoDefinizione dell’OrganizzazioneMondiale del Turismo Turismo spostamento con permanenza oltre alle 24 ore Escursionismo permanenza minore delle 24 ore
Tipologie Principali TURISMO PROPRIO: • per svago, ricreazione, divertimento (diporto) o per motivi di ordine culturale (es: vacanza, sport ricreativo, shopping, festival culturali..) TURISMO IMPROPRIO: per altre ragioni (es: Affari, Lavoro, Salute, Studio, etc.)
Elementi fondamentali SPOSTAMENTO: ◦ Origine –Destinazione
24
25
◦ Collegamento - Viaggio (Percorso/Itinerario) Indicatori statistici più comuni: Arrivi (italiani e stranieri) ◦Presenze (= n di pernottamenti) ◦Permanenza media (Presenza / Arrivi)
Turismi“ LOVE OF VARIETY ”THE TOURIST SAT IS FACT ION INCREASES WITH THE VARI ETY OF LOCAL GOODS. ASA CONSEQUENCE, THE DEMAND FOR ACCOMMODATION AND THE SHARE OFBUDGET SPENT IN THE DESTINATION BOTH INCREASE WITH THE RICHNESS OF IT SVARI ETY.THI SIMPL IES THAT “CENTRAL PLANNER ” HAS TO:Increase the variety of local goods and services (i.e., by favouring the development of localfirms, or merging in districts – the STL in the Italian case)Support the preservation and the availability of natural resourcesSupport in raising funds to finance its activity (taxation of the extra-profits of the firms)
Modelli turisticiMettono in evidenza alcuni aspetti del turismoModelli di circolazioneModelli di distanzaModelli di mobilitàModelli di origine e destinazioneModelli strutturaliModelli di evoluzioneCiclo di vita di una località turisticaModelli reticolari & sistemici
Modello di Campbelldescrive diverse modalità di movimento a partireda un centro urbano.I viaggiatori vengono raggruppati in diverse classi diindividui:- ricreativi (fulcro: l’attività ricreativa in sé)- vacanzieri (interesse sul viaggio e tappe)- vacanzieri-ricreativi (base ed escursioni)
25
26
Modello di ThurotFase 1 – Scoperta del luogo◦ turismo ricco, pochi alberghi di classe altaFase 2 – Espansione del flusso turistico◦ turismo medio-alto, alberghi di classe medio-altaFase 3 – Perdita dell’originalità◦ turismo di massa, alberghi budget e low cost
26
28
Destinazione TuristicaDestinazioni Monosemiche(Parco Naturale, La Mecca, Isola Maldive)Destinazioni Polisemiche (Gerusalemme, Los Angeles)
28
29
Destinazione turistica: definizioniMight be a single district, a big city or a small town, a rural, mountain or a coastal area, clearly shaped(Davidson and Maitland, 1997)A set of products, services, natural and artificial attractions able to draw tourists to a specific place(Leiper, 1995; Martini, 2001; Pechlaner, 2000)A package of tourism facilities and services, which like any other consumer product, is composed of a number ofmulti-dimensional attributes(Hu and Ritchie,1993)An amalgam of tourism products, offering an integrated experience to consumers(Buhalis, 2000)A supply system correlated with a specific area(Tamma, 2002; Brunetti, 2002)A particular type of district, sharing some of the features of industrial districts (positive externalities on costs)and of cultural districts (positive externality on quality).◦ (Dallari, 2005; Candela e Figini, 2009)
Sistema Turistico localeun contesto turistico omogeneo o integrato, comprendente ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzato dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate"(L. 29 marzo 2001 n.135, "Riforma della legislazione nazionale del turismo)
Itinerari turistici & culturali“Quando si va versoun obiettivo, è moltoimportante prestareattenzione alcammino. E’ ilcammino che ciinsegna sempre lamaniera migliore diarrivare, e ciarricchisce mentre lopercorriamo”Paulo Coelho“Il Cammino diSantiago” ( 2001)
29
30
Itinerari perché?
Riscoperta dei valori territoriali secondari L’articolazione e la riqualificazione dei prodotti turistici Diversificare i prodotti turistici Strumento per le politiche di dispersione o concentrazione dei turisti (ad esempio negli ecosistemi fragili) Rafforzare l’elemento didattico Rinnovare l’offerta Arricchire la visita con l’esperienza ed emozioni ….
Pianificazione dei Trasporti & Classificazione di viaggiI viaggi Home Based si classificano secondo lo scopo◦ Viaggi per lavoro◦ Viaggi per studio (scuola)◦ Viaggi per acquisti◦ Viaggi per attività sociali e ricreative◦ Viaggi per altri motivi (salute, burocrazia, etc.)Periodo◦ Viaggi effettuati nei periodi di punta◦ Viaggi effettuati nei periodi non di puntaTipologia del viaggiatore◦ Livello del reddito◦ Possesso d’auto◦ Dimensione della struttura della famigliaOrtuzar e Willumsen, 1990
La rete stradaleSchema a rete del percorso (grafo)Dato un percorso stradale esso si può semplificare come un sistema a rete(network) formato da archi (strade) e nodi (incontro di due o più strade).
Itinerarioun percorso geografico,un percorso matematico,un percorso mentale,un nuovo prodotto turistico,un bene culturale
30
31
Un itinerario è un processo decisionale◦ mentale◦ o automatizzatoche si basa sulla individuazione di elementi◦ esistenti◦ o da creare,può essere perciò il risultato◦ di un’analisi storica,◦ di un’analisi tematica,◦ di un’analisi ambientale/paesaggistica◦ di un algoritmo di ottimizzazione matematica◦ di una progettazione ex-novo.
SCALA
• Tras-nazionali• Trans-regionali• Regionali
FILO CONDUTTORE
• un tema,• una tipologia di beni culturali• elementi legati alla produzione naturale oIndustriale
Itinerario come bene culturale complessoUn itinerario è un nuovo tipo di bene culturale complesso che collega traloro dinamicamente beniculturali diversi od omogenei, creando un nuovo sistema di conoscenze. secondo logiche di turismo “lento”, consente al viaggiatore di avere uno scambio culturale con i Luoghi e le persone che lì vivono, in un paesaggio che è culturale ma anche vivente e non cristallizzato e adeguato alle esigenze del turismo.
L'art. 148 del d.lg. 112/1998 e la smaterializzazione deibeni culturalitra le attività da ricondurre ai compiti di Valorizzazione dei beni culturali
31
32
"l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi".
Itinerario CulturaleIl primo modello di itinerario culturale è quello che segue le tracce di un antico cammino, di una stradastorica che nei secoli ha mantenuto la sua funzione.◦ Pellegrinaggi◦ Rotte◦ Percorsi militariHa come obiettivo: la conservazione, la ricerca, la divulgazione, la cooperazione intra e interculturale
Programma Itinerari CulturaliNel 1987 il Consiglio d’Europa lanciò il ProgrammaItinerari Culturali24 itinerari culturaliContribuiscono alla visione di una identità europei che supera i confininazionali e regionaliMettono in rete i luoghi che nei secoli hanno conservato tracce e testimonianze della storia e dellacultura dei popoli, luoghi da tutelare, recuperare e valorizzare quali occasioni di crescita culturale e divolano per lo sviluppo economico dei territori e, talvolta, di un Paese.
EsempiIl Cammino di Santiago di Compostela;La Via Mozart;Il patrimonio Al Andalus;La Via Anseatica (Hansa);L’Itinerario dei Vichinghi e dei Normanni;L’Itinerario di San Martino di Tour;La Via Francigena;La Rotta dei Fenici: l’itinerario dell’interculturalità mediterranea.
La Rotta dei Feniciconnessione delle grandi direttrici nautiche che, dal XII secolo a.C. , furono utilizzate dal popolo deiFenici quali fondamentali vie di comunicazione commerciali e culturali nel Mediterraneo rete di siti archeologici, etno- antropologici, culturali, naturali e di scambi culturali tra i popoli e i paesi del Mediterraneo
32
33
La Rotta dei Feniciobiettivi:sviluppare una identità ed una immagine comune tra territori del Mediterraneo dalle caratteristiche analoghesviluppare una rete di sistemi culturali e turistici in grado di affrontare la sfida dei mercati internazionalifar crescere le performance in termini di qualità dell’offerta e, come conseguenza, di quantità dei flussimigliorare le strategie e le politiche territoriali per la fruizione compatibile del patrimonio mediterraneoaccrescere le forme di cooperazione internazionale per lo sviluppo di un prodotto turistico-culturale mediterraneo di grande evidenza.
Percorso geograficoIl viaggio è il trasferimento da un luogo ad un altro e per estensione implica effettuareun percorso. L’itinerario è il percorso adottato per lo svolgimento del viaggio o di una visita turisticaCIRCOLAZIONE
Strumenti alla base della progettazione di unitinerarioEsperienza, Informazioni CulturaliDati raccolti da indagini e testCheck-list (Liste di controllo) dedicateMappe e carte (anche mentali)Emozioni (attori), sensorialitàSistemi di supporto alle decisioni informatici• pacchetti informatici di routing (off-line o web-based)• sistemi di gestione GIS,• sistemi GIS integrati con GPS• altri pacchetti pacchetti informatici “tematici”
Scelta del percorso nella pianificazione dei percorsi automobilistici urbaniNel caso traffico automobilistico urbano la scelta è dominata dalfattore: tempo (ma % bassa che riescono a raggiungere l’obiettivo!)Differenti utenti scelgono differenti percorsi quando si spostano trala stessa coppia Origine/Destinazione per:◦ Effetti della congestione◦ Differenze tra la percezione di che cosa costituisce il percorso migliore
33
34
Tuttavia…per identificare un percorso turistico di successo bisogna tener conto inmaniera integrata anche di elementi:- organizzativi e gestionali- economici e finanziari- socio-culturali e cognitivi- geopolitici e ambientali
Elementi Principali per la determinazione di un percorso:ELEMENTI ECONOMICI E FINANZIARIcosto del trasportomargine operativo dell’attività turisticareddito dei partecipantisituazione dei cambi valutaricosti entrate in musei, siti, guide turistiche, etc.costi hotel e ristorazionecosti assicurativieventuali benefit ed offerte degli operatori…ELEMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALInumero di persone coinvoltemezzi di trasporto utilizzatinumero di giorni disponibiliorari dei mezzi di trasportopartnership privilegiate del tour operator…ELEMENTI SOCIO-CULTURALI e COGNITIVIobiettivi personali ed aspettative riposte nellavacanza/escursioneetàstato di saluteabitudini alimentaristato familiare (single, coniugato, con figli, etc)personalitàtipo di vita condottalivello sociale/culturalegusti culturalipercezione del paesaggiosistema sanitario del territorio visitatodisponibilità a pagare…ELEMENTI GEOPOLITICI e AMBIENTALI• stagione dell’anno• clima• stabilità politica del luogo• distribuzione delle risorse ambientali
34
35
• distribuzione delle risorse storiche-culturali• distribuzione delle risorse ricreative• …
Sviluppi TecnologiciRendering (Sistemi CAD, Cinema 3D)Viaggi VirtualiIntegrazione tecnologica (Routing, GPS,telefonia, Realtà aumentata, ….)
Arte & Itinerari- Arte intesa in senso classico «Patrimonio tangibile»◦ esempio: Le chiese romaniche dell’Emilia-Romagna- Performing Art◦ esempio: London Walks: Jack the Ripper (con attori)- Itinerario come progetto artistico◦ Esempio: the Brooklyn Bridge (walk percettivo con artista)
Immagine del territorio e turismo
Territorio e TerritorialitàTerritorio: il progetto attuato della società che vi si è insediata.Nasce dalla proiezione dei vari sistemi◦ culturali (sacralità, miti…)◦ sociali (gerarchie, rapporti sociali…) ed◦ economici (bisogni, ricchezze…)che quella società ha potuto e voluto imprimere sull’ambiente originale osu qualsiasi altroterritorio fatto proprio.proiezione attiva e azione incisivaTerritorialità: il sistema di valori in esso fissati, quell’insieme di qualità che lo rendono ilterritorio atto ad essere utilizzato, gestito e controllato da quella società.[Lando, 2008](NB: Il tema in questa e nelle prossime slide si può approfondire in Lando, 2008 in Sala,Grandi, Dallari, Turismo e Turismi, Patron Editore, tra i materiali bibliografia perapprofondimenti)
Territorializzazione
35
36
Processo di territorializzazione: “un grande processo in virtù del quale lo spazio incorpora valore antropologico; quest’ultimo non si aggiunge alle proprietà fisiche, ma le assorbe, le rimodella e le rimette in circolo in forme e con funzioni variamente culturalizzate…[questo] processo di territorializzazione non va confuso con l’accumulo di artefatti sulla superficie terrestre, con una generica e lineare crescita del valore antropologico di uno spazio; al contrario dobbiamo tener presente che esso si risolve in continue ri-configurazioni della complessità da cui in definitiva l’homo geographicus ricava occasioni, norme o almeno indicazioni per il suo agire”(Turco, 1988, p.76)In altri termini il processo di territorializzazione è legato a tutte quelle procedure mediante le quali una società fa proprio, organizza e gestisce un ecosistema imprimendovi quei valori che, definendone le qualità, permettono a quella società di trasformarlo in territorio ed utilizzarlo ai propri fini.
Mappa Mundi & Imago MundiLa visione del mondo individuale sociale es:Santi Luoghi FrancescaniEroi Testimonial(Esponenti della Cultura) ScrittoriParchi Letterari, Testimonial
Processo T-D-ROgni società possiede una “specifica razionalità territorializzante” che rappresenta una delle modalità attraverso cui essa vive e si riproduceProcesso di territorializzazione-deterritorializzazione-riterritorializzazione(Raffestin, 1988)l’uomo è “un animale semiologico la cui territorialità è condizionata dailinguaggi, sistemi di segni e codici” (Raffestin, 1986, p 76)
Turisticità e TuristicizzazioneProcesso di turisticizzazione: ad un dato ambiente, fornito di◦ congrue caratteristiche (spiagge, montagne…) o ad un determinato territorio con proprie articolazioni (città, paesaggio rurale…),◦ si attribuiscono precisi valori, simboli e significati che definiscono la turisticità◦ ed in seguito si fissano o si organizzano delle strutture ricettive tangibili (alberghi, campeggi…).Il tutto materialmente ed immaterialmente qualifica l’attrattività turistica.L’aspetto immateriale: turisticità
36
37
Turisticità: tutti quei valori, simboli e significati che la società, il turista ed i tour operator attribuiscono alterritorio.◦ - si riferiscono alla sfera culturale◦ - è la parte metafisica del turismoL’attrattività turistica e la turisticità, di un determinato territorio derivano da un preciso processo di territorializzazione. non sono un “dato” a-priori né un fenomeno intrinseco di una determinata area.
“Lo spazio turistico è innanzitutto: Immagine che si fanno i turisti e che danno gliorganizzatori di vacanze… Immagine complessa, sogno, che compare su manifesti, guide, depliant, dipinti, libri, film. Immagine ed evocazione che i turisti portano con sé e trasmettono agli altri. Evocazione di odori,suoni, sensazioni”(Miossec, 1991, p.15)
“Il significato delle cose ci viene trasmesso ancor prima della loro osservazione o, più esattamente, della loro presentazione… questa “metafisica” non è nient’altro che natura e la cultura prodotte intorno aun luogo. Non è nient’altro che la rappresentazione del luogo turistico. Non si tratta mai dunque della natura e della cultura del luogo reale, madi una rappresentazione prodotta”(Raffestin, 1991, p.7).
La scomposizione dell’attrattività turisticalo statico scenario preesistente comprende i vari caratteri fisici e tangibili dell’areaprecedenti alla territorializzazione◦ proprietà naturali che caratterizzeranno le varie tipologie turistiche (il turismo balneare ha bisogno dispiagge, quello termale di particolari condizioni presenti nel sottosuolo…),◦ le molteplici attività umane legate alla cultura materiale[rappresentate da quegli “accumuli di artefatti”indispensabili a quasi tutte le tipologie turistiche..la turisticità: quella “complessa immagine” prodotta da un preciso e fondamentale processo diterritorializzazione, la sola in grado di attribuire ad un territorio quelle caratteristiche meritevoli diattenzione dalla parte del turista o del tour operator e quindi di definire il suo “valore turistico”.le strutture ricettive: investimenti immobiliari ed infrastrutturali effettuati solo se quel
37
38
determinato territorio può essere considerato turisticamente importante el’imprenditorialitàqualsiasi luogo può diventare turisticamente importante e ciò non dipendedai dati,ma dai valori che la turisticità ad essi attribuisce e dall’imprenditorialità
Hardware: tangible factorsSpecialisation/diversity (Lynch/Jacobs)– Situation / public space / accessibility– Smart cities - a lot to offer
Software: quality of livingSociological factors (Putnam/Florida)– Social capital: trust & networks– Cultural capital: knowledge & highly skilled /educated people
Mindware: image / reputation / DNACome percepiamo la città– L’immagine della città ha conseguenze– Come le scopriamo: esperienza personale,racconti, TV, You-tube, Fiere, etc.
HERITAGE e IDENTITA’Identità e fondata sulla memoria (collettiva) condivisa, tracce che gli eventi hanno lasciato nel tempo (miti?) Memoria, heritage e potereConservazione vs/ UsoCostruzione dell’identità e heritage miningCultura popolare vs cultura tradizionale
Identità?Zararism, McDisneyfication,• Cancunism / Balnearizzazione• COMMODIFICAZIONE• UNIFORMIZZAZIONE e NON-LUOGHI• INSOSTENIBILTA’ (sociale, ambientale, economica)
Turismo e lettura geograficoculturaleLa lettura del territorio attraverso la chiave culturale evidenzia gli elementi materiali ed immateriali che
38
















































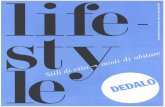








![Commentary on M. HEIDEGGER, Costruire abitare pensare [Building Dwelling Thinking], transl. by M. BARISON, in L. TADDIO (ed. by), Costruire abitare pensare [Building Dwelling Thiking],](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322becd63847156ac06c332/commentary-on-m-heidegger-costruire-abitare-pensare-building-dwelling-thinking.jpg)


