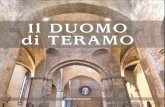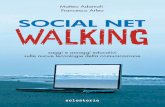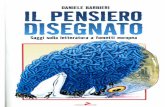RICERCHE, SAGGI E RASSEGNE
-
Upload
uninettuno -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of RICERCHE, SAGGI E RASSEGNE
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
77
RICERCHE, SAGGI E RASSEGNE Traumi irrisolti, comportamento genitoriale atipico e attaccamento disorganizzato: una rassegna della letteratura Elena Camisasca∗ Riassunto La presente rassegna esamina la relazione tra traumi infantili irrisolti, comporta-mento genitoriale atipico e insorgenza di legami di attaccamento di tipo disorga-nizzato. A tal fine, introduce sia le ragioni teoriche che spiegano tali relazioni sia i risultati delle ricerche empiriche sul tema. Relativamente al piano teorico, il con-tributo fornisce una descrizione sia degli stati della mente, che sono espressione di esperienze traumatiche irrisolte sia dei comportamenti genitoriali atipici, e chiari-sce il ruolo eziologico di tali sistemi di caregiving nell’insorgenza dell’attaccamento di tipo disorganizzato. Relativamente al piano empirico, sintetiz-za una serie di studi recenti che validano empiricamente la relazione tra trauma, caregiving anomalo e attaccamento disorganizzato. Parole chiave: trauma; comportamento genitoriale; attaccamento; rassegna. Abstract The current review examines the links between unresolved trauma, anomalous pa-rental behavior, and disorganized attachment relationships. For this purpose, the work introduces the theoretical explanations about these relations and the empirical data on this topic. In relation to the theoretical framework, the review describes the unresolved states of mind, the anomalous parental behaviour and explains the etio-logical role of these caregiving systems in the development of disorganized at-
∗ Ricercatore confermato in Psicologia dello Sviluppo, C.R.I.d.e.e., Università Cattolica di Milano. Indirizzare le richieste a: [email protected]
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
78
tachment. In relation to the empirical framework, the review summarizes a series of studies that validate the relation among trauma, anomalous parental behaviour, and disorganized attachment. Key words. trauma; caregiving; parental behaviour; attachment; review. Introduzione
Prendendo a riferimento la cornice teorica dell’attaccamento, il presente
lavoro si propone di descrivere l’effetto di alcune esperienze traumatiche infantili non elaborate o risolte, come ad esempio, la perdita di una persona significativa o l’aver subito maltrattamenti fisici, psicologici e abusi sessua-li, sul sistema di caregiving e sul conseguente sviluppo di legami di attac-camento di tipo disorganizzato.
Più specificatamente, verrà sottolineato come l’aver subito esperienze traumatiche irrisolte costituisca una condizione di rischio per l’assunzione di comportamenti di caregiving di tipo Minaccioso, timoroso e dissociato (FR) (Main & Hesse, 1992-2005) o alterato (Bronfman, Parsone, & Lyons-Ruth, 1992-2004) che, a loro volta, favoriscono l’insorgenza di legami di attaccamento di tipo disorganizzato. Verrà infatti evidenziato come la pre-senza nel caregiver di uno stato della mente che costituisce una diretta e-spressione dell’assorbimento della persona nelle memorie doloro-se/traumatiche, si estrinsechi attraverso l’adozione di comportamenti di ca-regiving connotati da emozioni di paura che producono un effetto disorga-nizzante sul bambino.
Il contributo si propone il duplice obiettivo di delineare sia le ragioni te-orico-concettuali che spiegano le connessioni sopra riferite sia i risultati delle ricerche empiriche che confermano l’esistenza di tali relazioni.
1. Esperienze traumatiche e stati della mente di tipo “Irrisolto” e “Ostile/Impotente”
Nell’introdurre il discorso circa il ruolo che le esperienze traumatiche in-
fantili irrisolte esercitano sul conseguente sviluppo di legami di attacca-mento di tipo disorganizzato, appare doveroso introdurre, seppure sinteti-camente, la questione relativa al “perché” alcune esperienze infantili di perdita e trauma si risolvano a differenza di altre. Proponendo una prospet-tiva di diatesi (vulnerabilità) relazionale, Lyons-Ruth, Bronfman e Atwood (2007), sostengono che la capacità di risolvere una esperienza traumatica o
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
79
di perdita dipenda da almeno due fattori: a) le caratteristiche dell’evento traumatico in se stesso, la fase evolutiva che caratterizza il soggetto colpito dall’evento, e il grado di coinvolgimento delle figure centrali di attacca-mento; b) la qualità nella comunicazione, nella cura e nella protezione mes-se in atto dalle figure di accudimento in relazione all’evento che provoca paura. In altre parole, secondo gli autori, ad eccezione di esperienze trau-matiche avvenute in circostanze particolarmente terribili o insolite, ci si do-vrebbe attendere che la mancata risoluzione derivi da relazioni affettive di attaccamento meno adeguate e, soprattutto, di tipo disorganizzato. Bowlby (1982) aveva infatti sottolineato quanto fosse probabile che gli adulti che reagiscono al lutto in modo patologico fossero stati coinvolti, prima di quell’evento, in relazioni affettive caratterizzate da conflittualità, ambiva-lenza, distanza emotiva o dalla messa in atto di cure compulsive.
È comunque fortemente assodato che i soggetti adulti che hanno subito esperienze traumatiche non elaborate o risolte, presentino un particolare stato della mente, efficacemente individuabile attraverso l’utilizzo della no-ta intervista Adult Attachment Interview (AAI, George, Kaplan, & Main, 1984, 1985, 1996; Main & Goldwyn, 1984-1998).
L’intervista, che esplora le descrizioni e le valutazioni che i soggetti a-dulti forniscono circa le relazioni con le proprie figure primarie di accudi-mento, permette una classificazione dei soggetti in 4 categorie, Sicuro-Autonomo, Insicuro–Distanziante, Insicuro-Preoccupato e Irrisolto (rispet-to ad un trauma), strettamente corrispondenti alle tipologie di attaccamento individuate attraverso la Strange Situation (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; Main & Solomon 1986). È bene sottolineare che le narrazioni dei soggetti che ottengono una classificazione di tipo Irrisolto risultano ca-ratterizzate da disorganizzazione del pensiero cosciente e da assenza di me-tacognizione che si estrinsecano attraverso una serie di lapsus nel monito-raggio del ragionamento e del discorso (vedi tabella 1, Hesse & Main, 2006, pag. 315).
Hesse e Main (2006) ipotizzano che tali lapsus, che emergono specifica-tamente durante il resoconto di esperienze traumatiche e non in altre parti dell’intervista, altro non siano che l’espressione di uno stato della mente di tipo dissociato, all’interno del quale i contenuti mentali contraddittori ven-gono conservati in strutture parallele scarsamente integrate tra loro. A conferma di tale ipotesi, essi rilevano una serie di associazioni tra le carat-teristiche di uno stato della mente di tipo dissociato ed i criteri individuati ed utilizzati per identificare tali lapsus.
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
80
Tabella 1 – Lapsus nel monitoraggio del ragionamento e del discorso Esempi di lapsus nel monitoraggio del ragionamento comprendono:
1. Frasi che attestano che una persona deceduta è, al tempo stesso, viva e non in senso metaforico o religioso bensì in senso fisico (“Sto molto meglio da quando mia madre è deceduta… e allora che con-tinui a rimanere morta, in modo tale che io possa pensare alla mia famiglia”; oppure, “Mia mamma (che è deceduta) desidera che io studi legge”). 2. Collocazione temporale di uno stesso decesso in periodi distinti e lontani tra loro (ad esempio, in momenti diversi dell’intervista, una stessa morte viene collocata a 9, 11 e 15 anni). 3. Indicazioni che attestano che la persona intervistata si considera responsabile e in colpa per la mor-te di una persona, anche se non esistono motivazioni plausibili in proposito (ad esempio, il soggetto ritiene che la morte sia avvenuta perché si è pensato qualcosa di negativo poco prima del decesso). 4. Affermazioni che attestano di non essere stati presenti durante la morte seguite da considerazioni opposte (ad esempio, rammaricarsi per essere rimasto a casa mentre altri membri della famiglia erano presenti ad un annegamento, e poco dopo dichiarare di essere stato presente e di non essere riuscito a nuotare in tempo per salvare la persona). Esempi di lapsus nel monitoraggio del discorso comprendono:
1. Utilizzo improvviso di modalità narrative di tipo elogiativo/funerario (ad esempio, “Era giovane e bella e ci è stata strappata dalla peggiore delle malattie: la tubercolosi”). 2. Nel bel mezzo di una frase, il soggetto si interrompe, rimanendo in silenzio per 2 minuti, e successi-vamente continua il discorso con un argomento non correlato al precedente. 3. Può venire fornita una attenzione estrema ai dettagli inerenti un decesso o un’altra esperienza po-tenzialmente traumatica che risultano inappropriati rispetto al contesto dell’intervista (ad esempio, il soggetto può intraprendere una discussione di 10 minuti sui dettagli di un decesso, raccontando le condizioni atmosferiche della giornata, il mobilio della stanza, il tipo di vettura utilizzata per il funerale, l’abbigliamento di ciascun membro della famiglia).
Più in particolare, viene specificato che:
• così come lo stato della mente di tipo dissociato costituisce l’esito di esperienze traumatiche/spaventanti, in modo analogo, le anomalie ri-scontrate nel monitoraggio del ragionamento e del discorso appaiono specificatamente solo durante il racconto di eventi traumatici o spaven-tanti;
• così come lo stato della mente di tipo dissociato viene individuato at-traverso l’identificazione di una serie di alterazioni nello stato di co-scienza e del comportamento, in modo analogo, l’individuazione dello stato della mente di tipo Irrisolto avviene attraverso l’identificazione dei lapsus nel monitoraggio del ragionamento e del discorso che costi-tuiscono specifiche “alterazioni” dello stato di coscienza;
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
81
• i criteri di identificazione dei lapsus nel monitoraggio del ragionamento e del discorso sono inoltre analoghi a quelli utilizzati per individuare: a) gli sforzi messi in atto dai soggetti al fine di allontanare/dissociare i ri-cordi dalla consapevolezza (ad esempio, l’intervistato afferma che i ri-cordi di una persona morta sono stati riposti in un luogo speciale della loro mente); b) la continua interferenza da parte di ricordi parzialmente dissociati (ad esempio, la sequenza logica o la struttura grammaticale del racconto viene distorta o interrotta da immagini o ricordi sensoria-li/visivi caratteristici di stati ipnotici e/o di flashback, associati a distur-bi post-traumatici o dissociativi); c) l’esistenza di sistemi di memoria coesistenti e incompatibili (i lapsus che fanno riferimento alla possibili-tà che una persona deceduta sia al tempo stesso viva e vegeta, implica l’esistenza di due distinti sistemi di memoria: nel primo, la persona vie-ne ritenuta oggettivamente assente, mentre nel secondo permangono una serie di strategie cognitive ed emotive volte a ricercare quella per-sona, come se fosse ancora possibile raggiungerla).
È bene rilevare che, secondo Hesse e Main (2006), non tutti i lapsus del ragionamento e del discorso sono indicativi di una forma estrema di disso-ciazione. In particolare, l’utilizzo di modalità narrative di tipo elogiati-vo/funerario o l’attenzione inusuale sui dettagli suggeriscono la presenza di uno stato di assorbimento, indicativo di una diminuita consapevolezza del contesto, che costituisce una forma di dissociazione più normativa (Spie-gel, 1990)
Nel tentativo di meglio delineare le modalità attraverso le quali uno stato della mente dissociato può evidenziarsi durante la AAI, Lyons-Ruth, Yel-lin, Melnick e Atwood (2005) hanno introdotto il concetto di stato della mente di tipo Ostile-Impotente (Hostile-Helpless: H/H) che implica la pre-senza o, ancor meglio, l’alternanza di strategie ostili e/o di oblatività e im-potenza nei confronti del mantenimento della relazione con il caregiver. A differenza di quanto accade per la rilevazione dello stato della mente di tipo Irrisolto, gli stati H/H sono ravvisabili durante il corso dell’intera intervista e, specificatamente, nella sua parte introduttiva quando viene chiesto al soggetto di fornire 5 aggettivi al fine di meglio comprendere la relazione avuta col caregiver.
Gli stati della mente di tipo Ostile implicano che almeno una figura di at-taccamento venga descritta in termini critici e negativi e che il soggetto ri-sulti essersi identificato con tale figura. Le svalutazioni e le critiche nei confronti del caregiver assumono caratteristiche estreme (ad esempio: “Era il mio nemico, era una strega”) anziché una forma puramente distanziante.
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
82
Le esperienze dolorose o traumatiche vengono descritte in modo esplicito e si ravvisa la tendenza del soggetto a escludere o limitare i sentimenti di vulnerabilità ad esse connessi, in particolare, attraverso l’utilizzo di “humor nero”.
Lo stato della mente di tipo Impotente risulta invece caratterizzato da sentimenti pervasivi di timore e impotenza. I soggetti con tale stato mentale sembrano essersi identificati con una figura di attaccamento vittimizzata, sono maggiormente capaci nel riconoscere i sentimenti di vulnerabilità e presentano valutazioni autocritiche che si estrinsecano attraverso sentimenti di colpa, responsabilità e disistima. Essi mantengono preservata una buona immagine del caregiver nei confronti del quale si evidenzia una sorta di inversione di ruolo.
Il senso di vulnerabilità e di impotenza vissuto dal soggetto può venire in-terpretato facendo riferimento sia alla mancata risposta ottenuta nei confronti dei suoi bisogni di attaccamento sia in funzione della incapacità evidenziata da tale soggetto durante i tentativi di alleviare la vulnerabilità del genitore. In sintesi, il racconto dei soggetti H/H è caratterizzato da una generale svaluta-zione delle figure di attaccamento, da una identificazione con tali figure sva-lutate, da un senso del sé come cattivo, da sentimenti di vulnerabilità/timore, da incongruità durante la descrizione di esperienze dolorose e da valutazioni contraddittorie e non integrate del caregiver prevalente. 2. Caregiving atipico e attaccamento disorganizzato: il contributo di
Main e Hesse e di Lyons Ruth e colleghi Main e Hesse (1990) sostengono che i soggetti, i cui stati mentali risulta-
no immersi in memorie dolorose irrisolte, come ad esempio, in memorie di lutti, di incidenti, di malattie, di maltrattamenti e violenze, vivono una per-vasiva condizione di paura che favorisce l’assunzione di comportamenti di caregiving di tipo Minaccioso/timoroso dissociato (FR).
Tali condotte altro non sono che una sorta di espressione fenomenologi-ca osservabile di uno stato della mente dissociato o assorbito nei confronti del quale il soggetto risulta incapace di esercitare un controllo o semplice-mente di porvi un rimedio. È infatti probabile che molti bambini vivano momenti di paura nella relazione coi genitori senza che tali situazioni pro-ducano effetti deleteri. Pensiamo ad esempio ad un genitore che inciampa mentre cammina e cade a terra col figlio di 9 mesi che teneva in braccio. Se il genitore non si lascia disorganizzare dalla paura e dalla sofferenza del bambino, continuerà a rappresentare per esso una fonte di sostegno e con-
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
83
forto, sia aiutandolo a superare la tensione e il dolore sia agendo per evitare il ripetersi di simili eventi in futuro. Se invece il genitore, in passato, non ha sperimentato conforto e sollievo in rapporto ad esperienze traumatiche o di perdita, il dolore e il distress del figlio evocheranno nella sua mente stati affettivi irrisolti di paura o la sensazione di non sapere come trovare con-forto o soluzione.
È inoltre facilmente intuibile come un caregiver, che induce ripetutamen-te sentimenti di paura nel figlio a causa del suo stesso comportamento, dif-ficilmente sarà in grado di riconoscere con prontezza le richieste di attac-camento conseguenti ai sentimenti di paura e, ancor meno, saprà risponder-vi (Hesse & Main, 2006; Lyons-Ruth, Bronfman, & Atwood, 2007).
Le condotte di caregiving che assumono una connotazione di tipo Mi-naccioso-timoroso (FR), che non possono essere riparate o risolte, sono sta-te individuate attraverso la messa a punto di un sistema di codifica (Main & Hesse, 1992-2005), che identifica una serie di comportamenti di caregiving quasi impercettibili e di durata molto breve (10-30 sec.), riconducibili a 6 tipologie di comportamento, a loro vota, ascrivibili a due macro-categorie.
La prima macro categoria (vedi tabella 2) comprende tre tipologie di comportamento definite primarie poiché ritenute in grado di provocare di-rettamente uno stato di allarme nel bambino. Si tratta di azioni che sono espressione di uno stato della mente di tipo dissociato; comportamenti a-nomali che spaventano il bambino e condotte indicative di una condizione di paura nel genitore.
La seconda macro categoria (vedi tabella 2) comprende tre tipologie di comportamento definite secondarie poiché, diversamente dalle precedenti, non determinano direttamente nel bambino una condizione di paura. Si trat-ta, nello specifico, di comportamenti denotati da timidezza, deferenza e in-versione di ruolo; condotte di tipo sessualizzato e di comportamenti disor-ganizzati, disorientati simili a quelli riscontrati nei bambini disorganizzati durante la Strange Situation (Main & Solomon, 1986, 1990).
È bene specificare come, secondo gli autori, tale comportamento di care-giving non possa venire considerato una semplice forma di insensibilità materna e questo perché tale comportamento si manifesta in un modo del tutto improvviso e privo di alcun ancoraggio contestuale (Hesse & Main, 2006). Gli autori specificano infatti che, all’interno di una relazione di ca-regiving sensibile e responsiva, alcune madri, per un periodo temporale li-mitato (a volte di pochi secondi) ed in modo del tutto improvviso, possono mettere in atto una serie di condotte minacciose/timorose (come ad esem-pio, entrare in uno stato di trance o manifestare dei comportamenti anoma-
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
84
li) che possono essere considerate insensibili nel momento in cui si confi-gurano come comportamenti intrusivi o come mancate risposte ai segnali del figlio. Tabella 2 - Sintesi delle 6 tipologie di comportamento del Sistema di Codifica “Comportamento
Minaccioso/timoroso o dissociato” (FR) (Hesse & Main, 2006, pag.320) Tipologie “primarie” di comportamento minaccioso/timoroso o dissociato.
1. Indici diretti di uno stato di tipo dissociativo. Ad esempio, stati di trance, espressioni facciali/vocali alterate, comportamenti di freezing o di conge-lamento. Alcuni genitori mantengono, in modo prolungato, posture particolarmente scomode, manten-gono gli occhi semichiusi o completamente spalancati per molto tempo. Ancora, alcune madri utilizzi-no una voce artefatta simile a quella utilizzata nei film “horror” e, in alcuni casi, tale voce assume una tonalità di tipo “sussurrato”, mentre in altri una tonalità di tipo “maschile”.
2. Indici diretti di un comportamento spaventante la cui origine risulta inspiegabile e/o che assume una forma anomala. Vengono adottati comportamenti e posture insolite, di breve durata, che prevedono, ad esempio, in-trusioni improvvise ed imprevedibili nello spazio personale del bambino. È stato, infatti, osservato il comportamento anomalo di alcuni genitori che, trovandosi alle spalle del proprio figlio, hanno teso le mani sul volto o sulla gola del bambino, in modo del tutto improvviso e silenzioso. O ancora, altri geni-tori si sono messi a carponi e, senza fornire alcun meta-segnale di gioco, hanno seguito in modo im-provviso il proprio figlio, simulando un comportamento minaccioso di tipo predatorio.
3. Indici diretti di un comportamento spaventato la cui origine risulta inspiegabile e/o che assume una forma anomala. Tali comportamenti comprendono una serie di reazioni di paura nel genitore, che sebbene abbiano origine da esperienze traumatiche pregresse, si evidenziano in conseguenza a specifici comporta-menti di tipo “neutro” messi in atto dal bambino. Ad esempio, una mamma, alla vista di una macchini-na giocattolo nelle mani del proprio figlio, esclama piangendo, “Nooo! Avremo un incidente e morire-mo tutti!” (Hesse & Main, 2006, pag. 322). Ulteriori forme di comportamento spaventato comprendono, inoltre, le situazioni in cui il genitore percepisce il bambino come pericoloso o spaventoso. Tipologie “secondarie” di comportamento minaccioso/timoroso o dissociato.
1. Comportamenti denotati da timidezza, deferenza e inversione di ruolo nei confronti del bambino. Tali comportamenti comprendono atteggiamenti denotati da timidezza e sottomissione nei confronti dei comportamenti aggressivi e oppositivi del figlio. In altri casi, invece, i genitori ritengono che il pro-prio figlio sia più forte e più capace di loro, così da ricercare il suo conforto in condizioni di disagio o di difficoltà. 2. Comportamenti di tipo sessualizzato. Tali comportamenti comprendono baci e carezze intime nei confronti del figlio che vengono interpretati come l’espressione di un comportamento di tipo dissociato.
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
85
3. Comportamenti disorganizzati, disorientati compatibili con quelli riscontrati nei bambini durante la Strange Situation (Main & Solomon, 1990). Sono stati osservati nei genitori una serie di posture o comportamenti bizzarri e anomali come ad e-sempio, lo sguardo di una madre che diviene improvvisamente cieco, l’adozione di movimenti asim-metrici, bizzarri, quasi robotici che risultano indicativi di lapsus nella memoria di tipo procedurale.
Note per la codifica: Vengono conteggiate tutte le azione di tipo FR e viene assegnato un punteggio complessivo ad ogni tipologia di comportamento. Viene poi attribuito un punteggio complessivo su una scala a 9 punti (1= assenza di comportamento FR; 3=FR lieve; 5 = FR moderata; 7 FR= intensa e 9 =FR estrema) che si basa sia sulla frequenza, sia sull’intensità e la tipologia dei pattern di comportamento osservati. I sog-getti che ottengono un punteggio superiore a 5 vengono categorizzati come soggetti aventi un sistema di caregiving di tipo FR.
Main e Hesse (1990; Hesse & Main, 2000) sostengono che tale compor-tamento minaccioso/timoroso del genitore, allo stesso modo di una azione maltrattante o violenta, produce paura nel bambino, favorendo l’insorgenza di un attaccamento di tipo disorganizzato.
Questo perché la condizione di paura vissuta dal genitore, che mette in atto un’azione minacciosa/timorosa, viene colta dal bambino che, come è noto, è in grado, fin dalle fasi più precoci dello sviluppo, di leggere le emo-zioni sul volto del genitore e di reagirvi di conseguenza.
Il bambino viene dunque a ritrovarsi in una situazione paradossale irrisol-vibile dal momento che il caregiver diviene, al tempo stesso, fonte di rassicu-razione e di paura. Possiamo immaginare che si realizzi una spirale di paura che prevede un avvicinamento-allontanamento tra bambino e caregiver senza soluzione. Infatti, quando il bambino impaurito avvicinando il caregiver vie-ne spaventato da questi, reagisce a tale paura allontanandosi; tale allontana-mento, tuttavia, diventa causa di ulteriore paura e, il sistema di attaccamento che diviene in tal modo sovrastimolato, guida ulteriormente il bambino a ri-cercare la vicinanza del caregiver; tale avvicinamento, tuttavia, lo espone di nuovo a paura con la conseguente tendenza a fuggire da esso.
Gli effetti disorganizzanti di tale spirale sull’attaccamento diventano e-videnti.
I bambini disorganizzati infatti presentano un crollo di strategie organizzate per affronta-re lo stress, una rottura delle modalità organizzate di regolazione delle emozioni, una assen-za di coordinazione tra il comportamento esplorativo e quello di attaccamento e una attiva-zione contemporanea del sistema di attaccamento e del sistema di difesa, così che la tenden-za ad avvicinarsi alla madre e quella ad allontanarsi dal pericolo si inibiscono l’un l’altra (Attili, 2007, pag.78).
Alla Strange Situation, questi bambini evidenziano una serie di pattern comportamentali contraddittori (ad esempio, avvicinamento-evitamento del
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
86
caregiver), movimenti ed espressioni indirette, dirette erroneamente, incom-pleti e interrotti (ad esempio, pianto esagerato nei confronti dell’estraneo, sa-lutare l’estraneo al ritorno del genitore, protestare per l’uscita del genitore e sorridere alla chiusura della porta), stereotipie, movimenti asimmetrici, mo-vimenti mancati e posture anomale (ad esempio, dondolarsi, sbattere la testa contro il muro, tirarsi gli orecchi, i capelli), movimenti ed espressioni rallen-tate e diretti indicatori di paura verso il genitore (Main & Solomon, 1986, 1990). Benché i bambini disorganizzati dimostrino di non disporre, durante l’infanzia, di strategie organizzate per soddisfare i propri bisogni di attacca-mento, sappiamo dalla letteratura come essi sviluppino in età prescolare stra-tegie coerenti di interazione con i caregiver (Jacobivz & Hazen, 2007). Que-sti bambini agiscono in modo controllato nei confronti della figura di accu-dimento utilizzando strategie punitive o premurose. Il bambino che adotta una strategia di controllo di tipo punitivo si comporta in modo prepotente nei confronti del caregiver, perlopiù rifiutandolo o umiliandolo. Viceversa, i bambini che adottano una strategia di controllo di tipo premuroso si compor-tano in modo estremamente intelligente, vivace e sollecito nel tentativo di ri-spondere ai bisogni del genitore con la premurosità e il sorriso (Main & Cas-sidy, 1988; Wartner, Grossman, Fremmer-Bombik, & Suess, 1994).
Le concettualizzazioni, proposte da Main e Hesse (1990; Hesse & Main, 2000) sul comportamento di caregiving di tipo FR, sono state riprese e am-pliate dagli studi di Lyons-Ruth, Bronfman e Parsons (1999) che sottoline-ano come i genitori caratterizzati da esperienze traumatiche irrisolte, oltre a mettere in atto specifiche condotte di tipo minaccioso/timoroso/dissociato, risultano sostanzialmente incapaci di accogliere, monitorare e contenere l’esperienza emotiva del proprio figlio. Secondo gli autori, i pensieri e le emozioni che invadono la mente del genitore caratterizzato da traumi irri-solti determinano uno stato mentale ed emotivo di allarme che gli impedi-scono di porsi come base sicura per il figlio. Infatti,
…se il genitore è costretto a limitare l’attenzione cosciente nei confronti degli indicatori di paura del bambino per evitare di risvegliare dentro di sé antiche esperienze analoghe irrisol-te, anche la sua capacità di rispondere in modo fluido alle richieste di attaccamento del figlio si riduce (Lyons-Ruth et al., 2007, pag. 63).
Sulla base di tali considerazioni, è stato messo a punto uno specifico strumento di codifica, chiamato the Atypical Maternal Behaviour Instru-ment for Assessment and Classification (AMBIANCE) (Bronfman, Parso-ne, & Lyons-Ruth, 1992-2004), che amplifica quello proposto da Main e Hesse (1992), nel senso che include alcuni comportamenti in esso previsti e ne aggiunge di nuovi.
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
87
Tale sistema, infatti, accanto ad una serie di comportamenti di tipo mi-naccioso/timoroso/dissociato, prevede una serie di azioni genitoriali che ri-flettono sia la tendenza a manifestare forme estreme di comportamento in-sensibile sia l’incapacità di riparare alcuni specifici errori comunicativi.
L’AMBIANCE (vedi tabella 3) prevede, pertanto, 5 tipologie di compor-tamento così denominate: errori nella comunicazione affettiva, comporta-menti disorganizzati/disorientati, comportamenti negativi-intrusivi; com-portamenti che denotano confusione di ruolo e comportamenti di ritiro).
Secondo Lyons-Ruth e collegli (Lyons-Ruth & Block, 1996; Lyons-Ruth, Bronfman, & Parsons, 1999; Lyons-Ruth & Spielman, 2004), tali comportamenti atipici favoriscono l’insorgenza di legami di attaccamento di tipo disorganizzato attraverso una serie di processi in parte diversi da quelli proposti da Main e Hesse (2000).
Un primo processo fa riferimento all’impossibilità da parte del caregiver, con traumi irrisolti, di riparare (failure of repair) alcuni errori nella comu-nicazione affettiva che si verifica nell’interazione coi figli. Più precisamen-te, si ritiene che, la sostanziale incapacità del caregiver di contenere e rego-lare le emozioni di paura e distress nel figlio, determini un effetto disorga-nizzante in un modo ancora più evidente della mera messa in atto di azioni di tipo spaventato/spaventante. Gli autori, infatti, sostengono che i compor-tamenti di ritiro, di inversione di ruolo, di ostilità e intrusività, evidenziati dal caregiver, quando il figlio si trova in una condizione di distress, dal momento che privano il bambino di una adeguata regolazione emotiva, fa-voriscono l’insorgenza di una condizione di paura sempre maggiore e di-sorganizzante. Infatti, poiché il senso di sicurezza e di protezione esperito dal bambino risulta strettamente associato alla adeguatezza della comunica-zione affettiva caregiver-bambino, una sostanziale e pervasiva incapacità da parte della madre di rispondere alle richieste del piccolo assume la conno-tazione di un comportamento spaventante poiché priva il bambino dell’esperienza di sentirsi adeguatamente protetto.
Un secondo processo fa riferimento alla messa in campo di strategie de-finite “competitive” (“competing”) che producono un effetto disorganizzan-te dal momento che privano il bambino di una risposta coerente ed adegua-ta ai propri bisogni. Tali strategie vengono messe in atto da quei genitori che, caratterizzati da uno stato cronico di paura rispetto ai propri bisogni di attaccamento, tendono sia a rifiutare sia a sollecitare le risposte di attacca-mento nel bambino, ignorando il figlio quando questi si trova in condizioni di distress e sollecitando il suo affetto in altre occasioni.
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
88
Tabella 3- Dimensioni dell’alterazione della comunicazione affettiva materna “AMBIANCE” (Lyons-Ruth, Bronfman, & Parsons, 1999, pag. 75)
Le 5 tipologie di comportamento individuate nell’AMBIANCE sono:
1. Errori nella comunicazione affettiva: a) Segnali contraddittori rivolti al bambino (ad esempio, inviti verbali di avvicinamento seguiti da azioni di distanziamento). b) Risposte non responsive, inappropriate o dissonanti nei confronti dei segnali del bambino (ad esempio, non vi sono tentativi di confortare il bambino quando si trova in una condizione di di-stress; la madre sorride quando il bambino sta piangendo o è in una condizione di distress).
2. Disorientamento (include item tratti da Main & Hesse, 1992): a) Il genitore è confuso o spaventato dal bambino (mostra un volto spaventato, voce tesa, tre-mula o alta). b) Disorganizzato o disorientato (improvvisa interruzione o mancanza di emozione connessa alle circostanze, stati di trance).
3. Comportamento negativo-intrusivo (include item tratti da Main & Hesse, 1992): a) Comportamento negativo-intrusivo di tipo verbale (deridere o tormentare il bambino). b) Comportamento negativo-intrusivo di tipo fisico (afferrare i bambini per i polsi; digrignare i denti; postura aggressiva; mettersi viso a viso contro il volto del bambino).
4. Confusione di ruolo (include item tratti da Main & Hesse, 1992): a) Inversione di ruolo (ad esempio cerca rassicurazione, aiuto, conforto nel bambino). b) Sessualizzazione (parlare in modo intimo e segreto al bambino). c) Affermazioni autoreferenziali (“Hai sentito la mia mancanza?” oppure “il piccolo non mi vuole vedere”).
5. Ritiro: a) Creazione di distanza fisica (allontanare fisicamente il bambino dal proprio corpo). b) Creazione di distanza verbale (non salutare il bambino dopo una separazione).
Note per la codifica Oltre a tali 5 categorie di comportamento, l’AMBIANCE prevede due scale riassuntive. La pri-ma, a 7 livelli, descrive il livello complessivo di comunicazione interrotta (1. equivale a un com-portamento normale; 3. normale- basso; 5. chiara evidenza di interruzioni nella comunicazione affettiva; 7. comunicazione interrotta). La seconda scala, di tipo categoriale, prevede una classi-ficazione delle madri la cui comunicazione è “alterata”.
Secondo Lyons-Ruth e colleghi (Lyons-Ruth & Spielman, 2004; Lyons-
Ruth et al. 2007) esiste una sostanziale differenza nel comportamento delle madri dei bambini disorganizzati che ottengono una seconda classificazione di tipo sicuro (D/sicuri) rispetto al comportamento delle madri dei bambini disorganizzati che ottengono una seconda classificazione di tipo insicuro (D/insicuri).
È bene specificare che, alla Strange Situation, i bambini D/sicuri sem-brano conservare l’ossatura di una strategia sicura di attaccamento dal mo-
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
89
mento che reagiscono con pianti e proteste all’allontanamento della madre ed escono da tale situazione di disagio al suo ritorno. Tali bambini mostra-no scarsi comportamenti di tipo evitante o di rabbia nei confronti della ma-dre ed esprimono comportamenti problematici quali: vagare senza scopo nelle vicinanze della madre, raggomitolarsi a terra, lanciare sguardi spaven-tati alla madre o assumere una postura depressa quando la madre è vicina. Diversamente, i bambini D/insicuri combinano sequenze comportamentali confuse e contraddittorie verso la madre, un più marcato evitamento del contatto e/o condotte rabbiose e resistenti. Questi bambini mostrano un for-te disagio in assenza della madre per poi manifestare un deciso evitamento al suo ritorno. Il comportamento evitante di questi bambini si mescola spes-so a una resistenza al contatto o a comportamenti passivi o conflittuali in presenza della madre.
Ma quali sono allora i comportamenti di caregiving messi in atto dalle madri di questi bambini?
Gli autori (Lyons-Ruth et al. 1999; Lyons-Ruth & Spielman, 2004; Lyons-Ruth et al., 2007) specificano che mentre le madri dei bambini D/sicuri esibiscono in modo consistente comportamenti di ritiro, inibizione e paura che le portano ad essere definite “Impotenti-timorose”, quelle dei bambini D/insicuri (ansioso ambivalenti-evitanti) esibiscono comportamen-ti di tipo negativo-intrusivo e/o di confusione di ruolo e, per tale ragione, vengono definite “Ostili”. In altri termini, le madri dei D/sicuri possono e-sprimere un comportamento di tipo responsivo che si associa ad uno stato sottostante di paura, tensione ed ansia, o ancora, possono cercare di risolve-re lo stato di tensione allontanandosi dal bambino e cercando di interagire con lui solo quando direttamente sollecitate dal bambino stesso (Lyons-Ruth et al. 1999). Al momento della riunione, infatti, la maggior parte delle madri di bambini D/sicuri manifesta tensione quando il bambino esprime con chiarezza di desiderare un contatto più intenso e una riluttanza ad ac-contentarlo. Tale riluttanza assume la forma di esitazione o di sottile allon-tanamento fisico piuttosto che di un più attivo e negativo rifiuto della co-municazione del figlio. Le madri dei bambini D/insicuri, invece, oltre a al-ternare momenti in cui risultano fortemente critiche, intrusive e ostili nei confronti dei figli a momenti in cui sollecitano una inversione di ruoli, ri-sultano, alla riunione, disorientate o fortemente incapaci di qualsiasi apertu-ra nei confronti dei segnali di ricerca della prossimità inviati dal figlio (Lyons-Ruth & Spielman, 2004; Lyons-Ruth et al. 2007).
È interessante specificare come, alla base di tali differenti condotte di ca-regiving, siano state individuate (Lyons Ruth & Block, 1996; Lyons-Ruth
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
90
et al., 1999; Lyons-Ruth & Spielman, 2004) esperienze traumatiche infanti-li di tipo diverso.
Più precisamente, è stato riscontrato come l’aver subito maltrattamenti di tipo fisico aumenti la probabilità che le madri adottino uno stile interatti-vo di tipo ostile e intrusivo nei confronti del bambino, mentre le esperienze di abuso sessuale e di lutto sembrano determinare atteggiamenti di ritiro fisico ed emotivo.
Secondo gli autori, le madri definite Ostili sono impegnate nel tentativo di gestire i propri sentimenti indesiderabili di vulnerabilità, attraverso sia la negazione dei propri sentimenti di paura/impotenza sia l’identificazione col genitore aggressore/ostile e controllante. La negazione dei propri vissuti di vulnerabilità può, inoltre, accompagnarsi ad un consistente tentativo di con-trollare gli altri, attraverso l’adozione di condotte di tipo punitivo.
Diversamente, le madri definite “Impotenti-timorose” presentano un fun-zionamento psicologico che le porta a esibire un atteggiamento di cura e di iper-vigilanza nei confronti delle necessità altrui (in primis, quelle del pro-prio genitore), alle spese dei propri bisogni di attaccamento. In realtà, i soggetti appartenenti a questa categoria risultano fortemente timorosi e fa-cilmente sopraffatti dalle richieste emotive di tipo intimo provenienti dagli altri. Il focus attenzionale, costantemente rivolto sugli altri, fa leva, pertan-to, sia su strategie di tipo dissociativo nei confronti della propria vita affet-tiva sia su strategie di ritiro nei confronti dell’esperienza emotiva altrui. L’ansia e la paura relativa ai contatti emotivi di tipo intimo, espressa dal caregiver, può inoltre venire colta dal figlio che, a sua volta, può sviluppare una serie di strategie di tipo punitivo e coercitivo, finalizzate al manteni-mento del legame affettivo col genitore.
Lyons Ruth e Block (1996) evidenziano pertanto come la mancata re-sponsività materna, evidenziata dalle madri traumatizzate, altro non sia che l’espressione dei processi psicologici messi in atto per difendersi dalla pau-ra, dal senso di impotenza e di rabbia associati alle esperienze subite. Appa-re quindi evidente come, per alcune donne traumatizzate, il compito della maternità possa diventare un’impresa quasi impossibile, dal momento che solo un atteggiamento empatico, che implica un accesso flessibile ai propri sentimenti di vulnerabilità e di distress, permetterebbe loro di fornire una risposta adeguata ai loro figli. Nel caso in cui queste donne siano impegnate nello strenuo tentativo di mantenere segregati nella propria mente le memo-rie/vissuti di vulnerabilità associati alla mancata protezione ricevuta dal proprio caregiver, non possono avvicinarsi empaticamente al figlio, se non a prezzo di essere letteralmente “inondate” dalle memorie disintegrate che
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
91
rievocano la loro dolorosa vulnerabilità. Il ritiro emozionale e l’intrusività ostile, possono quindi venire messi in atto come una sorta di “strategia di autoprotezione” che permette loro di ridurre ai minimi termini il contatto emozionale col figlio. 3. Stato della mente irrisolto, comportamento genitoriale “atipico” e attaccamento disorganizzato: una rassegna degli studi empirici
Prendendo a riferimento l’interessante studio di Madigan, Bakermans-
Kranenburg, Van Ijzendoorn, Moran, Pederson e Benoit, (2006) verranno qui di seguito rivisitati una serie di studi che hanno empiricamente sostan-ziato la relazione tra traumi genitoriali irrisolti, comportamento genitoriale “minaccioso/timoroso FR” o “alterato” (“disrupted”) e stili di attaccamento disorganizzato nei bambini.
Si tratta di una serie di lavori che, rivolgendosi a diadi caregiver-bambino a basso rischio o svantaggiate, si propongono di analizzare il comportamento genitoriale “FR” o “alterato”, sia in situazioni naturalisti-che (neutre o stressanti) sia in situazioni di laboratorio (ad esempio durante la Strange Situation).
La presente rassegna prenderà in considerazione, in primo luogo, gli stu-di che hanno utilizzato il sistema di codifica FR di Main e Hesse (1992-2005) e, in secondo luogo, i lavori che hanno utilizzato il sistema di codifi-ca AMBIANCE proposto da Bronfman et al. (1992-2005). 3.1 Gli studi sul comportamento genitoriale di tipo FR
Una prima conferma empirica all’ipotesi di Main e Hesse (1990), circa la
relazione tra traumi irrisolti, comportamento FR e attaccamento disorganiz-zato, viene proposta dallo studio di Schuengel, Bakermans-Kranenburg e van IJzendoorn (1999) condotto su un campione a basso rischio di 85 diadi madre-figlio, appartenenti ad un livello socioeconomico medio-alto.
Alle madri del campione, caratterizzate da esperienze di perdita signifi-cative, è stata somministrata la A.A.I. all’età di 12 mesi dei figli, il compor-tamento di tipo FR è stato osservato, in condizioni naturalistiche, quando i bambini avevano circa 10-11 mesi di vita, mentre gli stili di attaccamento sono stati valutati a 14-15 mesi con la Strange Situation.
I risultati indicano che la presenza di lutti irrisolti predice l’insorgenza di attaccamento disorganizzato solo tra le madri che, oltre ad avere uno stato della mente di tipo Irrisolto (U), ottengono una seconda classificazione di
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
92
tipo non autonomo-sicuro. Tali madri U-insicure (distanzianti o preoccupa-te), rispetto alle madri U-sicure, esibiscono, inoltre, un maggior numero di comportamenti di tipo minaccioso/timoroso. Tali comportamenti FR e, in particolare, quelli di tipo disorientato, risultano, a loro volta, strettamente associati allo stile di attaccamento disorganizzato.
Una ulteriore conferma dell’associazione tra comportamento FR e attac-camento disorganizzato, è stata riscontrata nello studio di True et al. (2001), condotto su 42 diadi madre-bambino di una popolazione del Mali in Africa. Le diadi sono state osservate, sia a domicilio sia in un setting di tipo clinico, quando i bambini avevano circa 10.5-12 mesi di età. I risultati evi-denziano come le madri dei bambini disorganizzati manifestavano un nu-mero significativamente più elevato di comportamenti FR rispetto alle ma-dri dei bambini sicuri.
Lo studio di Jacobvitz, Leon e Hazen (2006) condotto su un campione a basso rischio di 113 diadi madre-bambino, diversamente dagli studi sopra indicati, ha previsto la somministrazione della AAI durante la gravidanza delle madri ed ha osservato, all’età di circa 8 mesi dei bambini, l’interazione delle diadi, solo durante alcune specifiche situazioni ritenute potenzialmente stressanti (il cambio del pannolino, il momento dei pasti, una situazione di gioco).
I dati indicano che le madri classificate come Irrisolte (U) utilizzano fre-quentemente (48%) comportamenti spaventanti, a differenza delle madri non Irrisolte (non U) che utilizzano tali comportamenti in modo meno fre-quente (solo nel 13%). Gli autori evidenziano, inoltre, come le esperienze traumatiche che risultano significativamente connesse ad uno stato della mente di tipo U (non risolto) siano la morte di un genitore o la perdita di una persona significativa, avvenute prima dei 16 anni di vita e l’aver subito maltrattamenti fisici/abusi sessuali di particolare gravità. Tra le madri Irri-solte è, inoltre, emerso il ruolo protettivo della presenza di una seconda classificazione di tipo sicuro; infatti le madri U di tipo autonomo-sicuro, rispetto alle madri U-insicure, manifestano un minor numero comportamen-ti di tipo minaccioso/timoroso.
Nello studio di Abrams, Rifkin e Hesse (2006), condotto su un campione a basso rischio di 75 diadi genitore-figlio (25 padri e 50 madri), il compor-tamento FR è stato osservato durante una sessione di gioco lievemente stressante, durante la quale ai genitori veniva richiesto di proibire ai loro bambini (12-18 mesi) di toccare una serie di oggetti e che prevedeva una successiva interazione caratterizzata dalla presenza di un estraneo vestito da clown. I dati indicano che i genitori “Irrisolti” (U), durante la discussione di
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
93
lutti o di abusi, evidenziano in modo frequente (67%) condotte di tipo FR, rispetto ai genitori non risolti (8%). È inoltre emerso come i genitori dei bambini disorganizzati, rispetto a quelli sicuri o insicuri, evidenziano un numero decisamente superiore di comportamenti FR e, in particolare, di a-zioni di tipo dissociato. Tale tipologia di comportamento viene infatti uti-lizzata dall’87% dei genitori dei bambini disorganizzati. 3.2 Gli studi sul comportamento genitoriale di tipo “alterato”
Lyons-Ruth et al. (1999) hanno applicato il sistema di codifica AM-
BIANCE ad un campione di 65 madri svantaggiate e ai loro bambini di 18 mesi di età. Il comportamento “alterato” è stato codificato attraverso l’analisi delle interazioni madre-bambino avvenute durante la Strange Si-tuation. I dati indicano che le madri dei bambini disorganizzati, a differenza dei bambini sicuri e insicuri, adottano coi loro figli un comportamento di tipo “alterato”, esprimendo in particolare una serie di errori comunicativi di tipo affettivo. Come è stato già illustrato precedentemente, è inoltre emersa una differenza interessante all’interno del gruppo dei bambini disorganizza-ti. Infatti le madri dei bambini disorganizzati-sicuri esibiscono frequente-mente comportamenti di ritiro, a differenza delle madri dei bambini disor-ganizzati-insicuri che evidenziano in maniera consistente comportamenti intrusivi/negativi e di confusione di ruolo.
In uno studio successivo (Lyons-Ruth, Yellin, Melnick, & Atwood, 2005), che ha utilizzato lo stesso campione di madri dello studio sopra de-scritto, gli autori hanno esaminato l’associazione tra il comportamento “al-terato” osservato durante la Strange Situation e lo stato della mente irrisolto valutato quando i bambini avevano 7-8 anni. I dati indicano che lo stato della mente Irrisolto delle madri risulta associato al livello globale di co-municazione interrotta.
Goldberg, Benoit, Blokland e Madigan (2003) hanno tentato di replicare, su un campione di 197 diadi madri-bambino a basso rischio, lo studio di Lyons-Ruth et al. (1999). La A.A.I. è stata somministrata alle madri duran-te l’ultimo trimestre di gravidanza, mentre la Strange Situation è stata rea-lizzata quando i bambini avevano 12 mesi di vita. I dati indicano che il 44% delle madri Irrisolte (U) hanno figli con legami di attaccamento disorganiz-zato mentre l’83% delle madri non Irrisolte sviluppano legami di attacca-mento di tipo organizzato con i loro figli. Le analisi, che esaminano l’associazione tra stato della mente Irrisolto (U) e comportamento materno alterato, indicano che il 52% delle madri Irrisolte utilizzano coi loro figli
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
94
tale modalità comportamentale, a differenza delle madri non Irrisolte che ne fanno uso solo nel 35% dei casi. Inoltre, i dati indicano che il 62% dei bambini disorganizzati hanno madri classificate come aventi una comuni-cazione “alterata”, mentre solo il 32% dei bambini sicuri o insicuri hanno madri che adottano tale modalità comportamentale. Gli autori hanno infine testato il possibile ruolo di mediazione svolto dal comportamento materno ma i dati ottenuti non permettono di sostenere empiricamente tale ipotesi. In altre parole, non è possibile sostenere che il comportamento materno di tipo alterato costituisca la variabile in grado di spiegare l’associazione tra stato della mente Irrisolto e attaccamento disorganizzato. A giustifica di ta-le dato viene indicato il numero estremamente ridotto di madri Irrisolte (N=46) e di bambini disorganizzati (N=45), presenti nel campione a basso rischio analizzato.
Lo studio di Grienenberger, Kelly e Slade (2005), condotto su un cam-pione a basso rischio di 45 diadi madre-bambino di 14 mesi, diversamente dagli studi precedenti che si sono concentrati sullo stato della mente Irrisol-to, esamina l’associazione tra funzione riflessiva materna, comportamento materno alterato e attaccamento disorganizzato nei bambini. Viene infatti specificato come una serie di difficoltà nell’esercizio della “funzione rifles-siva” materna (Fonagy & Target, 1998) -che implica la capacità di distan-ziarsi dalla propria esperienza affettiva per poter cogliere le intenzioni sog-gettive del proprio bambino, in particolare durante i momenti di stress o di conflitto- possano venire colte attraverso il sistema di codifica dell’AMBIANCE. I risultati indicano il comportamento materno di tipo al-terato esercita un ruolo statisticamente significativo nel mediare la relazio-ne tra una carente funzione riflessiva materna e l’attaccamento di tipo di-sorganizzato.
Lo studio di Madigan, Moran e Pederson (2006) si è proposto di investi-gare, in un campione ad alto rischio composto da 82 madri adolescenti e dai loro bambini, se il comportamento materno alterato costituisce la variabile in grado di mediare la relazione esistente tra stato della mente Irrisolto e l’attaccamento disorganizzato. L’interessante novità di questo studio ri-guarda la procedura utilizzata per valutare il comportamento alterato nelle madri. Infatti, diversamente dagli studi precedenti che hanno applicato il sistema di codifica AMBIANCE alle interazioni avvenute durante la Stran-ge Situation, questo studio ha previsto la strutturazione di due distinte ses-sioni di gioco (aventi una durata di soli 3 minuti) con e senza l’utilizzo di materiale ludico.
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
95
I risultati evidenziano che il comportamento materno di tipo alterato svolge un ruolo significativo nel mediare la relazione tra stato della mente irrisolto e attaccamento disorganizzato solo durante la sessione di gioco che non prevede l’utilizzo di giocattoli. Gli autori interpretano tale risultato ipo-tizzando che le sessioni di gioco che non prevedono l’utilizzo di giochi pos-sono risultare maggiormente stressanti per le madri che si ritrovano a gesti-re senza alcun supporto il peso dell’interazione. Di conseguenza, tale speci-fica situazione contestuale può, per alcune madri, aumentare la probabilità che si verifichi un collasso nelle loro già vulnerabili strategie comporta-mentali e attenzionali. A conferma di tale interpretazione i dati ottenuti ri-velano livelli più elevati di comportamento materno alterato durante la ses-sione senza giochi e nelle diadi con bambini aventi legami di attaccamento di tipo disorganizzato.
Infine, l’imponente studio di meta-analisi (comprensivo di 12 studi e di un campione di 851 famiglie) di Madigan, Bakermans-Kranenburg et al. (2006), pur confermando l’esistenza di una relazione tra stato della mente irrisolto, comportamento genitoriale atipico e attaccamento disorganizzato, specifica come la porzione di varianza spiegata da tali variabili genitoriali (.21 e .34) solleciti l’opportunità di considerare anche il ruolo di altri fatto-ri.
Più precisamente, gli autori sollecitano l’opportunità di valutare, nell’eziologia dell’attaccamento disorganizzato, il peso predittivo delle ca-ratteristiche temperamentali del bambino, del conflitto coniugale e della condizione di salute mentale del genitore. 4. Conclusioni
In conclusione, la presente rassegna considera il peso predittivo di alcune
esperienza traumatiche infantili sul sistema di caregiving e sul conseguente sviluppo di legami di attaccamento di tipo disorganizzato.
È stato evidenziato come il principale fattore esplicativo di tali connes-sioni sia ravvisabile nella condizione di paura/terrore vissuta dal genitore che non è in grado di elaborare e risolvere le dolorose esperienze vissute nella relazione con le proprie figure di riferimento.
Infatti, è possibile sostenere come l’assorbimento da parte del caregiver nelle memorie traumatiche irrisolte o ancora, i suoi strenui tentativi per prenderne distanza, determinino una serie di condotte di tipo minaccio-so/tinoroso/dissociato (Main & Hesse, 2000; Hesse & Main, 2006) o for-temente inappropriate alterate (Lyons Ruth et al., 1999) che producono
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
96
l’effetto di spaventare il bambino. E il bambino che, impaurito, è spinto dal proprio sistema di attaccamento a ricercare il caregiver, si trova coinvolto in una spirale di paura che, determinando il crollo delle strategie utilizzate per affrontare una condizione di stress, favorisce l’insorgenza di attacca-mento di tipo disorganizzato. È possibile pertanto concludere, sostenendo come l’emozione di paura che caratterizza sia lo stato mentale del caregiver sia la relazione genitore-figlio costituisca la condizione psicologica in gra-do di spiegare l’esistenza di alte percentuali (15-20%; van IJzendoorn Schuengel & Bakermans-Kranenburg,1999) di bambini disorganizzati ri-scontrabili anche in campioni a basso rischio. Bibliografia Abrams, K., Rifkin, A., & Hesse. (2006). Examining the role of parental fright-ened/frightening subtypes in predicting disorganized attachment within a brief ob-servation procedure. Development and Psychopathology, 18, 345–361.
Ainsworth, M., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Attili G. ( 2007) Attaccamento e costruzione evoluzionistica della mente. Milano: Cortina.
Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment (2nd ed.). New York: Basic Books. (Original work published 1969).
Bronfman, E., Parsons, E., & Lyons-Ruth, K. (1992–2004). Atypical Maternal Be-havior Instrument for Assessment and Classification (AMBIANCE): Manual for coding disrupted affective communication (2nd ed.). Unpublished manual, Harvard University Medical School.
Carlson, E. (1998). A prospective longitudinal study of attachment disorganiza-tion/disorientation. Child Development, 69, 1107–1128.
Carlson, V., Cicchetti, D., Barnett, D., & Braunwald, K. (1989). Disorgan-ized/disoriented attachment relationships in maltreated infants. Developmental Psychology, 25, 525–531.
Fonagy, P., & Target, M. (1998). Mentalization and the changing aims of child psychoanalysis. Psychoanalytic Dialogues, 8, 87–114.
George, C., Kaplan, N., & Main, M. (1984, 1985, 1996) Adult Attachment Inter-view Protocol. Unpublished manuscript 1st–3rd eds. University of California, Berkeley, Department of Psychology.
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
97
Goldberg, S., Benoit, D., Blokland, K., & Madigan, S. (2003). Atypical maternal behavior, maternal representations and infant disorganized attachment. Develop-ment and Psychopathology, 15, 239–257.
Grienenberger, J., Kelly, K., & Slade, A. (2005). Maternal reflective functioning, mother–infant affective communication, and infant attachment: Exploring the link between mental states of observed caregiving behavior in the intergenerational transmission of attachment. Attachment and Human Development, 7, 299–311.
Hesse, E., & Main, M. (2000). Disorganized infant, child, and adult attachment: Collapse in the behavioral and attentional strategies. Journal of the American Psy-choanalytic Association, 48, 1097–1127.
Hesse, E., & Main, M. (2006) Frightened, threatening, and dissociative parental behavior in low-risk samples: Description, discussion, and interpretations. Develo-pment and Psychopathology, 18, 309–343
Jacobvitz, D., & Hazen, N. (2007) Percorsi evolutivi della disorganizzazione infan-tili alle relazioni coi pari nella fanciullezza. In Solomon J. & George C. (a cura di) L’attaccamento disorganizzato. Bologna Il Mulino.
Jacobvitz, D., Leon, K., & Hazen, N. (2006). Does expectant mothers’ unresolved trauma predict frightening maternal behavior? Risk and protective factors. Develo-pment and Psychopathology, 18, 363 – 379.
Lyons-Ruth, K., & Block, D. (1996). The disturbed caregiving system: Relations among childhood trauma, maternal caregiving, and infant affect and attachment. Infant Mental Health Journal, 17, 257–275.
Lyons-Ruth, K., Spielman E. (2004) Disorganized infant attachment strategies and helpless-fearful profiles of parenting: integrating attachment research with clinical intervention. Infant Mental Health Journal, Vol. 25(4), 318–335
Lyons-Ruth, K., Alpern, L., & Repacholi, B. (1993). Disorganized infant attach-ment classification and maternal psychosocial problems as predictors of hostile-aggressive behavior in the preschool classroom. Child Development, 64, 572 – 585.
Lyons-Ruth, K., Bronfman, E., & Parsons, E. (1999). Atypical attachment in in-fancy and early childhood among children at developmental risk. Part IV. Maternal frightened, frightening, or atypical behavior and disorganized infant attachment patterns. In J. Vondra & D. Barnett (Eds.), Atypical patterns of infant attachment: Theory, research, and current directions. Monographs of the Society for Research in Child Development, 64(3), 67 – 96.
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
98
Lyons-Ruth, K., Bronfman, E., & Atwood G. (2007) Gli stati mentali di ostilità e impotenza nell’interazione madre/bambino. In Solomon J. & George C. (a cura di) L’attaccamento disorganizzato. Bologna: Il Mulino.
Lyons-Ruth, K., & Jacobvitz, D. (1999). Attachment disorganization: Unresolved loss, relational violence and lapses in behavioral and attentional strategies. In J. Cassidy & P.R. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment (pp. 520–554). New York: Guilford.
Lyons-Ruth, K., Yellin, C., Melnick, S., & Atwood, G. (2003). Childhood experi-ences of trauma and loss have different relations to maternal unresolved and Hos-tile-Helpless states of mind on the AAI. Attachment and Human Development, 5, 330–352.
Lyons-Ruth, K., Yellin, C., Melnick, S., & Atwood, G. (2005). Expanding the con-cept of unresolved mental states: Hostile/Helpless states of mind on the Adult At-tachment Interview are associated with disrupted mother–infant communication and infant disorganization. Development and Psychopathology, 17, 1–23.
Madigan, S., Bakermans-Kranenburg, M., Van Ijzendoorn, M., Moran, G.; Peder-son, D., & Benoit, D. (2006). Unresolved states of mind, anomalous parental be-havior, and disorganized attachment: A review and meta-analysis of a transmission gap. Attachment & Human Development, 8, 2, 89–111
Madigan, S., Moran, G., & Pederson, D.R. (2006). Unresolved states of mind, dis-organized attachment relationships, and disrupted mother– nfant interactions of adolescent mothers and their infants. Developmental Psychology, 42, 293–304.
Main, M. (2000). The organized categories of infant, child, and adult attachment: Flexible vs. Inflexible attention under attachment-related stress. Journal of the American Psychoanalytic Association, 48, 1055–1096.
Main, M., & Cassidy, J.(1988). Categories of response to reunion with the parent at age 6: Predicted from infant attachment classifications and stable over a 1-month period. Developmental Psychology, 24, 415–426.
Main, M., & Goldwyn, R. (1984–1998). Adult attachment scoring and classifica-tion system. Unpublished scoring manual, Department of Psychology, University of California, Berkeley.
Main, M., Goldwyn, R., & Hesse, E. (2002). Adult attachment scoring and classi-fication system. Unpublished scoring manual, University of California at Berkeley.
Main, M., & Hesse, E. (1990). Parents’ unresolved traumatic experiences are re-lated to infant disorganized attachment status: Is frightened and/or frightening pa-rental behavior the linking mechanism? In M.T. Greenberg, D. Cicchetti, & E.M. Cummings (Eds), Attachment in the preschool years: Theory, research, and inter-vention (pp. 161–182). Chicago: University of Chicago Press.
Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 10, n. 2, luglio 2008
99
Main, M., & Hesse, E. (1992–2005). Frightened, threatening,dissociative, timid-deferential, sexualized, anddisorganized parental behavior: A coding system for-frightened/frightening (FR) parent–infant interactions. Unpublished manuscript, University of California at Berkeley.
Main, M., & Solomon, J. (1986). Discovery of a new, insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. In T.B. Brazelton & M. Yogman (Eds), Affective development in infancy (pp. 95–124). Norwood, NJ: Ablex.
Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorgan-ized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In M.T. Greenberg, D. Cicchetti, & E.M. Cummings (Eds.), Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention (pp. 121 – 160). Chicago: University of Chicago Press.
Schuengel, C., Bakermans-Kranenburg, M.J., & van IJzendoorn, M.H. (1999). Frightening maternal behavior linking unresolved loss and disorganized attach-ment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 54 – 63.
Spiegel, D. (1990). Hypnosis, dissociation and trauma: Hidden and overt observ-ers. In J.L. Singer Ed. Repression and dissociation: Implications for personality theory, psychopathology and health (pp. 121–142) Chicago: University of Chicago Press.
True, M., Pisani, L., & Oumar, F. (2001). Infant–mother attachment among the Dogon of Mali. Child Development, 72, 1451 – 1466.
van IJzendoorn, M.H., Schuengel, C., & Bakermans-Kranenburg, M. (1999). Dis-organized attachment in early childhood: Meta-analysis of precursors, concomi-tants, and sequelae. Development and Psychopathology, 11, 225–250.
Wartner, U., Grossman, K., Fremmer-Bombik, E., & Suess, G. (1994) Attachment patterns at age six in South Germany: predictability from infancy and implications for preschool behaviour. Child Development, 65, 1014-1027