(Re)Reading Time and Free Will: (Re)Discovering Bergson for the Twenty-First Century
"Ungaretti, Bergson e i miraggi della durata ", in "Le patrie della poesia. Ungaretti, Bergson e...
-
Upload
uantwerpen -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of "Ungaretti, Bergson e i miraggi della durata ", in "Le patrie della poesia. Ungaretti, Bergson e...
IVBERGSON E I MIRAGGI DELLA DURATA1
1. «Je suivais des cours…»
1. Come è noto, l’interesse per il lavoro degli intellettualivociani e i rapporti stabiliti con alcuni di loro offrirono aUngaretti una prima occasione di contatto con la filosofiadi Bergson. Gli esponenti della «Voce» (e prima ancora del«Leonardo») nutrirono infatti interesse per il bergsonismoe pubblicarono numerosi studi ad esso dedicati.2 Unga-
71
1 Questo saggio ne unifica due, di diverso contenuto: Ancora su Bergsonnel primo Ungaretti, in «Studi Italiani», 15 (1996), pp. 19-49; Ungaretti eBergson. La continuità di un rapporto, in «La Rassegna della Letteratura Ita-liana», CIII (1999), 2, pp. 429-448.
2 Il primo a interessarsi di Bergson fu probabilmente Prezzolini, che nel1902 frequentò i corsi del filosofo al Collège de France. L’influenza di Berg-son si avverte in scritti giovanili quali Vita trionfante, in «Il Leonardo», 4gennaio, 1903 e Il linguaggio come causa di errore. Henri Bergson, Firenze,Spinelli, 1904, che propone in chiusura un breve saggio sul filosofo france-se. Prezzolini ha ancora dedicato a Bergson numerosi scritti, tra cui La filo-sofia di Enrico Bergson, in La teoria sindacalista, Napoli, Perella, 1909, e IlBergson, in «La Voce», 6 gennaio 1910. Ha inoltre dichiarato il proprio debi-to nei confronti del filosofo in un articolo dal titolo Io devo...., in «La Voce»,15 febbraio 1912. Di Bergson scrissero anche Alessandro Casati (Bergson eil simbolismo, in «La Voce», 26 gennaio 1911), e Giovanni Boine (La novitàdi Bergson, in «La Nuova Antologia», 16 settembre 1914). Questi alcuni degliscritti di Giovanni Papini: Enrico Bergson. Il filosofo dell’intuizione, in 24Cervelli, Ancona, Puccini, 1913; Deux philosophes (Bergson et Croce), in «LesSoirées de Paris», mars 1914, poi Bergson et Croce in Stroncature, Firenze,Libreria della Voce, 1916; Mes rencontres avec Bergson, in «Les NouvellesLittéraires», 15 décembre 1928; Henri Bergson, in Passato remoto, Firenze,L’Arco, 1948 (i primi tre saggi sono ora in G. Papini, Filosofia e letteratura,
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 71
retti potrebbe essere stato a conoscenza di questi scritti, inparticolare di quelli usciti sulla rivista di Prezzolini, allaquale fu abbonato fin da quando viveva ad Alessandria.3
Le possibilità di approccio alla filosofia di Bergson furo-no tuttavia più consistenti durante la prima permanenza aParigi, dall’autunno del ’12 alla primavera del ’14. Neglistessi anni la notorietà del filosofo aveva raggiunto il cul-mine: le sue lezioni al Collège de France erano seguite daun pubblico numeroso, le riviste dedicavano al suo pen-siero articoli e inchieste,4 si consolidava il richiamo daesso esercitato sulle avanguardie artistiche e letterarie. Per
72
Milano, Mondadori, 1961, rispettivamente alle pp. 798-806, 577-582, 807-810; Bergson et Croce si trova anche in Id., Opere, a cura di L. Baldacci, conla collaborazione di G. Nicoletti, Milano, Mondadori, 1977, pp. 619-623; ilquarto è in Id., Autoritratti e ritratti, Milano, Mondadori, 1962, pp. 876-888).Di Papini, ancora, è la prima traduzione italiana di testi di Bergson, una bre-ve antologia intitolata La filosofia dell’intuizione, pubblicata dall’editoreCarabba di Lanciano nel 1909. Sulla penetrazione del bergsonismo in ambi-to vociano cfr. L. SCHRAM PIGHI, Henri Bergson e la cultura francese nel «Leo-nardo», premessa alla ristampa anastatica del «Leonardo», Bologna, Forni,1981, Ead., Bergson e il bergsonismo nella prima rivista di Papini e Prezzo-lini: «Il Leonardo» (1903-1907), Bologna, Forni, 1982 e P. MONTEFOSCHI,Bergson e la poetica di Ungaretti, in «L’Approdo Letterario», poi, ampliato,con il titolo La memoria. Innesti bergsoniani, in Giuseppe Ungaretti. Le eclis-si della memoria, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988, p. 63.
3 I rapporti di Ungaretti con l’ambiente vociano furono stabiliti a partiredal 1911. Su questo tema si veda, tra gli altri, G. LUTI, Ungaretti e «les com-pagnons de route» dell’avanguardia fiorentina, in AU, pp. 277-303.
4 Questi alcuni degli scritti riguardanti Bergson pubblicati durante il pri-mo soggiorno di Ungaretti a Parigi (1912-1914): E. FAGUET, Un historien dusymbolisme, in «Revue des Revues», janvier 1913, pp. 37-48; H. CLOUARD,Note pour M. Léon Blum, in «Revue Critique des Idées et des Livres», 25février 1913, pp. 460-463; J. MAIRE, Systèmes philosophiques d’écoles littérai-res, in «Revue Critique des Idées et des Livres», 25 février 1913, pp. 430-444;T. DE VISAN, La philosophie de M. Henri Bergson et l’esthétique contemporai-ne, in «Vie des Lettres», avril 1913, pp. 124-137; M. Proust, interviewaccordée à Elie-Joseph Boi, in «Le Temps», 13 novembre 1913, p. 2; J. MAI-RE, Les bergsoniens contre Bergson, in «La Revue», 1 février. 1914, pp. 316-330; T. DE VISAN, Ce que nous devons à M. Bergson, in «Temps Présent», 2février 1914; J. JARY, Ce que nous devons au bergsonisme, in «RenaissancePolitique, Littéraire et Artistique», 21 février 1914, pp. 28-29; Enquête sur M.Bergson et l’influence de sa pensée sur la sensibilité contemporaine, in «LaGrande Revue», 10-25 février, 10-25 mars, 10 avril 1914; G. PAPINI, Deux phi-
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 72
restare alla sola letteratura, il problema dell’incidenza delbergsonismo è stato posto per autori come Péguy,Romains, i tardo simbolisti, Proust.5
Ma Ungaretti ascoltò direttamente l’insegnamento delfilosofo. Partecipò a lezioni di almeno uno degli ultimicorsi tenuti da Bergson al Collège de France: il primodedicato al proprio pensiero, segnatamente al metodofilosofico e al rapporto fra concetto e intuizione; il secon-do alla teoria dell’anima in Spinoza. Entrambi sono anno-tati negli annali del Collège per l’anno accademico 1913-’14, e si tennero tra il gennaio e il marzo di quest’ultimoanno. Queste le sole lezioni che Ungaretti può avereseguito, vista la sospensione dei corsi nell’anno accade-mico precedente (1912-’13) e la chiusura di quelli ante-riori (1911-’12) prima del suo arrivo a Parigi, avvenutonell’autunno del ’12.6 Ungaretti ricorda queste lezioni nei
73
losophes (Bergson et Croce), cit.; C. PÉGUY, Note sur M. Bergson et la philo-sophie bergsonienne, in «La Grande Revue», 25 avril 1914, pp. 613-632; J.Benda, Sur le succès du bergsonisme. Précédé d’une réponse aux défenseursde la doctrine, Paris, Mercure de France, 1914.
5 Per uno studio complessivo sui rapporti fra il bergsonismo e la lettera-tura francese si veda R. ARBOUR, Henri Bergson et les lettres françaises, Paris,Librairie José Corti, 1956.
6 Presentiamo di seguito gli estratti dagli annali del Collège de France,riportati alle pp. 961, 974 e 1032 di H. BERGSON, Mélanges, a cura di A. Robi-net, premessa di H. Gouhier, Paris, Presses Unversitaires de France, 1972:«ANNÉE 1911-1912. COURS DU COLLÈGE DE FRANCE. (ACF, X, 1910, p.115). Programme pour 1911-1912. M. Bergson traitera de L’idée d’évolution,le vendredi. Il étudiera les Principes généraux de la philosophie de Spinoza,le samedis (ouverture des cours le 5 janvier). PRÉSENCE AU COLLÈGE DEFRANCE (Feuilles des présences, C-VIII-d-222-A, pp. 281-306) 1912: Janvier:5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27. Février: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24. Mars: 1, 2, 8, 9,15, 16, 22, 23, 30»; «ANNÉE 1912-1913. COURS DU COLLÈGE DE FRANCE.Suspendus pour permettre la mission à l’Université Columbia, qui se dérou-le en février 1913»; «ANNÉE 1913-1914 (ACF, XIII, 1913, p. 91.). Programmespour 1913-1914. Philosophie moderne. M. Bergson de l’Institut. De laméthode philosophique, concept et intuition, les vendredis à 5 heures, salle8. La théorie de l’âme dans la Philosophie de Spinoza, les samedis à 4 heu-res 1/4, salle 8. PRÉSENCE AU COLLÈGE DE FRANCE (Feuilles des présen-ces, C-VII -d-223-A, pp. 29-52).1914: Janvier: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31;Février: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28; Mars: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28».
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 73
numerosi scritti dedicati più tardi al filosofo.7 Il primo arti-colo, scritto dopo l’uscita, nel 1922, di Durée et simul-tanéité, offre indizi importanti circa il periodo di frequen-za dei corsi ed il loro argomento:
Turbato, da quell’aula mi recavo all’altra ove, tra poco,Bergson doveva proseguire il suo commento di Spinoza.Aula già gremita. C’erano tutte le eleganti lettrici del Gau-lois e del Figaro. E i fiori ovunque. L’aria pesava con tuttiquegli odori artificiali e spontanei. [...] Mi accorsi che l’atteso, eletto quel giorno accademico diFrancia, era già al suo posto, e ringraziava. Questo libro che mi provo a riassumere con voi, lettori,l’ho udito, nelle sue parti fondamentali almeno, che anco-ra, nel 1912 o 913, sull’orizzonte della pubblicità, non eracomparso l’astro Einstein.8
74
7 G. UNGARETTI, Una filosofia dell’effimero e Bergson umorista, in «Il Nuo-vo Paese», 24 aprile 1923; Id., L’estetica di Bergson, in «Lo Spettatore Italia-no», I (1924), 7; Id., Lo stile di Bergson, in «Lo Spettatore Italiano», I (1924),8-9; Id., Di palo in frasca-Lo stile di Bergson, in «Il Mattino», Napoli, 8-9luglio 1926. Il primo articolo è ora riportato in P. MONTEFOSCHI, GiuseppeUngaretti. Le eclissi della memoria, cit., pp. 183-187. Il secondo e il terzofigurano in SI, pp. 79-86 e 87-89. Il quarto è una riedizione del terzo conuna breve aggiunta, ora leggibile nel volume dei saggi a p. 898.
8 G. UNGARETTI, Una filosofia dell’effimero e Bergson umorista, cit., p. 186.Il saggio cui Ungaretti fa riferimento è H. BERGSON, Durée et simultanéité,Paris, Alcan, 1922. Tema del libro è l’opposizione della concezione bergso-niana del tempo alla teoria della relatività ristretta di Einstein. Non si puòverificare se l’argomento sia stato anticipato nelle lezioni frequentate daUngaretti. Tra i riassunti dei corsi tenuti al Collège de France, raccolti in H.BERGSON, Mélanges, cit., mancano infatti quelli relativi all’anno accademico1913-14, le cui lezioni sono le sole che Ungaretti può aver frequentato. Tragli scritti editi da Bergson e quelli pubblicati postumi in Mélanges non cisono comunque riferimenti ad Einstein e alla teoria della relatività anteriorial 1922, anno di pubblicazione di Durée et simultanéité. Le «parti fondamen-tali» del libro, che Ungaretti sostiene di avere ascoltato dalla viva voce delfilosofo, si riferiscono allora, presumibilmente, all’impianto generale dellasua filosofia, messa a confronto nel saggio con la teoria di Einstein. Lo stes-so Ungaretti nota infatti che «Bergson, col pretesto della teoria d’Einstein, hatentato una rielaborazione, una distillazione direi, del proprio pensiero» [G.UNGARETTI, Una filosofia dell’effimero e Bergson umorista, cit., p. 183].
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 74
Ungaretti non indica un anno preciso, non ricorda benee infatti si sbaglia. Fornisce lui stesso la prova dell’erroremenzionando l’elezione di Bergson all’Académie Françai-se, la quale avvenne il 12 febbraio 1914, il che confermala frequenza delle lezioni del filosofo nell’anno accademi-co segnalato dianzi. L’iniziale riferimento a Spinoza corri-sponde inoltre al titolo di uno dei corsi tenuti da Bergsonnello stesso periodo.9 In una testimonianza più tarda,Ungaretti ha ancora indicato in Spinoza l’argomento dellelezioni da lui seguite :
Je suivais des cours à la Sorbonne, je suivais des cours auCollège de France; j’ai entendu les leçons de Bergson surSpinoza. C’est un de mes plus beaux souvenirs de cettepériode.10
Ma non è da escludere che egli abbia seguito anchel’altro corso, dedicato da Bergson al proprio pensiero,come si sostiene nella più nota biografia del poeta.11
L’influsso del bergsonismo sull’opera ungarettianainveste numerosi temi (il tempo, la memoria, il sogno,l’assenza, il senso del nulla e la negazione, il panismo, illinguaggio) ed è stata già messa in evidenza da diversi
75
9 Sulla data di elezione di Bergson all’Académie Française, cfr. H. BERG-SON, Mélanges, cit. p. 1037. Per una diversa datazione delle lezioni di Ber-son seguite da Ungaretti, cfr. Album Ungaretti, a cura di L. Piccioni e di P.Montefoschi, Milano, Mondadori, 1989, p. 60, dove si afferma che Ungaret-ti seguì le lezioni di Bergson nel 1912-1913 e P. MONTEFOSCHI, La memoria.Innesti bergsoniani, cit., p. 64, dove la frequenza di corsi del filosofo èascritta all’anno accademico 1911-1912.
10 G. UNGARETTI - J. AMROUCHE, Propos improvisés, texte mis au point parPh. Jaccotet, Paris, Gallimard, 1972, p. 45.
11 Cfr. L. PICCIONI, Vita di un poeta. Giuseppe Ungaretti, Milano, Rizzoli,1970, p. 51: «Al Collège de France, nei corsi liberi affidati a insegnanti di altafama, Ungaretti segue specialmente i corsi di Bergson: uno su Spinoza, eduno sulla intuizione e sulla durata della dimensione temporale».
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 75
studi12. È tuttavia ancora possibile aggiungere riscontri,considerare nuovi argomenti, insistere sulle differenzeche dividono, su alcuni punti, il poeta dal filosofo.
2. Un abisso di vita
Per Ungaretti – lo si è già detto – la poesia esprime la vita.Così si pronunciava, in merito, il filosofo ascoltato a Pari-gi:
Quel est l’objet de l’art? Si la réalité venait frapper directe-ment nos sens et notre conscience, si nous pouvionsentrer en communication immédiate avec les choses etavec nous-mêmes, je crois bien que l’art serait inutile, ouplutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibre-rait alors continuellement à l’unisson de la nature.13
76
12 Il rapporto Ungaretti-Bergson è trattato, a quanto ci risulta, nei seguen-ti scritti: C. OSSOLA, L’assenza memorabile. La lezione di Bergson, in Giusep-pe Ungaretti, Milano, Mursia, 1982 (1a ed. 1975), pp.114-136; O. Macrì, Ilsimbolismo nella poetica di Ungaretti, in AU, pp. 228-231; M. PETRUCCIANI, La«ragion poetica» della memoria, in Il condizionale di Didone. Studi su Unga-retti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985, in particolare le pp. 90-93;P. MONTEFOSCHI, La memoria. Innesti bergsoniani, cit., pp. 61-87; G.GUGLIELMI, «Innocenza e memoria», in Interpretazione di Ungaretti, Bologna,Il Mulino, 1989, pp. 123-133; V. SICILIANO, La lezione di Bergson, in Unga-retti, Giunti & Lisciani Editori, Teramo, 1994, pp. 49-51; F. CURI, Durata rea-le e poesia. Sul rapporto fra il primo Ungaretti e Bergson, in «Studi di Esteti-ca», 11, 1995, pp. 49-73, poi incluso nel capitolo Pensiero analogico e dura-ta reale. Due modelli per l’«Allegria» del volume Il possibile verbale. Tecni-che del mutamento e modernità letteraria, Bologna, Pendragon, 1995, pp.221-262; E. LIVORNI, «In sé da simulacro a fiamma vera / errando»La poesiadi Ungaretti tra Platone e Bergson, in Giuseppe Ungaretti: identità e meta-morfosi, atti del convegno internazionale di Lucca, 4-6 aprile 2002, a cura diL. Fava Gazzetta et. al., Lucca, Pacini Fazzi (in corso di stampa).
13 H. BERGSON, Le rire. Essai sur la signification du comique, Paris, Alcan,1900, ora in Œuvres, texte annotés par A. Robinet, introduction par H.Gouhier, Paris, Presses Universitaires de France, 1959, pp. 458-459.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 76
A quoi vise l’art, sinon à nous montrer, dans la nature etdans l’esprit, hors de nous et en nous, des choses qui nefrappaient pas explicitement nos sens et notre conscience?Le poète et le romancier qui expriment un état d’âme nele créent certes pas de toutes pièces; ils ne seraient pascompris de nous si nous n’observions pas en nous, jusqu’àun certain point, ce qu’ils nous disent d’autrui. Au fur et àmesure qu’ils nous parlent, des nuances d’émotion et depensée nous apparaissent qui pouvaient être représentéesen nous depuis longtemps, mais qui demeuraient invisi-bles: telle, l’image photographique qui n’a pas encore étéplongée dans le bain où elle se révélera. Le poète est cerévélateur.14
L’arte è la capacità di stabilire un contatto più diretto eprofondo con la realtà. Esso è ottenuto, secondo Bergson,attraverso l’intuizione, atto conoscitivo capace di totaleimmedesimazione con il suo oggetto, «la sympathie parlaquelle on se transporte à l’intérieur d’un objet pourcoïncider avec ce qu’il a d’unique et par conséquent d’i-nexprimable».15 L’intuizione, a sua volta, è «l’instinct deve-nu désintéressé, conscient de lui-même, capable de réflé-chir sur son objet et de l’élargir indéfiniment».16 Di proba-bile derivazione bergsoniana è quindi in Ungaretti il lega-me fra arte, possesso della vita e istinto cui si fa riferi-mento in un brano dei saggi:
[...] per mestiere intendo un fatto dell’intelligenza, presup-ponendo nell’artista vocazione, cioè tutte quelle facoltàistintive, necessarie a impadronirsi di quella vita – e goder-
77
14 Id. perception du changement. Conférences faites à l’Universitéd’Oxford les 26 et 27 mai 1911, Oxford, Claredon Press, 1911, poi in Lapensée et le mouvant, cit., ora in Œuvres, cit., pp. 1370-1371.
15 Id., Introduction à la métaphysique, in «Revue de Métaphysique et deMorale», XXIX (1903), 1, poi in La pensée et le mouvant, Paris, Alcan, 1932,ora in Œuvres, cit., p. 1395.
16 Id., L’évolution créatrice, Paris, Alcan, 1907, ora in Œuvres, cit., p. 645.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 77
ne il possesso – sulla quale vorrà porre la sua meditazio-ne, esercitare il suo controllo, dalla quale trarrà la sua ope-ra d’arte.17
Il possesso della vita per istinto è attribuito espressa-mente al filosofo e configurato come adesione al profon-do nel principale saggio di Ungaretti su Bergson:
Presentataci l’operosità dell’uomo, l’uomo edificatore,l’imperio della materia mediante l’intelligenza, Bergson cipresenterà l’uomo profondo, il possesso della vitamediante l’istinto.18
Questo accostamento fra l’adesione alla vita e ilprofondo trova un’ulteriore evidente corrispondenza nelpensiero del filosofo. L’intuizione (forma raffinata dell’i-stinto) si applica innanzitutto alla realtà interiore, al fluiredella durata, allo scorrere degli stati di coscienza:
Il y a une réalité au moins que nous saisissons tous dudedans, par intuition et non par simple analyse. C’estnotre propre personne dans son écoulement à travers letemps. C’est notre moi qui dure.19
78
17 G. UNGARETTI, Punto di mira, conferenza tenuta agli Illusi di Napoli il21 gennaio 1925, ora in SI, p. 285. Sui riferimenti all’intuizione nei saggiungarettiani e sul debito che configurano verso il bergsonismo, cfr. M.PETRUCCIANI, La «ragion poetica» della memoria, cit. p. 92: «I documenti sag-gistici e di poetica lasciati da Ungaretti certificano frequentemente, pur nel-le rielaborazioni personali, il debito contratto con il bergsonismo. Soprat-tutto con ciò che ne costituisce uno dei cardini: l’intuizione, esaltata qualeatto supremo della coscienza in quanto capace di scavalcare i condiziona-menti delle illusorie apparenze e le stesse barriere concettuali e scientificheper penetrare – come l’arte, la poesia – nell’anima segreta e più vera dellecose. Così concepita, l’intuizione è caricata di un potere che va al di là del-la semplice funzione gnoseologica per immettere la coscienza umana nelflusso vivo del reale, rendendola compartecipe del divenire dell’universoquasi in una diretta immedesimazione con l’assoluto».
18 G. UNGARETTI, L’estetica di Bergson, cit., p. 82.19 H. BERGSON, Introduction à la métaphysique, cit., p. 1396.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 78
Gli stati di coscienza appaiono, in superficie, divisi l’u-no dall’altro, come oggetti nello spazio. La vera naturadella vita interiore si svela però nel profondo dove essiformano un divenire indiviso:
C’est, au-dessus de ces cristaux bien découpés et de cettecongélation superficielle, une continuité d’écoulement quin’est comparable à rien de ce que j’ai vu s’écouler. C’estune succession d’états dont chacun annonce ce qui suit etcontient ce qui précède. [...] En réalité, aucun d’eux necommence ni ne finit, mais tous se prolongent les unsdans les autres.20
L’intuizione si esercita dunque sotto la superficie, stabi-lisce in profondità l’adesione alla vita. In modo analogo,in Ungaretti, la parola che manifesta la vita è tratta dalprofondo «scavata» in essa «come un abisso»:
Quando io trovoin questo mio silenziouna parolascavata è nella mia vitacome un abisso.21
Il procedere del poeta è del resto descritto in terminiche trovano preciso riscontro in affermazioni del filosofosullo scavo interiore:
Vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde
Di questa poesia mi resta
79
20 Ivi, p. 1397. 21 G. UNGARETTI, Poesia, in Il porto sepolto, Udine, Stabilimento Tipografi-
co Friulano, 1916, ora a cura di C. Ossola, Venezia, Marsilio, 1990, p. 89.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 79
quel nulla d’inesauribile segreto.22
Exercé à l’observation intérieure, le philosophe devraitdescendre au-dedans de lui-même, puis, remontant à lasurface, suivre le mouvement graduel par lequel la con-science se détend, s’étend, se prépare à évoluer dans l’e-space.23
Descendez au plus profond de vous-mêmes pour amenerà la surface tout ce qu’il y a - que dis-je? plus qu’il n’y a, envous.24
Ma alla discesa nel profondo è anche legata per Berg-son l’intuizione che trascende la vita della persona e sicolloca nella realtà in generale:
En sondant ainsi sa propre profondeur, pénètre-t-elle plusavant dans l’intérieur de la matière, de la vie, de la réalitéen général? On pourrait le contester, si la conscience s’é-tait surajoutée à la matière comme un accident; [...]. Onpourrait le contester encore, si la conscience humaine,quoique apparentée à une conscience plus vaste et plushaute, avait été mise à l’écart, et si l’homme avait à se tenirdans un coin de la nature comme un enfant en pénitence.Mais non! La matière et la vie qui remplissent le mondesont aussi bien en nous; les forces qui travaillent en toutes
80
22 Id., Il porto sepolto, ivi, p. 42.23 H. BERGSON, L’âme et le corps, nel saggio collettivo Le materialisme
actuel, Paris, Flammarion, 1914, poi in L’énergie spirituelle, Paris, Alcan,1919, ora in Œuvres, cit., pp. 836-860: 842. Questo brano è stato accostatoda Petrucciani alla lirica Il porto sepolto con il seguente commento: «Maanche la poesia, per U., è discesa nel profondo (del porto sepolto) e risalitaalla luce e propagazione nello spazio: «Vi arriva il poeta / E poi torna allaluce con i suoi canti / E li disperde»» [M. Petrucciani, Elytis, Ungaretti e Plo-tino l’egiziano, in Il condizionale di Didone, cit., p. 279].
24 H. BERGSON, De l’intelligence, in «Correspondance», XXI (1914), 6, orain Mélanges, cit., p. 560.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 80
choses, nous les sentons en nous; quelle que soit l’essen-ce intime de ce qui est et de ce qui se fait, nous en som-mes. Descendons alors à l’intérieur de nous-mêmes: plusprofond sera le point que nous aurons touché, plus fortesera la poussée qui nous renverra à la surface. L’intuitionphilosophique est ce contact, la philosophie est cet élan.25
Un legame fra immedesimazione nella realtà esterna ediscesa nel profondo è posto anche da Ungaretti in unbrano dell’epistolario:
L’altro giorno mi disperavo; mi sentivo in uno stato di sfi-nimento, un pietrificarsi; e avevo sì un desiderio di sfini-mento, ma un ardore; non mi riconoscevo più; questo mioio che ama abbandonarsi e possedere era scomparso inuna lontananza; e non mi cavavo che un atroce mistero;ero bene una nebbia; non più novità inebrianti di creatu-re germoglianti nella mia serra; era un ghiacciaio il portosepolto.26
Come già si è mostrato nel terzo capitolo, l’«abbando-narsi e possedere» di questa lettera rientra verosimilmen-te nell’area semantica della condizione panica, la stessadel «congiungersi e possedere» di Distacco. Basteràaggiungere che Ungaretti può avere recepito il rapportofra assimilazione alla vita universale e discesa nel profon-do anche attraverso Papini, che in un articolo su Bergsone Croce, uscito in Francia nel marzo del ’14, così si riferi-sce all’insegnamento del filosofo francese:
[...] il faut recourir au moi profond, à l’intuition vitale, ilfaut s’insérer dans les choses elles-mêmes et nous pour-
81
25 Id., L’intuition philosophique, in «Revue de Métaphysique et de Mora-le», XIX (1911), 6, poi in La pensée et le mouvant, cit., ora in Œuvres, cit., p.1361.
26 G. UNGARETTI, Lettere a Giovanni Papini, a cura di M. A. Terzoli, intro-duzione di L. Piccioni, Milano, Mondadori, 1988, p. 106. Lettera del 28 feb-braio 1917. Corsivi miei.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 81
rons saisir dans cette fusion de la vie individuelle avec lavie universelle les ressorts cachés de l’univers.27
Questo brano attribuisce a Bergson la stessa idea difusione dell’individuo con il tutto, di immedesimazionenella vita universale, che caratterizza i componimenti delPorto sepolto e di Allegria di naufragi. Lo «sforzo occulto»di uno di essi («Si porta / un’infinita / stanchezza / natura-le / dello sforzo / occulto / di questo / principio / cheogni anno / accade / alla terra»)28 sembra ricalcare i «res-sorts cachées» del brano papiniano testé citato. Ma l’ade-sione panica, l’immedesimazione nella realtà è in ognicaso un dato di importanza capitale nei componimentidelle due prime raccolte ungarettiane. Non si tratta, nellagran parte dei casi, di semplice armonia con la natura, mapiuttosto di un sentimento di effusione intima, di profon-da compenetrazione in essa. Questo aspetto del panismoungarettiano è precisamente quello sul quale l’intuizioni-smo di Bergson può avere influito.29 Annientamento
82
27 G. PAPINI, Deux philosophes (Bergson et Croce), cit., p. 622. 28 Nella redazione apparsa in G. UNGARETTI, Allegria di naufragi, Firen-
ze, Vallecchi, 1919, ora in TP, p. 653.29 Per un breve esame di questo genere di incidenza del bergsonismo in
Ungaretti, cfr. ora V. SICILIANO, Ungaretti, cit., pp. 49-51. L’autore nota che perstabilire «un rapporto armonico con la natura» «Ungaretti recupera l’insegna-mento filosofico di Henri Bergson» (p. 50). E indica così il ruolo svolto dal-l’intuizione nel realizzare l’unione con il reale: «Grazie all’intuizione si entranel flusso stesso della realtà e ci si immedesima nel divenire dell’universo [...]Solo attraverso l’intuizione, in maniera non razionale, l’essere recupera l’u-nità della sua vita e del suo rapporto con il mondo che lo circonda, collo-candosi nel flusso continuo del tempo[...]» (p. 51). Non è peraltro da esclu-dere che l’incidenza bergsoniana si sia esercitata per il tramite di un ambien-te culturale già da essa raggiunto o comunque caratterizzato da posizionisimili. Cfr. a riguardo M. RAYMOND, Bergson et la poésie récente in Génies deFrance, Neuchâtel, La Baconnière, 1942, pp. 224-225: «Au reste, je l’ai notéailleurs, au développement de la pensée de Bergson, de 1889 à 1907 (del’Essai à L’évolution créatrice) qui passe du psychologique au biologique, del’auscultation du moi à la vision dynamique de la vie universelle [...] réponddans l’esprit de la plupart de poètes, par une sorte d’harmonisation dont le
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 82
costituisce l’esempio di più radicale fusione dell’io con larealtà esterna: «mi sono radicato / nella terra marcita /sono cresciuto / come un crespo / sullo stelo torto / misono colto / nel tuffo / di spinalba [...] mi fisso / nellacenere del greto / scoperto dal sole / e mi trasmuto / involo di nubi».30 Mentre in Trasfigurazioni in campagna, ilsimpatizzare ha il tratto peculiare dell’immedesimarsi inpersone: «Mi sento negli occhi / attenti alle fasi / del cielo/ dell’uomo rugato / come la scorza / dei gelsi che pota //Mi sento / nei visi infantili / come un frutto rosato / bru-cente / fra gli alberi spogli».31 Forma particolare di unani-mismo che trova anch’essa possibilità di riscontro nell’in-segnamento di Bergson:
Nos corps sont extérieurs les uns aux autres dans l’espace;et nos consciences, en tant qu’attachées à ces corps, sontséparées par des intervalles. Mais si elles n’adhèrent aucorps que par une partie d’elles-mêmes, il est permis deconjecturer, pour le reste un empiètement réciproque.Entre les diverses consciences pourraient s’accomplir àchaque instant des échanges, comparables aux phénomè-nes d’endosmose.32
83
principe nous échappe, un mouvement progressif d’expansion et de con-quête, un élan vers les choses, une prise de « possession du monde »».
30 G. UNGARETTI, Il porto sepolto, cit., pp. 48-50.31 Id., Allegria di naufragi, cit., ora in TP, p. 69.32 H. BERGSON, «Fantômes de vivants» et «Recherche psychique». Conféren-
ce faite à la Society for Psychical Research de Londre le 28 mai 1913, poi inL’énergie spirituelle, cit., ora in Œuvres, cit., p. 874. Il «compenetrarsi dellecoscienze» è espressamente ricondotto all’intuizione in un brano più tardo:«Ne va-t-elle pas plus loin? N’est-elle que l’intuition de nous-mêmes ? Entrenotre conscience et les autres consciences la séparation est moins tranchéequ’entre notre corps et les autres corps, car c’est l’espace qui fait les divi-sions nettes. La sympathie et l’antipathie irréfléchies, qui sont si souventdivinatrices, témoignent d’une interpénétration possible des conscienceshumaines. Il y aurait donc des phénomènes d’endosmose psychologique.L’intuition nous introduirait dans la conscience en général.» [Id., De la posi-tion des problèmes, in La pensée et le mouvant, cit., ora in Œuvres, cit., pp.1271-1330 : 1273].
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 83
In altri componimenti l’assimilazione panica coglie, delreale, l’aspetto temporale, il divenire e mutare continui. Èil caso de La notte bella («D’ora in poi / confidenziale / migenera / ogni attimo d’universo») dove il sentirsi solidalecon lo scorrere del tutto è indicato dall’esser «confiden-ziale» di «ogni attimo d’universo» e dal suo suscitare («migenera») la vita della persona. L’assorbimento nella realtàprosegue nei versi successivi («Sono ubriaco d’universo[...] / Comparso allo spazio / l’ho morso / come un neo-nato / la mammella»).33
3. Il nulla è un abbaglio
La rappresentazione del nulla, per Bergson, non fa capo aniente che esista di fatto o sia almeno concepibile. L’ine-sistenza assoluta di alcunché non si può dare e nemmenopensare e altrettanto impensabile è il nulla, quale non esi-stere di alcun oggetto. Le considerazioni del filosofo suquesto tema offrono elementi di riscontro nella poesia diUngaretti.
È innanzi tutto il caso delle riflessioni sull’idea di aboli-zione. L’abolizione di un oggetto non lascia dietro di sé unnulla “parziale” che unito agli altri darebbe il niente asso-luto. Una cosa nuova prende sempre il posto della scom-parsa e quanto vi è di obiettivo nella abolizione non è chela sua sostituzione ad opera della prima. L’impressione diassenza è allora solo soggettiva: nasce dal ricordo dell’og-getto passato, e dall’aspettativa, disattesa, di trovarlo pre-sente; implica uno sguardo esclusivo sul passato e la nonconsiderazione del presente che ne prende il posto:
Pour se représenter qu’une chose a disparu, il ne suffit pasd’apercevoir un contraste entre le passé et le présent; il
84
33 G. UNGARETTI, La notte bella, in Il porto sepolto, cit., pp. 79-80.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 84
faut encore tourner le dos au présent, s’appesantir sur lepassé, et penser le contraste du passé avec le présent enterme de passé seulement, sans y faire figurer le présent.34
Se l’abolizione si risolve in sostituzione, se il venirmeno di un oggetto equivale al darsi di un altro al suoposto, non si danno nel reale assenze d’essere, vuoti par-ziali che messi insieme porterebbero al nulla. L’idea delniente assoluto ottenuto per ipotetica abolizione di tutto èallora priva di fondamento: «aussi absurde» – la giudicaBergson – «que celle d’un cercle carré».35
Neppure i giudizi negativi affermano inesistenze asso-lute, la cui somma ipotetica darebbe il nulla. Un giudiziodel tipo «L’oggetto A non esiste» implica ancora la rappre-sentazione di A e la rappresentazione di A necessita diper sé che gli si attribuisca una certa esistenza. Il non esi-stere, che la negazione predica di un oggetto, può soloessere relativo e riferirsi alla sua esclusione della realtàattuale in generale36. Benché da essa escluso, l’“inesisten-te” conserva ancora un’esistenza puramente ideale, quel-la di un oggetto semplicemente possibile.37 Lungi dall’in-dicare inesistenze reali, i giudizi negativi hanno allora lasola funzione di distinguere il possibile dall’attuale e di
85
34 H. BERGSON, L’évolution créatrice, cit., p. 744.35 Ivi, p. 734.36 Cfr. ivi, p. 736: «Dès lors, qu’est-ce que penser l’objet A inexistant? Se
le représenter existant ne peut pas consister à retirer de l’idée de l’objet Al’idée de l’attribut ‘existence’, puisque, encore une fois, la représentation del’existence de l’objet est inséparable de la représentation de l’objet et ne faitmême qu’un avec elle. Se représenter l’objet A inexistant ne peut donc con-sister qu’à ajouter quelque chose à l’idée de cet objet: on y ajoute, en effet,l’idée d’une exclusion de cet objet particulier par la réalité actuelle en géné-ral». Corsivi nel testo.
37 Cfr. ivi: «En d’autres termes, se représenter un objet comme irréel nepeut pas consister à le priver de toute espèce d’existence, puisque la repré-sentation d’un objet est nécessairement celle de cet objet existant. Un pareilacte consiste simplement à déclarer que l’existence attachée par notre esprità l’objet, et inséparable de sa représentation, est une existence tout idéale,celle d’un simple possible».
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 85
prevenire l’errore eventuale di chiunque scambiasse l’esi-stenza possibile con quella di fatto.38 La rappresentazionedel possibile è dunque necessaria alla negazione. Comel’impressione di abolizione, essa è legata alla memoria eorigina allo spirito dalla non differenza essenziale fra un«passato che si ricorda» e un «passato che si immagina»:
Et comme il n’y a pas de différence essentielle entre unpassé qu’on se remémore et un passé qu’on imagine, ilaura vite fait de s’élever à la représentation du possible engénéral.Il s’aiguillera ainsi sur la voie de la négation.39
Se l’idea di abolizione implica che ci si pieghi sul pas-sato, senza considerare il presente che lo rimpiazza, cosìla negazione si involge tutta sul possibile negato, senzaindicare la realtà attuale che ne prende il posto:
De l’abolition à la négation qui est une opération plusgénérale, il n’y a maintenant qu’un pas. Il suffit qu’on sereprésente le contraste de ce qui est, non seulement avecce qui a été, mais encore avec tout ce qui aurait pu être. Etil faut qu’on exprime ce contraste en fonction de ce quiaurait pu être et non pas de ce qui est, qu’on affirme l’exi-stence de l’actuel en ne regardant que le possible.40
La realtà scorre senza fine, il presente evolve senzasosta dal passato e incessantemente lo supera. Non esi-stono assenze successive al venir meno di oggetti, solopresenze che di continuo si susseguono, in modo inter-
86
38 Cfr. ivi, p. 740: «Les jugements qui posent la non-existence d’une cho-se sont donc des jugements qui formulent un contraste entre le possible etl’actuel (c’est-à-dire entre deux espèces d’existence, l’une pensée l’autreconstatée) dans des cas ou une personne, réelle ou imaginaire, croyait à tortqu’un certain possible était réalisé». Corsivo nel testo.
39 Ivi, p. 744.40 Ibid.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 86
minabile. Per rappresentarsi l’assente o il possibile inat-tuale che su di esso si erige, occorre voltare le spalle aldivenire, concentrarsi sull’assente e sul possibile ignoran-do la realtà che ne prende il posto.
Et ce qui donne à la négation son caractère subjectif, c’estprécisément que, dans la constatation d’un remplacement,elle ne tient compte que du remplacé et ne s’occupe pasdu remplaçant. Le remplacé n’existe que comme concep-tion de l’esprit. Il faut, pour continuer à le voir et par con-séquent pour en parler, tourner le dos à la réalité, qui cou-le du passé au présent, d’arrière en avant. C’est ce qu’onfait quand on nie. On constate le changement, ou plusgénéralement la substitution, comme verrait le trajet de lavoiture un voyageur qui regarderait en arrière et ne vou-drait connaître à chaque instant que le point où il a cesséd’être; il ne déterminerait jamais sa position actuelle quepar rapport à celle qu’il vient de quitter au lieu de l’expri-mer en fonction d’elle-même.41
Carlo Ossola ritiene racchiusa in questo passo «l’ideolo-gia, l’episteme se si vuole, che sta alla base di Allegria dinaufragi»:
La negazione insomma s’inflette su stessa e sogna «l’assen-za», la mera disparizione «du remplacé», non offre e nonattende «remplaçant», non si proietta sul futuro, s’involgesul passato. La sostituzione insomma è sempre ciò che silascia, mai ciò che si potrebbe prendere, «ne voudrait con-naître à chaque instant que le point où il a cessé d’être»: equesto «voyageur» questo nomade è proprio l’Ungarettidell’Allegria.42
Servendosi delle liste di frequenza stilate da Genot,Ossola sottolinea l’elevata frequenza della particella «non»
87
41 Ivi, p. 743. 42 C. OSSOLA, L’assenza memorabile, cit, p. 119.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 87
e dei suoi «modificateurs» tra le liriche dell’Allegria.43
Quindi procede alla elencazione di un cospicuo numerodi occorrenze denegative di cui riportiamo alcuni esempi:
Il sole rapisce la città / Non si vede più / Neanche le tomberesistono molto (Ricordo d’Affrica); Come questa pietra / èil mio pianto / che non si vede (Sono una creatura); Ditanti / che mi corrispondevano / non mi è rimasto / nep-pure tanto (San Martino del Carso); Ma le strade percorseora riprincipiare non più (Le Suppliche)
Il frequente occorrere della negazione in Ungaretti èper Ossola un elemento di derivazione bergsoniana e,insieme, indice del ripiegamento sull’assenza che la carat-terizza.
Anche l’idea di «non differenza essenziale fra un passa-to che si rimemora e un passato che si immagina» può delresto avere inciso sulla poetica del primo Ungaretti:
L’affermazione essenziale, quella che tocca nel profondola struttura dell’Allegria, è nella certezza che «il n’y a pasde différence essentielle entre un passé qu’on se remémo-re et un passé qu’on imagine», che non c’è soluzione dicontinuità tra memoria e visione.44
La compresenza di memoria, visione, rappresentazionedel nulla figura in alcuni tra i primissimi componimentiungarettiani. In Diluvio le presenze si annullano, figure
88
43 Cfr. ivi: «Se infatti scorriamo le liste di frequenza compilate da Genotper l’Allegria, vediamo subito che la particella “non” (su cui ruota la nega-zione) ha una frequenza assoluta altissima [33], e una relativa molto signifi-cativa, poiché tra i “modificateurs” (se vi aggiungiamo le 5 occorrenze di né,neanche, neppure) raggiunge al primo posto l’aggettivo “quest-o/a” [44 fre-quenze], che funge nell’economia del testo da determinante, da indice del-l’hic et nunc, del presente». L’opera cui Ossola fa riferimento è G. GENOT,Sémantique du discontinu dans l’«Allegria di Ungaretti», Paris, Klincksieck,1972.
44 C. OSSOLA, L’assenza memorabile, cit., p. 121.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 88
umane dileguano nella nebbia: «Mamma mia! quanto haipianto! / C’è la nebbia che ci cancella / Nasce forse un fiu-me quassù / Non distinguo più». La constatazione diassenza dà spazio a visioni della memoria («Ascolto il can-to delle sirene del lago / dov’era la città»).45 Il ricordosconfina nell’immaginario, si fa miraggio, come lo stessoUngaretti precisa in una tarda nota alla poesia: «La nebbiaaveva mutato in quell’ora Milano in un lago che come unmiraggio mi richiamava alla mente il lago di Mereotis, neldeserto vicino ad Alessandria».46 In Chiaroscuro, le pre-senze si dissolvono entro l’ombra della notte: «Il biancodelle tombe se lo è sorbito la notte / Spazio nero infinitocalato / da questo balcone / al cimitero». Dal passatorifluiscono ricordi, riaffiora l’immagine del suicida Sceab(«Mi è venuto a ritrovare il mio compagno arabo / che si èsuicidato / che quando mi incontrava negli occhi / par-landomi con quelle sue frasi pure e frastagliate / era uncupo navigare nel mansueto blu»).47 Questo farsi del ricor-do fantasma denota, una volta di più, il reciproco sconfi-namento di immaginazione e memoria, a partire dallarappresentazione del nulla.
Dalla abolizione, al ricordo, alla rappresentazione delpossibile, alla negazione: «non vi è» – insegnava Bergson– «che un passo». Senso del nulla, disparizione di oggetti,iterazione della negazione caratterizzano Il panorama diAlessandria d’Egitto, componimento tutto denegante,interamente incentrato sulla registrazione di assenze:
89
45 Apparsa in «Lacerba» il 28 febbraio 1915, poi in Allegria di naufragi,cit., ora in TP, p. 598.
46 G. UNGARETTI, Note, in TP, pp. 497-584: 518. Per la «de-oggettivazionedel concreto» in questo componimento cfr., F. MUSARRA, Costituenti verbalidell’Allegria, in Risillabare Ungaretti, Roma-Leuven, Bulzoni-Leuven Uni-versity Press, 1992, pp. 70-72. Sul miraggio, cfr. anche G. NICOLETTI, «Ricor-do d’Affrica» di Giuseppe Ungaretti, in Le risposte della poesia da D’Annun-zio a Luzi, Firenze, Cadmo, 2003, pp. 67-98.
47Apparsa in «Lacerba», 17 aprile 1915.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 89
Città costruita di volubilitàdove nessuno è venuto per rimanerci moltoné il beduino della tendané l’italiano muratorené il tedesco cotoniere.Neanche le tombe ci resistono molto.Presto le case ci si petrizzano nelle spalle.Il sole è il mangia.48
Si esprimono il durare effimero, l’incessante sparire dicose e uomini nella città africana; il divenire è avvertitocome scarto continuo fra presente e passato; solo il pas-sato è però considerato e non il presente che senza sostane deriva: non presenze si indicano nel componimento,ma il loro costante venire a mancare. L’impressione delnulla è fissata, nel finale, dall’immagine del sole che dis-solve le cose e le divora («Il sole è il mangia»). Ma essa sidelinea già dai versi che precedono, dov’è determinata, inmisura preponderante, dalla progressione delle negazioni(«Nessuno», «né», «né», «né», «neanche»). In tutti e quattro icasi, la negazione rispecchia le caratteristiche segnalate daBergson: si inflette solo sull’assenza senza indicare larealtà attuale che ne prende il posto.
Senso del nulla, ripiegamento sul passato, sconfina-mento della memoria in miraggio, insistente frequenzadella negazione, sono tutti elementi che in Ungaretti siconfigurano in un modo che è analogo a quello in cuiBergson descrive la nascita dell’idea del nulla. Analogo intutto, salvo però in un punto, peraltro non secondario. Ilnulla è una falsa idea, occorre considerare l’essere, diret-tamente, nell’approccio con il reale:
il faut s’habituer à penser l’Etre directement, sans faire un
90
48 Pubblicata in «Critica Magistrale», il 15 marzo 1915, ora in C. OSSOLA-U.SERENI, «L’atto di Lucifero»: Ungaretti apuano, in «Lettere Italiane», XLII(1990), 3, pp. 388-413: 407.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 90
détour, sans s’adresser d’abord au fantôme de néant quis’interpose entre lui et nous.49
Ma questo porre l’assenza come principio mitopoieticonon è in fondo che uno risvolto della strutturale “dop-piezza” della poetica Ungaretti.50 Se da un lato rappresen-ta l’assenza, essa cerca per altro verso di riscattarla in unasorta di affermazione massima della presenza. Ciò si tra-duce, nell’Allegria, in recupero dell’io a se stesso e di tut-te le cose all’io: riconoscimento di sé (ricapitolazione delpassato) e in altro (l’universo): abolizione dell’assenza,del vuoto, del nulla, pienezza dell’essere, l’innocenza delsentirsi in armonia. Recuperi memoriali e immedesima-zioni nel reale del resto ammessi dall’insegnamento diBergson, la cui incidenza in Ungaretti si è già avuto mododi rilevare, nel precedente paragrafo.
4. Ritmi e metafore
Quale linguaggio rappresenta l’intuizione, il contattoimmediato con l’essere, la presa diretta sulla realtà? Ai cor-si di Bergson, uno dei quali dedicato, come si è visto, alrapporto fra concetto e intuizione, Ungaretti può avereappreso che l’intuizione aderisce alla vita interiore, ma èinesprimibile a opera del linguaggio:
[...] notre durée peut nous être présentée directement dansune intuition, [...] elle peut nous être suggérée indirectement
91
49 H. BERGSON, L’évolution créatrice, cit., p. 747. Su questo punto, cfr.anche C. Ossola, L’assenza memorabile, cit., p. 126: «Ma ciò che Ungaretti,in questo tentativo mitopoietico disperato, non ricordò della lezione diBergson, è precisamente che quest’idea del nulla, in quanto reduplicazionecensurata della realtà, rinvia specularmente agli oggetti rimossi, non puòessere mai una scommessa pascaliana fra il Tutto e il Nulla, non può con-durre alla “pura forma avversa al nulla”».
50 Cfr. il secondo capitolo.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 91
par des images, mais [...] elle ne saurait – si on laisse au motconcept son sens propre – s’enfermer dans une représentationconceptuelle.51
Può dunque aver ricordato la lezione del maestroquando ha detto imperscrutabile l’abisso, «indecifrabile» il«porto sepolto»52, la vita inafferrabile mistero:
La vita non è essa mistero, e mistero più profondo diquanto maggiori saranno i lumi della mente?53
Bergson ha però indicato un impiego del linguaggiopiù espressivo di quello convenzionale, basato sul ricorsoa immagini, metafore, analogie:
L’intuition ne se communiquera d’ailleurs que par l’intelli-gence. Elle est plus qu’idée; elle devra toutefois, pour setransmettre, chevaucher sur des idées. Du moins s’adres-sera-t-elle de préférence aux idées les plus concrètes,qu’entoure encore une frange d’images. Comparaisons etmétaphores suggéreront ici ce qu’on n’arrivera pas àexprimer.54
Nulle image ne remplacera l’intuition de la durée, maisbeaucoup d’images diverses, empruntées à des ordres dechoses très différents, pourront, par la convergence deleur action, diriger la conscience sur le point précis où il ya une certaine intuition à saisir.55.
Questa derivazione d’«immagini» da ambiti sensorialidisparati è coerente con l’asserita esistenza di nascostilegami, di affinità segrete fra cose lontane:
92
51H. BERGSON, Introduction à la métaphysique, cit., p. 1402. 52 Cfr. G. UNGARETTI, Note, cit., p. 523: «Il porto sepolto è ciò che di segre-
to rimane in noi indecifrabile».53 Id., Introduzione a «Eupalino», in «L’Italia Letteraria», 9 ottobre 1932,
ora in SI, p. 115.54 H. BERGSON., De la position des problèmes, cit., p. 1285. 55 Id., Introduction à la métaphysique, cit. p. 1399.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 92
La nature a arrangé les choses ainsi. Elle a ménagé entreles domaines intellectuels les plus éloignés, des commu-nications souterraines. Elle a disposé entre les ordres dechoses les plus divers, comme autant de fils invisibles, leslois mystérieuses de l’analogie.56
Tesi analoghe a queste sono state formulate, come ènoto, dai simbolisti, alla cui tradizione Ungaretti ha sicu-ramente attinto. L’apporto bergsoniano relativo al lin-guaggio può comunque averlo riguardato, soprattutto sesi considera, oltre alla frequenza dei corsi al Collège deFrance, la penetrazione del bergsonismo negli ambientiletterari frequentati durante il primo soggiorno a Parigi ela diffusione, già ricordata, delle tesi del filosofo sul lin-guaggio in ambito vociano. Delle posizioni di Bergson sullinguaggio, Ungaretti si mostra del resto al corrente neisaggi dedicati più tardi al filosofo:
La stessa diffidenza che dimostra verso le parole, Bergsonla dimostra verso le idee, e di qui nasce un suo uso curio-sissimo delle immagini.57
Il carattere spiccatamente metaforico del linguaggiopoetico, l’insistenza sull’analogia,58 il suo riferimento adambiti sensoriali disparati, possono dunque avere inUngaretti una derivazione bergsoniana, oltre che simboli-sta:
93
56 Id., De l’intelligence, cit., pp. 557-558.57 G. UNGARETTI, Lo stile di Bergson, cit., pp. 87-88. È stato giustamente
rilevato che il «referente stilistico determina una prima «armonia» tra poeta efilosofo [...] a cagione della scoperta di un comune impegno espressivo, diuna comune sofferenza della parola» [P. Montefoschi, La memoria. Innestibergsoniani, cit., p. 66]. Per Guglielmi, la critica di Bergson al linguaggiopuò avere stimolato il poeta senza però diminuire la sua fede nella parola:«Nessuna svalutazione della parola poetica in lui, ma svelamento delle suepossibilità» [G. GUGLIELMI, «Innocenza e memoria», cit., p. 128].
58 Su questi aspetti del linguaggio ungarettiano, cfr. in particolare J. GutiaLinguaggio di Ungaretti, Firenze, Le Monnier, 1959.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 93
Il poeta d’oggi cercherà dunque di mettere a contattoimmagini lontane. [...] Quando gli nascerà dal contattod’immagini, luce, ci sarà poesia, e tanto maggiore poesia,per quest’uomo che vuole salire dall’inferno a Dio, quan-to più grande sarà la distanza messa a contatto.59
Ascendenza bergsoniana e simbolista può avere anchela sottolineatura del valore della musicalità in poesia. Loscorrere degli stati di coscienza è per Bergson analogo alprocedere indiviso delle note di una melodia. Il contattocon la vita interiore equivale a percepire il fluire musicaledella durata:
Nous entendrions chanter au fond de nos âmes, commeune musique quelquefois gaie, plus souvent plaintive,toujours originale, la mélodie ininterrompue de notre vieintérieure.60
Poeti e scrittori scendono nel profondo della persona,aderiscono ai moti più riposti dell’anima, esprimono ciòche hanno percepito assemblando ritmicamente parole. Illoro impiego metaforico è legato al loro accordo musicale:
Le poète est celui chez qui les sentiments se développenten images, et les images elles-mêmes en paroles, docilesau rythme, pour les traduire.61
Et pour nous induire à tenter le même effort sur nous-mêmes, ils s’ingénieront à nous faire voir quelque chosede ce qu’ils auront vu: par des arrangements rythmés desmots, qui arrivent ainsi à s’organiser ensemble et à s’ani-mer d’une vie originale, ils nous disent, ou plutôt ils noussuggèrent, des choses que le langage n’était pas fait pourexprimer. – D’autres creuseront plus profondément enco-
94
59 G. UNGARETTI, Poesia e civiltà, testo di conferenze tenute fra il 1933-1936, ora in SI, p. 321.
60 H. BERGSON, Le rire, cit., p. 459. 61Id., Essai sur les données immédiates de la conscience, cit., p. 14.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 94
re. Sous ces joies et ces tristesses qui peuvent à la rigueurse traduire en paroles, ils saisiront quelque chose qui n’aplus rien de commun avec la parole, certains rythmes devie et de respiration qui sont plus intérieurs à l’homme queses sentiments les plus intérieurs, étant la loi vivante,variable avec chaque personne, de sa dépression et deson exaltation, de ses regrets et de ses espérances.62
In Ungaretti, l’aderire del poeta a moti elementari divita e di respirazione è così messo in risalto a propositodell’esperienza di Allegria di naufragi, dove l’estremaessenzialità e frammentazione del linguaggio determina-no le condizioni per il risalto preponderante del ritmo:
Nella trincea, nella necessità di dire rapidamente, perchéil tempo poteva non aspettare, e di dire con precisione etutto come in un testamento, e di dirlo, poiché si trattavadi poesia, armoniosamente – in tali condizioni estreme,trovai senza cercarla, quella mia forma d’allora nella qua-le il più che mi fosse possibile volli resa intensa di sensi laparola intercalata di lunghi silenzi – quella mia forma cheseguendo semplicemente il ritmo elementare del miorespiro, doveva portarmi ad intendere più tardi la virtùnaturale dei metri classici.63
Il poeta rileva inoltre che la componente musicale e lascelta dei metri sono in poesia un dato originario, maiposteriore alle parole. Esso governa il loro assemblaggio,ne modella il senso, le lega al di là del significato conven-zionale, infonde alla poesia gran parte dell’espressivitàche possiede:
Un poeta necessariamente risolve ogni problema propo-nendo un’arte poetica. Questa riafferma ciò che, e dal can-tare più remoto, è sempre stato detto poesia: un decidere
95
62 Id., Le rire, cit., p. 462. Corsivi miei.63 Poesia e umanità di Ungaretti, in «La Tribuna», 6 giugno 1933, ora [Le
prime mie poesie…], in SI, p. 268. Corsivi miei.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 95
la parola all’astrazione di moti melodiosi […]: agli spettrid’un corpo che accompagni danzando il grido d’un animafattosi elementare per raggiunta intensità.64
Nel tradurre, come nel comporre la mia stessa poesia, misono sempre principalmente preoccupato, ed era natura-le, del senso delle cose, da esprimere con somma esattez-za. [...]I novenari, i settenari, gli endecasillabi, i quinari, nonessendo per me mai schemi, non mi nascono dunquedopo trovate le parole, per partito preso; ma mi nasconoinsieme alle parole, muovendone naturalmente il senso.65
«Le parole», al limite, «non contano più nulla», vale lamusica che ad esse soggiace. Ungaretti lo afferma contermini identici a quelli del filosofo francese:
[...] quando leggo poesie di questa qualità, sento che leparole non contano più nulla, sento una musica che supe-ra il significato troppo facile, di qualsiasi parola. Il signifi-cato delle parole è una ben povera convenzione.66
C’est quelque chose comme l’art du musicien [...]. En réa-lité, l’art de l’écrivain consiste surtout à nous faire oublierqu’il emploie des mots. L’harmonie qu’il cherche est unecertaine correspondance entre les allées et venues de sonesprit et celles de son discours, correspondance si parfai-te que, portées par la phrase, les ondulations de sa penséese communiquent à la nôtre et qu’alors chacun des mots,pris individuellement, ne compte plus: il n’y a plus rienque le sens mouvant qui traverse les mots […]. Le rythmede la parole n’a donc d’autre objet que de reproduire lerythme de la pensée ;67
96
64 Id., Introduzione a «Eupalino», cit., p. 115. 65 Id., Della metrica e del tradurre, in «La Fiera Letteraria», 17 ottobre
1946, ora in SI, pp. 572-573.66 Id., Punto di mira, cit., p. 287.67 H. BERGSON, L’âme et le corps, cit., p. 849-850.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 96
Alla qualità musicale della parola Ungaretti attribuisceuna valenza espressiva. Le sue tesi si mostrano in propo-sito vicine alla lezione del filosofo.
5. Il tempo è immortale
Ungaretti ha dichiarato un grosso debito verso Bergson aproposito del sentimento del tempo, «precisatosi» in luianche grazie alle lezioni del filosofo seguite nel 1914:
Je crois que Bergson est un grand philosophe romantique,le plus grand philosophe de son temps. J’ai beaucoupappris de ses leçons, des leçons qui étaient très claires, maispas autant qu’on le pense. On les dit de l’eau transparente,du cristal, mais c’était tout de même quelque chose quivous enveloppait, qui était extrêmement séduisant, et ensomme difficile à pénétrer. Et c’était un homme profond. Jecrois que ma poésie lui a une grande dette. C’est par sesleçons que mon sentiment du temps s’est précisé.68
La reale percezione del tempo è innanzi tutto offertaper Bergson dal fluire indiviso degli stati di coscienza,durata che avanza incessantemente, ma prolunga il pas-sato nel presente:
La durée toute pure est la forme qui prend la successionde nos états de conscience quand notre moi se laissevivre, quand il s’abstient d’établir une séparation entre l’é-tat présent et les états antérieurs.69
Mais si nous tenons compte de la continuité de la vie inté-rieure et par conséquent de son indivisibilité, ce n’est plusla conservation du passé qu’il s’agira d’expliquer, c’est aucontraire son apparente abolition.70
97
68 G. UNGARETTI-J. AMROUCHE, Propos improvisés, cit., pp. 45-46.69 H. BERGSON, Essai sur les données immédiates de la conscience, cit., p. 67. 70 Id., La perception du changement, cit., p. 1388.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 97
la durée réelle est ce que l’on a toujours appelé le temps,mais le temps perçu comme indivisible.71
Nei componimenti ungarettiani non successivi al Portosepolto, il passato è in qualche caso rimpianto e sentitoassente. Può ancora però essere recuperato, riconnesso alpresente, consentire l’esperienza del riconoscimento,come dimostra – è noto a tutti – il caso dei Fiumi. Nonesistono dunque in questa fase stacchi netti fra presente epassato, l’orizzonte del tempo è ancora indiviso. Esso èpiù prossimo all’idea di durata72 di quanto non possa dir-si del «sentimento del tempo», che si afferma nei compo-nimenti scritti a partire dal 1917. Il tempo è in essi avver-tito come scarto invalicabile tra presente e passato, perdi-ta incessante, rimpianto della vita che fugge: «une monta-gne de ténèbres sépare le temps d’avant / du temps d’après// aussitôt qu’un de mes instants s’est écoulé j’en / suiséloigné de mille et mille ans».73 Questa visione del tempocome perdita della vita trascorsa si sviluppa nei componi-menti successivi e figura anche nei saggi dove si affermache tutto è «travolto, soffocato, consumato dal tempo»,74 lacui «funzione» è di «segnare caducità».75 Il poeta arriva adefinire il tempo «nemico»,76 ha «conscience de l’écoule-ment du temps par ce qu’il a de cruel en devenant passé,c’est-à-dire en se signalant par la mort».77 Il sentimento deltempo successivo al porto sepolto è in Ungaretti assai
98
71 Ivi, p. 1384. Corsivi nel testo.72 Per puntuali e persuasivi riscontri riguardo agli elementi indicativi di
durata nella poesia del primo Ungaretti, cfr. F. CURI, Pensiero analogico edurata reale, cit..
73 G. UNGARETTI, Conclusion, in La guerre, Établissement Lux, Paris, 1919,ora in TP, p. 349.
74 Id., Note, in TP, pp. 517.75 Id., Commento al Canto Primo dell’«Inferno», in «Paragone», 36 (1952),
ora in SI, p. 377. 76 Id., Note, cit., p. 525.77 G. UNGARETTI - J. AMROUCHE, Propos improvisés, cit., p. 89.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 98
intriso dell’idea della morte, incentrato sul perdersi,annullarsi, venire a mancare della vita nel divenire. Men-tre la conservazione del passato nel presente è per Berg-son la condizione stessa della durata:
Sans cette survivance du passé dans le présent, il n’yaurait pas de durée, mais seulement l’instantanéité.78
Benché Ungaretti utilizzi, come è stato rilevato, la cate-goria di durata nei saggi e nelle lezioni,79 non manca diconsiderarla, a volte, sotto il segno del perire: rilevando la«caducità delle nostre durate», che l’esperienza umana è«drammatica poiché si svolge, [...] nella durata, nel peritu-ro: nel corruttibile».80
Se domina l’assenza, la poesia non può più registrarepresenze, l’adesione immediata dell’io a se stesso e allavita universale. È tuttavia chiamata ad opporsi, a resistere,a riscattare il consumarsi dell’essere nel tempo:
L’arte ha un fine: la vita; tutta l’arte indistintamente e ogniatto umano, quando non sia contro natura. Il fine cui miral’arte è fatale. L’artista vorrebbe distruggere la morte nellesue opere. Più l’opera è fatta con l’intenzione di resistereal tempo, più è temeraria, meno è provvisoria, meno èrassegnata alla sorte umana e più dovrebbe essere degnadi rispetto da parte della critica; meglio difatti risponde alfine dell’arte.81
Nella opposizione al tempo distruttore, essa rimaneorientata ad affermare la vita sulla morte. In questa aspi-razione al riscatto della vita dalla morte, Ungaretti può
99
78 H. BERGSON, Introduction à la métaphysique, cit., p. 1411. 79 Cfr. in proposito P. Montefoschi, La memoria. Innesti bergsoniani, cit.,
p. 69.80 G. UNGARETTI, Commento al canto primo dell’ «Inferno» , cit., p. 380.81 Id., La critica alla sbarra, in «Gazzetta del Popolo», 31 dicembre 1930,
ora in SI, pp. 255-256.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 99
avere attinto – e in misura rilevante – al pensiero di Berg-son.
Lo dimostra, innanzi tutto, l’interpretazione della dura-ta bergsoniana come continuità storica, indicata dal poetastesso in uno dei brani che attestano il debito verso il filo-sofo:
J’ai eu, comme maître, au Collège de France, de 1912 à1914, Henri Bergson. En quelque sorte, – même s’il con-venait à Bergson de recourir au concept de durée pourdéfinir clairement, dans un champ psychologique étroitl’être universel, la vie d’une personne et l’étendue d’unparcours de faits sociaux – la durée bergsonienne peutavoir quelque analogie avec la continuité historique: avecla naissance et la décadence d’un langage qui avait frappéLeopardi et lui avait inspiré sa théorie.82
Ungaretti collega a Bergson un problema che è al cen-tro della sua poetica. L’aspirazione a radicarsi nella storiae a riconoscere le proprie matrici culturali è presente inlui sin dagli esordi. Dopo Allegria di naufragi essa assu-me un risvolto eminentemente letterario. Il senso dellacontinuità storica si esprime nel recupero di forme e metriclassici della lingua italiana. In Leopardi, Ungaretti ravvi-sa un atteggiamento non dissimile: la ricerca di unaespressione originale che, di fronte alla vecchiaia dellalingua, non esclude la tradizione e comporta piuttosto ilriattraversamento delle sue fasi.83 Quanto a Bergson, la
100
82 Id., Ma poétique, in L’Herne, 11 (1969), p. 123. Il periodo di frequenzadelle lezioni di Bergson è qui riportato con una leggera inesattezza. In effet-ti, data la sospensione delle lezioni nell’anno accademico 1912-1913, Unga-retti poté seguire solo quelle dell’anno accademico successivo, che si svol-sero tra il gennaio e il marzo del 1914 [cfr. H. BERGSON, Mélanges, cit., pp.974 e 1032].
83 Cfr. in proposito i brani seguenti: «E, poiché si prefigge di giungere aun uso personalissimo della propria lingua, il tormentato poeta invita sestesso a immedesimarsi nel corpo vetusto, a riviverne a una a una le epo-che sino a incontrarne la fanciullezza, non per diminuirgli l’età, il che sareb-
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 100
continuità storica può avere agganci con la sua idea didurata. Essa è in primo luogo percepita nell’indiviso scor-rere degli stati di coscienza. Ma l’intera realtà è durata,divenire, cambiamento. È il dispiegarsi di uno slanciovitale, eterno, che suscita e conserva la vita, trascina lecose e gli esseri, include, in linea di principio, la storia deipopoli e delle generazioni. Questa idea di slancio vitale,detto anche «grand fleuve de la vie»,84 è probabilmentepresente nei Fiumi. L’anamnesi, infatti, non riguarda neiFiumi il solo passato personale, ma è anche scoperta del-le matrici storiche: «Questi sono / i miei fiumi / questo è ilSerchio / al quale hanno attinto / duemil’anni / forse / digente mia / campagnola / e mio padre e mia madre / equesto è il Nilo / che mi ha visto / nascere e crescere / e
101
be mostruoso, anzi per averne l’intera esistenza presente e riscattarne, col-la memoria della naturalezza dei pensieri e delle immaginazioni del primotempo, il peso degli anni sempre più grave nel progresso dei secoli» [G.UNGARETTI, Immagini del Leopardi e nostre, in «La Nuova Antologia», LVIII(1943), 1072, ora in SI, p. 433]; «D’un côté la tradition, l’histoire, la mémoireparaissent indispensables à la naissance du fait poétique: de l’autre, il y al’abolition des frontières, des limites de la tradition – il y a une innocencerécupérée. La poésie existe lorsque, par élégance – et c’est ainsi que Leo-pardi nous l’apprend – seulement par élégance, par sagesse et connaissan-ce, une vieille langue parvient à croire qu’elle est redevenue primitive etqu’elle récupère son innocence» [Id., Ma poétique, cit.]. Sul rapporto Unga-retti-Leopardi, cfr. F. SIGNORETTI, Tempo e Male. Ungaretti su Leopardi, Urbi-no, Argalia, 1977; F. DI CARLO, Ungaretti e Leopardi. Il sistema della «memo-ria» dall’«assenza» all’«innocenza», Roma, Bulzoni, 1979; A. DOLFI, Ungaret-ti e la memoria immemore leopardiana, in AU, poi nel volume La doppiamemoria. Saggi su Leopardi e il leopardismo, Roma, Bulzoni, 1986, pp. 107-120; P. Montefoschi, «Infantili trame lunari». Appunti su Ungaretti lettore diLeopardi, in G. UNGARETTI, Lezioni su Giacomo Leopardi, a cura di M. Dia-cono e P. MONTEFOSCHI, introduzione di L. Piccioni, Roma, Presidenza delConsiglio dei Ministri, 1989, pp. 187-193; L. PICCIONI, Ungaretti e Leopardi,nell’opera collettiva Ungaretti e i classici, a cura di M. Bruscia et. al., Roma,Studium, 1993, pp. 121-132.
84 Cfr. Id., L’évolution créatrice, cit., pp. 723-724: «Le courant passe donc,traversant les générations humaines, se subdivisant en individus: [...] Ainsise créent sans cesse des âmes, qui cependant, en un certain sens, préexi-staient. Elles ne sont pas autre chose que les ruisselets entre lesquels se par-tage le grand fleuve de la vie, coulant à travers le corps de l’humanité».
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 101
ardere d’inconsapevolezza / nelle estese pianure / protet-te d’azzurro / e questa è la Senna / e in quel suo torbido/ mi sono rimescolato / e mi sono conosciuto // Questisono i miei fiumi / contati nell’Isonzo». I fiumi elencatisono le «umanità diverse» cui il poeta sente di appartene-re e nelle quali si riconosce, come dimostrano i versi diNotte, poesia coeva alla prima raccolta, ma da essa rima-sta fuori: «Il ragazzo / che nelle vene ha i fiumi / di tanteumanità diverse / è scappato / dalle cornici dove / ador-nava / il suo dolce tempo perduto».85 L’immemore vicen-da di civiltà è dunque nell’Isonzo passata in rassegna, inun fulmineo balenare di millenni, come meglio risulta dal-la redazione della celebre poesia inviata a Papini: «I mieifiumi si mettono in fila / chilometri e chilometri passo apasso / in un batter d’occhi di millanni / e li riconosco / auno a uno / come un accorto comandante»86. La memoriarecupera il passato, della persona e delle generazioni, sidilata nel tempo in cui esse hanno durato ed è come sepotesse, per un attimo, abbracciarlo interamente.
Ma il senso di adesione, che nel ripercorrere il tempo èacquisito, si estende alla comunione con il tutto: ricono-scersi è sentirsi «docile fibra dell’universo»:
Questo è l’Isonzoe qui megliomi sono riconosciutouna docile fibra dell’universo
102
85 Il componimento fu inviato a Prezzolini assieme a un’altra lirica inedi-ta, Soldato. Prezzolini ha pubblicato le due poesie in Il tempo della Voce,Milano-Firenze, Longanesi-Vallecchi, 1960, p. 705. Notte è ora inclusa nellasezione Altre poesie ritrovate di TP, p. 398. Per la relativa nota, si veda p.583.
86 G. UNGARETTI, I fiumi, in Poesie e prose liriche, a cura di C. MaggiRomano e M. A. Terzoli, introduzione di D. De Robertis, Milano, Mondado-ri, 1989, cit., p. 30.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 102
Questo avviene con la discesa nell’Isonzo, nel docileabbandono alla corrente del fiume; il fluire delle acque èfigura archetipa del divenire; la simbologia dell’aspersio-ne può così esprimere il riconoscersi in uno scorrere com-plessivo contenente le epoche della vita, la storia diciviltà, il divenire dell’universo. Il docile intridersi delloscorrere delle acque è sentirsi rifluire nell’alveo del tem-po, aspersione che integra nel divenire, assorbe e ricon-nette la persona nell’eterno scorrere del tutto:
Il nostro atomo di tempo non è perduto nell’eternità, èuna goccia del gran fiume.87
Questo passo potrebbe ben racchiudere il senso di unapoesia come I fiumi. Fa invece parte del più esteso saggioungarettiano sul filosofo francese ed è posta a commentodella sua teoria dello slancio vitale. Bergson indica conquesto termine l’impulso che suscita la vita dell’universoe incessantemente la propaga:
Un grand élan emporte les êtres et les choses. Par lui nousnous sentons soulevés, entraînés, portés. [...] Plus, en effetnous nous habituons à penser et à percevoir toutes chosessub specie durationis, plus nous nous enfonçons dans ladurée réelle. Et plus nous nous y enfonçons, plus nousnous replaçons dans la direction du principe, pourtanttranscendant, dont nous participons et dont l’éternité nedoit pas être une éternité d’immutabilité, mais une éternitéde vie : comment, autrement, pourrions-nous vivre etnous mouvoir en elle ? In ea vivimus et movemur etsumus.88
Lo slancio vitale è apertura d’origine, espansione inizia-le e perenne del tempo, che dà nascita all’esistente e insie-
103
87 Id., L’estetica di Bergson, cit., p. 83.88 H. BERGSON, La perception du changement, cit., p. 1392. Corsivi nel
testo.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 103
me lo accomuna. È la durata massimamente rinserrata ecoesa, pura corrente vitale, dal cui distendersi consegue ildisgregarsi del flusso primitivo in una miriade di rivoli epercorsi divergenti, corrispondenti al comparire di razze,specie, individui, della stessa materia inerte. Per alludereallo slancio il filosofo ricorre all’immagine del fiume:
Le courant passe donc, traversant les générations humai-nes, se subdivisant en individus [...]. Ainsi se créent sanscesse des âmes, qui cependant, en un certain sens, préexi-staient. Elles ne sont pas autre chose que les ruisseletsentre lesquels se partage le grand fleuve de la vie, coulantà travers le corps de l’humanité.89
L’idea bergsoniana di slancio vitale, grande fiume del-la vita che trascina le cose e gli esseri, non si discostamolto dalla panica esperienza dell’Isonzo: dove la vitaindividuale si risolve e riconosce in un divenire che èinsieme proprio, delle generazioni e dell’intero universo.Nel saggio ungarettiano che sopra si è citato, l’adozionedell’immagine del fiume non deve allora considerarsicasuale: può certo essere ripresa direttamente da Berg-son, ma anche testimoniare l’affinità avvertita dal poetatra l’idea di slancio vitale e il ricordo della più nota dellesue poesie.
Riscontri sul medesimo tema sono ancora possibili inPerché?, dove «la fionda del tempo» è lo slancio delladurata («Ma sono / come questi sassi tarlati / nella fiondadel tempo / come la scaglia del sasso battuto / dell’im-provvisata strada di guerra»).90
Di slancio vitale Ungaretti parla, del resto, nel più lun-go degli articoli dedicati a Bergson:
Canta Ronsard:
104
89 Id., L’évolution créatrice, cit., pp. 723-724.90 G. UNGARETTI, Il porto sepolto, cit., p. 63.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 104
Las! Non pas le temps, mais nous nous en allons, e indovi-na la perennità del tempo e noi in essa, parvenze fuggiti-ve certo, ma – ci dirà Bergson teso a far della coscienza larealtà unica, a identificarla con quell’assoluto ch’egli chia-ma slancio vitale – incarnazione momentanea dell’eter-nità, per quel passato di cui siamo lo slancio, e quell’av-venire che rampollerà dal nostro passaggio. Il nostro ato-mo di tempo non è perduto nell’eternità, è una goccia delgran fiume.
L’uomo è profondo!La lingua è il simbolo della civiltà d’un popolo. E dalposto che occupa il tempo nella struttura della lingua d’unpopolo si stima il grado di civiltà di detto popolo.91
Il popolo e la lingua, l’appartenenza a un divenire col-lettivo come «incarnazione dell’eternità»: nel finale di que-sto brano sono fissate le coordinate principali della tardainterpretazione ungarettiana dello slancio vitale di Berg-son. Un’interpretazione incentrata sulla continuità storicache lega gli appartenenti a un popolo nel divenire dellegenerazioni e sull’idea della lingua come espressione ditale continuità. Non a caso, il poeta indica, nello stessoarticolo, «il senso della storia, il senso del muoversi deltempo, il senso della genesi e della forza di sviluppo del-la lingua, il senso del tempo e dello slancio vitale conte-nuti nella sostanza della lingua»;92 fa riferimento allo «slan-cio vitale d’una stirpe di re com’è il popolo italiano»;93
ricorre, altrove, a un’immagine analoga a quella del «granfiume della vita» («È ricomparso nella storia il torrente, ilpopolo»)94 per alludere all’ingresso del popolo nella sto-ria, avvenuto a suo avviso con il fascismo.
105
91 Id., L’estetica di Bergson, cit., pp. 82-83. Corsivi nel testo.92 Ivi, p. 84.93 Ivi, p. 81.94 Id., Originalità del fascismo, in «Il Mattino», 20-21 febbraio 1927, ora in
SI, p. 153.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 105
La continuità della storia è vita collettiva della nazioneche si prolunga oltre l’esistenza dei singoli. Una visioneche Ungaretti ravvisa in Virgilio nelle lezioni brasiliane:
[...] per Virgilio il singolo non è immortale, ma immortaleè il tempo, in quanto il tempo è fisicamente continuitàinfinita d’una stirpe, e spiritualmente, unità di storia.95
Virgilio ha il culto dei morti nel senso del principio sacrodell’eredità: il figlio eredita il padre, nel senso che il nucleodella società è la famiglia, che dallo sviluppo d’una fami-glia e dal suo estendersi si forma la nazione, che la nazio-ne in un certo senso è una grande famiglia nella quale tut-ti i componenti hanno un legame di sangue cogli antenatie con i discendenti, con il passato e coll’avvenire, che que-sto filo che lega fisicamente le generazioni d’una nazionenel passato e nell’avvenire costituisce la continuità storicad’una nazione come l’unità storica la costituisce il suo spi-rito, cioè quella civiltà che attraverso i secoli, colle operecompiute o da compiersi manifesta le profonde disposizio-ni e le caratteristiche qualità morali d’una nazione.96
Ma applicando alla continuità storica la propria inter-pretazione dello slancio vitale, Ungaretti può aver trattoanche da Bergson l’idea di una vita collettiva, che avanzainarrestabile, eterna, capace di sconfiggere la morte:
[...] une immense armée qui galope à côté de chacun denous, en avant et en arrière de nous, dans une charge
106
95 Id., [Dante e Virgilio], testo di lezioni tenute fra il 1938 e il 1942, ora inG. UNGARETTI, Dante e Virgilio, testo attinente ai corsi tenuti all’Università diSan Paolo negli anni 1938-1942, in VL, p. 664.
96 Ivi, p. 668. Su Ungaretti e Virgilio si vedano: M. PETRUCCIANI, Didone.La memoria e Virgilio e Dante, in Il condizionale di Didone, cit., pp. 15-51e 111-249; S. SCONOCCHIA, Ungaretti e i classici latini: Lucrezio e Virgilio, nel-l’opera collettiva Ungaretti e i classici, cit., pp. 59-89; S. CRISTALDI, Ungaret-ti, Dante e il nuovo Enea, in AA.VV., Giuseppe Ungaretti: identità e meta-morfosi, atti del convegno internazionale di Lucca, 4-6 aprile 2002, a cura diL. Fava Gazzetta et. al., Lucca, Pacini Fazzi (in corso di stampa).
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 106
entraînante capable de culbuter toutes les résistances et defranchir bien des obstacles, même peut-être la mort.97
Può avere visto nella adesione alla durata storica unavia di riscatto al perire dei singoli e di approdo all’inno-cenza. Così Ungaretti interpreta Bergson:
Dans cette continuité Bergson introduit l’intuition, abolis-sant ainsi, tout en la confirmant, la durée dans le but de ladévoiler, de la rendre révélatrice, poétique, immédiate-ment innocente.98
La continuità storica si svolge nel tempo, si dispiega neldivenire. La sua intuizione è per questo rivelatrice didurata. È però divenire in cui la cui vita non perisce, dura-ta «abolita» in quanto indice di «caducità». Durata «inno-cente», al contrario, perché protrae la vita dei singoli inquella della specie e la rende vittoriosa sulla morte.Anche nell’adesione alle matrici culturali, nell’aggancioalla tradizione, in primo luogo letteraria, Ungaretti ha pra-ticato la fede nella continuità, l’ideale di resistenza dellavita alla morte come ragion d’essere della poesia.
6. La memoria, il sogno e d’intorno la morte
Strettamente legata al tempo e alla durata è in Ungaretti laquestione della memoria. Talmente importante da assu-mere carattere onnipervasivo («Tutto tutto tutto è memo-ria»),99 da indurlo a rilevare, in termini vicini all’insegna-mento di Bergson, che persino la percezione di ciò che èpresente è intrisa di ricordo:
107
97 H. BERGSON, L’évolution créatrice, cit., p. 725.98 G. UNGARETTI, Ma poétique, cit..99 Id., Influenza di Vico sulle teorie estetiche di oggi, conferenza tenuta in
Brasile nel giugno 1937, ora in SI, p. 345.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 107
L’oggetto stesso materialmente presente dinanzi a noi, è,nell’atto stesso di riflettersi nella nostra mente, ricordo, eperché la nostra mente non lo potrebbe riflettere se dalricordo non avesse appreso ad averne coscienza ed anominarlo, e perché intercorrerà sempre un lasso di tem-po, sia pure infinitesimale, tra il momento preso di miranell’oggetto e il momento in cui l’osservatore ne avrà chia-ra e distinta percezione: e l’avrà quando il momento mira-to sarà già passato.100
En fait, il n’y a pas de perception qui ne soit imprégnée desouvenirs. Aux données immédiates et présentes de nossens nous mêlons mille et mille détails de notre expérien-ce passée. Le plus souvent, ces souvenirs déplacent nosperceptions réelles, dont nous ne retenons alors que quel-ques indications, simples «signes» destinés à nous rappelerd’anciennes images101.
Per Bergson memoria e durata sono sinonimi. Lo scor-rere indiviso degli stati di coscienza è infatti memoria nelsuo prolungare il passato nel presente:
La durée intérieure est la vie continue d’une mémoire quiprolonge le passé dans le présent, soit que le présent ren-ferme distinctement l’image sans cesse grandissante dupassé, soit plutôt qu’il témoigne, par son continuel chan-gement de qualité, de la charge toujours plus lourde qu’ontraîne derrière soi à mesure qu’on vieillit davantage102.
Benché la visione ungarettiana del tempo diverga percerti aspetti dal bergsonismo, l’idea di memoria comeflusso indiviso sembra lasciare qualche traccia nei saggi:
108
100 Id., Poeta e uomini, in «L’Universitario», 30 marzo1946, ora in SI, pp.739-740.
101 H. BERGSON, Matière et mémoire, Paris, Alcan, 1896, ora in Œuvres,cit., p. 183-184.
102 Id., Introduction à la métaphysique, cit., p. 1411.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 108
Qui conviene spiegare meglio come vedo la forma petrar-chesca, e il mio modo di sentirla e di capirla. Apertasi essaindefinitamente progressiva a costituire una espressione dialta umanità [...] essa è sommamente evocatrice per esser-si tanti momenti lontani e diversi nell’animo, entro di essa,integrandosi in un unico continuo flutto, resi chiari facen-do luce nella notte del tempo.103
[...] nel Petrarca le rovine del passato tendevano a ricosti-tuire nell’unità della memoria, il sapere, e, insieme alsapere nella sua malinconia di flusso e mutamento conti-nui, la bellezza e l’amore immortali;104
Ma gli aspetti della riflessione di Bergson sulla memo-ria che più possono avere inciso su Ungaretti sono quelliriguardanti la conservazione del ricordo e le condizioni dirimemorazione. Temi che interessano il versante “positi-vo” dell’ungarettiana idea di memoria. Quello per cui ilricordo resiste alla scomparsa delle cose, le riscatta in unambito mentale:
Laura, l’antico e la sua arte inarrivabile, passato, luci chenella mente durano senza fine come ravvivate dall’infinitodisfacimento del nostro essere.105
Memoria: e Silvia nella memoria discorre, presente persempre, corpo presente106
Ciò che è stato, è stato per sempre, è divenuto patrimoniodella mente.107
109
103 G. UNGARETTI, Significato dei sonetti di Shakespeare, in «La Voce delleArti e delle Lettere», VI (1962), 1 e 2, ora in SI, p. 555.
104 Id., Vita d’un uomo. Fedra di Jean Racin, Milano, Mondadori, 1950,ora [Sulla Fedra di Racine] in SI, pp. 577-584: 582-583. Sul divenire dellamemoria, cfr. anche C. Ossola, L’assenza memorabile, cit., p. 119.
105 G. UNGARETTI, Immagini del Leopardi e nostre, cit., p. 437.106 Ivi, p. 443.107Annotazione autografa in margine al manoscritto di Canzone de La
terra promessa, riportata in L. Piccioni, Le origini della «Terra promessa», inTP p. 462.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 109
Ogni cosa è effimera, mortale, consumata dal tempo,ma per ciò stesso anche indelebile e eterna, «presenzairrevocabile»108 nella memoria. Essa conserva ciò che iltempo distrugge, ne trattiene per sempre il ricordo. Unga-retti può avere tratto da Bergson la convinzione che tuttoil passato è custodito dalla memoria in modo integrale epermanente:
Oui, je crois que notre vie passée est là, conservée jusquedans ses moindres détails, et que nous n’oublions rien, etque tout ce que nous avons perçu, pensé, voulu depuis lepremier éveil de notre conscience, persiste indéfiniment.Mais les souvenirs que ma mémoire conserve ainsi dansses plus obscures profondeurs y sont à l’état de fantômesinvisibles. Ils aspirent peut-être à la lumière; ils n’essaientpourtant pas d’y remonter; ils savent que c’est impossible,et que moi, être vivant et agissant, j’ai autre chose à faireque de m’occuper d’eux .109
Benché nulla nella memoria si cancelli, per Bergsonsono di norma presenti alla coscienza i soli ricordi utilialle necessità del momento. Tutti gli altri ne rimangonofuori, inconsci ma non perduti. E anche Ungaretti affermache la memoria può essere dimenticanza, oblio, che perònon esclude la conservazione del ricordo:
Anche l’oblio è memoria, memoria oscurata che per virtùimplacabile dell’ispirazione si snebbierà [...].110
Il filosofo ha inoltre indicato le condizioni per un piùesteso affiorare di ricordi. Esse si determinano nel distac-co dall’azione, nella rêverie e nel sogno:
110
108 M. PETRUCCIANI, La discesa nella memoria, il pilota innocente. Unga-retti e Virgilio, in Il condizionale di Didone, cit., p. 146.
109 H. BERGSON, Le rêve, in «Bulletin de l’Institut Psychologique Interna-tional», I (1901), 3, poi in L’énergie spirituelle, cit., ora in Œuvres, cit., p. 886.
110 G. UNGARETTI, Immagini del Leopardi e nostre, cit., p. 437.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 110
Mais si notre passé nous demeure presque tout entiercaché parce qu’il est inhibé par les nécessités de l’actionprésente, il retrouvera la force de franchir le seuil de laconscience dans tous les cas où nous nous désintéresse-rons de l’action efficace pour nous replacer, en quelquesorte, dans la vie du rêve. Le sommeil, naturel ou artificiel,provoque justement un détachement de ce genre.111
Les images passées, reproduites telles quelles avec tousleurs détails et jusqu’à leur coloration affective, sont lesimages de la rêverie ou du rêve;112
Un être humain qui rêverait son existence au lieu de lavivre tiendrait sans doute ainsi sous son regard, à toutmoment, la multitude infinie des détails de son histoirepassée113.
In Ungaretti, la compresenza di distacco dall’azione,sogno, rêverie e ricordo è assai frequente nei componi-menti delle due prime raccolte. Nelle Suppliche,114 distac-co dall’azione e rilassamento sono espressamente indicatinei versi di apertura e chiusura del componimento, com-posti entrambi di una sola parola, i quali fissano in «Tran-quillità» la tonalità emotiva dell’evocazione. Corrispondead essa un vasto affiorare di ricordi. Si fa riferimento alviaggio in nave dall’Egitto all’Italia («Un lieve sprofondo diflutti / al lontano ingombro del cielo / Orizzonte d’oceanocinque nottate contemplato / sdraiato a prua accanto aemigranti soriani / donne botti uomini pertiche bimbifagotti / spiaccicati a sedere / o trotterellando / mormora-vano una ninnananna / li guidava un mugolìo di piffero /Faceva freddo / sciambrottato in quel dominio di piro-
111
111 H. BERGSON, Matière et Mémoire, cit., p. 295.112 Ivi, p. 251.113 Ivi, p. 295.114 In «Lacerba», 15 marzo 1915, poi, rimaneggiata, con il titolo di Nebbia,
in Allegria di naufragi, cit., ora in TP, pp. 389, 853-855.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 111
scafo orco (vv. 2-12). Si allude quindi a una misteriosa«balia della Brianza» («balia della Brianza / scarlatto trepi-do represso tra due globi d’oro e il macigno del viso /sopra fulvo azzurro piombante affusolato / e tozza ripiditàa piedistallo / bianco e scarlatto listati a bruno», vv. 54-58),alla nutrice sudanese («Balia sudanese che mi ha allevato/ il sole che l’aveva bruciata le ho succhiato / O mio pae-se caldo ho avuto stanotte nostalgia del tuo sole / o suda-nese snella tutta evanescente di grigio azzurro» (vv. 61-64),a una notte nebbiosa che è forse la circostanza dell’evo-cazione e le cui luci richiamano i lumi utilizzati nei fune-rali dagli ebrei egiziani («Respiro ora che i lumi si struggo-no / vagiti o rantoli rotolanti nella nebbia / eco in proces-sione che si estingue lontano / e languiscono perplessi /viatico al selciato umido riflessi / viscidi viola argentei rab-brividire / e lascivi argentei limone / come quelli copertidi crespo / che adoprano gli ebrei di Levante / portandovia i loro morti di sabato sera», vv. 31-40). Questi ricordisembrano apparire in modo scombinato, slegati l’uno dal-l’altro, come per effetto di libera associazione. Un’atmo-sfera assorta pervade infine il componimento: come fosseesplorata una zona di confine tra sogno e realtà, uno sta-to di rêverie, di libero vagare del pensiero e del ricordo.Con la condizione di forte rilassamento alla quale si èaccennato, è la combinazione di questi tre elementi (rêve-rie, apparizione dei ricordi, la loro libera associazione) afissare, in misura preponderante, la matrice bergsonianadel componimento. Tocca ancora rilevare che ad una sor-ta di ritorno in sé, di scoperta del segreto dell’essere, diriconoscimento, si allude nei versi centrali: «Il bindolososta / Compiti gli anni della servitù / Tatuaggio mi scavonel cuore di questo momento / che l’orologio ha segnatod’un battito dolce / Come baco nascosto nel bozzolo sal-vo / quando gli spuntano le ali / s’inizia al bacio e si logo-ra le sue tenebre / Ora mondato come vino dagli anni /Rinvenute le strade del mio segreto / m’intride un miouragano d’incandescenza / Cristallo di rocca trasparenza
112
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 112
dell’essere mio / al mio esclusivo e perenne apparire esvanire / Fluire nella più sottile e intima arteria della poe-sia // Vivo» (vv. 13-26). È del tutto possibile che questoriconoscersi sia da riferire alla traversata verso l’Italia cui siallude nei versi precedenti e assuma significato nazionaleo di appartenenza etnica. Ma nemmeno è da escludereche sia legato all’esteso ripercorrimento memoriale chenella poesia si sviluppa, come è il caso del più noto rico-noscimento dei Fiumi. Quest’idea di riconoscimentocome ritorno di memoria ci riconduce allora nuovamenteal filosofo francese: non configura una corrispondenzaprecisa, perché in Matière et mémoire, il riconoscimento èsempre “identificazione” di una percezione esterna; ma,stabilisce, se non altro, una consonanza di fondo, perché,il tornare del ricordo, il suo rifarsi presente alla coscienzacostituiscono il tratto peculiare del fenomeno, nonché laragione per la quale è studiato. Definizioni di riconosci-mento che nel libro sono presenti («atto concreto attraver-so cui prendiamo possesso del passato nel presente»,«movimento concreto con cui il passato e il presente giun-gevano l’uno a contatto dell’altro»)115 si incentrano delresto sulla sola attualizzazione del ricordo e trascurano lapercezione che serve a richiamarlo.
Nelle restanti poesie della prima fase, la concomitanzadi sogno, rêverie e ricordo ha notevole frequenza. Il casopiù evidente di escursioni memoriali nel sonno (e dunquein sogno) è costituito da Risvegli:116 un viaggio a ritrosonel tempo («Ogni mio momento / io l’ho vissuto / un’altravolta / in un’epoca fonda / fuori di me // Sono lontano
113
115 Cfr. H. BERGSON, Matière et mémoire, cit., p. 235: «Or l’acte concret parlequel nous ressaisissons le passé dans le présent est la reconnaissance»(corsivo nel testo); e p. 367: «Nous étions amenés ainsi à suivre dans toutesses évolutions le mouvement progressif par lequel le passé et le présentarrivent au contact l’un de l’autre, c’est-à-dire la reconnaissance».
116 G. UNGARETTI, Il porto sepolto, cit., pp. 58-59. La redazione inviata aPapini, con il titolo di Terra colpita terra ricreata, reca, al v. 6, «memoria»invece di «malinconia» [cfr. Id., Poesie e prose liriche, cit., p. 24] .
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 113
colla mia malinconia / dietro quell’altre vite perse») haluogo prima del risveglio («Mi desto in un bagno / di carecose consuete / sorpreso / e raddolcito»).
Intrisa di memorie la Malinconia («Calante malinconiaper il corpo avvinto al suo destino / [...] Abbandono dol-ce / di corpi / pesanti d’amaro / labbra rapprese / in tor-nitura di baci / lontani / voluttà di corpi / estinti d’insa-ziabili voglie») del componimento omonimo.117 I «bacilontani» possono alludere a un ricordo e questo legarsiall’impulso sessuale, come indicano i «corpi estinti di insa-ziabili voglie» e le «labbra rapprese in tornitura di baci lon-tani». La «spasimante passione» figura ancora nei versi suc-cessivi («Mondo / Giro volubile di razzi / alla spasimantepassione / attonimento di mill’occhi / in una gita / dipupille amorose»), dove la «gita di pupille amorose» è for-se la confusa immagine di una rêverie; tanto più che è«evanescente» e sembra compiersi, da ultimo, in uno statointermedio tra la veglia e il sonno, sfumando poi in que-st’ultimo: «In una gita evanescente / come la vita che se neva / col sonno / e domani riprincipia / e se incontra lamorte / dorme soltanto / più a lungo».
Tra il sonno e la veglia si colloca il ricordo di Immagi-ni di guerra («Mi pare / che un affannato / nugolo di scal-pellini / batta il lastricato / di pietre di lava / delle miestrade / e io l’ascolti / non vedendo / in dormiveglia»)118
relativo «agli scalpellini pugliesi assunti dal Municipio diAlessandria per lastricare con pietra di lava le strade dellacittà», come suggerisce una tarda nota dell’autore.119
Carattere memoriale ha ancora il sogno di Nostalgia(«Stanotte / ho sognato / una gran / piana / striata / di ver-de / di fresc’alga / immersa / in varianti / veli / azzurr’o-ro»120), almeno se ci si attiene, di nuovo, alla precisazione
114
117 Id., Il porto sepolto, cit., pp. 60-61.118 Ivi, pp. 69-70.119 Id., Note, cit., p. 524.120 Id., Allegria di naufragi, cit., ora in TP, p. 649.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 114
del poeta, secondo cui «la piana a cui si allude è quella diAlessandria, stretta nelle braccia del mare».121
In Fase d’Oriente,122 il momentaneo “distrarsi” del pen-siero richiama ricordi del tempo andato («Si chiudono gliocchi / per guardare nuotare in un lago / le dolcezze deltempo svanito»). Attimo di rêverie cui segue il ridestarsialla condizione attuale («Ci rinveniamo a marcare la terra/ con questo corpo / che ora troppo ci pesa»). In Paesag-gio, infine, lo stato di evidente rilassamento («Fermato adue sassi / languisco / sotto questa immensa / appannatavolta di cielo»)123 suscita l’apparire di ricordi egiziani («Unavolta / non sapevo / che è banale / la consunzione / delcielo / al tramonto / e mi affievolivo poi / adagiato sullamia terra africana / calmata / a un arpeggio / perso perl’aria»).
Ma il caso più suggestivo ed esteso di recupero memo-riale in Ungaretti è certamente costituito dai Fiumi.124.L’a-namnesi suscita qui il riconoscimento: la loro concomi-tanza segnala una prima affinità con Le Suppliche di«Lacerba» e un comune elemento di riferimento a Bergson.Analoghe inoltre le condizioni di rimemorazione: benchésia assente ogni riferimento al sogno, il ripercorrimentodel passato è ottenuto in uno stato di radicale distaccodall’azione, indicato anche con allusioni alla morte: Unga-retti si ricorda disteso nell’Isonzo come «in un’urna d’ac-qua» e «come una reliquia» a riposare («Stamani mi sonodisteso / in un’urna d’acqua / e come una reliquia / horiposato»); evoca un rimettersi completo alla corrente, chescorrendo lo «levigava come un suo sasso» («L’Isonzo scor-rendo / mi levigava / come un suo sasso»); è assorbitonella docilità del sentimento panico ivi conseguito («Que-sto è l’Isonzo / e qui meglio / mi sono riconosciuto / una
115
121 Ivi, p. 525.122 Id., Il porto sepolto, cit., p. 47.123 Ivi, pp. 75-76.124 Ivi, pp. 71-74.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 115
docile fibra / dell’universo»). Al distacco estremo dall’a-zione corrisponde un ritorno sconfinato di memoria: «Horipassato / le epoche / della mia vita». Ripassare le epochedella propria vita è ritrovare il passato, riconnetterne alpresente le fasi, può equivalere a una sorta di visione del-l’eterno. Sentimento dell’eterno, innocenza, capacità diripercorre la vita trascorsa sono tutti evocati da Ungarettiin un passo più volte presente fra i saggi della maturità:
E anche le persone del nostro dramma, di artisti del primoNovecento, sono la memoria e l’innocenza. L’innocenza, abbiamo saputo com’è fatta. Ci è apparsa, eci ha tenuto sotto le sue ali più grandi, nei rivolgimenti diquesti anni. Ci occupava tutta la mente. La memoria avevagli occhi bendati, poteva dirsi abolita. Persino la nozionedi tempo era nuova. Il tempo pareva eterno, non permodo di dire. Non ci è stato nascosto l’orrore dell’eternità.Non contava più che l’istinto. Si era in tale dimestichezzacolla morte, che l’intero film del naufrago ci ripassavaogni momento in mente, e non c’era oggetto che non celo riflettesse; era, la nostra vita da capo a fondo, l’oggettostesso sul quale cadeva il nostro sguardo.125
Si riconsiderino adesso alcuni dati esposti nel terzocapitolo. Il film che «ripassava ogni momento in mente» èla visione integrale del passato occorrente ai naufraghi inpunto di morte: nello stesso saggio, discutendo della «setedi memoria del secolo decimonono», Ungaretti vi accennapoco prima, evocando «l’immagine del naufrago che, sul
116
125 Id., Innocenza e memoria, in «Il Mattino», Napoli, 21-22 maggio 1926,ora in SI, p. 130, corsivo mio. Passi analoghi figurano in Innocenza e memo-ria, in «L’Italiano», Bologna, 12-13, 7 ottobre 1926; Innocence et mémoire, in«La Nouvelle Revue Française», 1er novembre 1926; Naufragio senza fine(Risposta a un’inchiesta sulla poesia), in «Gazzetta del Popolo», Torino, 21ottobre 1931; Poesia e civiltà, testo di conferenze tenute da Ungaretti tra il1933 e il 1936 Questi scritti sono riportati in SI, rispettivamente alle pp. 129-131, 132-134, 135-138, 262-266, 303-323. Le varianti del brano citato sonoalle pp. 133-134, 138, 264, 320.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 116
punto di perire, rivede tutta la sua vita in un baleno».126 Iriferimenti alla morte riguardano presumibilmente la pri-ma guerra mondiale combattuta dal poeta, l’iniziale indi-cazione del «primo Novecento» conferma questa ipotesi e,tra le poesie scritte in quella fase, il riscontro più prossi-mo è certamente offerto da I fiumi. L’idea di rivisitazionedel passato in vicinanza della morte mette invece di nuo-vo sulle tracce del filosofo francese. Rimanda all’attenzio-ne rivolta da Bergson a una forma estrema di ipermnesia,detta dell’io dei morenti: persone che scampate al rischiodi una morte improvvisa raccontano di aver visto sfilare,nel momento del pericolo, l’intero corso della loro vita127.La spiegazione ricalca il modello precedentemente esami-nato, che lega al distacco dall’azione un più cospicuoritorno di memoria:
Une attention à la vie qui serait suffisamment puissante, etsuffisamment dégagée de tout intérêt pratique, embrasse-rait ainsi dans un présent indivisé l’histoire passée toutentière de la personne consciente, – non pas comme l’in-stantané, non pas comme un ensemble de parties simul-tanées, mais comme du continuellement présent qui seraitaussi du continuellement mouvant: telle, je le répète, lamélodie qu’on perçoit indivisible, et qui constitue d’unbout à l’autre, si l’on veut étendre le sens du mot, unperpétuel présent, quoique cette perpétuité n’ait rien de
117
126 Ivi. Poichè è evidente l’allusione a un ripercorrimento del passato, l’a-bolizione della memoria di cui nel brano si fa menzione pare non doversiintendere come assenza di ricordi. Abolita è la memoria che non recuperail passato, che è coscienza del distacco, della perdita, contraria all’innocen-za. Memoria non più «onesta», tipica del Sentimento del tempo – al cui perio-do (1919-1933) questi saggi appartengono – e che trova rappresentazioneesemplare in Caino: «Figlia indiscreta della noia, / Memoria, memoria inces-sante, / Le nuvole della tua polvere, / Non c’è vento che se le porti via? //Gli occhi mi tornerebbero innocenti, / Vedrei la primavera eterna. // E,finalmente nuova, / O memoria, saresti onesta.»
127 Per un riferimento alla questione dell’io dei morenti, cfr. S. POGGI, Gliistanti del ricordo. Memoria e afasia in Proust e Bergson, Bologna, Il Muli-no, 1991, p. 122.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 117
commun avec l’immutabilité, ni cette indivisibilité avecl’instantanéité. Il s’agit d’un présent qui dure.Ce n’est pas là une hypothèse. Il arrive, dans des casexceptionnels, que l’attention renonce tout à coup àl’intérêt qu’elle prenait à la vie: aussitôt, comme parenchantement, le passé redevient présent. Chez des per-sonnes qui voient surgir devant elles, à l’improviste, lamenace d’une mort soudaine, chez l’alpiniste qui glisse aufond d’un précipice, chez des noyés et chez des pendus, ilsemble qu’une conversion brusque de l’attention puisse seproduire, – quelque chose comme un changement d’o-rientation de la conscience qui, jusqu’alors tournée versl’avenir et absorbée par les nécessités de l’action, subite-ment s’en désintéresse. Cela suffit pour que mille et milledétails «oubliés» soient remémorés, pour que l’histoireentière de la personne se déroule devant elle en un mou-vant panorama.128
Le sujet, revenu à la vie, déclare avoir vu défiler devantlui, en peu de temps, tous les événements oubliés de sonhistoire, avec leurs plus infimes circonstances et dans l’or-dre même où ils s’étaient produits.129
Il tema della rivisitazione del passato in punto di morteha una certa diffusione in letteratura,130 ma numerosi indi-zi inducono a ritenere che proprio Bergson sia la fonte di
118
128 H. BERGSON, La perception du changement, cit., p. 1387. 129 Id, Matière et mémoire, cit., p. 295. Riferimenti alla visione retrospet-
tiva dei morenti figurano anche in «Fantômes de vivants» et «Recherche psy-chique», cit., p. 873 e negli appunti delle lezioni del 1910-1911 al Collège deFrance, ora in Mélanges, cit., p. 849.
130 Per la sua presenza in ambito francese, inglese, tedesco, cfr. G. POULET,Bergson et le thème de la vision panoramique des mourants, in «Revue DeTheologie et de Philosophie», 10, 1 (1960), pp. 23-41. Nessuno degli autorimenzionati (Ballanche, De Quincey, Egger, Ribot, von Shubert, Derepas, Stil-ling, Fechner, Hawthorne, George Eliot) può dirsi familiare ad Ungaretti. Èaltresì da escludere che la conoscenza del tema gli derivi da Pascoli, che viallude in Morte del papa, come egli stesso ha segnalato: «Eppure il suo poe-metto era partito dal concetto patetico che i moribondi in un baleno retro-cedono nella loro memoria dai propri anni a quelli della gioventù, a quelli
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 118
Ungaretti: il filosofo ha molto insistito su questo tema inanni vicini al primo soggiorno parigino di Ungaretti131 emenzione dello stesso è fatta da Albert Thibaudet in unsaggio sul bergsonismo letto dal poeta nel 1923;132 Unga-retti parla di «naufrago», non discostandosi molto da Berg-son che riferisce invece di annegati («noyés»); sottolinea ilcarattere fulmineo («in un baleno») e integrale («l’interofilm del naufrago», «la nostra vita da capo a fondo») dellarievocazione del passato, che per Bergson avviene «enpeu de temps» e ripresenta al morente «tous les événe-ments oubliés de son histoire»; individua in questo statouna sorta di sentimento («orrore») dell’eterno, mentre ilfilosofo definisce «pérpetuel présent» lo sguardo panora-
119
dell’infanzia, sino al raggiungimento dell’istante della nascita, la morte essen-do un ritorno all’infinito precedente la nascita» [G. UNGARETTI, Secondodiscorso su Leopardi, in «Paragone», Firenze, I (1950), 10, ora in SI, p. 463.Nella poesia pascoliana a evocare il passato è una vecchia in fin di vita: «E lavecchietta, dietro il suo pensiero, / guardando il cielo, ora vedea sé stessa, /non così vecchia, su per un sentiero. // Andava col su’ omo, era ben messa,/ incignava quel giorno anzi un guarnello: / andava a su per ascoltar la mes-sa. // Lo conosceva quel viottarello : / era pieno di fragole e di more. / Qua-si quasi n’empiva il suo pannello. // Ma poi ben altro le diceva il cuore, /perché sentiva scampanare a festa : / era la festa delle Quarant’ore. // Ellasaliva i poggi lesta lesta, / canterellando, fresca come brina; / ma in fondo alcuore era tra lieta e mesta. / E si trovava povera bambina : / frignava, diceaPappa, dicea Bombo : / un’altra voce ripetea: Cammina! // Tremava in ariapiù vicino il rombo / del doppio. Lesta, che non è lontano! / Si, ma le suegambette erano un piombo. // Allor sua mamma la pigliò per mano» [G.PASCOLI, Morte del papa, XIII, in Nuovi poemetti, ora in Poesie, Milano, Mon-dadori, 1968, p. 373]. Ciò che Ungaretti sa della visione panoramica dimorenti non può provenire, almeno in forma esclusiva dalla poesia pasco-liana: egli parla di «naufrago», mentre Pascoli di una vecchia nel letto di mor-te; la rimemorazione che essa compie non ha carattere di visione fulminea enon abbraccia l’intera vita trascorsa, limitandosi a scene singole, mentre ilnaufrago di Ungaretti rivede la vita trascorsa fulmineamente e per intero.
131 Cfr. sopra la nota 131. 132 Cfr. A. THIBAUDET, Le bergsonisme, in Trente ans de vie française, par-
te III, tomo I, Parigi, Gallimard, 1923, p. 36. In uno dei saggi su BergsonUngaretti trae spunto dalla lettura di questo libro: «Colla scorta dell’ottimolibro di Thibaudet facciam dunque quattro passi» [G. UNGARETTI, L’estetica diBergson, cit., p. 80].
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 119
mico sulla vita trascorsa; attribuisce infine il recupero tota-le del ricordo all’«esclusivo contare dell’istinto», che comegià si è ricordato, è per Bergson la forma grezza di quel-l’intuizione chiamata a cogliere il divenire indiviso delladurata.133 Nel passo di Bergson che sopra si è citato lavisione panoramica dei morenti è proprio la percezionedi questo divenire continuo, intuizione della durata: l’at-tenzione staccata da ogni interesse pratico abbraccerebbe«l’intera storia della persona» («l’histoire entière de la per-sonne») in un presente che è detto «indiviso» («indivisé»);esso sarebbe colto non come un insieme di istanti stacca-ti e simultanei («non pas comme l’instantané, non pascomme un ensemble de parties simultanées»), ma comemovimento continuo («continuellement présent qui seraitaussi du continuellement mouvant»); il perpetuo presentecosì percepito («perpétuel présent») sarebbe uno scorrereindiviso («mélodie qu’on perçoit indivisible»); «il s’agit» – siafferma infine – «d’un présent qui dure». Ma l’intuizione èla forma raffinata dell’istinto: probabile allora che, nei sag-gi in cui riferisce della visione retrospettiva del naufrago,Ungaretti abbia voluto, scambiando i termini, indicare conistinto l’intuizione dello scorrere della durata interiore, lastessa che Bergson fa coincidere con la visione panorami-ca dei morenti.
Sulla base di quanto precede si possono formulare leseguenti tre tesi: una traccia bergsoniana è riscontrabilenei Fiumi e consiste nella concomitanza di distacco dall’a-zione e ricapitolazione memoriale; un’esperienza analogaa quella della poesia è ricordata nei saggi ungarettiani cheaccostano sentimento dell’eterno al ripercorrimento dellavita trascorsa; elementi precisi di riferimento a Bergson sipossono in essi ravvisare nella allusione alla ipermnesiadei morenti. Di qui due ipotesi ulteriori: la prima è cheUngaretti possa alludere in questi saggi alla ricapitolazio-
120
133 Cfr. Il paragrafo 2.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 120
ne temporale dei Fiumi e all’esperienza del tempo che adessa è legata; la seconda è che la interpreti bergsoniana-mente, visti i riferimenti che sopra si sono individuati. Manon è infine da escludere che l’idea della visione panora-mica dei morenti abbia già inciso nel concepimento dellapoesia: la somiglianza di tale idea con «il ripassare le epo-che della vita» è di per sé evidente; il distacco estremo dal-l’agire, che ne è (bergsonianamente) la condizione, trovaanch’esso riscontro nel componimento, dove esistono acaratterizzarlo – particolare non trascurabile – i simboliciriferimenti alla morte che prima si sono ricordati.134
Tra le poesie della prima fase, la conoscenza ungaret-tiana della visione retrospettiva dei morenti appare delresto documentata da Roman cinéma.135
7. Il sogno incanta, la memoria inganna
Qualche anno più tardi, Sentimento del sogno e Senti-mento della memoria diventano i titoli delle due sottopar-ti de La morte meditata, penultima sezione di Sentimentodel tempo, edizione Vallecchi 1933.136 Il binomio sogno-memoria ha inoltre una spiccata ricorrenza nei saggi:137
121
134 Cfr. sopra le pp. 27-28.135 Si veda, per questo, il capitolo 2.136 Sogno è inoltre un titolo assai ricorrente tra i componimenti che rien-
trano nella storia della raccolta. Cfr. G. UNGARETTI, Il sentimento del tempo,edizione critica a cura di R. Angelica e C. Maggi Romano, Milano, Fonda-zione Mondadori, 1978.
137 Per ciò che riguarda i saggi, Mario Diacono ha rilevato che «a Bergsonrisalgono i concetti ungarettiani di «memoria» e «sogno»; benché il termine«sogno» passi poi per una accezione surrealista e approdi, infine, dopo il ’40a quella leopardiana.» [M. DIACONO, Ungaretti e la parola critica in SI, p.XXIII-XCV: XXIX]. Sul rapporto sogno-memoria e la relativa influenza diBergson sul tardo Ungaretti, cfr. anche C. OSSOLA, L’assenza memorabile, cit.Per l’incidenza di Bergson sulla poetica ungarettiana della memoria, cfr. M.PETRUCCIANI, La «ragion poetica» della memoria, cit.; P. MONTEFOSCHI, Lamemoria. Innesti bergsoniani, cit.; G. GUGLIELMI, Innocenza e memoria, cit.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 121
[...] il fu, profondità d’ogni pensiero, difatti è perno d’ognialternarsi in sogno e in memoria di evocazioni di passa-to.138
Mi fu: al passato remoto. Dunque era vero, non ci siamosbagliati: a muovere gli aggetti, qui, opera, allo stato disogno, una reminiscenza.139
Nella sostanza psicologica delle parole risiede quello slan-cio plastico che, permettendo loro dall’indole degli impul-si d’una vita di ricostruirla, le fa toccanti come realtà che,oscuramente attive nel nostro animo, per un gesto o un’in-tonazione di voce subitamente ritrovate in sogno, oppure,brusco isolamento da ogni altra presenza, nel ricordo,sono restituite a noi come erano prima della loro scom-parsa, non solo nei loro connotati fisici, ma definite daabitudini morali.140
In modo conforme all’insegnamento di Bergson, ilsogno è qui investito, come la memoria, della capacità diricordare il passato. Tra sogno e memoria Ungaretti stabi-lisce però una differenza importante. Il sogno ricorda ilpassato senza la determinazione temporale, l’esatta collo-cazione nella durata che la memoria comporta. Le resur-rezioni del passato in stato di sogno corrispondono, inquesto senso, all’oblio della memoria, come mostrano iseguenti brani su Leopardi:
Quando ci addentreremo nel commento [dell’Infinito],vedremo come Leopardi passi dalla memoria al sogno,cioè ad una memoria che sorga in noi come apparizione,
122
138 G. UNGARETTI, Secondo discorso su Leopardi, cit., p. 475. 139 Ivi, p. 473.140 Id., Significato dei sonetti di Shakespeare, cit., p. 566. Sulla diade
sogno-memoria nei saggi e sui suoi collegamenti con la filosofia di Bergson,cfr. anche M. DIACONO, Ungaretti e la parola critica, cit., p. XXIX e C. OSSO-LA, L’assenza memorabile, cit., pp. 114-115.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 122
con l’oblio cioè delle circostanze di tempo e di luogo pro-prie della memoria, atte e necessarie a indicarne lo svilup-po in una personale coscienza.141
Sempre: l’idillio s’apre con una sollecitazione della memo-ria fattasi sogno – del sogno che annulla i limiti spaziali etemporali; ma li può annullare solo dove esso ha giuoco:nel passato, in ciò che è scomparso, in ciò che è nulla, edè solo campo della parola, dell’evocazione: [...] c’è l’ango-scioso sforzo della memoria a farsi sogno, a conseguirel’oblio.142
Privo di determinazione temporale, senza esatta collo-cazione nella durata, il passato che risuscita in sogno nonserba con sé la consapevolezza d’esser tale:
Il sogno fa sorgere davanti alla nostra mente, ma senza oquasi senza nostra consapevolezza, e ci rende presenti inun momento, o più momenti diversi, o una successione dimomenti del passato.143
Quest’idea di passato dimentico di sé, non riconosciu-to come parte della propria storia, benché ravvisato inLeopardi, può ancora trovare riscontro nella lezione diBergson:
Quant au rêve lui-même, il n’est guère qu’une résurrectiondu passé. Mais c’est un passé que nous pouvons ne pasreconnaître. Souvent il s’agit d’un détail oublié, d’un sou-venir qui paraissait aboli et qui se dissimulait en réalitédans les profondeurs de la mémoire.144
123
141 G. UNGARETTI., Secondo discorso su Leopardi, cit., p. 963. 142 Ivi, pp. 472-473. 143 Id., [Memoria, sogno e immaginazione nel Leopardi], in VL, p. 965. La
lezione è datata 1946-1947.144 Id., Le rêve, cit., p. 885.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 123
Ma attenzione. In quanto privo di determinazione tem-porale, il passato che risuscita in sogno si colloca perUngaretti fuori del tempo, della durata e della memoria:
Campana segue le figure che via via insorgono nel fluireincessante della memoria, e al tempo stesso fissa certimomenti che si distaccano da quel flusso e continuano avivere per proprio conto, con una carica autonoma, nelsogno: che non è più la memoria.145
Conservazione del passato, tempo, memoria, durata,sono invece per Bergson tutt’uno e non esistono momen-ti che se ne stacchino per assumere una esistenza auto-noma.
Nel tardo Ungaretti, la connotazione del sogno e più ingenerale della memoria risente della curvatura negativadel sentimento del tempo che sopra si è esaminata. Lamemoria conserva il passato, lo conserva in eterno, risar-cisce di ciò che il tempo incessantemente cancella.Togliendo al ricordo ogni segno del passato, finanche laconsapevolezza di essere tale, il sogno riscatta dal tem-po, rende l’innocenza, è comparato per questo alla mor-te («Immemore sorella, morte, / L’eguale mi farai delsogno / Baciandomi / [...] Mi darai il cuore immobile /D’un Iddio, sarò innocente»).146 La memoria, invece, sabene che il passato è passato. Da un lato conserva ciòche non c’è più, dall’altro è coscienza della sua mancan-za. Di qui conforto e tormento, il bene e il male dellamemoria, la «carità feroce»147 del ricordo. Questo tormen-
124
145 Il testo, tratto dalle lezioni universitarie su Campana, è stato trascrittoe pubblicato da Mario Petrucciani e pubblicato, è riportato in C. OSSOLA,L’assenza memorabile, cit., p. 114.
146 G. UNGARETTI, Inno alla morte, in Sentimento del tempo, Firenze, Val-lecchi, 1933, ora in TP, p. 117 e 699.
147 Id., Ultimi cori per la Terra promessa, in Il Taccuino del vecchio, Mila-no, Mondadori, 1960, ora in TP, p. 274.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 124
to del ricordo non ha alcun riscontro nella riflessione diBergson sulla memoria.148 Le idee di integrale conserva-zione del ricordo e di un passato dimentico, in sogno,persino d’esser tale possono invece avere inciso – e inmisura rilevante – sulla visione ungarettiana della memo-ria come opposizione al tempo. Proprio questa contra-rietà al tempo, lo sfondo entro il quale tale incidenza sicolloca, è però del tutto estranea all’insegnamento delfilosofo. Mentre Ungaretti insiste sul consumarsi dellavita nel tempo, per Bergson il tempo è la vita stessa chesi conserva, cresce, si rinnova. Come si è visto, solo l’in-terpretazione della durata come continuità storica mostradi avere in Ungaretti degli agganci con la temporalitàbergsoniana.149
8. «Da una parte Platone e dall’altra Bergson»
Sviluppando oltre questa opposizione al tempo «nemico»,Ungaretti giunge a posizioni ancora più distanti da quelledel «maestro». Annullato dal tempo e riscattato dallamemoria, l’essere diviene realtà d’ordine trascendente,ideale, cui si accede per reminiscenza. Il sentimento delnulla abita la sfera temporale, la quale separa dalla cono-scenza assoluta e da una aurora incontaminata. In una tar-do commento alla Canzone che apre La Terra promessa,«varcare la soglia» di una «nuova esperienza» è andare oltre
125
148 Sulle divergenze tra Bergson e Ungaretti riguardo alla concezione del-la memoria, cfr. anche P. MONTEFOSCHI, La mamoria. Innesti bergsoniani,cit., p. 74 («per quel che riguarda i riferimenti a Bergson, si può osservareche, mentre il senso di tormento della memoria è completamente estraneoal filosofo francese, comune a entrambi si palesa invece il suo valore posi-tivo di stimolo e provocazione») e G. GUGLIELMI, «Innocenza e memoria», cit.,pp. 132-133 («Nella memoria di Ungaretti si affacciano infatti temi che era-no completamente assenti in Bergson. Non per caso Il porto sepolto si aprecon la poesia In memoria, ponendo il tema della morte»).
149 Cfr. il paragrafo 5.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 125
la conoscenza dei sensi, accedere ad un «altro grado dellarealtà»,150 superare la storia e le barriere del divenire:
I momenti nei quali il poeta può essere poeta sonoappunto quelli in cui la «prima immagine» «rompe il gelo»costituito da quella infinità di muri che uno dietro l’altro iminuti ci lasciano in eredità – muri impalpabili, che non sipossono toccare, eppure presenti, uno dietro l’altro; e piùi minuti passano e più lasciano in eredità al povero uomo,«muri».151
Queste tesi, più in linea con la tradizione del platoni-smo, si discostano visibilmente dal pensiero di Bergson.Per il filosofo non esistono realtà fuori dal divenire, néreminiscenze che permettano di accedervi. La sua filoso-fia ammette solo contatti diretti, immediati, intuitivi conl’essere. Afferma, soprattutto, che è sbagliato dismettere lapercezione e cercare il vero essere fuori del cambiamen-to, in un ambito puramente ideale. Perché il cambiamen-to è l’essere stesso, la vita, la sostanza delle cose. Nonbisogna porsi, allora, fuori del tempo, ma allargare la per-cezione della durata, sforzarci di entrare più profonda-mente in essa, percepirne il divenire indiviso e autentico:
[...] il n’y aurait pas à sortir du temps (nous en sommesdéjà sortis !), il n’y aurait pas à se dégager du changement(nous ne nous en sommes que trop dégagés!), il faudrait,au contraire, ressaisir le changement et la durée dans leurmobilité originelle.152
Faisons effort, au contraire, pour apercevoir le change-ment tel qu’il est, dans son indivisibilité naturelle: nousvoyons qu’il est la substance même des choses, et ni le
126
150 Id., Note, cit., p. 546. 151 G. UNGARETTI, Note, cit., p. 558. Sul superamento del tempo per via di
memoria, confronta, in questo stesso volume, il capitolo II, par. 7. 152 H. BERGSON, La perception du changement, cit., p. 1376.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 126
mouvement ne nous apparaît plus sous la forme éva-nouissante qui le rendait insaisissable à la pensée, ni lasubstance avec l’immutabilité qui la rendait inaccessible ànotre expérience.153
Tutto questo è assai lontano dal superamento del tem-po, della storia, della conoscenza dei sensi, di cui Unga-retti parla nel testo che sopra si è citato154. Può dunquestupire che proprio in questo scritto il poeta definiscaBergson suo maestro di pensiero:
tutta la mia poesia è un modo platonico di sentire le cose,ed essa ha del resto due maestri nel campo dello spirito,da una parte Platone e i Platonici, e dall’altra Bergson:sono i due maestri che mi hanno sempre accompagnatoquando io ho dovuto pensare.155
A guardar bene, però, egli distingue: Platone e platoni-ci «da una parte», Bergson «dall’altra» e interpreta ormai lapropria poesia come un «modo platonico di sentire lecose». L’ammissione del debito verso il filosofo francese
127
153 Ivi, p. 1390.154 Nello stesso testo, assai distanti dal pensiero di Bergson appaiono
anche i riferimenti all’«intuizione di una forma suprema, dell’idea di purez-za assoluta verso la quale tendiamo» [G. UNGARETTI, Note, cit., p. 559]. Per ilfilosofo francese l’intuizione conosce, in forma immediata, la realtà concre-ta, attuale, temporale, non idee pure o «forme supreme».
155 Ivi, pp. 560-561. Al di là che Ungaretti afferma, ccorre ricordare glistudi che analizzano il suo interesse per filosofi qui non menzionati. Cfr. G.SAVOCA, Ungaretti e Pascal: l’illusione e il cuore, in AA.VV, Ungaretti e ilBarocco. Testi e problemi, atti del seminario internazionale di studi organiz-zato a Roma, dalla Fondazione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti, il 28 mag-gio 1999, Firenze, Passigli, 2003, pp. 113-125; Id., Verso l’infinito: Ungaret-ti e Pascal, in AA.VV., Giuseppe Ungaretti. Identità e metamorfosi, cit.; D.LUGLIO, Sentimento dell’assenza e memoria dell’assenza: presenza del Viconel percorso poetico di Ungaretti, in AA.VV., Ungaretti 2001. Cultura e poe-sia, colloque international organisé par l’Université de Paris-Sorbonne, l’In-stitut Italien de Culture et la Fondazione La Sapienza – Giuseppe Ungaretti,le 19-20 octobre 2001, en corus de publication.
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 127
rispecchia benissimo l’influenza duratura che il suo pen-siero ha avuto sulla poetica ungarettiana. Ma non puòessere legata al contenuto dei brani riportati dianzi, i qua-li configurano, al contrario, una forte divaricazione tra lapoetica di Ungaretti e il pensiero di Bergson.
128
Il confronto 22 Gennaro 4-10-2004 7:55 Pagina 128


































































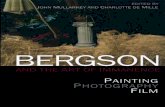









![[Spilimbergo] Il duomo e gli altri edifici di culto](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312c47d5cba183dbf06cb45/spilimbergo-il-duomo-e-gli-altri-edifici-di-culto.jpg)


