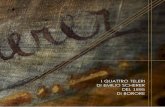un'opportunità epocale per gli ingegneri Carlo Emilio Gadda ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of un'opportunità epocale per gli ingegneri Carlo Emilio Gadda ...
PE
RIO
DIC
O D
I IN
FO
RM
AZ
ION
E (
CIN
EC
A-M
IUR
n. E
2038
72)
DE
LL’
OR
DIN
E D
EG
LI
ING
EG
NE
RI
DE
LL
A P
RO
VIN
CIA
DI
TE
RN
I w
ww
.ord
ingt
r.it
ISSN 1971 - 6648
Ann
o X
XV
III
– N
. 113
– G
enna
io -
Mar
zo 2
018
– Sp
ed. i
n A
.P. –
45%
– F
ilial
e di
Ter
ni
La rivoluzione digitale: un’opportunità epocale per gli ingegneriCarlo Emilio Gadda ingegnere divulgatore
2
LineaVitaR
distributore Umbria per:
Soluzioni per la sicurezza nei lavori in quota!
Foligno (Pg) - Italy | Via A. Clareno 15/D, 06034 | Tel: 0742 320 920 Fax: 0742 32 90 98FAP srl | www.fapsrl.net | [email protected]
Preventivi e sopralluoghi gratuitiRealizzazione di sistemi anticaduta - Verifica analitica della struttura di supporto
Fornitura e posa in opera certificata mediante personale altamente specializzato - Collaudo in operaElaborazione del fascicolo tecnico - Progettazione e realizzazione di elementi di ancoraggio su misura
FAP
SRL
- DU
OM
O O
RVIE
TO
FAP
SRL
- DU
OM
O O
RVIE
TO
FGM
SRL
- IT
IS T
ERN
I
L
Anno XXVIII - n. 113gennaio-marzo 2018
Il contenuto degli articoli firmatirappresenta l’opinione dei singoli Autori.
Direttore responsabile:CARLO NIRI
Caporedattore:MARCO CORRADI
Redazione:
PAMELA ASCANI
MARIO BIANCIFIORI
CLAUDIO CAPORALI
MARCO CORRADI
GIANNI FABRIZI
DEVIS FELIZIANI
ALBERTO FRANCESCHINI
PIERGIORGIO IMPERI
FRANCESCO MARTINELLI
SIMONE MONOTTI
SILVIA NIRI
PAOLO OLIVIERI
MARCO RATINI
ELISABETTA ROVIGLIONI
Sommario
EditoreOrdine degli Ingegneridella Provincia di Terni
05100 Terni - Piazza M. Ridolfi, 4
Responsabile editorialePresidente pro-tempore
Dott. Ing. SIMONE MONOTTI
Direzione, redazione ed amministrazioneOrdine degli Ingegneridella Provincia di Terni
Piazza M. Ridolfi, 4 - 05100 TerniTel. 0744/403284 - Fax 0744/431043
Autorizzazione del Tribunaledi Terni n. 3 del 15/5/1990
Composizione elettronica: MacAugStampa: Tipolitografia ViscontiViale Campofregoso, 27 - Terni
Tel. 0744/59749
In copertina:Foto aerea dell'ex zona industriale di Papigno che mostra l'inarrestabile degrado delle centrali storiche della cascata (v. articoli da pag. 10 a pag. 19)
3
INGENIUM è inserito nell’elenco delleRIVISTE SCIENTIFICHE CINECA-MIUR
al numero E203872
5 Un punto di depressione ciclonica
5 L’altra Cascata di Carlo Niri
6 Un’opportunità epocale per gli ingegneri di Mario Ascari
10 La Cascata e l’energia di Piero Sechi
13 Un giornalista scientifico ante litteram di Paolo Olivieri
16 La SIRI e il motore ad ammoniaca di P. O.
17 Un immenso patrimonio di memoria storica della Redazione
20 Le novità del 2018 di Elisabetta Roviglioni
21 Un nuovo approccio per la qualità ambientale della Conca ternana di Andrea Sconocchia
23 Rinforzo strutturale a vista per edifici storici mediante acciaio inox di Valerio Cavalieri e Marco Corradi
25 Il direttore lavori nell’esecuzione dell’opera di Gianni Fabrizi
26 Formazione continua.... un primo parziale bilanciodi Simone Monotti
28 Passatempi e giochi matematici a cura di F. P.
29 La teoria dei giochi di S. N.
30 Passatempi (soluzioni) a cura di F. P.
31 Partita IVA: quando il professionista deve aprirla e quando noda Ingegneri.info
32 Studio teorico-sperimentale di Simone Menichetti
34 QUÌ INARCASSA: Pensione di vecchiaia unificata
5
Un punto di depressione ciclonica
Il grande scrittore-ingegnere Car-lo Emilio Gadda, di cui trattiamo dif-fusamente in questo numero, nel suofamoso romanzo “quer pasticciacciobrutto de via Merulana” sostenevache le inopinate catastrofi non sonomai la conseguenza o l’effetto chedir si voglia d’un unico motivo, d’u-na causa singolare: ma sono comeun vortice, un punto di depressioneciclonica nella coscienza del mondo,verso cui hanno cospirato tutta unamolteplicità di causali convergenti.
La considerazione sembra fattaapposta per descrivere quanto staaccadendo nella nostra città dove,dopo anni di crisi, l’ultimo “vortice”del dissesto comunale con le dimis-sioni del sindaco e l’avvento delcommissariamento ha portato a fon-do l’amministrazione civica. In que-sto senso appare evidente che, peruscire da una tale “depressione ci-clonica”, non basterà procedere anuove elezioni amministrative, ria-prire la fontana di piazza Tacito e,magari, restaurare il Verdi ma, comeindica appunto Gadda, dovremo pri-ma individuare ed analizzare tutte lesingole “causali convergenti” che“hanno cospirato” contro.
Soltanto dopo aver acquisito que-sta consapevolezza potremo opera-re il necessario rilancio economicoe produttivo, ottenere l’efficienzadei servizi, recuperare la qualità am-bientale, e così via.
Ancora una volta la nostra rivistatorna a porre l’attenzione su quellache, ormai da più di vent’anni, ab-biamo sempre chiamato l’ “altra ca-scata”. In questo numero, infatti, tor-niamo ad occuparci dei due secoli ditecnologia sviluppatisi nel complessodelle Marmore (v. Aticolo dell’inge-gner Sechi a pag. 10), ricordandoanche le appassionate descrizioni delnostro mondo siderurgico fatte all’e-poca dal famoso ingegnere-divulgatoreCarlo Emilio Gadda (v. articolo deldottor Olivieri a Pag.13), fino, pur-troppo, a dover constatare le tristi con-dizioni dello stato attuale delle nostregloriose centrali storiche di Papigno(v. Servizio a pag.18).
Con l’occasione, pertanto, ci sen-tiamo nuovamente stimolati a ribadi-re la necessità di di valorizzare l’altracascata. Quella progettata e realizza-ta dagli uomini, quella che costitui-sce una grandiosa opera di tecnologiaunica al mondo.
Ecco quanto scrivevamo già nel lon-tano anno 2000 su Ingenium e sulla ri-vista internazionale del T.I.C.C.H. :
“I turisti che guardano lo spettacolodelle acque, non sono in grado di com-prendere appieno la particolare ori-ginalità della nostra Cascata.Nonpossono rendersi conto di quale me-raviglioso monumento di archeologiaindustriale sia il complesso delleMarmore. Noi ternani stessi, di soli-to,lo ignoriamo.
Quanti di noi sanno che, in que-st’area, per più di duemila anni, uo-mini di tutte le epoche hanno scava-to e costruito, regolando le acque edutilizzandone la forza per muovere ma-cine di molini,per costruire macchined’acciaio o per produrre elettricità?In una parola:chi si accorge dell’al-tra cascata? Eppure è questa che fadelle nostre Marmore una originalitàunica al mondo”.
Purtroppo, ancora oggi, potremmoripetere le stesse parole, constatandoche l’altra cascata manca ancoradella necessaria valorizzazione turi-stico-culturale.
Carlo Niri
In difesa delle nostre tradizioni
“L’ALTRA CASCATA”
Le vcchie copertine di INGENIUM e di PATRIMOINE DE L’INDUSTRIE che, circa vent’an-ni fa, già ponevano la necessità di valorizzare “l’altra cascata”
6
L’epoca in cui viviamo è caratte-rizzata da profondi cambiamenti. Lenuove tecnologie, internet e la digita-lizzazione di ogni ambito e contestosocio-economico hanno innescato unanuova rivoluzione sociale ed indu-striale. I cambiamenti in atto sono tal-mente incisivi per il futuro del gene-re umano da essere universalmenteconsiderati al pari delle tre preceden-ti rivoluzioni industriali indotte dal-l’invenzione della macchina a vapore,dell’elettricità e dell’elettronica. La tra-sformazione digitale viene infatti con-siderata la quarta rivoluzione epoca-le dell’era moderna. In ambito indu-striale la rivoluzione digitale porteràad una produzione totalmente auto-matizzata ed interconnessa, nella qualeil ruolo del uomo sarà sempre più cir-coscritto ad un ambito di pianifica-zione e gestione. La produzione saràtotalmente effettuata da macchine au-tomatiche fortemente interconnesse egovernate da sistemi digitali che con-divideranno, in tempo reale, dati edinformazioni con il modo esterno.L’interazione uomo-macchina lasceràil posto all’integrazione macchina-macchina che attraverso dispositivi esistemi connessi, prevalentemente wi-reless, consentirà lo scambio e l’ana-lisi dei dati dando vita ad un ecosi-stema denominato “” in cui ogni di-spositivo invierà e riceverà, in realtime, dati che consentiranno al siste-ma globale di reagire e autoregolarsi.
L’adozione massiva delle nuovetecnologie digitali avrà un profondoimpatto su almeno quattro fronti stra-tegici. Il primo riguarda la “Connec-tivity”, cioè l’interconnessione delle ri-sorse (persone, dispositivi, macchine,impianti, strutture, ecc.) e la sistema-tica raccolta, uniformazione e condi-visione dei dati. Il secondo asset con-templa la “Analytics”, che consiste nel-l’analisi dei dati raccolti al fine diestrarne informazioni ad elevato va-
lore. Se si considera che oggi non piùdel 5 % dei dati raccolti viene profi-cuamente analizzato e convertito ininformazioni ad elevato valore si puòcogliere l’importanza strategica ditale asset. Grazie alla capillare con-nettività ed alla notevole potenza dicalcolo, tecnologie come Internet ofThings, Machine-To-Machine, CloudComputing, Big Data e Open Dataconsentiranno una smisurata raccolta,analisi e condivisione di dati che ver-ranno centralizzati, uniformati ed con-servati per innumerevoli usi. Il terzofronte abbraccia la “Human Interface”nel quale l’interazione uomo-mac-china estenderà sempre più l’utilizzod’interfacce fortemente user-friendly(touch, smart, ecc.) e lo sviluppo di si-stemi a realtà aumentata. Il quarto fron-te è quello “Smart Manufacturing” cheannovera le innumerevoli tecnologieche permettono di passare dal digita-le al reale attraverso la produzione dibeni mediante nuove ed innovative tec-niche come la stampa 3D, la manifat-tura additiva, la robotica avanzata, ecc.
Tali tecnologie consentono un’estremaflessibilità ed una produzione di pic-coli lotti con costi e tempi di svilup-po, produzione e commercializzazio-ne particolarmente contenuti. La pro-gettazione e la prototipazione stannogià godendo, da alcuni anni, dei be-nefici di queste innovative tecnologieche consentono un azzeramento delTime To Market. Tutto ciò assicura unamigliore qualità, una riduzione deglierrori ed un incremento della compe-titività e del profitto globale.
La disponibilità di immense massedi dati consentono di monitorare, ri-levare e gestire (in tempo reale) l’an-damento e le variazioni della maggiorparte dei fenomeni che caratterizzanola vita sociale ed economica. In ambitoindustriale, grazie allo sfruttamento deidati (raccolti ed analizzati in temporeale) è già possibile monitorare il flus-so della domanda, pianificare la pro-duzione, ridurre i tempi, ottimizzare lescorte di magazzino, programmare emigliorare i servizi di logistica nonchéattuare una politica di gestione più ef-
La rivoluzione digitale
UN’OPPORTUNITÀ EPOCALEPER GLI INGEGNERI
7
ficiente dei consumi energetici e sal-vaguardia dell’ambiente.
Ciò che caratterizza e contraddi-stingue questa rivoluzione dalle pre-cedenti è la velocità con la quale staavvenendo il cambiamento. A diffe-renza delle rivoluzioni precedenti,che hanno richiesto un paio di decen-ni per produrre un cambiamento sta-bile e tangibile nella società, l’attua-le rivoluzione sta già producendocambiamenti epocali i cui effetti si sta-bilizzeranno in pochi anni. L’elevatavelocità con la quale sta avvenendo ilcambiamento sta mettendo a duraprova l’intero sistema economico e so-ciale dei Paesi con modelli sociali edorganizzativi ancorati a schemi rigidio conservativi. Il dinamismo e laprofonda attitudine al cambiamentosono le principali armi con le qualiconquistare una posizione di rilevo nelnuovo assetto globale. I Paesi che stan-no maggiormente avvantaggiandosidelle nuova rivoluzione sono infatti iquelli che hanno già attivato piani d’in-vestimento per favorire la trasforma-zione dei propri modelli sociali, eco-nomici e produttivi armonizzandolicon la velocità con cui dovranno essereattuati i cambiamenti necessari a co-gliere le nuove sfide imposte dalla di-gitalizzazione.
In estrema sintesi, ciò che differenzaquesta rivoluzione dalle precedenti èla velocità, la pervasività e la trasver-salità con cui le nuove tecnologie di-gitali stanno diffondendosi nella so-cietà, influenzando lo stile e la qualitàdella vita dei cittadini, delle imprese
e delle pubbliche amministrazioni. Icambiamenti e le potenzialità indottidalle nuove tecnologie imprimerannoinfatti un’accelerazione dirompentesulla crescita e la competitività del-l’intero sistema sociale, economico eproduttivo.
La velocità e l’accelerazione saran-no le sfide che caratterizzeranno lanuova epoca che ci approcciamo a vi-vere. L’immensa potenza di calcolomessa a disposizione a bassissimocosto dalle nuove tecnologie unita allasterminata vastità di dati, accessibili intempo reale, consentiranno ai nuovi si-stemi informatizzati di monitorare e ge-stire autonomamente la maggior partedei contesti e processi sociali ed eco-nomici. Le decisioni saranno pertantoprese ed attuate autonomamente da si-stemi automatici in pochi millesimi disecondo sulla base dell’analisi deidati raccolti e condivisi da migliaia disensori e dispositivi intelligenti con-nessi in rete. La velocità con le qualesaranno prese le decisioni rappresen-terà una grande sfida poiché compor-terà di rivedere profondamente le lo-giche, le dinamiche ed i modelli deci-sionali che oggi governano la maggiorparte degli ambiti e dei contesti sociali.La metabolizzazione dell’incrementovertiginoso della velocità con cui do-vranno essere prese ed attuate le deci-sione metterà a dura prova le organiz-zazioni più lente a reagire alle pertur-bazioni o ai cambiamenti, rischiandoseriamente di comprometterne la so-pravvivenza. Chi invece saprà reagirevelocemente riuscirà ad avvantag-
giarsi delle opportunità e dei beneficiche ogni rivoluzione offre a chi sa co-gliere e dominare le nuove sfide.
Ogni rivoluzione industriale è sca-turita a seguito di invenzioni tecnolo-giche che hanno consentito di utiliz-zare una nuova tipologia di “motore”in grado di sfruttare la forma di ener-gia o carburante disponibile a bassocosto. Durante la prima rivoluzione in-dustriale di fine ‘700 la macchina a va-pore rappresentò il “motore” dell’e-poca. Nella seconda rivoluzione ilmotore elettrico e l’elettricità-petroliopermisero al genere umano di fare unbalzo in avanti sulla strada del pro-gresso. Nell’attuale era digitale il“motore” è rappresentato dall’im-mensa “potenza di calcolo” a dispo-sizione di chiunque mentre l’energia-carburante da sfruttare consistononell’inesauribile mole di dati che si ge-nera ininterrottamente attraverso la retee di dispositivi digitali. A differenzadelle precedenti epoche, il carburan-te (dati) non è destinato ad esaurirsi macontinuerà ad aumentare, sia in quan-tità che e qualità. I dati sono pertantola nuova risorsa naturare da estrarre,raffinare, plasmare e manipolare conla quale si potrà governare ogni con-testo della vita. Come in passato, chiriuscirà a dominare e sfruttare lanuova risorsa otterrà benefici strepi-tosi. Chi invece non ci riuscirà soc-comberà.
È bene tenere in considerazione chela quarta rivoluzione industriale è giàin atto e proseguirà con un’accelera-zione esponenziale diffondendosi, inpochi anni, in ogni luogo e ambito so-ciale ed economico. I grandi playerscome Google, Apple, Microsoft, Sie-mens, Bosch, Samsung, Toshiba, ecc.hanno identificato le nuove tecnologiecome l’asset su cui far convergere iloro programmi di sviluppo, desti-nandovi migliaia di milioni di dollaridi investimenti. Anche gli altri opera-tori del settore stanno già fortementeinvestendo su tali tematiche. L’ultimorapporto di ASSINFORM rileva unacrescita vertiginosa degli investimen-ti in tali tecnologie. I settori in cui siinveste maggiormente sono Data Cen-ter e Cloud Computing, Internet ofThings , Web management systems,
8
Software and new Generation Solu-tions.
I Governi dei paesi più avanzatistanno già attivandosi per ottenere ilmassimo beneficio dalla trasforma-zione epocale. Paesi come la Germa-nia e la Cina hanno fatto del Internetof Things (IoT) la principale leva su cuiagire per cogliere le straordinarie op-portunità portate dalla nuova rivolu-zione.
Anche il Governo Italiano ha con-siderando l’Industria 4.0 una delle prin-cipale leve su cui agire per far ripar-tire la crescita del Paese. Il piano In-dustria 4.0 prevede inoltre +11,3 mi-liardi di spese private aggiuntive inR&S nel periodo 2017 - 2020 e +2,6miliardi per gli investimenti privati. Ilpiano del ministro Carlo Calenda pre-vede inoltre incentivi fiscali per 13 mi-liardi attraverso un incremento del-l’aliquota dell’iperammortamento al250% dall’attuale 140% per i beni le-gati alla manifattura 4.0.
Il massiccio utilizzo delle tecnolo-gie digitali sta già creando nuovi sce-nari che, se non gestiti adeguatamen-te, possono esporre a gravi rischi. Si-curezza informatica, privacy, tutela deidati, ecc. sono la punta di un immen-so iceberg che può seriamente com-promettere la rotta verso il cambia-mento e la sostenibilità. Internet e larete non sono più un “modo virtuale”ma hanno assunto una dimensione tal-mente concreta e tangibile da essere di-venute inoltre un nuovo teatro diguerra. In passato le guerre si com-
battevano in terra, mare ed aria. Oggigli attacchi avvengono in rete poichéè sulla rete che ci sono le nuove risorseda conquistare e controllare per do-minare il futuro. Tutto ciò spiega il mo-tivo che sta spingendo Governi, Or-ganizzazioni e gruppi di potere ad ar-marsi delle migliori conoscenze, tec-nologie e strumenti (armi) necessariea conquistare la rete.
Come tutte le altre rivoluzioni in-dustriali, anche quella in atto porteràprofondi cambiamenti nel mercatodel lavoro. È scontato che si svilup-peranno nuove professionalità mentrediverse delle attuali figure occupa-zionali vivranno un’inevitabile tra-monto per scomparire entro qualcheanno. Il settore dell’ingegneria saràampiamente coinvolto in questo pro-cesso. Le opportunità e le sfide che at-tendono gli ingegneri sono di portataepocale. Va infatti considerato chesenza un massiccio contributo degli in-gegneri il Paese e non riuscirà a ca-valcare e cogliere le incredibili op-portunità che la rivoluzione digitaleoffre.
L‘intero sistema ordinistico dovràvelocemente reagire al cambiamentoper adattarsi e rispondere ai nuovi bi-sogni della società. Non a caso l’ulti-mo Congresso degli Ingegneri, tenu-tosi a Palermo lo scorso giugno, si èampiamente focalizzato sul tema,tanto da intitolare il congresso “OF-FICINA ITALIA Progettiamo il cam-biamento” per enfatizzare il ruolocentrale dell’Ingegneria nel processo
di cambiamento che sta investendo ilPaese nei settori delle infrastrutture di-gitali, robotica, mobilità, medicina, in-dustria 4.0, ecc.
Gli ingegneri, ed in particolarequelli dell’informazione, saranno iprincipali protagonisti della nuova ri-voluzione industriale. Ad essi è affi-dato il compito di portare l’intera so-cietà nel nuovo mondo facendole co-gliere le opportunità e contribuendoalla crescita del Paese. Gli ingegneridell’informazione ricopriranno unruolo sempre più strategico e centra-le per il sistema economico. L’ampiadiffusione delle nuove tecnologie di-gitali comporterà infatti una crescitaesponenziale della domanda di figu-re tecniche capaci di governare ilcambiamento e far cogliere le oppor-tunità indispensabili ad assicurare lacompetitività dell’intero sistema in-dustriale. Senza un’adeguata catego-ria di ingegneri, con una specifica edelevata preparazione, competenza edesperienza in ambito digitale, il Paeseperderà l’occasione di avvantaggiarsidelle opportunità e rischierà di mina-re la competitività dell’intero sistemaproduttivo. Più esplicitamente, gli in-gegneri dell’informazione sono tra ipochi soggetti che detengono il know-how tecnologico e gestionale neces-sario per assicurare un proficuo cam-biamento. Il loro ruolo è infatti di vi-tale importanza non solo per l’idea-zione, lo sviluppo, la diffusione el’impiego delle nuove tecnologie di-gitali ma altresì per la gestione dei pro-
9
cessi e l’analisi dei dati e le informa-zioni di elevato valore.
Non va inoltre dimenticato che ilmassiccio impiego della tecnologiadigitale in ogni ambito socio-econo-mico ci esporrà a nuovi rischi. Oltre aitemi legati alla privacy e tutela dei datidovranno essere gestiti anche rischi de-rivanti da una elevatissima automatiz-zazione globale. Già oggi salire su unaereo, prendere un treno, entrare inospedale, ecc. comporta di affidarsi adun sistema digitale che governa e ge-stisce la sicurezza, l’organizzazione eogni processo operativo. La progetta-zione, l’implementazione ed il collaudodei sistemi digitali dovrebbe pertantoseguire gli stessi iter adottati per le altrestrutture critiche per la sicurezza e lasalvaguardia della salute. Purtroppo ilquadro normativo che disciplinata la si-curezza dei sistemi digitali è ancoraparticolarmente acerbo ed inadeguatoa garantire un buon livello di sicurez-za ed affidabilità. La progettazione edil collaudo dei sistemi digitali non è in-fatti riservata a figure con una speci-fica formazione, competenza ed espe-rienza ma è concessa a chiunque di-chiari di vantare un’affinità con le tec-nologie digitali. Ciò è dovuto al fattoche la fornitura di un sistema digitale,anche critico, è soggetta solo alle di-sposizioni normative previste per la for-nitura di beni o servizi e non è consi-derata al pari della realizzazione di
un’opera che necessita di un iter pro-gettuale. Tale approccio porta al para-dosso che la realizzazione di un banalegazebo richiede un progetto ed una spe-cifica autorizzazione mentre l’imple-mentazione del sistema informatizza-to di un ospedale o di un aeroporto puòessere liberamente effettuata da chiun-que, senza nessun progetto e autoriz-zazione.
Da anni gli ingegneri dell’infor-mazione chiedono una maggiore at-tenzione su tali temi ed in particolaresollecitano la necessità di disciplina-re adeguatatene il settore. Nonostan-te qualche passo in avanti sia stato fattoil percorso è ancora lungo ed impe-gnativo. Per favorire ed armonizzarel’attività degli Ordini degli Ingegneri,nel 2005, si è costituito il Comitato Ita-liano dell’Ingegneria dell’Informa-zione (C3I – ) a cui hanno aderito oltre85 ordini provinciali ed il CNI.
Lo scopo del Comitato è di quali-ficare e valorizzare il ruolo dell’In-gegnere dell’Informazione al fine dimettere al servizio del Paese le cono-scenze, le competenze e l’etica pro-fessionale degli Ingegneri dell’Infor-mazione, per offrire una qualità eprofessionalità allineata alle necessitàed attese della committenza. Più pre-cisamente il Comitato C3I svolge le se-guenti funzioni:
Stimola la cooperazione tra le
Commissioni dell’Ingegneria dell’In -formazione degli Ordini provinciali.
Promuove la figura del Ingegne-re dell’Informazione organizzandoeventi per valorizzarne e tutelarne ilruolo.
Proporre al Legislatore normati-ve che, nel rispetto della concorrenza,garantiscano la qualità e la sicurezzadei sistemi digitali.
Fornisce supporto agli Ingegne-ri dell’Informazione del settore C.
Fungere da osservatorio sulletecnologie e sul mercato del ICT.
Stimola un approccio omogeneoin ambito normativo e contrattualisti-co.
Promuovere la crescita profes-sionale e l’attività didattica.
Promuovere la regolamentazio-ne delle attività svolte dagli Ingegneridell’Informazione.
In estrema sintesi, la mission delComitato Italiano dell’Ingegneria del-l’Informazione è di favorire la coor-dinazione e collaborazione degli In-gegneri dell’Informazione per valo-rizzarne il ruolo ed affrontare con,slancio e determinazione, le sfideche il Paese dovrà cogliere per garan-tire un florido futuro alle nuove ge-nerazioni.
Ing. Ascari MarioPresidente C3I
Comitato Italiano Ingegneria Informazione
10
La industrializzazione della concaternana, a seguito della prima rivo-luzione industriale, favorita dallosfruttamento dell’energia idraulica,iniziò nel 1794, con la costruzione diun canale derivato dalla sponda sini-stra del Nera, nei pressi di PentimaBassa, per azionare la Ferriera di PioVI, situata laddove, più di un secolodopo, sarebbe sorta la SIRI. Suc-cessivamente, nel 1873, iniziò la co-struzione del Canale Nerino, deriva-to dalla sponda destra del Nera, sem-pre a Pentima Bassa, per alimentarela Regia Fabbrica d’armi, il Lanifi-cio Gruber, lo Jutificio Centurini ealtri opifici. Il Canale Nerino, con isuoi 27 metri cubi al secondo di por-tata, appariva come la prima vera eimponente opera idraulica industria-le di sfruttamento dell’energia idrau-lica, e per questo fu subito definito“ il fonte battesimale” della Terni in-dustriale. Negli stessi anni, furonorealizzati altri canali derivati dal Ser-simone e dal Canale Nerino in gra-do di fornire l’energia idraulica ne-cessaria per la Fonderia della DittaLucowich, sorta nei pressi della sta-zione ferroviaria. Tutti questi canaliperò erano derivazioni del Nera, equindi potevano consentire limitatidislivelli. Quindi l’energia che se nepoteva ricavare era relativamente mo-desta. Basti pensare che l’opera piùimponente, il Canale Nerino, con unalunghezza di circa due chilometri,sfruttava un salto di soli 17 metri conuna portata di 27 metri cubi al se-condo, conseguendo una potenza di3200 cavalli, con un rendimento di120 cavalli per metro cubo di acqua.
Il salto tecnologico si ebbe nel1884, in concomitanza della costru-zione dell’Acciaieria di Terni, alloraSAFFAT (Società Alto Forni Fonde-ria Acciaieria Terni), quando si resenecessario derivare dal Velino unaportata di 5 metri cubi al secondosfruttando un salto di 200 mt tra l’o-pera di presa e il piano dello Stabi-
limento, e conseguire una potenza di5866 cavalli, pari a circa 1200 ca-valli per metro cubo. L’energia pro-dotta per metro cubo di acqua era die-ci volte quella del Canale Nerino.
L’opera per portare l’acqua dal Ve-lino allo stabilimento di Terni, tutto-ra in funzione, fu chiamata “ Il Ca-nale Motore ”, perché forniva l’e-nergia necessaria per il funziona-mento dell’Acciaieria. Fu un’operaimponente per l’epoca, che partivadall’opera di presa, rimasta inaltera-ta, situata sulla sponda destra del Ve-lino, 400 metri a monte del primo sal-to della cascata delle Marmore, perarrivare in località i Campacci a unlaghetto di decantazione, dal qualepartivano le condotte in ghisa che sisnodavano per oltre 3200 metri e unagalleria a pelo libero lunga 2557 me-tri sul monte Pennarossa. È bene sot-tolineare che l’energia idraulica delCanale Motore non fu mai utilizzataper la produzione elettrica fino al1970, perché all’epoca della sua rea-lizzazione non si era sufficientementesviluppata la tecnologia sia dellemacchine elettriche che delle linee ditrasporto dell’energia. L’energiaidraulica fu utilizzata per azionaregli apparati meccanici dello stabili-mento fino all’introduzione dell’e-lettricità, e successivamente per i pro-cessi produttivi, come il raffredda-mento dei vari apparati.
Quest’opera dette l’avvio alla uti-lizzazione dell’acqua del fiume Ve-lino che si gettava nella Cascata del-le Marmore. Nel frattempo la scien-za elettrotecnica, per merito di An-tonio Pacinotti e Galileo Ferraris,consentì negli ultimi anni dell’otto-cento, l’introduzione dei motori e deigeneratori elettrici, ed il trasporto adistanza dell’energia elettrica. Nel1882 fu installata la prima centraletermoelettrica in Italia, alimentata acarbone, quella di Santa Redegondaa Milano, su tecnologia Edison, perilluminare Piazza Duomo, la Galle-
ria e la Scala. La notevole disponi-bilità di energia idraulica nel territo-rio ternano, evidenziata dalla realiz-zazione del Canale Motore dell’Ac-ciaieria nel 1884, dette un deciso im-pulso alla possibilità di utilizzarel’acqua del Velino per la produzionedi energia elettrica. Ne è una chiaratestimonianza la pubblicazione nel1900 dell’Ing. Pompeo Bresadola “L’Utilizzazione della Cascata delleMarmore per la città di Terni”, dovesu incarico del Sindaco di Terni, pre-sentò un “ Progetto per un impiantoelettrico con officina alla Cascatadelle Marmore”. Tale impiantoavrebbe dovuto servire per la forni-tura di energia elettrica per l’illumi-nazione della città di Terni in previ-sione della scadenza nel 1907 dellaconcessione di tale servizio che il Co-mune di Terni aveva affidato alla SIV( Società Italiana Valnerina) di Cas-sian Bon con una Centrale di pro-duzione, in viale Campofregoso ,ali-mentata da una derivazione del ca-nale Nerino.
Dal progetto dell’Ing Bresadola siavviò così la produzione di energiaelettrica utilizzando l’acqua del Ve-lino a monte della Cascata delleMarmore.
La prima centrale fu realizzata nel1906 dal Comune di Spoleto, con unaconcessione di 2,3 metri cubi al se-condo, con una potenza installata di2400 KW. Essa era situata sulla spon-da sinistra del fiume Nera, in pros-simità dello stabilimento di Colle-statte piano della Carburo di Calcio.
Nel 1908 fu costruita la centraledel Comune di Terni, con una con-cessione di 2,7 metri cubi al secon-do e una potenza installata di 2950Kw. Essa era situata in prossimitàdella centrale di Spoleto, ma sullasponda destra del Nera e adiacentealla strada statale valnerina.
Sempre nel 1908 fu costruita dal-la Soc. Carburo di Calcio la centra-le di Collestatte, a servizio dello sta-
Due secoli di tecnologia nel complesso delle Marmore
LA CASCATA E L’ENERGIA
11
bilimento di Collestatte della stessasocietà, in località Molino Cocchi,sempre sulla sponda sinistra del Ne-ra. La concessione era di 7,6 metricubi al secondo, e la potenza instal-lata di 7800 KW.
Nel 1922 fu costruita la centrale diMarmore, situata sulla sponda sinistradel Nera, in prossimità del secondosalto della Cascata, delle stesse di-mensioni di quella di Collestatte.
Le opere di presa delle suddettecentrali erano situate sulla sponda de-stra del Velino, a circa 150 metri dalsalto principale della cascata. Un ca-nale a pelo libero in galleria di circa700 metri, portava l’acqua dall’ope-ra di presa alle vasche di carico del-le tre centrali, situate nella piana deiCampacci.
Nel 1911 entrò in funzione la cen-trale di Papigno, della Soc. Carburodi Calcio per fornire energia elettri-ca allo stabilimento di carburo di cal-cio di Papigno, a seguito del poten-ziamento e ampliamento di una cen-trale del 1901. La centrale di Papi-gno rappresentò un deciso incremen-to in termini di potenza installata edi energia elettrica prodotta. Con unapotenza installata di 59700 KW, siraggiunse una produzione media an-nua di 172 milioni di KWh. Questa
centrale sarebbe poi stata essenzialeanche per la produzione di calcio-ciannamide dal carburo di calcio eazoto dell’aria, ugualmente prodottaal forno elettrico con un processomolto energivoro. L’opera di presa,inizialmente sulla sponda sinistra delVelino in prossimità della diga Sto-ney di sbarramento della Cascatadelle Marmore, fu definitivamenteabbandonata negli anni successivi peressere associata a quella di Galle-to, la cui realizzazione iniziò nel1925. Anche la condotta di alimen-tazione della centrale di Papigno fuderivata dalla condotta forzata di Gal-leto. In tal modo le centrali di Papi-gno e Galleto costituivano un com-plesso produttivo unico. La centraledi Papigno, oltre ad essere alimenta-ta dal Velino, era alimentata anche dauna derivazione del Nera, derivazio-ne Pennarossa in galleria, con una po-tenza installata di 7000 KW. La gran-de disponibilità di energia elettrica fuuna delle ragioni per la scelta di Ter-ni da parte di Luigi Casale per la mes-sa a punto del processo di sintesi del-l’ammoniaca da azoto e idrogeno.
Con la centrale di Galleto, comple-tata a cavallo del 1930, si attua il pro-getto per il pieno sfruttamento delleacque del Velino a monte della casca-
ta delle Marmore. Con una potenzainstallata di 160.000 KW e una pro-duzione annua media di 738 milionidi KWh, era all’epoca la più grandecentrale idroelettrica d’Italia e tra lemaggiori in Europa. Per conseguireuna tale potenzialità si rese necessa-rio incrementare la disponibilità di ac-qua in misura notevole, con la co-struzione della galleria del “ MedioNera” per derivare l’acqua del Nerada Triponzo, dove erano convogliateanche le acque del Vigi e del Corno,al lago di Piediluco. Questa galleria,lunga 42 Km, fu realizzata in soli treanni, e rappresentò all’epoca un pri-mato mondiale per le costruzioniidroelettriche. Lungo il suo percorsosi resero necessari alcuni ponti cana-li, tra i quali quello di Rosciano, inprossimità di Arrone, una imponentee ardita opera idraulica . Con la rea-lizzazione del “ Medio Nera” il Neradiviene un affluente del Velino attra-verso il lago di Piediluco, e le acquedei due fiumi si ricongiungono com-pletamente dopo gli scarichi delle duecentrali, a valle della cascata delleMarmore. L’opera di presa della Cen-trale di Galleto, sulla riva sinistra delVelino, in derivazione, a pelo libero,convoglia l’acqua del Velino alla con-dotta forzata di alimentazione della
Planimetria centrali idroelettriche gruppo Nera Velino, località Marmore
12
centrale sfruttando un dislivello di cir-ca 200 metri.
La completa utilizzazione delle ac-que del Velino sarebbe stata comple-tata successivamente negli anni 19421943 con la realizzazione dei duegrandi serbatoi del Salto e del Tura-no, i cui scarichi sul Velino, attraver-so la centrale di Cotilia, con una po-tenza complessiva di circa 67.000KW, confluivano sul lago di Piedilu-co, e da qui come descritto, alle cen-trali di Galleto e Papigno.
Nel corso degli anni ’20 e ’30, laSoc. Terni, dopo l’acquisizione dellasocietà Carburo di Calcio, era dive-nuta la proprietaria della quasi totalitàdi impianti idroelettrici del sistemaNera-Velino, e si accingeva a diveni-re una delle maggiori industrie elet-triche nazionali, insieme alla Edison,la Sade (Società adriatica di elettri-cità), la SME ( Società meridionaledi Elettricità), la SIP (Società idroe-lettrica piemontese). Con la realizza-zione dei suoi imponenti bacini di ac-cumulo, la Soc. Terni assunse così unruolo essenziale nel sistema elettriconazionale come cerniera di compen-sazione tra gli impianti idroelettrici al-pini e quelli dell’Italia centrale.
Ma con la seconda guerra mon-diale, il grandioso complesso idroe-lettrico che si era sviluppato intornoalla Cascata delle Marmore, subìgravissimi danni.
Il 10 giugno 1944, fu una data me-morabile per gli impianti idroelettri-ci del gruppo Nera – Velino. I tede-schi in ritirata, distrussero la maggiorparte delle centrali e delle stazionielettriche. Irrimediabilmente dan-neggiate furono le quattro centrali mi-nori descritte in precedenza, alimen-tate dalla sponda destra del Velino.Danni ingenti subirono anche le duecentrali di Galleto e Papigno. Alla da-ta del 10 giugno 1944, il complessodegli impianti della So. Terni, dispo-neva di una potenza installata di340.000 KW, in grado di garantire unaproduzione annua di 1.300.000.000KWh. Rimasero in efficienza duepiccoli generatori con una potenzacomplessiva di soli 250 KW.
L’opera di ricostruzione fu rapidae immediata. Le quattro centrali mi-nori non furono ricostruite per variee comprensibili ragioni. Innanzi tut-to perché il macchinario di questi im-pianti era antiquato ed era quello che
aveva subito i maggiori danni. In se-condo luogo, dopo la costruzione diGalleto, questi impianti minori eb-bero una funzione di riserva e di in-tegrazione per far fronte alle richie-ste di punta. In sostanza la loro uti-lizzazione era molto limitata, e fu na-turale utilizzare le loro concessioniin modo continuativo nei due im-pianti maggiori di Galleto e Papigno,sui quali si concentrarono gli sforzidella ricostruzione, sfruttando un sal-to idraulico maggiore.
Le distruzioni belliche furono l’oc-casione per razionalizzare il com-plesso Galleto – Papigno, in consi-derazione anche del fatto che la Cen-trale di Galleto era stata progettataper il raddoppio della potenza, chefu realizzato successivamente con duegruppi da 80 MW cadauno. Il rapi-do ripristino della Centrale di Papi-gno consentì una disponibilità dienergia in un momento di particola-re criticità per le problematiche de-terminate dagli eventi bellici. Nellostesso tempo furono adottati inter-venti tecnici migliorativi ai fini del-la disponibilità di potenza. A lavoridi ricostruzione compiuti, la potenzaresa disponibile dal complesso Gal-leto – Papigno risultò superiore aquella che prima delle distruzioni bel-liche veniva assicurata dalle due an-zidette centrali e quelle del gruppoMarmore – Collestatte.
La storia degli impianti idroelet-trici alimentati dalle acque del Veli-no e del Nera hanno fatto la storia
dell’industria idroelettrica del paese,contribuendo in modo determinanteallo sviluppo industriale del territo-rio ternano. La Società Terni è statala protagonista, fin dalla sua costitu-zione, dello sfruttamento industrialedelle risorse idriche. Nel 1962 con lalegge di nazionalizzazione, il settoreidroelettrico della Terni viene trasfe-rito all’Enel. La liberalizzazione del-l’energia elettrica del 1999 impone ilpassaggio degli impianti alla societàspagnola Endesa, e successivamentealla società tedesca E.ON. Oggi laproprietà è nuovamente italiana, do-po l’acquisizione nel 2015 da partedella Società ERG.
Piero Sechi
Profilo schematico degli impianti della TERNI sui bacini del Nera e del Velino esistenti e la costruzione al giugno 1944
Piero Sechi, laureato in Ingegneriapresso l’Università “La Sapienza” diRoma, è stato assunto nel 1967 alla“Terni”, dove ha ricoperto il ruolo diDirigente dei Servizi Tecnici di sta-bilimento, partecipando, agli inizi de-gli anni ‘70, al progetto di amplia-mento e potenziamento del sistemaelettrico della Divisione Siderurgica.Dal 1992 al 1995 ha ricoperto l’in-carico di Direttore Generale della Ca-muzzi - Gazometri spa, primariaazienda nazionale nel settore delladistribuzione del gas naturale. Dal1999 al 2004 è stato Presidente del-l’ASM di Terni e successivamentePresidente di Umbria Energy spa e diTerni Reti srl.
13
Nel precedente lavoro su Carlo Emi-lio Gadda (si veda Ingenium AnnoXXVII - N.12I - Ottobre-Dicembre2017), nel ricordarne l’attività di divul-gatore scientifico, ci siamo limitati a ci-tare i tre articoli scritti sull’ammoniacaper la “Gazzetta del Popolo”, nel perio-do aprile-maggio 1937, rappresentan-do un Gadda confinato ai temi di cui siera occupato per l’attività in AmmoniaCasale e quindi in SIRI.
Al tempo Gadda aveva lasciatol’Ammonia Casale da qualche anno(1931) e questo interesse per lastraordinaria vicenda della sintesi del-l’ammoniaca e il fortunato brevettoCasale è stato visto più come un ten-tativo di riavvicinamento alla Societàpresso la quale egli aveva lavorato(che in effetti lo riassumerà), che noncome un vero e proprio interesse al-la divulgazione scientifica.
In realtà, considerando il complessodegli articoli di carattere tecnico diGadda (raccolti in “Carlo Emilio Gad-
da Scritti Vari e Postumi, Pagine di Di-vulgazione Tecnica (1), emerge un in-tento scientifico-divulgativo del - l’ingegnere-scrittore che lo fa, piutto-sto, considerare un vero e propriogiornalista scientifico ante-litteram;anzi, Gadda è tanto convinto dell’uti-lità di una simile funzione da teoriz-zarne in modo esplicito in un articolodell’aprile 1932 su L’Ambrosiano, daltitolo Accessibilità di una rivista, unodei tre pezzi facente parte del gruppodi Divulgazione tecnica ivi pubblica-to (2): Gadda cita l’esempio di una ri-vista francese (“La Science et la Vie”)“semplice nel formato ed accessibilenella scrittura” che “onora certamen-te quello spirito di facilità e di chia-rezza divulgativa che pertiene a un dif-fuso interesse pubblico per la tecnicadella vita contemporanea” e aggiunge“ameremmo questo esempio imitatoin Italia, con uguale serietà e facilità”auspicando “l’esistenza (…) di un ce-to di lettori che amino conoscere i da-
ti di fatto, il meccanismo palese o se-greto della vita e della tecnica”.
E questo è in linea con quanto dicelo stesso Gadda del suo amore per lescienze esatte come riportato da PieroBianucci nell’articolo “Gadda avevaun’idea: l’auto ad ammoniaca, conl’occhiello: Quando l’autore del “Pa-sticciaccio” scriveva di tecnica” (3).
Bianucci ricorda che “nel ‘Gior-nale di guerra e di prigionia’ sotto ladata 31 maggio 1918 Gadda dichia-ra una vocazione scientifica non me-no autentica di quella umanistica: ‘Seavessi una decisa avversione per lamatematica, sarei un uomo felice: migetterei freneticamente sul lavoro fi-losofico e letterario: ma tanto mi pia-ce la matematica, e la meccanica ra-zionale, e la fisica, e tanto più là do-ve si raffina l’analisi’ ”).
Emerge infatti una sorprendenteimmedesimazione di Gadda nelle vi-cende tecniche con le quali veniva acontatto nel suo lavoro di ingegnere,
Carlo Emilio Gadda ingegnere divulgatore
UN GIORNALISTA SCIENTIFICOANTE LITTERAM
Carlo Emilio Gadda visto da Tullio Pericoli
14
unita ad una lucida visione d’insiemein campo industriale; colpisce, in par-ticolare, la molteplicità degli argo-menti trattati, dal settore chimico, al-l’elettrico, al metallurgico e le acuteosservazioni nei raffronti tecnologicied economici. In particolare, per il no-stro territorio, i riferimenti non ri-guardano solo la sintesi dell’ammo-niaca e quindi i rapporti con l’Am-monia Casale, ma tutte le attività chesi erano affermate nell’area o che viavevano lasciato tracce di grande ri-levanza.
Questa attività di divulgazione ini-zia in realtà nel 1921 con un artico-lo su “La Perseveranza”, un foglioche chiuderà l’anno dopo. Gaddascrive un articolo sulla crisi di pro-duzione di elettricità con il sistemaidroelettrico per problemi di siccità;nello stesso anno interviene su la ri-vista “L’Elettrotecnica”, organo uffi-ciale dell’AEI (Associazione Elet-trotecnica Italiana), con un articolosu “L’attuale crisi d’energia. Impiantitermici o idraulici?” in cui affrontaanche il problema dei costi di pro-duzione dei due sistemi anticipandoil tema della possibile dipendenza delprezzo del combustibile dalle crisipolitiche o altro (4).
Segue una lunga interruzione equindi una importante collaborazio-ne con “L’Ambrosiano” inseguita condeterminazione anche dopo gli in-successi iniziali, come confiderà aUgo Betti in due lettere del 1923 ein una del 1931 indirizzata a Bona-ventura Tecchi (entrambi compagnidi guerra e di prigionia) (la foto ri-trae Gadda al tempo di guerra).
“L’Ambrosiano” gli pubblica alcu-ni articoli letterari e una serie di ar-ticoli tecnici quali la serie sui “me-talli leggeri” del 1931, i due articolisull’azoto del 1932, cui seguirannoquelli sulla Fiera di Milano sempredel 1932 e altri del 1934 e 1936.
Completano la serie dell’azoto quel-li già citati del 1937 sull’ammoniaca,che verranno pubblicati, invece, dalla“Gazzetta del Popolo”. Sulla “Gaz-zetta del Popolo” in effetti aveva giàcominciato a pubblicare nel 1935, con-temporaneamente a “L’Ambrosiano”,soprattutto articoli letterari.
Per una trattazione dettagliata del-l’argomento si vedano le Note ai testidi Andrea Silvestri nel libro citato al
riferimento bibliografico (1), da cuiabbiamo tratto questi spunti.
Negli articoli di divulgazione scien-tifica colpisce la competenza e la chia-rezza espositiva; quello che affascina,unitamente alla sintetica descrizionedei processi e dei prodotti, è l’effica-cia linguistica perché anche aridi ar-gomenti tecnici, come dice Piero Bia-nucci, “sotto la penna dello scrittoremilanese acquistano un fascino insi-nuante” (3).
Per gli articoli del 1937 sull’ammo-niaca, Gadda torna a Terni. Così scri-ve Gadda a Lucia Rodocanachi (la si-gnorina conosciuta a Firenze alleGiubbe Rosse, con la quale ebbe unlungo epistolario dal 1935 al 1964:“Lettere a una gentile signora”): “al-cuni articoli “autarchici” sulla “Gaz-zetta del Popolo” (…) mi costringonoa visite di stabilimenti qua e là” (cfr. leNote ai testi di Andrea Silvestri sopracitate). Ed è così che Gadda deve es-sere venuto a conoscenza dei lavoriche il dottor Mario Zavka aveva fatto,nel 1935, sul motore per auto alimen-tato ad ammoniaca.
Bellissime le parole con cui descri-ve la visita all’impianto di Papigno perla produzione di carburo di calcio ecalciocianamide, nell’articolo “Azotoatmosferico tramutato in pane” del1937, anche se esordisce con una sor-ta di rammarico per lo stravolgimentodell’ambiente ad opera dell’uomo:
“Rimontando la valle del Nera così ra-dicalmente manomessa dalle opere,dove il sereno cielo dell’Umbria è ve-lato e fatto greve da bianchi vapori,pensavo quante valli d’Italia, quantisuoi fiumi conoscono la fatica dei mi-nuscoli esseri, indaffarate formiche,che giorno per giorno ne cavano mate-ria di vita, dopo aver contenuto e vin-to la ignara pienezza dell’acque!”(5)
Il Gadda coinvolge il lettore nella vi-sita con una vivacità che nasce anchedalle parole scelte e, spesso, create, inuna sorta di vera e propria ingegnerialinguistica, tipica della sua prosa:
“Pensieri che mi suggeriva il fra-stuono della fabbrica mangiatrice diroccia, il riverbero delle bocche in-candescenti dei forni da carburo. Ec-co i dati naturali: il monte (carbonatodi calcio purissimo, d’un color biancocrema); quello che vedo spaccato dacima a fondo, sopra la forra, nel soledell’Umbria; l’atmosfera; il fiume co-sì fervido e ricco. Ai dati naturali cor-rispondono le opere; la fabbrica di car-buro e di calciocianamide, le centralielettriche. (…) Si aprì difatti al miosguardo, deserta e lucida, la sala dellacentrale: che è la più potente di tuttauna serie; e si è bevuta la cascata delleMarmore. Le enormi trottole degli al-ternatori verticali, da 50.000 cavalli(ognuno), (…) La condotta, quattrometri di diametro, usciva dal monte:entrava in quella cava (…) Le chioc-ciole dei distributori di turbina (…)Così l’impeto delle masse d’acquaviene trasformato in una potenza cheè occulta alla nostra filosofia” (5).
Seguono la descrizione del forno do-ve ad altissima temperatura si forma ilcarburo di calcio e quella della successi-va azotazione del carburo con azoto ot-tenuto dalla distillazione frazionata del-l’aria liquida: “Una rete di tubi e una re-te di barre distribuiscono ai forni azoto ecorrente. Dopo sessanta-settanta ore lamassa è trasformata in calciocianamide:composta di calcio, carbonio, azoto.Macinatala, se ne ottiene una polverebruna, volatile: la si umetta con olio mi-nerale perché, allo spargerla lungo i col-tivi, il vento non se la porti. (…) Ecco co-me l’azoto dell’aria è stato chiuso in sac-chi. (…) L’Italia è stata la prima nazionea produrre calciocianamide su vasta sca-la.” (5) (v. foto).
Gadda è affascinato dal percorsodell’azoto, dall’aria al terreno, e affa-
Carlo Emilio Gadda col fratello Enricoin tempo di guerra (il fratello, pilota della35.ma squadriglia, morirà in un incidente diguerra nell’aprile del 1918).
15
scina con la descrizione di questo ci-clo che vede l’uomo protagonista nelfissare l’azoto dell’aria per riportarloal terreno, per nutrire l’umanità. Ac-canto alla produzione di calciociana-mide menziona “quella assai recentedell’ammoniaca sintetica, del solfatoammonico, e dei nitroderivati: i ki-lowattora del Nera, ad esempio, azio-nano anche una grande fabbrica diammoniaca sintetica. Essa vi è ottenu-ta coi geniali e italianissimi procedi-menti del chimico Luigi Casale, da Vi-gevano, scomparso ancor giovane nel1927” (5).
Piena l’immedesimazione anche ri-spetto agli ambienti e allo spirito del-la gente con cui veniva in contatto,pronto a farne propri i vezzi e i detti,come si può derivare da questa descri-zione contenuta nello stesso articolo:“Ma il pieno deflusso del Nera, o del-la Nera, se preferite, m’avvince: doposerenità di colli, querceti, uliveti, ilfiume va così torbido e ricco, allorchèle sue forre lo inghiottono, che mi ri-viene a mente il detto che dicono a Or-te: ‘Il Tevere non sarebbe il Tevere, sela Nera non gli desse da bevere’ ” (5).
Con la descrizione dei processi edelle produzioni emerge a trattiun’immagine dell’Umbria meridiona-le e delle sue acque frammista a quel-la degli imponenti impianti che vi ave-vano trovato collocazione; incisiva lasintesi contenuta in un passo dell’arti-colo del 1932 “L’esposizione e il con-gresso di fonderia”: “Roma ospiterà icongressisti dal 22 al 27, donde visiteed escursioni ai centri artistici ed in-dustriali dell’Umbria, specie a quellidella zona di Terni, dove le ciclopicheopere idroelettriche gareggiano pergrandiosità e ardimento con quelledell’Alta Italia e forniscono l’energiaagli importantissimi stabilimenti me-tallurgici e chimici della regione.”(6)
Molto aperta l’ammirazione perLuigi Casale come espresso nell’arti-colo del 1932 “I metalli leggeri nel fu-turo prossimo”: “L’acido nitrico è rica-vabile dall’ammoniaca sintetica, a cuila genialità italiana ha dedicato puretanta e così felice attenzione e studio,riuscendo ad imporsi industrialmentecon i processi dell’ing. Giacomo Fau-ser, di Novara, e del compianto dott.Luigi Casale, di Vigevano, alla memo-ria del quale si rivolge ammirata la esti-
mazione degli scienziati e dei tecnici ditutto il mondo” (7) .
L’elogio di Casale si rinnova nel-l’articolo “Pane e chimica sintetica”:“Dopo gli studi di Haber circa la sin-tesi dell’ammoniaca dai suoi duecomponenti e l’applicazione fattanedurante la guerra (i risultati venneromantenuti segreti), si ebbero, in Italia,gli studii e le esperienze di Luigi Ca-sale, perseguiti con silente tenacia du-rante anni e concretati in un metodoindustriale che ha caratteristiche pro-prie e reca, si può dire, l’impronta fe-lice della genialità” (8). E continua:
“Casale esperimentò a Terni: instal-lò il suo primo impianto in una vecchiaofficina sulla sponda sinistra del Nerae raggiunse nel 1920-21 le sue primeconstatazioni probative. E i suoi bre-vetti si diffusero ben presto nel mon-do” (8), ed ebbero anche i tedeschi tragli acquirenti: “Da rilevare appunto co-me i tedeschi, detentori del processoHaber, acquistarono e fecero montarenella regione della Ruhr impianti Ca-sale di grande potenzialità” (8).
Ci piace segnalare che di questa at-tività di divulgatore scientifico diGadda si trova un importante riferi-mento nel materiale del fondo GinoPapuli esistente presso l’Archivio diStato di Terni (cfr. busta n. 27, fasci-colo 89).
La ricchezza di questa trattazione
scientifica da parte di Gadda, unita alcopioso carteggio tenuto da Gaddastesso con l’Ammonia Casale (cfr.“Carteggio dell’ing. Carlo EmilioGadda con l’ “Ammonia Casale S. A.”(1927-1940)), ci induce a proporre al-l’Amministrazione Comunale di Ter-ni di studiare la realizzazione di unpercorso scientifico-letterario chepartendo dal CAOS, e quindi dalla vi-cenda dell’ammoniaca sintetica e delprocesso Casale, si estenda a Colle-statte-Papigno e a tutta la Valnerina fi-no a Nera Montoro; un percorso chepossa diventare attrattivo per studen-tesche di tutta Italia e per un qualifica-to turismo archeo-industriale scandi-to da letteratura magica e illuminante.
Per la parte scientifica relativa al-l’attività della SIRI, si potranno uti-lizzare i poster e il copioso ma terialepredisposto dall’ICSIM e utilizzato nel2004 per la mostra allestita presso l’An-tenna della Pressa e ora custoditopresso l’ITIS di Terni.
Paolo Olivieri
Bibliografia
(1) Carlo Emilio Gadda Scritti Vari ePostumi, Pagine di Divulgazione Tecni-ca, a cura A. Silvestri, C. Vela, D. Isella,P. Italia, G. Pinotti, Garzanti, 1993
(2) Divulgazione tecnica sottotitolo Ac-cessibilità di una rivista, Carlo EmilioGadda, 12 aprile 1932, L’Ambrosiano
(3) L’ingegner Gadda aveva un’idea:l’auto ad ammoniaca, con l’occhiello:Quando l’autore del “Pasticciccio” scri-veva di tecnica, Piero Bianucci, La Stam-pa, Tutto libri, 21.3.1987
(4) L’attuale crisi d’energia. Impiantitermici o idraulici?, Carlo Emilio Gadda,25 dicembre 1921, L’Elettrotecnica
(5) Azoto atmosferico tramutato in pa-ne, con soprattitolo Per l’autarchia eco-nomica, Carlo Emilio Gadda, 13 Aprile1937, Gazzetta del Popolo
(6) L’esposizione e il congresso di fon-deria, Carlo Emilio Gadda, 1931, L’Am-brosiano
(7) I metalli leggeri nel futuro prossi-mo, Carlo Emilio Gadda, 1931, L’Am-brosiano
(8) Pane e chimica sintetica, con so-prattitolo Per l’autarchia economica esottotitolo Fabbricazione dell’ammonia-ca secondo un sistema italiano adottatoin tutto il mondo, Carlo Emilio Gadda, 27Aprile 1937, Gazzetta del Popolo
Manifesto pubblicitario della calciocianamideche si produceva a Terni (opera di Holzer,1948)(notare in alto a sinistra lo storico mar-chio della Terni con la cascata delle Marmore)
Il titolo dell’articolo citato al riferi-mento bibliografico e cioè “L’ingegnerGadda aveva un’idea: l’auto ad ammo-niaca” può far pensare che l’idea del-l’auto ad ammoniaca sia stata di Gadda;in realtà Gadda descrive –nel 1937- so-lo quanto sviluppato in SIRI e brevetta-to tra il 1935 e il 1938 dal dottor MarioZavka Direttore delle Ricerche dellaSIRI.
L’articolo di Gadda in realtà era inti-tolato: Automobili e automotrici azio-nate ad ammoniaca (1) e in effetti l’in-cipit dell’articolo non lascia dubbi:“Ecco i termini del problema: può l’am-moniaca servire agli usi di trazione au-tomobilistica? Vi sono tecnici ed espe-rimentatori che non hanno dubbi al ri-guardo: e nessuno oggi ne dovrebbeavere, poiché si sono compiute prove sustrade normali, con motori ad ammo-niaca applicati a vetture normali, e i ri-sultati sono stati favorevolissimi.” e laprima auto sulla quale il motore fu ap-plicato per prove è stata la FIAT 509dello stesso dottor Zavka.
Con questa vettura il dottor Zavka fe-ce un viaggio da Terni a Trieste con so-ste prestabilite per i controlli e i rilievi.La figura mostra lo schema dell’ali-mentatore della miscela allegato al bre-vetto USA 2, 140, 254 del 1938 (2) (Ar-chivio Zavka).
Senza entrare in dettagli tecnici, sipuò dire semplicemente che l’alimenta-tore è costituito da un vaporizzatore e da
un apparecchio che decompone una par-te dell’ammoniaca (nel brevetto si dicetra il 3,4 e il 18,2%) negli elementi co-stituenti in modo da avere una misceladi ammoniaca, idrogeno e azoto, in cuil’idrogeno ha la funzione di regolariz-zare la marcia del motore “data la relati-va lentezza con la quale avviene l’e-splosione della miscela di aria e ammo-niaca.” (3) La decomposizione si ottienefacendo passare l’ammoniaca su so-stanze simili a quelle utilizzate come ca-talizzatori nella produzione di ammo-niaca sintetica.
Dopo le prove pratiche effettuate daldottor Zavka il motore venne montatosu una “FIAT Ardita 2500” che fu of-ferta a personalità del governo dell’e-poca.
Nel suo articolo Gadda concludeva:“L’ammoniaca, al pari del petrolio e del-la essenza, è energia in scatola: come c’èil salmone in scatola, c’è anche l’ener-gia in scatola. Non mancheranno le dif-ficoltà di messa a punto: ma sarebbe giàmolto poter sopperire a una parte deltraffico, nelle regioni e nelle stagioni piùidonee, con un combustibile che nondobbiamo pagare in oro. Attualmente, aTerni, sono in corso degli esperimenti albanco-prova con un motore di serie(Fiat, Ardita 3500) caricato da freno di-nametrico a bilancia … I detti esperi-menti mirano, fra l’altro, a darci i con-sumi in ammoniaca per cavallo-ora nel-le diverse condizioni di carico …” (1).
L’auto ad ammoniaca però non ebbesuccesso. Stessa sorte toccò al motore ametanolo che venne sperimentato in se-guito (l’utilizzo del metanolo può esse-re considerato in qualche modo il pre-cursore di quello attuale dell’etanolo –si usa il bioetanolo, ottenuto da biomas-se – anche se va chiarito che si tratta diun utilizzo in miscela, in piccole per-centuali, con le normali benzine ndr.).
Nonostante l’insuccesso di questitentativi, va però sottolineata l’eccezio-nale vitalità di ricerca di questa societàche quasi un secolo fa cercò di sostitui-re carburanti tradizionali con sostanzesuccedanee che permettessero ai paesinon produttori di petrolio di affrancarsida onerose importazioni.
P. O.
Bibliografia(1) Automobili e automotrici azionate
ad ammoniaca, Carlo Emilio Gadda, 12maggio 1937, Gazzetta del Popolo (daTerni)
(2) U.S. Patent 2,140, 254 Device foroperating internal combustion engineswith mixtures of ammonia, hydrogen, ni-trogen prepared from ammonia, MarioZavka, Terni, Italy, Dec. 13, 1938 (Archi-vio Zav ka)
(3) Descrizione dell’invenzione aventeper titolo “Combustibile per motori acombustione interna”, 30 ottobre1935/XVI (Archivio Zavka).
16
Schema dell’alimentatore della miscelaallegato al brevetto USA 2,140,254 del1938 (10) (Archivio Zavka).
La Siri e il motoread ammoniaca
Maria Casale Sacchi, il dottor Calissano, l’ing. Santagostino (?), il dottor Zavka e l’ing.Fabi davanti alla FIAT 509 (di Mario Zavka) su cui fu sperimentato il motore ad ammo-niaca (Archivio Zavka).
17
Per la maggioranza di noi CarloEmilio Gadda è l’autore di “Quer pa-sticciaccio brutto de via Merulana”(nemmeno letto per intero), per i cul-tori di questo magico scrittore è qual-cosa di più, è l’impareggiabile autoredella “Cognizione del dolore” o di“Meditazione milanese”, ma solo perpochissimi è anche l’ “ingegnere” delCarteggio con l’Ammonia Casale ol’affascinante divulgatore delle opereindustriali dell’uomo degli scritti di“Divulgazione tecnica”. Ed è singola-re che in molte biografie di Gadda siparli solo fugacemente della sua vitadi ingegnere. A titolo esemplificativoriportiamo un breve profilo che cisembra tipico:
“… rientrato a Milano (dopo la pri-gionia in Germania, ndr.), nel 1920consegue la laurea in ingegneria elet-trotecnica. Come ingegnere lavora inSardegna, in Lombardia, in Belgio e inArgentina. Nel 1924 decide di iscriver-
si alla facoltà di Filosofia e di dedicar-si alla passione a lungo rimandata: laletteratura. Supererà tutti gli esami, nondiscuterà mai la tesi, ma abbandoneràla professione di ingegnere per dedi-carsi completamente alla scrittura”.
In realtà Gadda dal 1925 al 1931 è,come abbiamo visto, in Ammonia Ca-sale, con l’interruzione di poco più unanno tra il 1927 e il 1929 e intrattieneuna collaborazione con la stessa So-cietà anche successivamente, dal 1937al 1940.
Dunque un Gadda “ingegnere” perun lungo periodo: “ingegnere di pro-fessione e scrittore per vocazione”,come ha detto qualcuno, e il conflittotra vita in azienda ed esclusivo impe-gno “letterario” non è di poco contonel travaglio intimo dello scrittore; in-fatti l’interruzione del primo periododi lavoro con l’Ammonia Casale, uffi-cialmente per malattia, viene descrit-to, il 4 novembre 1927, all’amico Ugo
Betti, in tutt’altro modo: “ho dato unesame di filosofia. (…) La mia crisi in-tima … si è risolta in un atto pazzesco:ho dato le dimissioni dalla Società incui mi trovo … per vedere di incana-larmi sulla miserabile via delle più omeno belle lettere e della più o menoconsolante filosofia”.
Questo immenso patrimonio di me-moria storica, uscito dalla penna diquesto grande scrittore, unito alle im-ponenti vestigia della chimica dellaprima metà del secolo scorso, ci do-vrebbe consentire di organizzare unpercorso scientifico letterario che, ini-zialmente, potrebbe partire dal Caos epotrebbe completarsi nella struttura diricevimento della Cascata attraversola realizzazione di appropriati pannel-li descrittivi delle grandiose opere tec-nologiche del sito di Marmore, arric-chiti dal “fascino insinuante” delle de-scrizioni di Gadda.
La Redazione
UN IMMENSO PATRIMONIO DIMEMORIA STORICA
La colata del carburo dai forni elettrici di Papigno. Ecco una descrizione di Gadda (da “Azoto atmosferico tramutato in pane”)
“Pensieri che mi suggeriva il frastuono della fabbrica mangiatrice di roc-cia, il riverbero delle bocche incandescenti dei forni da carburo. Ecco idati naturali: Il monte (carbonato di calcio purissimo, d’un color biancocrema); quello che vedo spaccato da cima a fondo, sopra la forra, nel so-le dell’Umbria; l’atmosfera; il fiume, così fervido e ricco” .
La grande sala di azotazione (oggi parte degli studi cinematografici).Ecco in proposito la descrizione di Gadda (da “Azoto atmosferico tra-mutato in pane”)
“Di questa polvere (il carburo di calcio, ndr) vengono riempite certeenormi cartucce: un nuovo carro-ponte le solleva, le depone nei forni diazotazione. Sono dei vasi in ferro: diametro più che due metri: alti più chetre: allineati e stipati nel padiglione immenso. Ogni forno accoglie unacartuccia. Caricatili e chiusili ermeticamente (hanno un coperchio piat-to, circolare) vi si fa pervenire l’azoto, la corrente elettrica. Questa, nel-l’interno di ogni vaso, porta all’incandescenza certi elettrodi di carbone,a bastoncino, che riscaldano il circostante carburo e innescano e pro-muovono l’azotazione. Una rete di tubi e una rete di barre distribuisconoai forni azoto e corrente” .
18
Foto aerea attuale degli ex stabilimenti di Papigno. In alto il fiume Nera e la strada Valnerina. Al centro i capannoni risistematiper le attività cinematografiche. In basso a destra la zona degradata delle centrali storiche.
Dettaglio dell’area delle vecchie centrali che mostra, al centro, la copertura degradata della storica centrale Velino-Pennarossacon la caratteristica forma planimetrica a “V”.
UN IMMENSO PATRIMONIO
19
Foto dei primi anni del novecento che mostra la sala di comando della centrale.Si noti l’impostazione strategica a ridosso della grande colonna, nel vertice del-la “V”, che permetteva il controllo contemporaneo dei due bracci di raccolta del-le condotte, quelle della cascata (Velino) e quelle di Pennarossa.
Planimetria generale d’epoca della centraleVelino-Pennarossa.
Sezione indicativa della centrale con le con-dotte di adduzione alle turbine sotto cui è vi-sibile il lago sotterraneo dei canali di scarico(a tutt’oggi ancora inesplorato).
Lo stato attuale della grande colonna al centrodella sala di comando (v. foto sopra).
Lo stato attuale dei bracci della centrale (sala Velino).
IO DI MEMORIA STORICA
20
Si è tenuto a Salerno presso il Tea-tro Augusteo lo scorso 23 e 24 feb-braio il Convegno nazionale di pre-sentazione delle “Nuove Norme Tec-niche per le Costruzioni – Anno 2018.Prima presentazione nazionale”.
Con finalità formative ed infor-mative, sono stati delineati gli aspet-ti di carattere tecnico ed operativo le-gati all’applicazione delle NTC 2018come da DM 17/01/2018 (Aggiorna-mento delle «Norme tecniche per lecostruzioni») pubblicate nella Gaz-zetta Ufficiale ed in vigore dal 22marzo 2018.
Nonostante la nuova normativasembra risolvere alcune criticità in-terpretative del precedente testo, siresta in attesa della pubblicazione del-la Circolare applicativa e delle Ap-pendici agli Eurocodici 2018 che do-vranno esplicitare le molte novità in-trodotte per i professionisti, soprat-tutto in tema di geotecnica, adegua-mento e miglioramento sismico, ar-monizzazione agli Eurocodici e in-troduzione di nuovi materiali da co-struzione.
La progettazione geotecnica vienesemplificata chiarendo un approcciostatico progettuale a seconda dell’o-pera, permettendo così di snellire ilcompito del progettista di eseguire unadoppia verifica di combinazioni. Ladefinizione univoca dell’Approccioproposto permette la contemporaneaverifica sia geotecnica che struttura-le. Inoltre, sono stati variati alcuni
coefficienti parziali di sicurezza suiparametri di resistenza del terreno erivisitati alcuni valori dei coefficientidi riduzione delle accelerazioni mas-sime riferiti ad alcune opere.
Anche a seguito dei tragici eventidel terremoto che ha coinvolto l’Ita-lia centrale a breve distanza di tempo,si sono affrontati i temi dell’adegua-mento sismico e del miglioramento si-smico, inteso come livello minimo ac-cettabile di sicurezza che si richiedeper una costruzione esistente. In que-st’ottica, la Normativa allontana il con-cetto di adeguamento sismico al rag-giungimento di uno standard di sicu-rezza pari a quello di un edificio nuo-vo, mentre fissa indici minimi che do-vranno essere rispettati in caso di mi-glioramento sismico.
Tuttavia, la vastità dell’argomento(all’interno del quale si innescano co-munque i meccanismi di equipara-zione dei livelli di sicurezza degli edi-fici esistenti a quelli per edifici nuo-vi, difficoltà di analisi e di modella-zioni degli edifici esistenti, costru-zioni storiche, esigenze di conserva-zione, etc.) non permette ancora diconfermare che con gli accorgimen-ti normativi introdotti le problemati-che siano completamente risolte.
Viene inoltre attribuita una mag-gior organicità ed omogeneità ai fat-tori di struttura ed agli stati limite si-smici (prevedendo l’accorpamentodel capitolo 7 al capitolo 4 essendo,
sostanzialmente, tutto il territorio Na-zionale sismico).
L’armonizzazione agli Eurocodici,trattandosi di una normativa di com-provata validità, è un’ alternativa va-lida all’uso delle NTC, purchè glistessi siano adottati alle appendiciNazionali. Nei documenti applicati-vi, tale adozione è auspicabile inquanto potrebbe risultare importan-te, essendovi un’enorme quantità diparti degli Eurocodici che non han-no corrispondente normativa tecnicaitaliana.
Finalmente vengono introdottinuovi materiali da costruzione (datempo presenti in altri Stati e studia-ti anche in Italia) in particolare i cal-cestruzzi fibrorinforzati (FRC). Ven-gono inoltre forniti (Capitolo 11) icoefficienti che permettono di deter-minare le caratteristiche dei materia-li da costruzione.
Le novità introdotte dalle NTC2018 prevedono pertanto una sem-plificazione con l’obiettivo di con-sentire la realizzazione di interventi(soprattutto di ristrutturazione) concosti sostenibili e di facilitare l’ac-cesso al sismabonus o alle detrazio-ni fiscali previste, oltre che promuo-vere l’utilizzo di nuove tecnologienelle costruzioni
Così come previsto dall’Articolo2, alle opere private per cui è già sta-to depositato il progetto esecutivo ole cui parti strutturali sono in corsodi esecuzione, non si applicheranno
le nuove NTC macontinueranno ad ap-plicarsi le NTC 2008.La stessa regola valeper le opere pubbli-che in corso di ese-cuzione, con contrat-ti già firmati, proget-ti definitivi o esecu-tivi già affidati.
Elisabetta Roviglioni
Norme tecniche per le costruzioni
LE NOVITÀ DEL 2018
21
Con Deliberazione n. 165 dell’8maggio 2017, l’Assemblea Legislati-va della Regione Umbria, senza alcunvoto contrario, impegna la Giunta Re-gionale su diversi aspetti legati al-l’articolata questione dello stato diqualità ambientale dell’area ternanaed in particolare, la impegna ad av-viare un confronto a livello governa-tivo e con le competenti Commissio-ni dell’Unione Europea, perriconoscere l’unicità della conca ter-nana come “area ambientale com-plessa”.
È infatti convinzione di alcuni con-siglieri regionali che l’area ternanarisulti caratterizzata dalla compre-senza di diversi fattori che, operandoin sinergia, ingenerano una situazio-ne di particolare complessità am-bientale. Le specificità proprie dellaconca ternana sono state sintetizzate
dall’Assemblea Legislativa in tre ca-ratteristiche fondamentali di cui laprima è legata a fenomeni di caratte-re naturale e prevalentemente identi-ficabili nella connotazione morfolo-gica, mentre le rimanenti due sono dinatura antropica e rispettivamente as-sociate all’attuale tessuto industriale(importanti insediamenti siderurgici epiccole/medie imprese del settore chi-mico) e alle conseguenze delle attivitàindustriali svolte nel passato (preva-lentemente attività di smaltimento deirifiuti del settore siderurgico).
Come prima cosa va positivamen-te notato un approccio “bilanciato” escientifico dell’azione intrapresa;l’attenzione viene infatti posta sullacomplessità del fenomeno e non sul-la criticità della situazione, facendointendere un interesse indirizzato astudiare, comprendere e gestire que-
sta complessità attraverso un proces-so documentato, referenziato e obiet-tivo, togliendo spazio a possibili stru-mentalizzazioni, catastrofiste o ne -gazioniste, che possono nascerequan do il processo conoscitivo o ildato non sono frutto di una valuta-zione indipendente e autorevole e diuna trasparente campagna di infor-mazione.
Gli altri impegni per la Giunta Re-gionale, contenuti nel medesimo attodeliberativo, siano finalizzati a darecorpo operativo alla richiesta di rico-noscimento di area ambientale com-plessa. Alla Giunta viene infatti ri-chiesto di istituire un tavolopermanente di indirizzo e controllosull’oggetto della deliberazione inesame e di rivedere i parametri e glistrumenti per “rendere più sicura laqualità dell’aria della conca ternana”
Area Ambientale Complessa e progetto VIIAS
UN NUOVO APPROCCIO PER LAQUALITÀ AMBIENTALE DELLA
CONCA TERNANA
22
attraverso una pianificazione regio-nale adeguata. A tale proposito laGiunta viene impegnata a definire icriteri per costruire un piano straor-dinario degli interventi mirati all’im-plementazione delle migliori tecni-che disponibili. È chiaro che per fareciò vi è la necessità di procedere pre-liminarmente all’identificazione ditutte quelle attività e situazioni criti-che ove l’implementazione di tali tec-niche possa fornire i migliori risulta-ti in termini di efficienza ed efficacia.Per questa ragione viene richiesto unpieno coinvolgimento sia sul pianopolitico ma anche su quello finanzia-rio dei Ministeri dell’Ambiente e del-la Salute, proprio con l’obiettivo direalizzare uno studio sulle correla-zioni esistenti tra lo stato dell’am-biente e della salute nell’area ternanaidentificando così gli aspetti ambien-tali che maggiormente possono esse-re causa di problemi di salute. La ri-chiesta avanzata dall’AssembleaLegislativa sembra nascere da una at-tenta valutazione degli studi e dei me-todi più autorevoli impiegati a livellonazionale; nella delibera viene fattoesplicito riferimento non solo allo stu-dio SENTIERI, ampiamente citato inaltri contesti, ma anche, e soprattutto,all’approccio impiegato nel progetto“VIIAS” e alla metodologia “MIN-NI”, elementi dei quali si ritiene siaimportante fornire alcuni dettagli co-noscitivi.
Il progetto VIIAS (Valutazione In-tegrata dell’Impatto dell’Inquina-mento atmosferico sull’Ambiente esulla Salute) è stato finanziato nelquadro delle iniziative del CentroControllo Malattie (CCM) del Mini-stero della Salute ed ha effettuato lavalutazione integrata dell’inquina-mento atmosferico in Italia valutandol’intera catena di eventi (dalle politi-che, alle fonti di esposizione, alle mo-dalità di esposizione, agli impatti) chepossono influire sulla salute della po-polazione.
Il Progetto VIIAS è basato sul-l’impiego contestuale di due sistemimodellistici (Sistema Modellistico At-mosferico(SMA) e GAINS – Italy) checostituiscono la base del MINNI (Mo-dello Integrato Nazionale a supportodella Negoziazione Internazionale sui
temi dell’Inquinamento Atmosferico)che è stato sviluppato per conto delMinistero dell’Ambiente e della Tu-tela del Territorio e del Mare.
Grazie all’impiego di questi mo-delli VIIAS costituisce un potentestrumento che integra modellistica at-mosferica, misure per la riduzionedelle emissioni e valutazione dei co-sti al fine di supportare le scelte nelcampo della gestione della qualitàdell’aria.
Il progetto VIIAS è stato coordina-to dal Dipartimento di Epidemiologiadel Servizio Sanitario Regionale delLazio e vede la collaborazione di:ENEA, ARPA Piemonte, Emilia Ro-magna e Lazio, ISPRA, Dipartimen-to di Statistica (Università di Firenze),Dipartimento di Biologia Ambientale(Università di Roma La Sapienza),Università di Urbino.
Il progetto riunisce le competenzein materia ambientale e sanitaria nelcontesto italiano al fine di disporre diun sistema di valutazione integratadegli effetti ambientali e sanitari del-l’inquinamento atmosferico in gradodi valutare la situazione esistente e ipossibili scenari futuri nel contestonazionale. Questi gli obiettivi speci-fici del programma:
• disporre di stime modellistiche sulterritorio nazionale delle concen-trazioni al suolo di particolato at-mosferico (PM2,5), Biossido diAzoto (NO2) e Ozono (O3) in unanno di riferimento (2005) e inscenari previsionali (2020);
• stimare la esposizione della popo-lazione ai tre inquinanti per loscenario di riferimento e negliscenari previsionali;
• quantificare l’impatto sulla popola-zione italiana dell’inquinamentoda PM2,5, NO2 e O3 in termini dicasi di morte e di malattia attri-buibili all’inquinamento e di annidi vita persi.
Il progetto VIIAS e l’impiego delmodello MINNI costituiscono utilis-simi strumenti di supporto alle deci-sioni per elaborare politiche regiona-li di gestione della qualità dell’ariacoerenti con quelle nazionali elabo-rate a livello ministeriale (il quale
adotta il medesimo modello). Tale ap-proccio consente di fornire rispostealle principali domande alle quali lePubbliche Amministrazioni devonosaper rispondere nella gestione dellaqualità dell’aria dei territori ammini-strati.
Se verrà dato corso a quanto pre-visto dalla Deliberazione 165/17, inUmbria potrà essere sviluppato unapprofondimento del progetto VIIAScon il coinvolgimento degli Enti Lo-cali, per studiare gli elementi neces-sari da cui partire per una valutazio-ne dell’efficacia delle misure che laRegione potrà introdurre per miglio-rare la qualità dell’aria e la salute deicittadini. Per questa ragione appareassolutamente condivisibile ed op-portuno il contenuto dalla delibera-zione 165/17 con la speranza che ven-ga dato realmente seguito agliimpegni assunti e che presto sianoavviati degli approfondimenti del pro-getto VIIAS per il territorio della con-ca ternana.
Si invitano comunque i lettori in-teressati ad approfondire i risultati egli scenari prospettati dal progettoVIIAS sul sito web: dove è già pos-sibile trovare interessanti informazio-ni anche sulla situazione umbra.
Andrea Sconocchia
Oltre il 60% del patrimonio edilizioitaliano è stato realizzato precedente-mente all’entrata in vigore della primanormativa sismica del 1974, con tipo-logie edilizie molto differenti tra loro.Murature storiche soggette ad azioniorizzontali nel proprio piano, possonoincorrere in stati limite per meccani-smi di taglio. Le rotture generate da ta-li stati limite, possono essere: rottureper scorrimento dei giunti di malta(quando la resistenza a trazione dellamalta è minore della resistenza a tra-zione dell’elemento resistente), rottu-re per fessurazione diagonale (quandoelementi resistenti e malta hannouguale resistenza a trazione) o rotturecombinate.
Le lesioni ad “X” che si manifesta-no di frequente nei maschi murari diedifici colpiti da eventi sismici (Figu-ra 1), sono dovute, nella maggior par-te dei casi, a rotture della prima tipo-
logia (rottura per fessurazione diago-nale).
Recentemente si è deciso dunquedi sperimentare in laboratorio, me-diante prove di taglio (codificate se-condo la norma ASTM E 519), unatecnica di consolidamento statico in-novativa, costituita da lastre in ac-ciaio inossidabile austenitico (AI-SI304, Carbonio-Cromo-Nichel), didimensioni 40x3x1000 , disposte in-clinate di un angolo pari a 45° ri-spetto all’orizzontale (Figura 2). Lelastre sono state collegate meccani-camente alla muratura mediante bul-loni in acciaio M8x1.75x100 mm,classe di resistenza 8.8.
Sono stati sottoposti alla sperimen-tazione alcuni provini realizzati contecniche il più possibile simili a quel-le utilizzate per le murature storichepresenti nel territorio italiano. Le pro-ve sono state effettuate su 8 provini: 4
costituiti da elementi resistenti in la-terizio pieno (con percentuale di fora-tura 15%, di dimensioni nominali55x120 x250 ) e malta di calce a bas-so contenuto di cemento (proporzionidella miscela in volume: calce aerea-sabbia-cemento pari a 1:2:0.15); 4 co-stituiti da elementi resistenti in pietranaturale irregolare (di dimensionicomprese tra 50-300 ) e malta di calcea basso contenuto di cemento.
I provini sono stati sottoposti a ciclidi carico e scarico a collasso. Prelimi-narmente sono stati sottoposti a provadi taglio due provini (uno in laterizio,l’altro in pietra) ai quali non erano sta-te applicate le lastre di rinforzo, peravere dei valori di riferimento con iquali confrontare i risultati ottenutidalle altre prove rinforzate.
Grazie alle prove di taglio è statopossibile ottenere i valori di resisten-za a taglio (), di deformazione diago-
23
Una tecnica innovativa
RINFORZO STRUTTURALE A VISTAPER EDIFICI STORICI MEDIANTE
ACCIAIO INOX
Figura 1: Lesioni tipiche di maschi murari, generate da azioni sismiche
24
nale di compressione e trazione, dideformazione a taglio e del modulo dielasticità tangenziale (G, ottenuto dal-la pendenza del grafico - ).
Dall’analisi dei risultati ottenuti(Figura 3), si evince che, grazie alrinforzo mediante lastre in acciaioinossidabile, i valori di resistenza a ta-glio dei pannelli sono significativa-mente aumentati. Infatti nei pannellicomposti da elementi resistenti in la-terizio pieno la resistenza ha taglio haavuto un incremento medio di circa il67% (nel calcolo dell’incremento me-dio sono stati ignorati i risultati ano-mali della P_R_02 poiché il provinoera presumibilmente già lesionato pri-ma dell’inizio della prova); mentre neipannelli composti da elementi resi-stenti in pietra naturale l’incrementomedio è stato pari a circa il 51%.
Il valore del modulo di elasticitàtangenziale calcolato ad un terzo delcarico di collasso, non è invece au-mentato significativamente, anzi, inalcune delle prove rinforzate è addirit-tura diminuito. Questo potrebbe di-pendere dal fatto che la fessurazionenei pannelli è avvenuta prima dell’en-trata in gioco della lastra di rinforzo, lacui azione quindi si inserisce in fasepost-elastica.
Tutti i provini rinforzati sono inol-tre giunti al collasso per crisi del col-legamento meccanico tra lastra-bullo-ni-muratura.
Il descritto metodo di rinforzo, in-novativo e non invasivo, ha dunquefornito incrementi di resistenza soddi-sfacenti per entrambe le tipologie dimuratura storica testate.
L’intervento sperimentato attraver-so l’uso di barre in acciaio inox pre-
senta inoltre numerosi vantaggi ri-spetto alle tecniche convenzionali diconsolidamento statico, come di se-guito indicato:
Forte resistenza agli agenti cor-rosivi, visto l’impiego di lastre in ac-ciaio inossidabile e alta compatibi-lità con le murature storiche (a dif-ferenza degli interventi che preve-dono intonaci cementizi o resineepossidiche);
Facilità e velocità di messa inopera dell’intervento;
Reversibilità con possibilità di ri-mozione senza arrecare danno allamuratura storica;
Costi ridotti dei materiali utiliz-zati. L’acciaio inox è infatti reperibi-le sul mercato ad un prezzo oramiaccessibile;
Limitatissimi incrementi dellamassa dell’edificio (qualche decinadi chilogrammi per un intero edifi-cio), poiché si utilizzano materialimolto maneggiabili e leggeri;
Utilizzabilità anche con finalitàdi messa in sicurezza provvisoriapost-sisma;
L’intervento, infine, non copre, néaltera l’aspetto originario dei para-menti murari, divenendo utilizzabilein murature storiche con elevato valo-re artistico o vincolate (Figura 4).
Valerio Cavalieri e Marco Corradi
Figura 2: Provini rinforzati mediantelastre in acciaio inossidabile
Figura 4: Rendering di un edificio sto-rico rinforzato mediante lastre in ac-ciaio inox. Figura 3: Confronto mediante grafico - tra i risultati ottenuti per le quattro prove su
pannelli in laterizio pieno
25
Il ruolo del Direttore Lavori negliultimi anni è notevolmente mutato.
Oggi il D.L. oltre ad una supervi-sione sulla realizzazione dell’opera,deve ,se dotato dei requisiti previstidalla normativa , svolgere anche lefunzioni di coordinatore per la sicu-rezza in fase di progettazione ed ese-cuzione.
In base al nuovo Codice degli ap-palti (Dlgs 50/2016)) l’art. 111 preve-de che con decreto del MIT, su propo-sta dell’ANAC, sentito il Consigliosuperiore del Lavori Pubblici e la Con-ferenza Unificata, siano approvate le li-nee guida sulla direzione lavori.
Il D.L. è la figura professionale in-dividuata dal committente ( pubblicoo privato ) e ha il principale compi-to di assistere e sorvegliare i lavori,garantendo la regolare esecuzione se-condo quanto previsto dal progetto edalle norme, impartendo le opportu-ne istruzioni quando necessario.
Durante la fase esecutiva dell’o-pera in base all’art. 101 comma 3 delCodice degli Appalti (Dlgs 50/2016)il D.L. ha la responsabilità relativaall’accettazione dei materiali, inoltredeve altresì verificare che materiali ecomponenti rispondano a tutte le pre-scrizioni previste, in particolare i ma-teriali ed i componenti devono corri-
spondere alle prescrizioni del capito-lato speciale; devono corrispondere aicontenuti dell’opera presentata in se-de di gara; devono essere stati appro-vati dalle strutture di controllo di qua-lità del fornitore e che abbianosuperato le fasi di collaudo previsteda controlli di qualità, normative vi-genti o prescrizioni contrattuali, inbase alle quali sono stati costruiti.
Un D.L. che svolge il proprio ruo-lo in stretta collaborazione con le al-tre figure professionali presenti incantiere (progettista, impresa, coor-dinatore della sicurezza etc) diventaun valore aggiunto per la committen-za in termini di regolare esecuzionedell’opera e di risparmio economico.
Nei recenti sismi dell’Aquila, diNorcia e di Amatrice è emerso unproblema ricorrente.
Si è notato uno scarso impiego del-le staffe nei pilastri e nei nodi, se nontotale assenza in alcuni casi; ribalta-menti fuori piano delle murature;scarsa qualità dei materiali impiega-ti; formazione di pilastri tozzi per er-rata disposizione degli elementi se-condari; posa in opera di staffe nonchiuse.
Se consideriamo un pilastro sog -get to a sforzo normale e momentiflettenti
(sollecitazione di pressoflessionedeviata ) per effetto del carico di pun-ta l’elemento e le armature in essopresenti tenderanno a “ spanciare “verso l’esterno.
Una attenta presenza in cantiere daparte del D.L. avrebbe evitato pro-blemi di questo tipo con vantaggionon solo per la committenza, ma perl’intera popolazione.
Concludo con un mio personalepensiero, quando si accetta l’incaricodi D.L. si deve essere presente in can-tiere in modo continuo e collaborarein modo fattivo con tutte le altre fi-gure professionali coinvolte nell’ese-cuzione dell’opera.
Gianni Fabrizi
Un ruolo notevolmente mutato negli ultimi anni
IL DIRETTORE LAVORINELL’ESECUZIONE DELL’OPERA
Gianni Fabrizi, diplomato geometranel 1991, nel 2011 si iscrive a Inge-gneria e nel 2017 consegue la laureamagistrale. Assunto nel 1996 comeresponsabile della manutensione sco-lastica presso la Provincia di Terni,nel 2014 è passato all’Azienda Ospe-daliera Santa Maria alla S. C. TecnicoPatrimoniale. Nel 2016 nominato Ca-valiere della Repubblica. Nel 2017nominato cultore della materia Pro-getto di Restauro dall’Università tele-matica Ecampus.
26
La Formazione continua obbligato-ria è senza dubbio uno degli oneri piùgravosi, sotto tutti i punti di vista, chel’Ordine debba gestire. Molti Ordini eCollegi hanno scelto di appoggiarsi apartners professionali privati. Altrihanno delegato le loro federazioni re-gionali, diversi hanno fondazioni eco-nomiche interne che gestiscono la lo-ro piattaforma, godendo di ampie co-perture. Indipendentemente da questedifferenze l’aspetto che accomuna lapressoché totalità delle altre realtà or-dinistiche è il fatto che i seminari sia-no sempre e comunque a pagamento,non fosse altro per diritti di segreteriada pagare sul posto od in anticipo.
L’Ordine degli Ingegneri della Pro-vincia di Terni, fin dalla istituzione diqueste attività, ha invece scelto dimantenere la gestione diretta dellaformazione ed anche di garantire se-minari a titolo gratuito per gli iscritti.Gli unici corsi a pagamento sono
quindi quelli abilitanti o di lunga du-rata su più giornate, come ad esempioi corsi legati al coordinamento dellasicurezza, o quelli di prossimo avviosulla prevenzione incendi e sulle NTC2018.
Il fatto che i seminari siano gratuitinon va certo a discapito della qualitàed anzi l’offerta garantita dall’estate2017 ad oggi è stata di elevato valore.
Di certo abbiamo cercato di mantene-re gli elevati standard del passato, rin-graziando chi, come Alessandro Pas-setti, ha ottimamente gestito questocomplesso ambito nel precedentemandato.
A dimostrazione dell’interesse cre-scente per i nostri seminari vi è l’am-pia partecipazione di colleghi di altriOrdini come Perugia, Rieti, Viterbo.Non a caso alcuni eventi sono staticoorganizzati con i colleghi dell’Or-dine di Perugia, a noi confederato. Al-tri hanno visto la partnership degli Or-dini di Viterbo e Rieti, con noi gemel-lati.
Le linee guida che stiamo cercandodi seguire sono di “andare alla fonte”e “stare sul pezzo”. Per “andare allafonte” si intende, per quanto possibi-le, avere come relatori professionistidi eccellenza o docenti universitaricoinvolti in prima persona nei temitrattati. Non di rado i docenti sono sta-
Le linee guida: stare sul pezzo e andare alla fonte
FORMAZIONE CONTINUA…UN PRIMO PARZIALE BILANCIO
27
ti anche Dirigenti apicali di enti pub-blici coinvolti. Ciò anche al fine dipermettere, durante i seminari, unconfronto diretto con i partecipanti, li-mitando al minino interpretazioni va-riabili.
Di certo è stata fondamentale lacollaborazione con gli enti pubbliciche gratuitamente hanno messo a di-sposizione il loro personale. Lo “staresul pezzo” si concretizza invece nelloscegliere temi di grande attualità.
A puro titolo esemplificativo, manon esaustivo, possiamo ricordare idue seminari sull’Industria 4.0 tenutidal Presidente Nazionale del Comita-to per l’Ingegneria dell’InformazioneMario Ascari di Modena. Ad essi stan-no facendo seguito i seminari settima-nali da noi patrocinati in collabora-zione con la Camera di Commercio diTerni sullo stesso tema. Non possonoessere dimenticati poi i seminari orga-nizzati dalla nostra commissione am-biente e territorio sulla gestione delleterre e rocce da scavo e sulle autoriz-zazioni ambientali VIA-AIA, con do-cenze da parte dei dirigenti e funzio-nari della Regione Umbria maggio-rante interessati. Di grande seguitoanche il corso sulla piattaforma MU-DE per la ricostruzione post-sismicatenuto dalla Dirigenza dell’UfficioSpeciale per la Ricostruzione “USR”.
Per altro tale incontro è stato il primo(ed ad oggi unico) organizzato nellaprovincia di Terni ed il terzo in assolu-to in Umbria. Sempre nell’ambitostrutturale vanno citati i 4 seminarisulla nuova piattaforma digitale SISper i depositi e le autorizzazioni si-smiche, grazie alla docenza diretta deifunzionari ed istruttori della Regione.Restando sul tema va sicuramente ri-cordato il corso sul Sisma Bonus conil Centro Studi Sisto Mastrodicasa.
Oltre a queste tematiche più “con-crete” si cerca anche di inserire even-ti di ampio respiro tecnico e culturale.In questo senso è stato un vero piace-re organizzare l’incontro sul MOSE diVenezia con l’Ing. Hermes Redi di Pa-
dova che del Consorzio MOSE è statoper anni alla guida. A dimostrazionedella eccezionalità dell’evento si èavuta “a sorpresa” la partecipazioneanche dell’Ing. Roberto Linetti, Prov-veditore Interregionale alle OperePubbliche per il Veneto e Friuli Vene-zia Giulia.
Per il futuro abbiamo intenzione dicontinuare su questa linea operativa.Come sempre sarà fondamentale ilsupporto degli iscritti, sia in termini dipartecipazione che in termini propo-sitivi. Le porte sono quindi come sem-pre totalmente aperte al fine di recepi-re suggerimenti e richieste. Stay Tu-ned!!!
Simone Monotti
28
Per mantenere l’agibilità mentale
PASSATEMPI E GIOCHIMATEMATICI
In questo numero presentiamo per la primavolta una serie di giochi e problemi, che ci pia-ce definire “divertimenti matematici”, i qualirichiedono solo conoscenze matematiche ele-mentari unite però a un po’ di buon senso edintuito. Si tratta di due doti che sembrano con-naturate nell’uomo (e particolarmente negliingegneri) ma che, in realtà per esprimersi almeglio hanno bisogno di continuo allena-mento. In questo senso abbiamo la presunzio-ne di ritenere che la presente iniziativa possariuscire di una certa utilità non solo per il di-vertimento o il passatempo che essa offre, maanche per il suo piccolo contributo al mante-nimento dell’agilità mentale.
Eccone alcuni, noti fin dall’antichità, piùo meno facili ma sempre divertenti:
1 - Il peso del mattone Quanto pesa un mattone che pesa un chilopiù mezzo mattone ?
2 - L’inseguimento L’auto della polizia si lancia a 130 km/h inautostrada all’inseguimento dell’auto pira-ta che viaggia a 100 km/h. A quale distanza
si troverà il pirata un minuto prima di essereraggiunto?
3 – Il masso in barcaUna grossa pietra dal peso di 1 tonnellata edal volume di circa 1/3 di metro cubo vienetrasportata su una barca in un laghetto. Adun certo punto, per un falso movimento, ilmasso scivola in acqua. Il barcaiolo, che è untipo pignolo, si domanda allora cosa sia suc-cesso al livello del lago: si sarà alzato o sisarà abbassato?
4 – L’eredità del califfoUn califfo lasciò ai suoi tre figli una ereditàdi 17 cammelli disponendo che al primoge-nito ne toccasse la metà, al secondo un ter-zo e al più piccolo soltanto un nono. I tre gio-vani, non riuscendo a dividersi gli animali,litigarono a lungo ma un bel giorno passò dilì un vecchio saggio in groppa al suo cam-mello che, ascoltata la storia, risolse il pro-blema in un attimo. Come fece?
Se, dopo averli risolti, volete confrontare levostre soluzioni con quelle più o meno uffi-ciali andate a pagina 30.
29
La cosiddetta teoria del giochi èun settore della matematica che, puressendo di tipo assolutamente astrat-to, ha notevoli applicazioni con le si-tuazioni concrete della vita. A primavista potrebbe sembrare che la teoriadei giochi riguardi soltanto gli scac-chi, la dama o, magari, il calcio od iltennis. Invece essa è applicabile aquasi tutte le circostanze della nostraesistenza, perchè tutta la nostra vitainterattiva è praticamente modelliz-zabile attraverso la teoria dei giochi.
Ormai da circa un secolo, in questocampo, si sono cimentati numerosistudiosi che hanno ottenuto anche im-portanti riconoscimenti. Il più notodi questi è stato reso particolarmentefamoso dal notissimo film “beautiful
maind”. Si tratta di John F. Nash che,applicando la teoria dei giochi all’e-conomia, ha addirittura conseguito ilpremio Nobel nel 1994.
Con il termine “giochi” possiamo
quindi intendere tutti i processi prati-cati normalmente dagli esseri umanicon l’intenzione di ottenere un risul-tato positivo. Una vittoria sportiva o,più generalmente, un vantaggio eco-nomico, politico o esistenziale. In unaparola : una vincita. Ma quali sono lestrategie da applicare per conseguir-la? È qui che la teoria dei giochiesplica la sua funzione. Essa studia imetodi per influenzare l’evoluzionedegli avvenimenti. Si occupa, cioè,della cosiddetta “interazione strate-gica”, individuando appunto le rego-le che stabiliscono la migliore con-dotta di gioco possibile da attuare perraggiungere lo scopo.
S. N.
Matematica applicata alle decisioni
LA TEORIA DEI GIOCHI
30
PASSATEMPI E GIOCHI MATEMATICI
Ecco le soluzioni dei giochi di pag. 26.
1 - L’altro mezzo mattone che manca per ar-rivare al mattone pesa evidentemente un kge quindi il mattone pesa 2 kg. In formule,detto x il peso del mattone, si ha x = ½x + 1 equindi x=2. Le varianti del gioco possono es-sere innumerevoli: quanto è lunga una cordache è lunga metà della sua lunghezza più 10m ? (R: 20m) ecc. ecc.
2 - In un’ora la polizia percorre 30 km in più,e quindi in un minuto 1/2 km in più. E’ que-sta perciò la distanza a cui si trova il pirata unminuto prima di essere raggiunto.
3 - Il livello si abbassa perché la pietra im-mersa sposta un minor volume di acqua ri-spetto a quando galleggia. Infatti, quando ilmasso è sulla barca, il sistema per poter gal-leggiare deve ricevere una spinta dal bassoverso l’alto pari al suo peso e sposta perciòun corrispondente peso di liquido, ossia 1 tone cioè 1 m3 di acqua; quando invece il massoè completamente immerso sposta un volumedi acqua pari al proprio, cioè 1/3 di m3. Percui alla fine il livello è diminuito.
4 - Da un punto di vista strettamente aritme-tico la ripartizione non è possibile, sia perché
bisognerebbe fare a pezzi qualche cammel-lo, sia perché alla fine ne avanzerebbe qual-che pezzo che non si saprebbe a chi dare (in-fatti 1/2 +1/3 +1/9 dà un po’ meno di uno, eprecisamente 17/18 per cui resta alla fine1/18 di eredità non ripartita). Il vecchio sag-gio interpellato notò che se i cammelli fosse-ro stati 18, con la ripartizione disposta dal ca-liffo ne sarebbe avanzato giusto uno. Allorascese dal suo cammello e, seguendo le di-sposizioni, ne assegnò 9 al primo figlio, 6 alsecondo e 2 al terzo, dopo di che risalì ingroppa al proprio cammello e riprese le suemeditazioni salutando i tre fratelli esterre-fatti..Il problema si può porre con altri dati, con-sentendo al massimo le 7 varianti numericheriportate in tabella (nella prima colonna c’èil numero iniziale di cammelli e nelle altre lefrazioni possibili):
7 1/2 1/4 1/811 1/2 1/4 1/611 1/2 1/3 1/1217 1/2 1/3 1/919 1/2 1/4 1/523 1/2 1/3 1/841 1/2 1/3 1/7
a cura di F. P.
31
In linea generale, nel caso in cui ilprofessionista svolga un’attività pro-fessionale in via abituale, ancorchénon esclusiva, dovrà procedere all’a-pertura della partita IVA. Per attivitàprofessionali si intendono le presta-zioni che presentano un pronunciatocarattere intellettuale, richiedono unaqualificazione di livello elevato e so-no normalmente soggette da una nor-mativa professionale precisa e rigo-rosa. Invece, l’abitualità si riscontraogni qualvolta l’esercizio di una pro-fessione consente la qualificazionedi chi la esercita rispetto alla tipolo-gia di attività esercitata, vale a direche chi la esercita, per il solo fatto diesercitarla, ne assume una vera e pro-pria qualificazione professionale(esempio: il consulente aziendale, ilconsulente software, l’amministrato-re di condominio, ecc.).
N.B.: i requisiti di professionalitàed abitualità sono riscontrabili ogniqualvolta il soggetto (professionista)ponga in essere una pluralità di ope-
razioni economicamente rilevanti,coordinate e finalizzate al raggiungi-mento di uno scopo.
Esclusione dall’apertura dellapartita IVA (secondo quanto stabi-lito dall’art. 5 del D.P.R. n.633/1972)
Il professionista non deve aprire lapartita IVA quando svolge:• unicamente lavoro occasionale, il
lavoro occasionale, a differenza del-l’attività autonoma abituale, è ca-ratterizzato dall’esistenza dei se-guenti requisiti:
– dall’assenza di coordinamento conl’attività del committente;
– dalla mancanza di inserimento fun-zionale nell’organizzazione azien-dale;
– dalla completa autonomia del la-voratore in merito all’espletamentodella prestazione (sia in terminidi tempo che di metodologia);
– dal carattere episodico (non conti-nuativo) dell’attività prestata (indi-
pendentemente dal valore econo-mico dell’attività prestata).L’INPS ha chiarito che si è in pre-senza di lavoro occasionale (ai finicontributivi e non anche ai finiIVA) nel caso in cui l’attività sia li-mitata nel tempo (non superiore a 30giorni nel corso dell’anno solare) enon venga superato il limite di red-dito annuale di euro 5.000,00 (siveda anche art. 61 del D.Lgs. n.276/2003)(circolare 6 luglio 2004,n. 103; si veda anche la circolare n.1 del 2004 del Ministero del lavoroe delle politiche sociali);
• unicamente un lavoro a progetto;• unicamente lavoro dipendente,
quindi prestando la propria attivitàsulla base di un regolare contratto diassunzione;
• prestazioni non aventi carattere dicontinuità, abitualità e professio-nalità.
( da Ingegneri.info)
Il vademecum per il tecnico
PARTITA IVA:QUANDO IL PROFESSIONISTA DEVE
APRIRLA E QUANDO NO
L’innovazione presentata nella miatesi di laurea riguarda lo studio di si-stemi che sfruttano il fenomeno delloSloshing per la dissipazione e mitiga-zione del moto delle strutture causatoda perturbazioni esterne quali adesempio sisma e vento.
Il termine Slosh Dynamics, o piùcomunemente Sloshing, richiama inse il significato di movimento di unfluido all’interno di un contenitoreriempito parzialmente e causato dasollecitazioni esterne (figura 1). Que-sto spostamento della massa fluida ge-nera una variazione della distribuzio-ne della pressione sulle pareti del ser-batoio e conseguentemente si crea unsistema di forze che interferisconosull’equilibrio del recipiente e dellastruttura al quale quest’ultimo è soli-dale. Lo studio dello Sloshing ha uncampo d’applicazione vastissimo. Leprime ricerche risalgono agli inizi delsecolo scorso in campo aeronautico,mentre le prime modellazioni intorno
agli anni quaranta. Il movimento delcombustibile all’interno del serbatoiogenera delle sollecitazioni che dalcontenitore si trasmettono alla struttu-ra del veicolo compromettendone lastabilità. Negli aeroplani le vibrazioninate dal movimento del liquido anda-vano a influenzare la stabilità, conconseguenti problemi di mantenimen-to della traiettoria di volo. Attualmen-te è ambito di ricerca persino dalle ca-se concorrenti nel campionato delmondo di motociclismo, dove lo slo-shing si manifesta negli istanti in cui ilpilota impone l’azione di frenaturacompromettendone la stabilità. Nonmeno rilevante l’applicazione aero-spaziale della NASA per la costruzio-ne di razzi, missili e satelliti che perquesto fenomeno possono subire unadeviazione della traiettoria originale.Importante è anche nella progettazio-ne dei veicoli terrestri e navali, si pen-si ad esempio ai mezzi per le movi-mentazioni stradali dei liquidi, autoci-
sterne o autobotti o treni merce oppu-re agli enormi serbatoi delle navi. Intutti i campi d’applicazione accennatifinora lo Sloshing risulta un fenome-no di disturbo che allontana dalla con-figurazione d’equilibrio (figura 2).
Nell’ambito dell’ingegneria civile,invece, l’idea è di studiare tale feno-meno come un aiuto al mantenimentodella configurazione stabile che in se-guito ad eventi eccezionali, quali si-sma o vento, può venire meno. Da ta-le idea nascono i Tuned SloshingDampers, ovvero sistemi dissipatividi energia, che hanno lo scopo di miti-gare gli eccessivi spostamenti causatida forzanti esterne. In particolare que-sti sistemi si posizionano a quota ele-vata e rappresentano una massa liqui-da che si mette in moto con un certosfasamento rispetto al moto dellastruttura. Quindi la massa fluida muo-vendosi in ritardo rispetto alla struttu-ra e infrangendosi sulle pareti del ser-batoio, che la contiene, crea un siste-
32
Pubblichiamo qui di seguito una breve sintesidella tesi di laurea con cui il neo ingegnereSimone Menichetti, lo scorso anno, ha ottenuto ilpremio “Ingegneria e innovazione” del nostroOrdine.
STUDIO TEORICO-SPERIMENTALE DELL’ENERGIADISSIPATA DALLO SLOSHING DELL’ACQUA NEISERBATOI SOPRAELEVATI CON PROSPETTIVE
D’IMPIEGO ALL’INGEGNERIA SISMICA
Figura 1 Figura 2
ma di forze che ostacolano il motodella struttura, determinando dissipa-zione di energia e conseguentementediminuzione degli spostamenti. L’ef-ficacia dei sistemi sta, perciò, nel ta-rare lo sfasamento in modo tale che simassimizzi l’energia meccanica dis-sipata durante il moto. Questa tecnicadissipativa è ampiamente utilizzatacon i “cugini” più vicini che sono i Tu-ned Mass Dampers. Questi ultimi so-no puramente masse aggiuntive all’e-dificio utilizzate con il solo scopo didissipare energia. Uno dei vantaggidei TSD sta nell’avere un volume di ri-serva d’acqua aggiuntivo disponibile,oltre che per uso dissipativo, in caso digravi incendi, o in caso di disservizi.Infatti, si pensi a edifici importanti,abbastanza alti, in cui dovrebbero es-sere installati sistemi a masse accor-date: l’uso di sistemi TSD piuttostoche TMD oltre a garantire un volumedi riserva d’acqua gratis, abbassereb-be molto i costi garantendo la stessaqualità di sicurezza.
Il problema dei Tuned SloshingDampers è caratterizzato dal peculia-re comportamento insito in questi si-stemi che mostrano la forte non linea-rità che caratterizza il fenomeno delloSloshing e la mancanza di modelli li-
neari in grado di riprodurre sufficien-temente tale comportamento. Ciò ren-de quindi parzialmente efficaci questisistemi.
Il mio lavoro di tesi nasce dall’o-biettivo di contribuire a validare il mo-dello teorico scelto per riprodurre il si-stema, disciplinando il fenomeno del-lo Sloshing per raggiungere una mag-giore efficacia dei TSD. A tale scoposono partito da una sperimentazionecon serbatoi di diverse dimensioni do-ve ho ottenuto buona corrispondenza
con il modello teorico, finché non su-bentrano fenomeni non lineari. Per ri-solvere il problema avvicinando il si-stema sperimentale al sistema teoricoho introdotto delle griglie che consen-tono di laminare il moto del fluido de-terminando un comportamento linea-re a discapito di una minor dissipazio-ne (figura 3). Infine ho effettuato unasimulazione numerica che riproduceil fenomeno in 2D presentando unbuon accostamento con i dati speri-mentali (figure 4 e 5).
Ad oggi i Tuned Sloshing Damperssono già utilizzati in importanti edifi-ci (figura 6), tuttavia la loro efficaciaè limitata. In futuro questi sistemi so-no chiamati a sostituire i vecchi cugi-ni TMD, uguagliandone se non mi-gliorandone l’efficacia dissipativa.
Simone Menichetti
33
Figura 5 Figura 6
Figura 3
Figura 4
34 34
La Riforma previdenziale ha in-trodotto a decorrere dall’1/1/2013 ilnuovo istituto della pensione di vec-chiaia unificata (PVU), che sostitui-sce la pensione di vecchiaia e, a re-gime, assorbirà anche l’attuale pen-sione di anzianità e pensione contri-butiva, costituendo la principale pre-stazione pensionistica nell’ordina-mento Inarcassa.
I requisiti per il pensionamento nel2017 sono 66 anni di età e 32 di con-tribuzione, il numero di anni aumen-terà progressivamente fino a 35 nel2023.
La pensione di vecchiaia unifica-ta è costituita da due quote:
• una relativa ai periodi maturatifino al 31 dicembre 2012, cal-colata con il metodo pro-rataretributivo. Per gli iscritti chepresentano un reddito pensio-nabile inferiore al valore dellapensione minima (nel 2017 pa-ri a euro 10.876,00) è previstal’applicazione del metodo dicalcolo contributivo se più fa-vorevole;
• una contributiva, per le anzianitàmaturate a partire dal 1° gen-naio 2013.
La quota retributiva di pensione siottiene moltiplicando l’anzianità con-tributiva per la media reddituale e peri coefficienti di rendimento, decre-scenti per scaglioni di reddito. Ai fi-ni del calcolo della suddetta quota,per ciascuna annualità i redditi ven-gono presi in considerazione nellamisura massima del tetto pensiona-
bile riportato nella tabella corrispon-dente e rivalutati in base agli indiciistat.
La quota contributiva di pensionetiene conto dell’ammontare dei con-tributi accreditati sulla posizione as-sicurativa individuale fino al mo-mento del pensionamento.
Nel calcolo entrano in gioco i se-guenti due elementi:
• il montante dei contributi sog-gettivi versati, entro il tettopensionabile;
• il coefficiente di trasformazionelegato all’età alla data di ma-turazione del diritto a pensio-ne.
Il montante individuale è formato da:• contributo soggettivo; • contributo facoltativo; • parte del contributo integrativo,
retrocesso in funzione dell’an-zianità retributiva maturata fi-no al 31/12/2012;
• contributi figurativi riconosciu-ti per le agevolazioni contribu-tive.
Il montante contributivo è rivalutatoal 31 dicembre di ogni anno a un tas-so pari alla variazione media quin-quennale del Monte Redditi degliiscritti alla Cassa, con un valore mi-nimo dell’1,5%.
La pensione di vecchiaia può es-sere “ordinaria”, cioè percepita se-condo le regole sopra esposte per etàanagrafica e anzianità contributiva,oppure “anticipata” a partire dai 63anni di età purchè sia stata raggiun-ta l’anzianità contributiva prevista in
quell’anno. In questo caso la pensio-ne subisce una decurtazione propor-zionata all’età anagrafica all’atto delpensionamento (nel 2017: 11,189%a 63 anni – 8,113% a 64, 3,604% a65).
Esiste poi anche la pensione posti-cipata, che è corrisposta ai professio-nisti dal settantesimo anno di età, an-che in assenza del requisito contribu-tivo minimo di anzianità contributiva.In questo caso l’importo della presta-zione – anche in relazione alla quota dipensione ante Riforma – è calcolatoesclusivamente secondo il metodocontributivo.
Il pensionamento non impedisce dicontinuare con l’esercizio della pro-fessione; in tal caso la contribuzioneversata dopo il pensionamento daràorigine a supplementi pensionisticiogni 5 anni e in ogni caso all’atto del-la cancellazione da Inarcassa.
(da INARCASSA)
Le regole della Riforma Previdenziale
PENSIONE DI VECCHIAIAUNIFICATA
QQUUII INARCASSA