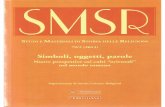Nell'officina del CIL. I signacula nei lavori preparatori del Corpus inscriptionum Latinarum
Transcript of Nell'officina del CIL. I signacula nei lavori preparatori del Corpus inscriptionum Latinarum
INSTRVMENTA INSCRIPTA V
Signacula ex aere.Aspetti epigrafici, archeologici, giuridici,
prosopografici, collezionistici
ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE
(Verona, 20-21 settembre 2012)
a cura di Alfredo Buonopane e Silvia Braito
con la collaborazione di Cristina Girardi
Scienze e LettereRoma 2014
Volume stampato con il contributo di: Dipartimento Tempo Spazio Immagine Società (TeSIS) dell’Università degli Studi di Verona
Rotary Club Como Baradello
Con il patrocinio di: Università degli Studi di Verona, Dipartimento TeSIS Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine (A.I.E.G.L.) Terra Italia Onlus
&RPLWDWR�VFLHQWL¿FR� Giulia Baratta, Alfredo Buonopane, Ivan Di Stefano Manzella,
Sergio Lazzarini, Marc Mayer i Olivé, Giovanni Mennella
Redazione: Alfredo Buonopane, Silvia Braito, Cristina Girardi
(GLWLQJ�H�OD\RXW�JUD¿FR��Cristina Girardi
Coordinamento peer review: Alfredo Buonopane
I contributi raccolti in questo volume sono stati sottoposti alla peer review secondo la procedura del “doppio cieco”
© 2014 Scienze e Lettere dal 1919 S.r.l.già Bardi EditoreVia Piave, 7 – 00187 RomaTel. 0039/06/4817656 – Fax 0039/06/48912574e-mail: [email protected] 978-88-6687-072-2
In copertina: il signaculum di Asturius (CIL XV, 8094) in J. Muselli, Antiquitatis reliquiae, Verona 1756, tab. XXXXVIII, 2 (incisione di Dionisio Valesi e Domenico Cunego).
IX
11
35
61
69
81
91
101
133
141
Alfredo BuonopanePremessa
Marc Mayer i Olivé Signata nomina; sobre el concepto y valor del término signaculum con algunas consideraciones sobre el uso de los instrumentos que designa
Ivan Di Stefano ManzellaSignacula ex aere e mercatura: indizi e ambiguità testuali
Manfred HainzmannSignacula und Synonyme
Simona MarchesiniSignacula: analisi linguistica
Sergio LazzariniI signacula: tra certezza dei “diritti soggettivi” e tutela GHOO¶DI¿GDPHQWR
Margherita Bolla&HQQL�VXOOH�IDOVL¿FD]LRQL�QHOOD�EURQ]LVWLFD
Giulia BarattaIl signaculum al di là del testo: la tipologia delle lamine
Francesca CeneriniNec desunt mulieres: signacula al femminile
Alfredo BuonopaneSchiavi e liberti imperiali nei signacula ex aere
Indice
Silvia Braito1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL. I signacula nei lavori preparatori del Corpus inscriptionum Latinarum
Cristina GirardiLe societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere
Norbert FrankenDie lateinischen Bronzestempel der Berliner Antikensammlung aus sammlungsgeschichtlicher Sicht
Daniela Rigato I signacula ex aere del Museo Nazionale di Ravenna: un quadro introduttivo
Antonio SartoriNon Dianam magis montibus quam Minervam inerrare
Giovanna CicalaSignacula pompeiani: appunti di una ricerca in corso
Raimondo ZuccaSignacula ex aere provinciae Sardiniae
Silvia EvangelistiSignacula da Aeclanum in CIL (IX e X). Alcune note
Claudia GattaSignacula ex aere e collezionismo. Carlo Morbio e le sue raccolte
Stefano MagnaniSignacula ex aere dal territorio di Aquileia
Filippo BoscoloSignacula conservati nel Museo Archeologico di Padova
Giovanni MennellaSignacula aenea e bollatura di laterizi: a proposito di un timbro inedito nel Museo di Antichità di Torino
Marina VavassoriSignacula a Bergamo e dintorni: curiosità e quesiti
159
173
195
203
217
233
241
257
267
279
297
303
309
Elena CimarostiTre signacula da raccolte museali nell’Italia nord-occidentale
Valeria ValcheraSignacula ex aere del Museo Civico Archeologico di Bologna: notabilia�WHFQLFL��SURVRSRJUD¿FL�H�FROOH]LRQLVWLFL
Simona Antolini, Silvia Maria MarengoI signacula ex aere della regio VI adriatica
Silvia BraitoSignacula “in rete”: fra documentazione, aste online e collezionismo
Heikki SolinEpiclinus: una nota onomastica
Marco FirmatiSigilli di mercatores per doli dal porto di Pisa
Luigi Vecchio Un signaculum in bronzo con iscrizione greca da Velia
Paola Pacchiarotti, Giada Fatucci, Laura Ebanista, Sarah Gozzini, Federica LamonacaI signacula del Museo Nazionale Romano: un’esperienza didattica tra studio e EDR
0DXUL]LR�%XRUD��(UJ�Q�/DÀÕTre signacula dall’Asia Minore
Christophe Schmidt HeidenreichSignacula ex aere dans les deux Germanies et les trois Gaules : observations sur une documentation récalcitrante
Gaetano ArenaVasetti iscritti e produzione di medicamenta a Priene ellenistico-romana
Margherita Cassia“Marchi di fabbrica” a Creta e tituli picti di Ercolano: considerazioni socio-economiche
319
325
345
363
379
383
393
405
417
423
439
459
Reinhold WedenigBleiplomben mit Stempel- und Ritzinschriften aus Iuvavum (Noricum)
Zsolt VisyInstrumenta Inscripta Aenea aus Ungarn
Angela Donati(�SHU�¿QLUH
%LEOLRJUD¿D
Lista autori
479
497
515
519
581
159
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONE
Riassunto: Presso l’archivio del Corpus inscriptionum Latinarum di Berlino è stata esa-minata la documentazione pertinente alle fasi preparatorie delle sezioni dedicate ai signa-cula nei volumi IX, X e XV del Corpus. La selezione dei materiali presentati comprende GRFXPHQWL�DXWRJUD¿�H�VFKHGH�UHGDWWH�GD�7KHRGRU�0RPPVHQ�H�GDL�VXRL�FROODERUDWRUL��WUD�cui Heinrich Dressel, G.B. De Rossi, Giulio De Petra, Filippo Nissardi, che testimoniano i contatti tra gli autori e le fasi di lavorazione dei volumi.
Abstract: This paper presents a selection of documents preserved in the archives of the Corpus inscriptionum Latinarum in Berlin, related to the sections of the volumes CIL IX, X and XV, concerning the signacula ex aere. Among these documents there are autograph annotations and drafts of Theodor Mommsen and his collaborators, Heinrich Dressel, G.B. De Rossi, Giulio De Petra, Filippo Nissardi, that enlighten the working method and the contacts between the authors.
Parole chiave: Corpus inscriptionum Latinarum, signacula, Theodor Mommsen, Hein-rich DresselKeywords: Corpus inscriptionum Latinarum, signacula, Theodor Mommsen, Heinrich Dressel
L’archivio del Corpus inscriptionum Latinarum di Berlino1 continua a fungere da ricca miniera di documentazione per quanto riguarda le fasi di raccolta delle notizie, di elaborazione e di stesura dei diversi volumi; durante i mesi antecedenti questo con-vegno ho avuto la possibilità di consultare le bozze preparatorie delle sezioni dedicate all’instrumentum domesticum dei volumi che le prevedono, con lo scopo di raccoglie-re ed esaminare il materiale manoscritto pertinente ai signacula ex aere. I documenti
1. Desidero ringraziare Manfred Schimdt, Direttore del Corpus inscriptionum Latinarum presso la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, per avermi concesso di consultare e pubblicare questo materiale d’archivio, e Camilla Campedelli, per aver facilitato in ogni modo il mio lavoro. Sono molto grata ad Alfredo Buonopane, per avermi seguito in questa ricerca, e a Ivan Di Stefano Manzella, per avermi permesso di partecipare con un’anteprima di questo contributo al dossier $JiWKRQ�(di stefano Manzella et alii 2012).
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL. I signacula nei lavori preparatori del Corpus inscriptionum Latinarum
Silvia Braito
160
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL..��6LOYLD�%UDLWR
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEche qui presento compongono una selezione del materiale che ho raccolto: ho cercato
GL�LQFOXGHUQH�LO�PDJJLRU�QXPHUR�SRVVLELOH�WUD�TXHOOL�FKH�SUHVHQWDQR�JOL�VSXQWL�GL�ULÀHV-sione più interessanti e ho scelto di approfondire in quest’ottica il materiale pertinente
ai volumi CIL IX e X (1883) e al supplemento a CIL XV2.
1. CIL IX e X.I volumi IX e X del Corpus appartengono a quel numero ristretto che Mommsen
curò anche nelle sezioni dedicate all’instrumentum domesticum, nonostante la sua
LGLRVLQFUDVLD�SHU�OD�³URED�H�UREDFFLD´�FKH�EHQ�YROHQWLHUL�DI¿GDYD�DL�VXRL�FROODERUDWRUL3.I documenti testimoniano come la raccolta del materiale per i due volumi andò di
pari passo: Mommsen lavorò contemporaneamente a entrambi operando, in alcuni
FDVL��GHJOL�VSRVWDPHQWL�GD�XQ�YROXPH�DOO¶DOWUR�VX�EDVH�JHRJUD¿FD4. Purtroppo la docu-
mentazione pertinente al volume IX è scarsa, a causa, credo, del fatto che il materiale
preparatorio per l’instrumentum di questo volume fu danneggiato dall’incendio che
nel luglio 1880 colpì la biblioteca dello studioso, come egli stesso afferma in una
lettera inviata a G.B. De Rossi poco dopo la sciagura. Scrive infatti: “Dei volumi IX e
X, che conoscete, tutto il continente è salvo, come pure l’instrumentum domesticum
del vol<ume> X. Il manoscritto per le isole, specialmente la Sicilia e la Sardegna,
ha patito molto, ma spero che potrà redintegrarsi. L’istesso vale per l’instrumentum
dom<esticum> del vol<ume> IX”5. Di nessuno dei due volumi ho rinvenuto le schede
FKH�0RPPVHQ�GH¿QLYD�³FDUWROLQH´��RYYHUR�L�VLQJROL�IRJOLHWWL�GHGLFDWL�RJQXQR�D�XQ¶L-scrizione. Si conservano invece alcuni cartoncini e diversi foglietti con le trascrizioni
di signacula singoli o a piccoli gruppi, nella maggior parte dei casi su base esclusiva-
PHQWH�ELEOLRJUD¿FD��PD�QRQ�PDQFDQR�DOFXQL�IRJOL�FKH�ULWHQJR�GL�PDJJLRUH�LQWHUHVVH�H�meritevoli di approfondimento.
'XH� IRJOL�PDQRVFULWWL� �¿JJ�� ����� ULSURGXFRQR� LQ�PRGR�YLVLYDPHQWH� HI¿FDFH�XQD�serie di signacula, la cui provenienza si deduce dall’intestazione e dagli appunti a
margine. Si tratta di un elenco che illustra una serie di signacula appartenuti alla col-
lezione del patrizio salernitano Matteo Girolamo Maza6, e illustrati originariamente
LQ�XQD�PLVFHOODQHD�HSLJUD¿FD��FRPH�VSLHJD�0RPPVHQ�QHJOL�auctores del volume X.
Questa miscellanea si conservò presso l’erede Diego, dove Ignazio Maria Como la
vide e ne trasse appunti che inviò a Ludovico Antonio Muratori e conservati poi nei
fascicoli 18, 224 e 21, 231 dell’epistolario modenese. Dalle schede del fascicolo 18,
2. &,/�;9�������������VLJQDFXOD�DHQHD�&RUSRULV�LQVFULSWLRQXP�/DWLQDUXP�YROXPLQLV�;9��SDUWLV�,,�fasciculo II destinata collegit H. Dressel, Berolini 1975. Si veda infra §2. 3. La nota espressione proviene da una lettera inviata all’amico Gian Battista De Rossi, in cui elogia
Dressel e la sua ineguagliabile capacità di studiare l’instrumentum: Buonocore 2003, n. 129 pp. 243-246;
l’espressione è a p. 244.
4. Vedi infra, con elenco alla nota 24.
5. Lettera del 7 agosto 1880: Buonocore 2003, n. 83 p. 176.
6. Cfr. CIL X, p. LII e p. 187.
161
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL..��
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONE224 risulta tratto questo elenco, i cui sigilli hanno subito quindi diversi passaggi di FRSLDWXUD��SULPD�GL�FRQÀXLUH�WXWWL�LQ�CIL X7. Il confronto tra le trascrizioni sul mano-scritto e le schede del Corpus si rivela in questo caso molto utile. Innanzitutto in que-sto volume del Corpus le forme sono riportate solo in rari casi, e per quando riguarda questo nucleo nessuna delle forme particolari è segnalata8. Inoltre alcune trascrizioni
7. L’intestazione del foglio 1 recita: “Murat. Sched., Filza XVIII 224 / Como sched. s.d. / Inscriz in metallo: signacula, presso gli eredi di Matteo Girolamo Mazza”, mentre quello del foglio 2 aggiunge: “In detto libro nella rubrica Inscriptiones ex metallo et signaculorum veterum si leggono le seguenti che si conservano appresso gli eredi di Matteo Girolamo Maza patrizi Salernitani (cfr f. 1)”. 8. CIL X, 8059, 59: pesce; 64: ovale; 70: tabula ansata; 128: lettera S; 144: lunata; 174: due rettangoli sovrapposti a gradino; 284: due rettangoli sovrapposti a gradino; 299: planta pedis; 307: foglia d’edera; 316: lunata; 345: solea; 489: circolare.
¿J�����)RJOLR�PDQRVFULWWR�GL�7��0RPPVHQ�FRQ�L�signacula�GHOOD�FROOH]LRQH�0D]D��%HUOLQ�%UDQGH�EXUJLVFKH�$NDGHPLH�GHU�:LVVHQVFKDIWHQ��)RWR�$UFKLY�&,/��,QY��1U��6&+���������
162
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL..��6LOYLD�%UDLWR
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEpresentano delle differenze. Tra tutti spicca il caso di CIL X, 8059, 33, nel Corpus
edito come AMEMpTI · AVG / ISMARIANI, ma nel corrispondente disegno trascrit-
to AMEMI·TI · AVG / LIB · ISMARIANI. Nel commento alla scheda è segnata la
trascrizione di r. 1, interpretata come Amempti da Mommsen, ma si è persa nel pas-
saggio tra il manoscritto e il Corpus l’abbreviazione LIB in r. 2. Questa nuova lettura
permette di reinterpretare il sigillo, superando quella precedente che lasciava spazio a
dubbi di comprensione: propongo di leggere quindi Amempti Aug(usti) lib(erti) Isma-riani9��4XHVWD�IRUWXQDWDPHQWH�ULVXOWD�HVVHUH�O¶XQLFD�GLIIHUHQ]D�ULVFRQWUDWD�FKH�PRGL¿FD�nella sostanza la lettura di un signaculum, sebbene in altri due casi si siano perduti dei
9. Amem[p]tus Aug. Ismarianus anche in chantraine�������S�������Q�������6L�YHGDQR�OH�ULÀHVVLRQL�QHO�contributo di Alfredo Buonopane in questi Atti. Per il nome Amemptus: solin 1996, p. 412; per Ismarus:
id. 1996, p. 370.
¿J�����)RJOLR�PDQRVFULWWR�GL�7��0RPPVHQ�FRQ�L�signacula�GHOOD�FROOH]LRQH�0D]D��%HUOLQ�%UDQGH�EXUJLVFKH�$NDGHPLH�GHU�:LVVHQVFKDIWHQ��)RWR�$UFKLY�&,/��,QY��1U��6&+���������
163
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL..��
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEnessi10 e dei segni di interpunzione. Un nucleo consistente dei signacula elencati in CIL X appartenevano alle collezio-
ni del Museo Nazionale di Napoli. Per la ricognizione di questo nucleo Mommsen si avvalse della collaborazione continuativa e fondamentale prima di Giulio de Petra e poi di Heinrich Dressel, come spiega nell’introduzione alla sezione “Signacula Pom-peiana et Herculanensia”11. Giulio de Petra, insigne archeologo e dal 1875 direttore del Museo Archeologico di Napoli12, inviò allo studioso le notizie riguardanti i pos-sedimenti del Museo, mentre Heinrich Dressel compì la fondamentale opera di revi-sione autoptica delle collezioni, tanto da indurre Mommsen a utilizzare il plurale nel commento alle schede, per sottolineare il continuo e costante lavoro in collaborazione che era servito a costruirle. Rimangono, di questo lungo e meticoloso lavoro per fasi, alcuni documenti che ne testimoniano le tappe.
Alla prima fase di raccolta dei dati appartiene un gruppo di 6 fogli intitolati “Sug-gelli conservati nel Museo Nazionale”, redatti con estrema precisione da Giulio de Petra. Essi conservano un elenco di signacula�VXGGLYLVL�SHU�SDUDJUD¿�H�RUGLQDWL�DO�ORUR�interno alfabeticamente: “Pompei” (47 sigilli)”, “Ercolano” (1), “Stabia” (1), “Monte Vesuvio” (1), “Città Vesuviane” (23), “Bovianum Vetus” (1) e “di sito incerto” (96)13. Questo fascicolo non è datato, ma si tratta chiaramente dell’elenco di cui si servì Mommsen come base per comporre la prima stesura delle bozze del Corpus.
Fra i documenti pertinenti a CIL X si conserva, infatti, anche una bozza a stam-pa delle due sezioni “Signacula Pompeiana et Herculanensia” e “Signacula reliqua”, nelle quali le trascrizioni dei sigilli del Museo di Napoli corrispondono senza alcuna PRGL¿FD�D�TXHOOH� LQYLDWH�GD�'H�3HWUD�� ,O� IDVFLFROR�FRQVLVWH� LQ����IRJOL� �FRQ�SDJLQH�numerate 55-73) non rilegati, sui quali sono ben leggibili numerose annotazioni re-datte a penna o a matita; si tratta di alcune delle bozze del Corpus, che Mommsen HUD�VROLWR�GH¿QLUH�³VWDPSRQL´14 e che venivano regolarmente inviate dallo studioso ai suoi collaboratori per essere sottoposte a revisione. Le correzioni che compaiono in questo fascicolo appartengono con certezza a Heinrich Dressel, che ebbe l’incarico di revisionare l’instrumentum del volume X a Napoli, come afferma lo stesso Mommsen
10. In CIL X, 8059, 188 manca l’indicazione del nesso AV, mentre in CIL X, 8059, 268 manca il nesso MV in r. 1. 11. CIL X, p. 916: “Pleraque huius capitis signacula cum extent in museo Neapolitano hodie distributa in ordines tres Pompeianorum, oppidorum ad Vesuvium, originis incertae, ibi ea nobis descripsit Iulius de Petra, recognovit omnia nuper diligentissime Dresselius. Auctores in singulis non adscripsimus, sed satis KDEXLPXV�VLJQL¿FDYLVVH�TXDH�QRELV�FROODWD�HVVHQW´�� ���� �6XOOD�¿JXUD�GL�*LXOLR�'H�3HWUD�VL�ULPDQGD�D�scatozza-höricht 1987; gaBucci 1991. 13. L’ordine rispecchia la suddivisione interna del Museo, già descritta da Mommsen nell’introduzione a p. 916, ed espressa poi nelle schede con “mus. Pomp.” e “mus. città vesuv.” in CIL X, 8058; quelli di “originis incertae” FRQÀXLURQR� LQYHFH� LQ�CIL X, 8059. L’ordine alfabetico di elencazione corrisponde a una numerazione di cui si trova traccia in alcune schede (ad esempio CIL X, 8059, 224: “Neapoli in mus. publico n. 24”). La maggior parte di esse invece presenta numeri di inventario nuovi, dovuti probabilmente alla sistemazione del Museo effettuata da De Petra. 14. Ad esempio si veda la lettera n. 85 in Buonocore 2003, pp. 179-180.
164
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL..��6LOYLD�%UDLWR
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEin una lettera del 22 novembre 1880 a G.B. De Rossi: “Per l’instrumentum dei due
volumi ancora le porte sono aperte. Quel[lo] del vol<ume> IX non è stampato; il
manoscritto, in gran parte distrutto, è stato restituito alla meglio, spero senza grandi
hiatus. L’altr[o] del vol<ume> X fu composto prima dell’incendio e poi dato al Dres-
sel per completarlo a Napoli; aspetto ogni giorno i suo[i] materiali”15.
Le schede elencate nelle bozze sono 85 per la prima sezione e 501 per la seconda,
XQ� QXPHUR� OHJJHUPHQWH� LQIHULRUH� D� TXHOOH� FKH� SRL� FRQÀXLURQR� QHOOD� VWHVXUD� ¿QDOH�del volume, e presentano una numerazione differente (8016-8017 rispettivamente).
Le annotazioni manoscritte sono prima realizzate a matita e poi ripassate a penna, e
riguardano una buona percentuale delle schede; alcune invece non ne sono interessate
e sono barrate con un tratto a matita. Tutte le correzioni riguardano signacula appar-
tenenti a collezioni napoletane, a ulteriore conferma del fatto che questi stamponi accompagnarono Dressel durante le ricognizioni. Egli visitò innanzitutto le collezioni
del Museo Nazionale, dove ebbe modo di riesaminare gli esemplari che già De Petra
aveva trascritto per Mommsen; inoltre, vide sicuramente la collezione Santangelo16,
quella di Ferdinando Colonna di Stigliano17 e quella del collezionista Alfred Bour-
guignon18. In alcune schede compare l’indicazione “non vidi”, nel caso di signacula indicati presso tali collezioni ma non trovati, in altre l’espressione “vidi” nel caso di
signacula visionati ma le cui schede non necessitavano di correzioni.
Gli appunti riguardano principalmente le caratteristiche emerse durante l’autopsia:
indicazioni sulla forma, nei casi diversi dalla più comune rettangolare, sull’alline-
amento verticale delle lettere, se disposte su più righe, sul verso di scrittura, sulla
presenza di lettere cave. La precisione di Dressel emerge inoltre dall’attenzione de-
dicata ai castoni: ai pochissimi già indicati nelle bozze, per lo più quelli iscritti, egli
DJJLXQVH�WXWWL�L�FDVWRQL�¿JXUDWL�FRUUHGDQGR�O¶DQQRWD]LRQH�FRQ�LO�GLVHJQR�LQ�PDWLWD�GHO�VLPEROR��4XHVWR�HOHPHQWR�RYYLDPHQWH�q�DQGDWR�SHUGXWR�QHOOD�VWHVXUD�¿QDOH��FKH�VL�limita all’indicazione di ramus, caduceus alatus, uva, delphinus, amphora, ecc.; in
particolar modo il termine vas, utilizzato per un considerevole numero di signacula
SRPSHLDQL��DSSDUH�OLPLWDQWH�ULVSHWWR�DOOD�YDULHWj�GHL�FRQWHQLWRUL�HIIHWWLYDPHQWH�UDI¿-
gurati19. In modo analogo l’attenzione dedicata ai segni d’interpunzione si perde nel
15. Buonocore 2003, n. 87, pp. 182-184.
� ���� �/D�FROOH]LRQH�GHOO¶DYYRFDWR�)UDQFHVFR�6DQWDQJHOR�H�GHO�¿JOLR�1LFROD�IX�DFTXLVWDWD�GRSR�GLYHUVH�vicissitudini dal municipio napoletano nel 1864 per interessamento di Giuseppe Fiorelli. Sulla storia del
museo: Milanese 1996.
17. Il nobile napoletano Ferdinando Colonna di Stigliano (1837-1907) fu un cultore e collezionista di
antichità; fu inoltre Ispettore degli Scavi e Monumenti antichi del Circondario di Napoli e corrispondente
GL�0RPPVHQ��D�FXL�LQYLz�GLYHUVH�QRWL]LH�HSLJUD¿FKH�SRL�FRQÀXLWH�QHO�Corpus.� ���� �$OIUHG�%RXUJXLJQRQ��GD�LGHQWL¿FDUH�FRQ�LO�EDQFKLHUH�VYL]]HUR�FRLQYROWR�QHOOH�YLFHQGH�GHOOD�EDQFD�0HXULFRIIUH�GL�1DSROL��IX�XQ�FROOH]LRQLVWD�DWWLYR�D�¿QH�µ����LQ�DUHD�QDSROHWDQD��RYH�UDFFROVH�PROWL�SH]]L�che oggi si ritrovano conservati dai maggiori musei del mondo, dopo la dispersione della collezione.
Cenni in Bellelli 2006, pp. 23-24 e 29; PalMa venetucci 2007, p. 223.
� ���� �6L�YHGDQR�OH�ULÀHVVLRQL�GL�*LRYDQQD�&LFDOD�QHO�VXR�FRQWULEXWR�LQ�TXHVWL�$WWL�
165
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL..��
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEtesto stampato, che li uniformizza in pochi simboli e spesso tralascia quelli più par-ticolari, ad esempio le diverse varietà di foglie20��0RGL¿FKH�SDUWLFRODUPHQWH�HYLGHQWL�al testo riguardano soprattutto quei signacula con nessi complessi, lettere particolari R�GL�GLI¿FLOH�OHWWXUD��QHOOD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�FDVL�OH�PRGL¿FKH�VRQR�VWDWH�DFFROWH�QHOOD�VWHVXUD�¿QDOH21, anche se qualche precisazione, per motivi che mi sfuggono, è stata ignorata22. Anche l’ordine delle schede ha subito degli spostamenti, dovuti agli ag-giornamenti dei luoghi di reperimento o delle letture23. Si nota inoltre il trasferimento di un nucleo di sigilli al volume IX24, l’accorpamento di alcune schede25��O¶XQL¿FD]LR-ne di multipli26, il trasferimento ad altre sezioni27.,Q�FDVR�GL�SDUWLFRODUL�GLI¿FROWj�GL�OHWWXUD�R�GL�IURQWH�DOOD�QHFHVVLWj�GL�DSSRUWDUH�PR-
GL¿FKH�VRVWDQ]LDOL�DOOD�WUDVFUL]LRQH��'UHVVHO�UHDOL]]z�LO�GLVHJQR�GHO�signaculum28 op-pure ne trasse dei calchi, a matita su carta velina o per impressione su carta assorbente QRQ�FROODWD��FKH�LQ�VHJXLWR�¿VVz�FRQ�XQ�SXQWR�GL�FROOD�LQ�FRUULVSRQGHQ]D�GHOOD�VFKHGD�sulla pagina delle bozze. In due casi il calco fu realizzato in matita direttamente sul bordo esterno della pagina, sfruttando lo spazio libero. I due calchi in questione ap-partengono a un esemplare della collezione Santangelo (CIL X, 8059, 146) e a uno del Museo Nazionale (CIL X, 8059, 331). Un terzo calco, che doveva essere presente in corrispondenza di CIL X, 8059, 81, è stato ritagliato. I calchi in totale sono otto su carta assorbente29, tre su carta velina30, uno a matita su carta31. Tra i calchi su velina spicca quello in corrispondenza di CIL X, 8059, 236, poiché su un unico ritaglio sono realizzati i calchi dei tre multipli registrati nella scheda, due visti presso la collezione
20. Ad esempio in CIL X, 8059, 65, 86, 203, 226, 253. 21. CIL X, 8058, 35: “Aut LALI aut DALI” Dressel; CIL X, 8059, 240: “Extrema littera aut V fuit aut Y”. 22. CIL X, 8058, 25 e 8059, 18: A senza traversa; CIL X, 8058, 53: riguardo al castone: “quod est alterum sigillum”; indicazioni di eliminare spazi tra lettere (Tra I e C in 8059, 37, tra O e D in 8059, 153); CIL X, 8059, 172: le lettere sul castone sono indicate come prominenti; CIL X, 8059, 223: la forma è di planta pedis; CIL X, 8059, 231: non vi è spazio tra le ultime due lettere di r. 2; CIL X, 8059, 233: Dressel suggerisce la lettura Marci Luci Publi (lib?) SHU�LO�JUXSSR�GL�OHWWHUH�LQ�¿QH�U�����CIL X, 8059, 245: la lamina è a forma di due rettangoli sovrapposti a gradino; CIL X, 8059, 291 è a lettere cave non bonis con A senza traversa; CIL X, 8059, 303 presentava probabilmente forma a S, in quanto P è su un braccio ad angolo retto rispetto ad AE; CIL X, 8059, 323: suggerisce la lettura Apringi (?) d[i]s(pensatoris?). 23. Ad esempio in CIL X, 8059, 83 con l’aggiunta del nesso TF la lettura proposta passa da M(ercurialis?) C. Fann(i) Firmi a M. C(- - -) T. f. Ann(i) Firmi, o in CIL X, 8059, 129 dove la lettura passa da PICOVI a P. Covi. 24. CIL IX, 6083, 30, 53, 98, 105, 109, 110, 116, 147, 174, 183. 25. CIL�;������������q�LO�ULVXOWDWR�GHOO¶XQL¿FD]LRQH�GL�GXH�VFKHGH�VHSDUDWH��ULFRQRVFLXWH�SRL�FRPH�appartenenti allo stesso signaculum letto in modo impreciso. 26. CIL X, 8059, 429 b. 27. CIL X, 8061, 9: inserito tra i signacula, dopo l’autopsia constata che l’iscrizione era su una gemma. 28. CIL X, 8059, 127. 29. CIL IX, 6083, 98; CIL X, 8059, 94, 347, 208, 353, 460, 466, 483. 30. CIL X, 8059, 153, 236, 419. 31. CIL X, 8059, 440.
166
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL..��6LOYLD�%UDLWR
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONESantangelo e uno presso il Museo Nazionale32��¿J������,Q�SDUWLFRODUH��'UHVVHO�DSSXQWD�a margine della pagina l’osservazione “alles drei echt und sind desselben Form ge-gossen” per sottolineare che l’autopsia dei tre esemplari ne conferma l’autenticità, e la completa corrispondenza lo induce ad affermare che siano realizzati dalla medesima matrice, considerandoli quindi dei multipli ex forma33.
I signacula FKH�PDQFDQR�QHOOH�ER]]H�H�IXURQR�DJJLXQWL�SHU�OD�VWHVXUD�GH¿QLWLYD�GHO�volume sono facilmente individuabili: alcuni provengono dalle ricognizioni napoleta-ne di Dressel, che li vide presso le stesse collezioni dove realizzò le autopsie di quelli già noti34��PHQWUH�DOWUL�SURYHQJRQR�GD�QXRYH�FRQRVFHQ]H�ELEOLRJUD¿FKH35, da rinve-nimenti avvenuti nell’intervallo di tempo tra la composizione delle bozze e la stesura GH¿QLWLYD36, o da segnalazioni inviate direttamente a Mommsen dai suoi collaboratori37.
32. Di questi signacula (N. Luci / Grati) era già noto un altro multiplo (CIL XV, 8310, conservato presso il British Museum di Londra, inv. 1772,0313.14), e ne è stato individuato uno inedito, conservato presso le Civiche Raccolte Archeologiche di Milano e presentato da Antonio Sartori nel contributo in TXHVWL�$WWL��Q������FRQ�¿JXUD���� ���� �3HU�OD�VSLQRVD�TXHVWLRQH�GHL�PXOWLSOL�H�OD�ORUR�GH¿QL]LRQH��VL�YHGD�di stefano Manzella et alii 2012, pp. 38-39. 34. CIL X, 8059, 7, 361, 423 (presso Colonna-Stigliano); CIL X, 8059, 13, 73, 87, 269, 336 (presso il Museo Nazionale); CIL X, 8059, 479 (presso la collezione Santangelo). 35. CIL X, 8059, 11, 32, 88, 93, 106, 134, 276, 338, 339, 370, 408 (da faBretti 1699, nucleo conservato a Napoli presso Diego Vincenzo Vidania, cappellano maggiore del re); CIL X, 8059, 207. 36. CIL X, 8058, 2 (rinvenuto a Pompei nel 1881); CIL X, 8058, 77 (rivenuto a Pompei nel 1880). 37. CIL X, 8058, 41 (“Mau descripsit a. 1880”); CIL X, 8059, 97 (“Nissardius descripsit”), rinvenuto in Sardegna; CIL X, 8059, 210 (da Porto Torres, “ectypum misit Schmidtius”). Per i signacula sardi si veda il contributo di Raimondo Zucca in questi Atti.
¿J�����(VWUDWWR�GDOOH�ER]]H�GL�CIL�;�DQQRWDWH�GD�+��'UHVVHO��%HUOLQ�%UDQGHEXUJLVFKH�$NDGHPLH�GHU�:LVVHQVFKDIWHQ��)RWR�$UFKLY�&,/��,QY��1U��6&+���������
167
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL..��
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEA quest’ultimo caso appartengono due
signacula visti da Friedrich von Duhn38 a
Napoli presso Enrico Stevenson, il primo
con provenienza ex provincia Barensi (CIL
IX, 6083, 13), il secondo dalla Basilicata
(CIL X, 8059, 262). Di entrambi i sigilli
Duhn inviò a Mommsen un calco in cera-
lacca, realizzato sul retro di due biglietti
GD�YLVLWD�GL�/pRQ�+HX]H\��¿JJ��������FRPH�SRL�VSHFL¿FDWR�QHO�FRPPHQWR�DOOD�VFKHGD��“cera expressum misit Duhnius”. Anche
in questo caso la visione dei calchi è si-
JQL¿FDWLYD�SHUFKp�SHUPHWWH�GL�DJJLXQJHUH�alcuni dati che non sono riportati nel CIL:
il primo ha lamina rettangolare, il secondo
ha lamina a forma di solea e lettere cave. Da Ettore Pais invece Mommsen ricevette
il calco di CIL X, 8059, 256, come speci-
¿FDWR�QHOOD�UHODWLYD�VFKHGD39, signaculum
che apparteneva alla collezione dell’avv.
Aperlo Sclavo di Sassari40. L’esame pale-
RJUD¿FR�GHJOL�DSSXQWL�H�GHL�GLVHJQL�UHDOL]-zati sulla stessa scheda del calco (alcune lucerne e una “testa di sole”) rivelano però
che esso non fu realizzato direttamente da Pais, bensì da Filippo Nissardi41, per essere
poi solo trasmesso da Pais a Mommsen42��,O�FDOFR��¿J������UHDOL]]DWR�VX�XQ�ULWDJOLR�GL�carta e molto nitido (misure in cm: lamina 4,5 x 2, h. lettere 0,5) si rivela estremamen-
te prezioso in quanto il signaculum risulta ad oggi perduto. Mi sembra infatti di leg-
gere con chiarezza Marciani / Aug(usti) n(ostri) seguito dal simbolo ben riconoscibile
di una corona, fugando quindi ogni dubbio di lettura espresso da Mommsen43, che,
� ���� �3HU�OD�ELEOLRJUD¿D�VX�'XKQ�ULPDQGR�D�FLz�FKH�q�FLWDWR�LQ�Buonocore 2003, p. 80, nota 217.
39. “Expressam charta misit Hector Pais”; su questo signaculum si veda il contributo di Raimondo
Zucca in questi Atti (n. 32).
40. La collezione del canonico Luigi Sclavo fu ereditata dal nipote, Vittorio Aperlo. Vedi Mastino
2010, p. 196.
41. Filippo Nissardi (1852-1922), Soprastante agli scavi d’Antichità del Regio Commissariato ai
Musei e Scavi della Sardegna, fu incaricato da Fiorelli, su richiesta di Mommsen, di fornire calchi di
iscrizioni della Sardinia per il CIL��6XOOD�VXD�¿JXUD�VL�YHGD�loddo canePa 1951.
42. Sono molto grata a Raimondo Zucca per avermi segnalato l’appartenenza a Filippo Nissardi della
FDOOLJUD¿D�VXOOD�VFKHGD�H�SHU�OH�QRWL]LH�FKH�PL�KD�IRUQLWR��H�FKH�TXL�KR�FLWDWR��VXOOD�FROOH]LRQH�$SHUOR�6FODYR�H�VXOOD�¿JXUD�GL�1LVVDUGL� 43. La lettura venne già corretta in egBert 1896, p. 332, poiché il sigillo fu visto in possesso di Mr.
Olcott, Columbia College, New York; questa risulta essere l’ultima attestazione nota. Desidero ringraziare
Margherita Bolla per la segnalazione.
ÀJJ�� ����� &DOFKL� LQ� FHUDODFFD� GL� CIL� ,;�����������H�CIL�;��������������%HUOLQ�%UDQ�GHEXUJLVFKH�$NDGHPLH� GHU�:LVVHQVFKDIWHQ��)RWR�$UFKLY� &,/�� ,QY��1U�� 6&+���������6&+���������
168
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL..��6LOYLD�%UDLWR
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEabbastanza inspiegabilmente, leggeva una S seguita da un trattino orizzontale e solo nel commento affermava che “postremum signum corona videtur esse”.,Q¿QH��XQ�IDVFLFROR�GL���SDJLQH�UHGDWWR�
su carta da lettere permette di inserire an-che Gian Battista De Rossi tra coloro che contribuirono alla raccolta dei signacula per i due volumi del Corpus. Le pagine autografe, numerate 9-16, appaiono estra-polate da un fascicolo che doveva essere più corposo e presentano un elenco di 31 signacula, WXWWL�FRQÀXLWL�QHL�YROXPL�,;�H�
;��¿J������,O�FRQIURQWR�FRQ�OH�VFKHGH�GH¿QLWLYH�SHUPHWWH�GL�LGHQWL¿FDUH�TXHVWR�HOHQFR�come uno spoglio parziale del codice autografo di Gaetano Marini 9DW��/DW������, di cui Mommsen si servì per integrare con alcuni sigilli le bozze sopra descritte44. In una lettera del 30 agosto 1880 allo stesso De Rossi, Mommsen lamentava la perdita delle sue personali copie del codice di Marini nell’incendio della biblioteca, e ringraziava l’amico per avergliene inviato uno spoglio che gli era stato utile per completare le bozze dell’instumentum del volume IX45. La mancanza dei fogli iniziali del fasci-FROR�QRQ�SHUPHWWH�GL� LGHQWL¿FDUH�VH�VL� WUDWWD�SURSULR�GL�TXHOOL�FLWDWL��PD� WHVWLPRQLD�comunque come il continuo scambio tra i due studiosi in questo caso incluse anche signacula.
Per concludere, una piccola menzione merita l’introduzione alla sezione Signacula Pompeiana et Herculanensia��QHOOD�YHUVLRQH�GH¿QLWLYD�H�QHOOD�YHUVLRQH�LQ�ER]]D��,Q�TXHVWR�FDVR�OH�PRGL¿FKH�VRQR�PLQLPH��SULQFLSDOPHQWH�GL�WLSR�JUDPPDWLFDOH�R�VLQWDW-WLFR�H��LQ�XQ�XQLFR�FDVR��OHVVLFDOH��OD�VRVWLWX]LRQH�GHO�SL��VSHFL¿FR�panibus con eduli-bus; si nota inoltre un incremento degli esempi citati tra parentesi che accompagnano le diverse tipologie di testi. Questa introduzione, insieme al pionieristico compendio di Vittorio Poggi46, non solo è unica all’interno del Corpus47, ma rimane la prima e più
44. In particolare provengono da questa fonte gli undici signacula della collezione Vidania elencati supra alla nota 35. 45. Buonocore 2003, n. 84, pp. 177-178: “[...] In ogni caso avrete i bozzoli dell’instrum<entum> dom<esticum> vol<ume> IX. Lo spoglio del Marini per quella parte mi è stata di molta utilità; la mia FRSLD�GHOOH�GROLDUH�q�EUXFLDWD��H�GH¶�VLJLOOL�¿QRUD�QRQ�KR�VDSXWR�QXOOD´� 46. Poggi 1876. 47. Brevi introduzioni sono premesse alle rispettive sezioni nei volumi XI, XII e XIII, ma in ognuna di esse si rimanda a quella di CIL X, p. 915. In quella di CIL XIII (1899) compare un rimando, oltre all’introduzione mommseniana, anche all’introduzione di Dressel in vol. XV, p. 997. Come è noto questa introduzione, e di conseguenza questa pagina, verranno date alle stampe solamente postume nel 1975; ciò testimonia come fossero già ampiamente in lavorazione prima del 1899, anno di pubblicazione del CIL XIII (si veda infra §2).
ÀJ�����&DOFR�VX�FDUWD�GL�CIL�;�������������%HUOLQ�%UDQGHEXUJLVFKH� $NDGHPLH� GHU�:LVVHQVFKDIWHQ�� )RWR�$UFKLY� &,/�� ,QY��1U��6&+���������
169
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL..��
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEimportante summa sui si-gnacula a cui far riferi-PHQWR�SHU� OH�ULÀHVVLRQL�VXO�loro impiego, prima del contributo di Ivan Di Stefa-no Manzella48. La volontà di Mommsen di dedicarvi una così ampia introduzio-ne dimostra a mio avviso che egli ne riconoscesse le peculiarità all’interno delle altre categorie dell’instru-mentum, soprattutto per la varietà delle formule ono-mastiche e delle categorie di individui rappresenta-ti su di essi, di cui elenca numerosi esempi. Manca ancora apparentemente in-vece una visione più ampia del loro potenziale infor-mativo, quando rapportato al contesto di rinvenimento, se noto, e agli studi proso-SRJUD¿FL�GL�XQ�GHWHUPLQDWR�territorio. Ritengo però si possa individuare un’evo-luzione positiva nell’ap-proccio alla raccolta dei dati. La sezione dedicata ai signacula nei volumi IX e X appare infatti più aggiornata e supportata da numerose autopsie rispetto a quella loro dedicata nelle IRN (1852)49, costruita essenzialmente VX�EDVH�ELEOLRJUD¿FD��1RQ�PDQFDQR�SHUz�LPSUHFLVLRQL��FRPH�PRVWUDWR�VRSUD�H�FRPH�VSHVVR�FDSLWD�GL�VFRSULUH�GXUDQWH�VWXGL�VSHFL¿FL�HG�DSSURIRQGLWL50, da imputare forse ad una minore scrupolosità nell’approfondire le schede dell’instrumentum durante le fasi preparatorie, rispetto alla nota ed evidente meticolosità riservata alle altre tipo-logie di iscrizioni.
48. di stefano Manzella 2011. 49. IRN 6310, 1-293. 50. Vedi ad esempio le diffuse correzioni annotate da Silvia Evangelisti nel contributo in questi Atti.
ÀJ�����*�%��'H�5RVVL��VSRJOLR�GHO�FRGLFH di Gaetano Marini 9DW��/DW��������IRJOLR�Q������%HUOLQ�%UDQGHEXUJLVFKH�$NDGH�PLH�GHU�:LVVHQVFKDIWHQ��)RWR�$UFKLY�&,/���
170
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL..��6LOYLD�%UDLWR
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONE2. CIL XV.Per il Volume XV del Corpus Heinrich Dressel aveva previsto anche una pars VIII
destinata a signacula, gemmae, anuli. La morte dello studioso interruppe il lavoro di pubblicazione, e solo nel 1975 uscì, curato da Hans Krummrey, un supplemento che contiene il caput primum dedicato ai signacula ex aere. &RPH�VSHFL¿FD�LO�FXUDWRUH�nella prefazione, l’edizione ha comportato il riordino del materiale raccolto da Dres-VHO��DI¿QFKp�TXHVWH�LVFUL]LRQL�QRQ�ULPDQHVVHUR�SL��ineditae vel absconditae.
Le schede che si conservano sono realizzate per la maggior parte sullo stesso tipo di carta� XWLOL]]DWD�SHU� L� FDOFKL� HSLJUD¿FL� H� VRQR�GHGLFDWH�RJQXQD�D�XQ� signaculum. Su ogni scheda si possono leggere quindi tutte le informazioni relative al sigillo e YLVXDOL]]DUH�OD�FURQRORJLD�GHOOH�DJJLXQWH�H�GHOOH�PRGL¿FKH�FKH�QHO�WHPSR�'UHVVHO�KD�DSSRUWDWR�SHU�RJQL�DFTXLVL]LRQH�GL�QXRYL�GDWL��FRPH�ELEOLRJUD¿D�R�VHJQDOD]LRQL��$Q-che in questa serie di schede si nota la presenza di calchi, realizzati sulle stesse o su ritagli di carta a esse allegati.
Un primo nucleo di calchi sono tratti dai signacula appartenenti alla collezione dei Musei della Biblioteca Apostolica Vaticana. Furono tutti inviati a Dressel da Enrico 6WHYHQVRQ��FRPH�VSHFL¿FDWR�LQ�RJQL�VFKHGD��³HFW\SRQ�PLVLW�6WHYHQVRQ´�RSSXUH�³GH-scripsit Stevenson”. I calchi, realizzati in matita su carta velina, in questo caso sono confrontabili con gli originali, fortunatamente tuttora conservati presso la Biblioteca e pubblicati da Marco Buonocore51. È evidente, nel caso di calchi ben realizzati quali ad esempio questi realizzati da Stevenson, come essi costituiscano delle copie estrema-mente fedeli del sigillo, e quale possa essere la loro importanza nel caso gli originali siano perduti oppure ad oggi non localizzati.
Appartiene a questa seconda, sfortunata, eventualità un gruppo di signacula con-servati all’epoca a Callaly Castle, nel Northumberland inglese, dei quali Hübner inviò D�'UHVVHO�GHL�FDOFKL��FRPH�VSHFL¿FDWR�LQ�RJQL�VFKHGD��&DOODO\�&DVWOH��QRQ�&DOODE\��come indicato nel Corpus52) ospitò dal 1890 la collezione di W.H. Forman, qui tra-slata dal nipote, il Maggiore A.H. Browne, come indicato nel catalogo della collezio-ne redatto nel 189253. La collezione fu poi venduta per la maggior parte tra il 1899 e il 1900, tramite un’asta di cui rimangono due cataloghi54, e per la parte restante nel 192555. Il catalogo del 1892 registra “thirteen roman bronze stamps, with rings, handles, and potters’ names”56, senza però trascriverne alcuno. Il Corpus riporta sette signacula visti a Callaly Castle57, che ad oggi risultano dispersi. I calchi allegati alle schede permettono in questo caso di avere una chiara immagine del sigillo perduto:
51. Buonocore 1990, pp. 43-60. 52. Cfr. anche CIL VI, 31709, 36332. 53. chaffers 1892. 54. The Forman Collection 1899 e 1900. 55. walters 1926, p. 11 56. chaffers 1892, p. 96, n. 1631. 57. CIL XV 8081, 8181, 8187, 8359, 8542, 8547, 8574c.
171
1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL..��
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEparticolare ritengo sia il caso di CIL�;9��������¿J������FKH�SUHVHQWD�XQD�IRUPD�LQX-suale e dimensioni considerevoli (9,6 x 2 cm ca.), con lettere cave ed ampie (h. 1,7 FP�FD����FKH�FUHDQR�XQ¶LPSURQWD�DI¿QH�SL��DL�PDUFKL�VX�ODWHUL]L�FKH�QRQ�DOOH�GLYHUVH�forme di signacula.
In sede di autopsia Dressel realizzò altri calchi presso diverse collezioni: tra que-sti due esemplari, già visti presso la collezione Campana di Roma da Henzen, e poi giunti a Parigi presso il Museo del Louvre (CIL XV, 8334 = de ridder 1915, n. 4031, p. 213; CIL XV, 8576 = de ridder 1915, n. 4051, p. 214, tav. 123), mentre altri due furono realizzati su carta velina da due sigilli visti presso i Musei Capito-lini: su uno dei due calchi è appuntata la data 1895 vicino all’indicazione del mu-seo, elemento che sicuramente indica l’anno dell’autopsia (CIL XV, 8427 e 8437). Dressel trasse dei calchi anche da alcuni dei signacula che lui stesso possedeva, e che SRL�FRQÀXLURQR�QHOOH�UDFFROWH�GHOO¶$QWLNHQVDPPOXQJ�GL�%HUOLQR�DOOD�VXD�PRUWH58. Atto DSSDUHQWHPHQWH�VXSHUÀXR��ULVXOWD�LQYHFH�SURSL]LR�GDO�PRPHQWR�FKH�PROWL�HVHPSODUL�delle collezioni berlinesi furono gravemente danneggiati durante la guerra, e risultano oggi deformati e quasi illeggibili a causa della corrosione da fuoco e delle incrostazio-ni, oppure risultano dispersi59.
58. Si veda weiss 2007, Anhang 1, pp. 79-80 per la trascrizione del testamento, datato 27 gennaio 1914. 59. Si vedano le osservazioni nel contributo di Norbert Franken in questi Atti.
ÀJ�� ���+��'UHVVHO�� VFKHGD�DXWRJUDID�GL�CIL�;9�� ����� �%HUOLQ�%UDQGHEXUJLVFKH�$NDGHPLH�GHU�:LVVHQVFKDIWHQ��)RWR�$UFKLY�&,/��,QY��1U��6&+���������