Le societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere, pp. 173-193.
Transcript of Le societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere, pp. 173-193.
INSTRVMENTA INSCRIPTA V
Signacula ex aere.Aspetti epigrafici, archeologici, giuridici,
prosopografici, collezionistici
ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE
(Verona, 20-21 settembre 2012)
a cura di Alfredo Buonopane e Silvia Braito
con la collaborazione di Cristina Girardi
Scienze e LettereRoma 2014
Volume stampato con il contributo di: Dipartimento Tempo Spazio Immagine Società (TeSIS) dell’Università degli Studi di Verona
Rotary Club Como Baradello
Con il patrocinio di: Università degli Studi di Verona, Dipartimento TeSIS Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine (A.I.E.G.L.) Terra Italia Onlus
&RPLWDWR�VFLHQWL¿FR� Giulia Baratta, Alfredo Buonopane, Ivan Di Stefano Manzella,
Sergio Lazzarini, Marc Mayer i Olivé, Giovanni Mennella
Redazione: Alfredo Buonopane, Silvia Braito, Cristina Girardi
(GLWLQJ�H�OD\RXW�JUD¿FR��Cristina Girardi
Coordinamento peer review: Alfredo Buonopane
I contributi raccolti in questo volume sono stati sottoposti alla peer review secondo la procedura del “doppio cieco”
© 2014 Scienze e Lettere dal 1919 S.r.l.già Bardi EditoreVia Piave, 7 – 00187 RomaTel. 0039/06/4817656 – Fax 0039/06/48912574e-mail: [email protected] 978-88-6687-072-2
In copertina: il signaculum di Asturius (CIL XV, 8094) in J. Muselli, Antiquitatis reliquiae, Verona 1756, tab. XXXXVIII, 2 (incisione di Dionisio Valesi e Domenico Cunego).
IX
11
35
61
69
81
91
101
133
141
Alfredo BuonopanePremessa
Marc Mayer i Olivé Signata nomina; sobre el concepto y valor del término signaculum con algunas consideraciones sobre el uso de los instrumentos que designa
Ivan Di Stefano ManzellaSignacula ex aere e mercatura: indizi e ambiguità testuali
Manfred HainzmannSignacula und Synonyme
Simona MarchesiniSignacula: analisi linguistica
Sergio LazzariniI signacula: tra certezza dei “diritti soggettivi” e tutela GHOO¶DI¿GDPHQWR
Margherita Bolla&HQQL�VXOOH�IDOVL¿FD]LRQL�QHOOD�EURQ]LVWLFD
Giulia BarattaIl signaculum al di là del testo: la tipologia delle lamine
Francesca CeneriniNec desunt mulieres: signacula al femminile
Alfredo BuonopaneSchiavi e liberti imperiali nei signacula ex aere
Indice
Silvia Braito1HOO¶RI¿FLQD�GHO�CIL. I signacula nei lavori preparatori del Corpus inscriptionum Latinarum
Cristina GirardiLe societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere
Norbert FrankenDie lateinischen Bronzestempel der Berliner Antikensammlung aus sammlungsgeschichtlicher Sicht
Daniela Rigato I signacula ex aere del Museo Nazionale di Ravenna: un quadro introduttivo
Antonio SartoriNon Dianam magis montibus quam Minervam inerrare
Giovanna CicalaSignacula pompeiani: appunti di una ricerca in corso
Raimondo ZuccaSignacula ex aere provinciae Sardiniae
Silvia EvangelistiSignacula da Aeclanum in CIL (IX e X). Alcune note
Claudia GattaSignacula ex aere e collezionismo. Carlo Morbio e le sue raccolte
Stefano MagnaniSignacula ex aere dal territorio di Aquileia
Filippo BoscoloSignacula conservati nel Museo Archeologico di Padova
Giovanni MennellaSignacula aenea e bollatura di laterizi: a proposito di un timbro inedito nel Museo di Antichità di Torino
Marina VavassoriSignacula a Bergamo e dintorni: curiosità e quesiti
159
173
195
203
217
233
241
257
267
279
297
303
309
Elena CimarostiTre signacula da raccolte museali nell’Italia nord-occidentale
Valeria ValcheraSignacula ex aere del Museo Civico Archeologico di Bologna: notabilia�WHFQLFL��SURVRSRJUD¿FL�H�FROOH]LRQLVWLFL
Simona Antolini, Silvia Maria MarengoI signacula ex aere della regio VI adriatica
Silvia BraitoSignacula “in rete”: fra documentazione, aste online e collezionismo
Heikki SolinEpiclinus: una nota onomastica
Marco FirmatiSigilli di mercatores per doli dal porto di Pisa
Luigi Vecchio Un signaculum in bronzo con iscrizione greca da Velia
Paola Pacchiarotti, Giada Fatucci, Laura Ebanista, Sarah Gozzini, Federica LamonacaI signacula del Museo Nazionale Romano: un’esperienza didattica tra studio e EDR
0DXUL]LR�%XRUD��(UJ�Q�/DÀÕTre signacula dall’Asia Minore
Christophe Schmidt HeidenreichSignacula ex aere dans les deux Germanies et les trois Gaules : observations sur une documentation récalcitrante
Gaetano ArenaVasetti iscritti e produzione di medicamenta a Priene ellenistico-romana
Margherita Cassia“Marchi di fabbrica” a Creta e tituli picti di Ercolano: considerazioni socio-economiche
319
325
345
363
379
383
393
405
417
423
439
459
Reinhold WedenigBleiplomben mit Stempel- und Ritzinschriften aus Iuvavum (Noricum)
Zsolt VisyInstrumenta Inscripta Aenea aus Ungarn
Angela Donati(�SHU�¿QLUH
%LEOLRJUD¿D
Lista autori
479
497
515
519
581
173
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONE
Riassunto: Si presentano alcune osservazioni sulle forme di associazione (societates) ri-scontrabili nei tituli dei signacula ex aere. Le attestazioni sono state suddivise in sei ma-crogruppi rappresentativi delle possibilità di associazione (membri di una stessa familia; servi; donne-uomini; individui non imparentati; casi particolari e casi dubbi). La maggior parte di queste societates aveva luogo in ambito familiare, spesso non è però possibile determinare il grado di parentela dei membri. Altrettanto numerose sono le attestazioni di servi di una familia o di due membri della stessa famiglia. Particolarmente interessanti VRQR�LQ¿QH�L�tituli che menzionano uomini e donne (marito e moglie o fratello e sorella?).
Abstract: The current research presents some observations about the form of associations (societates) that can be found on the signacula ex aere. The tituli have been divided into six macrogroups, representative of the association possibilities (members of the same fa-milia; servi��ZRPHQ�PHQ��QRW�UHODWHG�SHRSOH��SDUWLFXODU�FDVHV��XQFHUWDLQ�FDVHV���7KH�PDMR-rity of these societates took place in a familiar range; often it’s unfortunately not possibile to determinate the degree of kinship. Likeweise copious are the exempla of the servant of D�IDPLO\�RU�RI�WZR�PHPEHUV�RI�WKH�VDPH�IDPLO\��4XLWH�LQWHUHVWLQJ�DUH�LQ�¿QH�WKH�tituli with the mention of a woman and a man together (wife and husband or sister and brother?).
Parole chiave: signacula, societates, familiae, senatores, serviKey words: signacula, societates, familiae, senatores, servi
Premessa metodologica La presente raccolta di signacula con plurima nomina si basa esclusivamente su
XQD�ULFHUFD�GL�WLSR�ELEOLRJUD¿FR��SHUWDQWR�WXWWH�OH�WUDVFUL]LRQL�H�OH�FRQVHJXHQWL�LQWHU-pretazioni sono derivate dall’edizione relativa. Manifesti sono i limiti di una ricerca meramente cartacea a cui però si è cercato di supplire rintracciando, ove possibile, di-VHJQL�H�IRWRJUD¿H��/¶LUULQXQFLDELOLWj�GHOOD�ULFRJQL]LRQH�DXWRSWLFD1 quando ci si occupa
* Desidero ringraziare il prof. Alfredo Buonopane innanzitutto per avermi coinvolto nello studio di
Le societates nel mondo romano:DWWHVWD]LRQL�GDL�signacula ex aere
Cristina Girardi
174
Cristina Girardi
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEdi instrumentum inscriptum, e di signacula in particolare, è ben evidenziata dai due casi che seguono.
Il signaculum (n. 31) fa parte di quella serie di sigilli per i quali, durante la stesura del Corpus, non venne intrapreso alcun accertamento autoptico e la cui menzione ven-ne semplicemente riportata traendola da pubblicazioni antecedenti. Dal confronto tra la trascrizione del Corpus2 tratta dal catalogo manoscritto dei musei arretini e una foto recentemente scattata, risulta evidente che sulla seconda riga è presente un legamento ET in luogo della lettera T riportata dal Corpus. Inoltre nel Corpus manca totalmente la menzione del titulus “QFO´� SUHVHQWH� VXO� FDVWRQH� VHFRQGDULR�� FKH� FHUWL¿FD� O¶DS-partenenza del sigillo ad Onesimus e lascia presupporre l’esistenza di un signaculum gemello di proprietà di Sabinus��¿J�����
Altro esempio è quello del signaculum a forma di pelta (n. 24) visto e fotografato al mercato di antichità della città di Siviglia da Fernando Fernandez Gomez3 e del
questa speciale categoria di instrumenta inscripta, per i preziosi consigli che mi ha dato durante lo studio di questo nucleo di signacula e per tutto il tempo che ha dedicato a discutere con me le relative interpretazioni. Sono grata al prof. Ivan Di Stefano Manzella per le indicazioni sulla struttura organizzativa del presente contributo e al prof. Manfred Hainzmann per le correzioni relative ai criteri di edizione. Ringrazio: la dott.ssa Giovanna Cicala per l’informazione relativa al signaculum (n. 58), il quale non si trova più nella collezione del museo parmense come indicato nel Corpus; la dott.ssa Orietta Piolanti per le informazioni H� OH� IRWRJUD¿H� GHL� GXH� signacula riminesi (nn. 19, 30); la dott.ssa Cinzia Murolo direttrice del Museo archeologico del territorio di Populonia (Piombino) per avermi inviato, già in occasione della stesura del poster per il convegno, le foto relative al signaculum (n. 21) e le informazioni relative; la dott.ssa Silvia Vilucchi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, per aver cortesemente accolto la mia domanda di studio della collezione di signacula arretini (n. 31); la prof.ssa Daniela Rigato per avermi dato la possibilità di leggere in anteprima il suo contributo da cui ho tratto l’informazione relativa al signaculum (n. 5), così come il prof. Antonio Sartori (n. 68) e la dott.ssa Valeria Valchera (n. 14). Uno VSHFLDOH� ULQJUD]LDPHQWR� YD� LQ¿QH� DOOD�PLD� DPLFD� H� FROOHJD� GRWW�VVD� 6LOYLD� %UDLWR� SHU� DYHUPL�PHVVR� D�GLVSRVL]LRQH�WXWWR�LO�PDWHULDOH�ELEOLRJUD¿FR�GD�OHL�SRVVHGXWR�VXL�signacula e per aver sempre trovato il tempo di discutere con me la presente ricerca. Il permesso alla pubblicazione delle foto Cat. nn. 19, 30 è stato concesso con lettera prot. n. 187213 del 11/10/2013, rilasciata dal direttore dei Musei Comunali di Rimini (dott. Maurizio Biordi); l’autorizzazione allo studio e alla pubblicazione delle foto della collezione dei signacula di Arezzo (tra cui il Cat. n. 31) è stata concessa con lettera prot. n. 13610 del 2/09/2014, rilasciata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (Firenze). 1. A riguardo si veda di stefano Manzella 2011. 2. CIL XI, 6712, 195. 3. fernández góMez 1991, pp. 310-312.
¿J�����6FKHGD�&,/�;,������������H�IRWR�GHOOD�ODPLQD�GHO�signaculum�FDW��Q������IRWR�&��*LUDUGL��
175
Le societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEdisegno del calco4 dello stesso, di proprietà di un collezionista sivigliano. Le discrasie di lettura riguardano la prima riga e in particolar modo la parte sinistra del sigillo; le lettere coinvolte sono quelle che più frequentemente possono dare adito a letture HUUDWH��RYYHUR��/��(��,��¿J�����
Ho organizzato le iscrizioni in una serie di tabelle: nel campo trascrizione i segni GL�LQWHUSXQ]LRQH�¿JXUDWD�FRQ�IXQ]LRQH�ULHPSLWLYD�VRQR�VWDWL�VRVWLWXLWL�GD�XQ�SXQWR��QHO�campo interpretazione, per evitare di sovraccaricare le tabelle, ho deciso di scrivere solo la lettura da me condivisa - ho però riportato in una nota ad ogni tabella le letture VXJJHULWH�GD�DOWUL�DXWRUL��/H�LQGLFD]LRQL�ELEOLRJUD¿FKH�DQWHULRUL�DO�Corpus sono state ULSRUWDWH�LQ�TXDQWR�VSHVVR�FRQWHQHQWL�XWLOLVVLPL�GLVHJQL��+R�LQ¿QH�HVSXQWR�GDOOD�WDEHOOD�il signaculum berlinese con l’iscrizione Lexo/viorum5 in quanto più probabilmente riferibile a un’etnia gallica che non a un gentilizio romano.
Societates in signaculisIl limite più rilevante dello studio di signacula in generale e degli exempla di so-
cietates�LQ�SDUWLFRODUH��q�OD�DWWXDOH�QRQ�FRQRVFHQ]D�GHOOR�VSHFL¿FR�DPELWR�GL�XWLOL]]R�GL�tali sigilli. Anche se statisticamente minoritario, è comprovato l’utilizzo dei signacula per la bollatura di laterizi6, di anfore, di pigmenti, di calce e di intonaco; altrettanto probabile è il loro utilizzo come strumento da cancelleria7. Di fondamentale impor-tanza, per capire il tipo di attività in cui erano coinvolti i personaggi menzionati sui sigilli, potrà essere lo studio dei signacula pompeiani8 e lo studio incrociato di im-pronte e timbri.
4. gonzález fernández ������Q�������SS�����������¿J�������$(/,�6$;,�,//2�590�)(/,&,66,�MI ET LEGITIMI. 5. CIL XIII, 10022, 167; di stefano Manzella 2011, p. 355. 6. taglietti 1994. 7. di stefano Manzella 2011, p. 362. 8. Ricerca in corso di svolgimento da parte della dott.ssa Cicala.
¿J�����)RWR�H�FDOFR�GHO�signaculum�FDW��Q������fernández góMez 1991, pp. 311-312; gonzález fernández ������Q�������SS�����������¿J����� ).
176
Cristina Girardi
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONESolo a titolo esemplicativo, vale la pena menzionare le societates publicanorum, non vi sono infatti prove che i personaggi menzionati nella presente raccolta possano HVVHUH�VWDWL�GLUHWWDPHQWH�FRLQYROWL�LQ�TXHVWR�VSHFL¿FR�WLSR�GL�VRFLHWj9. I settori di in-tervento di queste società erano i più diversi: costruzione, riparazione, manutenzione di opere pubbliche; sfruttamento di cave e miniere; fornitura di materiale bellico e vettovagliamento per l’esercito; riscossione delle imposte dovute allo stato: chiara è quindi la loro importanza dal punto di vista economico e sociale negli ultimi secoli della Repubblica e in parte durante i primi secoli del principato10. Queste società erano organizzate «quasi come una società per azioni moderna, alla quale i soci partecipa-vano con un apporto di capitale, traendone utili proporzionali, senza […] prendere parte attivamente alle attività […]. »11 Se nel primo periodo i publicani appartenevano pressochè esclusivamente alla classe dei cavalieri, in quanto «ai senatori era interdetta l’assunzione di appalti pubblici»12, durante il principato le societates publicanorum LQ]LDQGR�LO�ORUR�GHFOLQR��YHQQHUR�DI¿DQFDWH�GD�conductores13, i quali non appartene-vano più esclusivamente all’ordine equestre, ma potevano essere liberti e addirittura peregrini14.
Il dato più importante che emerge dalla presente raccolta di exempla di signacula con plurima nomina è che la maggior parte di società aveva luogo in ambito familiare. Purtroppo la struttura onomastica latina, unita alla diffusissima pratica dell’utilizzo di abbreviazioni, spesso non ci permette di sapere con precisione quale fosse il tipo di parentela che intercorreva tra i membri di una stessa familia��IUDWHOOL��"���SDGUH�¿JOL�R�(?), fratello-sorella (?), marito-moglie (?).
Come si dirà più diffusamente in seguito (infra §2), la possibilità di fondare società EDVDWH�VX�XQ�GHWHUPLQDWR�DPPRQWDUH�GL�GHQDUR�SHUPHWWHYD�GL�©LPSHUQLDUH�>«@�VX�¿JOL�e schiavi, a diversi livelli di responsabilità, l’organizzazione di qualsivoglia attività imprenditoriale»15, limitando H�SUHGHWHUPLQDQGR�OD�UHVSRQVDELOLWj�¿QDQ]LDULD�GHO�pater familias verso terzi.
Una visione d’insiemeRettangolare è la forma16 della lamina prevalentemente adottata per questo nucleo
di signacula, come del resto per i sigilli in generale; interessante è piuttosto l’utilizzo, attestato in 4 esemplari17, di una lamina in forma di rettangoli sovrapposti in modo scalare, conformazione che permette una suddivisione anche “ottica” dei nomi dei
9. Sulle società si veda anche il contributo di Sergio Lazzarini in questo volume. 10. ciMMa 1981, p. 1. 11. ciMMa 1981, p. 112. 12. ciMMa 1981, p. 3. 13. ciMMa 1981, p. 103. 14. ciMMa 1981, p.105. 15. di Porto 1984, p. 58. 16. Si veda il contributo di Giulia Baratta in questo volume. 17. Cat. nn. 21, 26, 52, 53.
177
Le societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEtitolari del sigillo. Una nave18, un pesce19� �IRUVH�XQ�GHO¿QR���una pelta20, un crescente lunare21 e due plantae pedis22 sono OH�DOWUH�IRUPH�ULVFRQWUDWH��¿JJ����D�E���5LPDQHQGR�LQ�DPELWR�¿JXUDWLYR��GD�VHJQDODUH�VRQR�OH�UDI¿JXUD]LRQL�WDORUD�SUHVHQWL�sul manubrio del sigillo. Non univoche sono le interpretazioni UHODWLYH�DOOD� IXQ]LRQH�GL�TXHVWH� LPPDJLQL�¿JXUDWH��SHUVRQDO-mente ritengo che possano essere ricondotte all’attività svolta dagli individui menzionati sul titulus maior; infatti le poche UDI¿JXUD]LRQL� LQGLYLGXDWH� ULPDQGDQR�� SUHVVRFKq� WXWWH�� DG� DW-tività produttive / lavorative (spica23, caduceus24, amphora25, equus26, pes27). Non solo imagines, ma anche tituli potevano essere stampigliati sul manubrio del sigillo: tituli prevalen-temente abbreviati, riconducibili spesso a uno o a entrambi i titolari del signaculum (nn. 15, 18, 31, 53), ma anche pro-babili sigle del cognomen o cognomina di servi (n. 7) e non mancano abbreviazioni particolarmente oscure, il cui possibile VFLRJOLPHQWR�ULPDQH�DQFRUD�QHOO¶RPEUD��Q������ �¿JJ����D�E����Quattro28 sono i casi di utilizzo del caso nominativo, invece del consueto genitivo; l’aspetto più singolare che si osserva è come il primus casus venga adottato prevalentemente negli exempla di associazione tra uomo e donna (nn. 49, 50, 54). 'D�ULOHYDUH�LQ¿QH�OD�SUHVHQ]D�GL�XQ�SUREDELOH�titulus mul-
tiplo29 (n. 51) attestato sia a Patavium che ad Aquae Sextiae. Non essendo stato possibile rintracciare disegni o documenta-]LRQH�IRWRJUD¿FD�GL�HQWUDPEL�L�WLPEUL�PD�VROR�GHOO¶HVHPSODUH�patavino, non è da escludere che si tratti dello stesso timbro, visto e trascritto da diverse persone in luoghi diversi. I signa-cula sono stati e sono tuttora oggetto privilegiato del collezionismo, fenomeno che ne ha comportato il loro “allontanamento” dall’originario luogo di ritrovamento, molto spesso senza lasciare alcuna traccia. Azzardato è dunque tentare qualunque supposi-
18. Cat. n. 34. 19. Cat. n. 3. 20. Cat. n. 24. 21. Cat. n. 2. 22. Cat. nn. 13, 67. 23. Cat. n. 37. 24. Cat. n. 19. 25. Cat. n. 41. 26. Cat. n. 16. 27. Cat. n. 66. 28. Cat. nn. 40, 49, 50, 54. 29. di stefano Manzella 2011, p. 349; di stefano Manzella et alii 2012, pp. 38-39.
¿JJ�� �D�E�� Exempla di signacula a forma di crescente luna-UH�FDW��Q���� (cayLus ������ H� D� IRUPD�GL� SHVFH� FDW�� Q�� ��(LiesviLLe�������
¿JJ�� �D�E��Exempla GL�UDI¿JXUD]LRQL�FDW��Q�� ��� H�GL� tituli cat. Q�� ��� VXO� PDQXEULR�dei sigilli.
178
Cristina Girardi
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEzione su possibili organizzazioni imprenditoriali/commerciali “internazionali”, come questo esempio di titolo multiplo potrebbe indurre. In assenza del puntuale confronto autoptico tra i due esemplari non è inoltre da escludere che si tratti di calchi o copie galvanoplastiche; tenderei invece a scartare l’ipotesi di un caso di omonimia.
I macrogruppiHo scelto di suddividere le attestazioni in sei macrogruppi, ognuno dei quali do-
YUHEEHUR� ULVXOWDUH� UDSSUHVHQWDWLYR� GHOOH� SRVVLELOLWj� DVVRFLDWLYH� ¿QRUD� ULVFRQWUDWH�(membri della stessa familia §1, servi §2, donne-uomini §3, individui non imparentati §4, casi particolari §5, casi dubbi §6).
1. Membri della stessa familiaCome già in precedenza accennato, appare chiara l’inclinazione dei Romani a fon-
dare società su base familiare; è probabile che le società create in ambito familiare fossero quelle in cui il rischio imprenditoriale era piuttosto ridotto, mentre venivano SUHIHULELOPHQWH�DI¿GDWH�DOOD�JHVWLRQH�GL�VHUYL��TXHOOH�LQ�FXL�L�ULVFKL�HUDQR�SL��HOHYDWL�H�in cui si voleva investire solo un determinato ammontare di capitale senza intaccare, in caso di mala riuscita, tutto il patrimonio familiare (infra §2).
Tabella 130: Membri della stessa familia
Nr. Trascrizione Interpretazione Luogo di conservazione %LEOLRJUD¿D
1ALEXIORVM Alexiorum.
Londra, British Museum, Inv. N. 1867,0508.164
walters 1899, n. 3116, p. 367; CIL XV, 8061.
2 OLIORVM //RA Oliorum // RA.
caylus 1764, p. 306, n. II, tav. 98; CIL XIII, 10022, 198; di stefano Manzella 2011, p. 362; di stefano Manzella 2014.
� · · IVLIÔRVM Iuliorum. CIL XII, 5690, 68; liesville 1870, p. 399.
4 SERGIOR Sergior(um).CIL XI, 6712, 405;Poggi 1876, p. 42, n. 70. Tav III, n. 40.
30. Tabella 1: altre letture:Cat. 2: Oliorum. // Ra(tiones?) [di stefano Manzella 2011, p. 362].Cat. 3: Duorum Luciorum Iuliorum [CIL XII, 5690, 68]. Cat. 21: LL(uciorum duorum) Corneliorum / Cerdonis et / Romuli ? Rom(ilia tribu). [Megale c.s., pp. 424-425).
179
Le societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONE5 FLAVIORVM Flaviorum.Ravenna, Museo Nazionale
rigato 2014-
6 VELLONIORVM Velloniorum.
Brunati 1837, n. 53, p. 44; de ruggiero 1878, n. 478, p. 132.
7GELONIORVM //EVC
Geloniorum��� E(- - -) V(- - -) C(- - -).
CIL X, 8059, 179.
8 LICINIORVM Liciniorum.
CIL X, 8059, 229; liBertini 1930, p. 143; Manganaro Perrone 2006, n. 18, S������¿J��S������
9 OLYMPIORVM Olympiorum.
Piacenza, Musei Civici Num. Inv. 1162
Braito 2014a.
10ANICIORVM //AN
Aniciorum // A(- - -) N(- - -). CIL XI, 6712, 38.
11 SERVILIORVM Serviliorum. CIL XV, 8473.
12 AVILLࡂ IORV · Avillioru(m).
CIL X, 8059, 63; Guarini 1834a, n. 34, p. 51.
13 VICIRIORVM Viciriorum.
CIL X, 8059, 437; cochet 1868, pp. 68-69.
14 MALIORVNIPL
Malioru(m) NIPL. Bologna, Museo Civico Archeologico
ciL xi, 6713, 27; valchera 2014.
15 VMBRICIORVM //CATETONES
Umbriciorum // Cat(- - -) et Ones(imi).
CIL XI, 6712, 487; di stefano Manzella 2014.
16ERASIORVM VALERIORVM // equus
Erasiorum (et) Valeriorum velet (?) Rasiorum (et) Valeriorum.
de köhne 1848, n. 81, p. 365; stePhani 1872, n. 109, p. 54; CIL XV, 8194; di stefano Manzella 2011, p. 348.
180
Cristina Girardi
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONE
17
&1�ƮƮƮ�5$&,/SVCC FAVS GRAT
&Q�DHRUXP��ƮƮƮ�Racil(iorum) Succ(essi) (et) Faus(ti) (et) Grat(i).
Roma, Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano
Brunati 1837, n. 30, p. 43; de ruggiero 1878, n. 462, p. 180; CIL XV, 8434; EDR029541 (S. Gozzini); di stefano Manzella 2011, p. 354; di stefano Manzella 2012b, p. 359.
18L · L PATVLCIOR IVC · ET · SVCC // IVCVNDI · L · P
L(uciorum duorum) Patulcior(um) Iuc(undi) et Succ(essi) //Iucundi L(uci) P(atulci).
CIL IX, 6083, 109.
19 MMM SEGVࡂ Lࡂ IORƨ(50�Æ7ࡂ Tࡂ $�Æ5,672%���caduceus
M(arcorum trium) Segulior(um) Herm(- - -) (et) Atta(- - -) (et) Aristob(- - -).
Rimini, Museo della Città
CIL XI, 6712, 399; giovagnetti, Piolanti 1981, p. 35.
20 QQQ · FVLVIORVM CARPI QVINTILIANI LAMIANI
Q(uintorum trium) Fulviorum Carpi (et) Quintiani (et) Lamiani.
Parigi, Cabinet des médailles, Collection Froehner
CIL IX, 6083, 62; dollfus 1967, n. 43, p. 144 (Tav. 8, n. 5, p. 145).
21 LL CORNELIORVM CERDONIS ETROMVLI · ROM
L(uciorum duorum) Corneliorum Cerdonis et Romuli Rom(a).
Museo archeologico del Territorio di Populonia (Piombino)
Megale c.s., pp. 424-426.
22 CC CORNࡂ ELIORVMFVPORI ET PHARNACIS · DC · PLO
C(aiorum duorum) Corneliorum �XSRUL�HWࡉ)ࡈPharnacis DC plo(- - - ?).
Cracovia, Czartoryski Museum
Segnalazione di Silvia Braito CZA 228744 www.bridgemanart.com
23 //�ā�Æ176�ā�0ࡂ VRR MODESTI ·ET SERENI ·
L(uciorum duorum) Ant(i)s(tiorum) Murr(iorum) Modesti et Sereni.
Biblioteca Apostolica Vaticana, magazzino del Museo profano
CIL XV, 8072; Buonocore 1984, n. 23, p. 163; Buonocore 1990, n. 35, p. 45, Tav. XXIX, n. 67; di stefano Manzella 2014.
24 II LL SEXTILIORVM FELICISSIMI ÊT LEGITIMI
II L(uciorum duorum) Sextiliorum Felicissimi et Legitimi.
fernández góMez 1991, pp. 310-312.
181
Le societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONE25II SIDERIORV Q ÊT A
II Siderior(um) Q(uinti) et A(uli).
ciL xiii, 10022, 239; schMidt 2014
26P · ATIL · QVI 3�ā�$7,/�ā�Æ03
P(ubli) Atil(i) Qui(- - -) (et) P(ubli) Atil(i) Amp(- - -).
Brunati 1837, n. 5, p. 43; de ruggiero 1878, n. 421, p. 125; CIL XV, 8099.
27M · A · VM · A · L
M(arci) A(- - -) V(- - -) (et) M(arci) A(- - -) L(- - -).
ciL xi, 6712, 17
28 ABLABIORVM MARC · TITI ·
Ablabiorum Marc(i) (et) Titi.
de ruggiero 1878, n. 415, p. 124; CIL XV, 8040.
29SVBSTENENDI · M · P
Substenendi M(arci) (et) P(ubli).
guarini 1834a, n. 86, p. 64; CIL X, 8059, 386.
30 Q · RVFRI VERI ET VICTORINI
Q(uinti) Rufri Veri et Victorini.
Rimini, Museo della Città
CIL XI, 6712, 375; giovagnetti, Piolanti 1981, p. 35.
31Q · FVLVI · ONESIMI · ÊT · SABINI // Q F O
Q(uinti) Fulvi Onesimi et Sabini // Q(uinti) F(ulvi) O(nesimi).
Arezzo, Museo Archeologico Nazionale
CIL XI, 6712, 195.
32M MAN VITALIS ET VERI
M(arci) Man(- - -) Vitalis et Veri vel M(arciorum duorum) An(- - -) Vitalis et Veri.
Brunati 1837, n. 37, p. 43; de ruggiero 1878, n. 451, p. 129; CIL XV, 8327.
33SEX C QVIETI ÊTCAECILIORVM
Sex(ti) C(aecili?) Quieti et Caeciliorum.
CIL XIII, 10022, 55.
34CAECILIOR SERVILIANI ET POTITI HERENNIANI IVN
Caecilior(um) Serviliani et Potiti (et) Herenniani Iun(- - -).
Catania, Museo Biscari
CIL X, 8059, 91; liBertini 1930, p. 143; Manganaro Perrone 2006, p. ����Q�����¿J��S�������BuonoPane 2014, p. 546, n. 27; di stefano Manzella 2014.
35 AAHERENN VIBIORVMEPITYNCHANI ·ET · EXPEDITI
A(ulorum duorum) Herenn(iorum) Vibiorum Epitynchani et Expediti.
Braito 2014d.
182
Cristina Girardi
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONE36M · IVL IVLIANI F M IVLI EVTYCHETIS
M(arci) Iul(i)
Iuliani
f(ili) (et) M(arci)
Iuli Eutychetis.
Catania, Museo Biscari
CIL X, 8059, 211; liBertini 1930, p. 143; Manganaro Perrone 2006, n. 15, S������¿J��S������
Numerose sono le attestazioni di signacula riportanti un gentilizio31 plurale di nor-ma scritto per esteso e disposto prevalentemente su due righe. E’ stato invece indivi-duato un unico esempio di sigillo (n. 16) riportante l’indicazione di due nomina diver-si in associazione. Potrebbe trattarsi sia di una gens con doppio nomen, oppure, più probabilmente, dell’associazione di due famiglie (Erasia e Valeria). Il nomen Erasius non risulta però attestato, lo è invece Rasius; è possibile quindi che il legamento ET non sia stato riconosciuto e sia stata riportata solo la lettera più evidente32. Se la mia ipotesi fosse corretta, avremmo due33 sigilli il cui titulus inizia con la congiunzione et, lasciando pertanto presupporre l’utilizzo in successione di più signacula con tituli diversi.
Altrettanto numeroso è il sottogruppo comprendente i sigilli con una serie onoma-stica completa contraddistinta dall’iterazione del praenomen o dall’indicazione del nume-rale34 relativa ad esso. La maggior parte di cognomina sono latini, l’unico esempio con cognomina grecanici è quello del signaculum riminese (n. 19). Peculiare in questo sigillo è il massiccio utilizzo di nessi concentrato nel-la zona centrale della seconda riga e l’impie-go di caratteri di dimensioni35 estremamente ULGRWWH��6XO� FDVWRQH� VHFRQGDULR�q� UDI¿JXUDWR�un caduceo, da porre probabilmente in rela-zione alla vocazione commerciale della so-FLHWj��¿J�����6LQJRODUH�q�O¶DEEUHYLD]LRQH�520�DOOD�¿QH�
del titulus del signaculum (n. 21) conservato presso il Museo Archeologico del Territorio
31. Le gentes menzionate sono: Alexia, Olia, Iulia, Sergia, Flavia, Vellonia, Gelonia, Licinia,
Servilia, Avillia, Viciria, Umbricia, Rasia, Valeria, Olympia, Mallia. 32. La trascrizione proposta dal Corpus si basa su due pubblicazioni ottocentesche riguardanti le antichità del Museo di Pawlowsk (stePhani 1872, de köhne 1848). 33. Cat. nn. 16, 64. 34. Cat. n. 17. 35. Altezza lettere 0,3-0,4 cm (giovagnetti, Piolanti 1981, p. 35).
¿J�����Signaculum riminese con cogno-mina�JUHFDQLFL�FDW��Q������IRWR�0XVHL�GL�Rimini).
¿J�����Signaculum con probabile indica-
zione di origo�FDW��Q������MeGaLe c.s.).
183
Le societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEdi Populonia36, potrebbe trattarsi di una indicazione di origo37, oppure, come sug-gerisce Carolina Megale38, della tribu39 di appartenenza, anche se la mancanza della ¿OLD]LRQH�UHQGH�O¶LSRWHVL�PHQR�SUREDELOH��¿J������
Tre sono gli exempla di tituli riportanti una serie onomastica completa a cui è unito, tramite congiunzione, un ulteriore cognomen (nn. 30, 31, 32). L’utilizzo della con-giunzione coordinante et suggerisce che si tratti di due individui appartenenti alla VWHVVD�IDPLJOLD��FRQ�EXRQD�SUREDELOLWj� IUDWHOOL��GLI¿FLOH�q� LQIDWWL� LPPDJLQDUH�FKH�XQ�LQJHQXR�SRWHVVH�DI¿DQFDUH�FRQ�TXHVWD�PRGDOLWj�il suo nome a quello di un servo.
Per quanto riguarda il sigillo (n. 30) sono da segnalare due diverse letture della seconda riga: Eugen Bormann40 lesse Victorini, mentre Oriet-ta Piolanti41, confrontando attentamente tutte le I presenti nel titulus, afferma che il tratto oriz-zontale della L, sebbene breve, è certo, e legge pertanto Ulctorini, cognomen che, tuttavia, non ULVXOWD�DWWHVWDWR��¿J�����
Peculiare, sia per la tipologia della lamina a forma di nave oneraria ma soprattutto per il ti-tulus, è il signaculum (n. 34). Il titulus recita CAECILIOR SERV/ILIANI ET POTITI/ HE-RENNIANI IVN. Il primo individuo menzionato potrebbe essere Q. Caecilius Secundus Servilia-nus42 JRYHUQDWRUH�GHOOD�7UDFLD�DOOD�¿QH�GHO�UHJQR�di Commodo e proconsole d’Asia negli anni 208-20943. Non sono purtroppo noti altri membri della sua familia, pertanto la corretta interpretazione della parte rimanente del titulus�ULVXOWD�GLI¿FLOH��3RWUHEEH�WUDWWDUVL�GL�XQ�PHPEUR�QRQ�QRWR�GHOOD�familia dei Cae-cilii, Potitus Herennianus Iun(ior ?), oppure di due persone distinte Caecilius Potitus e Caecilius Herennianus Iun(ior ?). Va tenuto inoltre presente che potrebbe trattarsi di un caso di omonimia (infra §4) e che quindi il signaculum non sia da riferire al VHQDWRUH��¿J������(G�LQ¿QH�XQ�SRVVLELOH�HVHPSLR�GL�signaculum menzionante l’associazione tra un
ingenuo ed un liberto (n. 36). Il primo tria nomina è seguito dall’abbreviazione f(ilius)
36. Num. Inv. 82020. 37. Altre attestazioni di origo si trovano in di stefano Manzella 2011, p. 355. 38. Megale c.s., p. 425. 39. Tribù Romilia (Megale c.s., p. 425). 40. CIL XI, 6712, 375: descripsit Bormann. 41. giovagnetti, Piolanti 1981, p. 35. 42. PIR2 C 82; EOS, I, pp. 537, 538; EOS, II, p. 733. 43. christol, drew, Bear 1998, p. 154.
¿J�� ���Signaculum riminese cat. n. ����IRWR�0XVHL�GL�5LPLQL��
¿J�����Signaculum a forma di nave RQHUDULD�FDW��Q������ManGanaro per-rone�������
184
Cristina Girardi
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEprobabilmente per marcare l’ingenuità del primo individuo rispetto al secondo avente un cognomen di chiara condizione servile. Non è però da escludere che invece della lettera F si debba riconoscere un legamento ET (purtroppo il grado di qualità della foto non permette di stabilirlo con certezza); in tal caso avremmo un semplice esem-pio di associazione tra due individui della stessa familia, probabilmente entrambi di condizione libertina.
2. ServiL’impiego di servi per la gestione di strutture produttive e la successiva commer-
cializzazione dei beni prodotti nasce come espediente per aggirare la lex Claudia del 218 a.C. e la lex Iulia del 59 a.C.44 che proibivano il personale coinvolgimento dell’élite sociale romana in attività produttivo-commerciali. A prescindere dalle proi-bizioni legislative, i vantaggi di «exercere negotiationes per servos»45 erano innu-merevoli: innanzitutto il servus (magister o institor) posto alla conduzione dell’impre-sa era fornito, per l’esercizio dell’attività, di un peculium che formava il patrimonio dell’impresa. L’ammontare del peculium costituiva pertanto il limite massimo e quindi predeterminabi-le del rischio imprenditoriale che il dominus voleva correre46. Questo tipo di società, che in termini mo-GHUQL� YHUUHEEH� GH¿QLWD� ³D� UHVSRQVDELOLWj� OLPLWDWD´��permetteva di mantenere il patrimonio individuale del padrone separato dall’attività imprenditoriale, riducendo la responsabilità del dominus verso terzi da illimitata a limitata. Il vantaggio più evidente di tale pratica era la limitazione dei rischi imprendi-toriali, a cui deve essere aggiunta la possibilità di gestire parallelamente le negotiationes più diverse, evitando che l’andamento di una potesse interferire sulle altre47.
Non infrequente era inoltre la pratica della manomissione dei “servi-managers” che si guadagnavano, nel corso della loro vita lavorativa, l’indipendenza48. Probabilmente riconducibile a questo usus è il signaculum contenente cognomina di stampo servile in coppia (n. 45); non è però da escludere che si tratti comunque di servi di una famiglia la cui menzione è stata sottesa.
44. auBert 1994, p. 114, nota 306. 45. di Porto 1984; auBert 1994. 46. di Porto 1984, p. 373. 47. di Porto 1984, p. 26. 48. auBert 1994, p. 36.
¿J������'LVHJQR�GHO�signaculum FDW��Q������poGGi�������
¿J������'LVHJQR�GHO�signaculum FDW�� Q�� ��� �MeesTer de rave-sTein).
185
Le societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONETabella 249: Servi
Nr. Trascrizione Interpretazione
Luogo di
conservazione
%LEOLRJUD¿D
37
ROMVLI
LAELIOR //
spica
Romuli Laelior(um) (scil. servi).
Parigi, Cabinet
des Medailles
dollfus 1967,
p. 144, n. 45;
giovagnetti,
Piolanti 1981, p. 40,
n. 30.
38 NESTORIS
NETTIORVM
Nestoris Nettiorum (scil. servi).
Cagliari,
Municipio
sotgiu 1980, p. 35-
36, n. 5; AE 1981,
472; sotgiu 2000, p.
1019; zucca 2014.
39 GELLIORVM
APRICEL[VM]
Gelliorum Apricel[um] (scil. servi).
gonzález fernández
1991, p. 187, n. 813,
¿J�������di stefano Manzella 2014.
40 SERVANDVS
Q L P ET C L P
Servandus, Q(uinti) L(- - -) P(- - -) et C(ai) L(- - -) P(- - -) (scil. servus).
Cagliari,
Museo
Archeologico
CIL X, 8059, 366;
cocco 2011, p. 827;
zucca 2014.
41
DRACONIS
Q · P · TRVTTEDI · PI //
amphora
Draconis, Q(uinti) (et) P(ubli) Truttedi Pi(- - - ) (scil. servi).
verMiglioli 1805, p.
470, n. XLVI; Poggi
1876, p. 56, n. 115
(Tav. VII 95); CIL
XI, 6712, 151.
42
M · K · B
QVINT · I
LIORVM
M(- - -) (et) K(- - -) (et) B(- - -) Quint iliorum (!) (scil.
servorum ?).
Londra, British
Museum,
Num. Inv.
1772,0313.12
walters 1899,
p. 365, n. 3079;
CIL XV, 8314; di stefano Manzella
2014.
43 MARCCLDI
ONYSIORVM ·
Marc(- - -) Cl(audiorum ?) Dionysiorum (scil. servi).
Bruxelles,
Musée du
cinquante-
naire
Meester de ravestein 1882, p.
394; CIL XV, 8330;
dollfus 1967, p.
149, n. 12.
49. Tabella 2: altre letture:
Cat. 40: L’abbreviazione PI del signaculum andrebbe sciolta, secondo Poggi, in pistori “…interpretazione
sarebbe anche nella fattispecie corroborata dal fatto che si rinvennero in Pompei pani portanti impronte di
suggelli, onde lice arguire che questi fossero molto usati dai pistori” (Poggi 1876, p. 56, n. 115). Marini
(CIL XI, 6712, 151), invece, propone un ulteriore scioglimento: pincernae (servo addetto alla mescita del
YLQR���9D�D�TXHVWR�SURSRVLWR�VHJQDODWD�OD�SUHVHQ]D�GHOOD�UDI¿JXUD]LRQH�GL�XQ¶DQIRUD�VXO�FDVWRQH�VHFRQGDULR��Cat. 42: Ivan di Stefano Manzella in questo volume propone invece la seguente lettura: mu(ria) k(astimonialis) (!) b(ona) / Quinti/liorum.Cat. 44: Un’altra possibile lettura del signaculum mi è stata suggerita da Ivan Di Stefano Manzella:
Eutychi (scil. servi) / C(ai) Cornili (!) / Athicti R�I¿FLQDWRULV� / D(ecimi) C(orneli) Nigrini. Del signaculum
QRQ�q�VWDWR�SRVVLELOH�ULQWUDFFLDUH�DOFXQD�IRWR�R�GLVHJQR�FKH�SHUPHWWD�GL�YHUL¿FDUH�VH�O¶XOWLPR�VHJQR�VXOOD�terza riga sia una lettera o un segno di interpunzione con funzione riempitiva.
186
Cristina Girardi
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONE
44
EVTYCHI
C · CORNILI
ATHICTI ·
D · C · NIGRINI
Eutychi, C(ai) Cornili (!) Athicti (et) D(ecimi) C(orneli ?) Nigrini (scil. servi).
CIL XIII, 10022,
101.
45DVMRAGMITHRES
ET CHARITONIS
Dumragmithres et Charitonis.
Maffei 1749, p.
CCXLIV, n. 5; CIL
III, 6020, 5; CIL XV,
8435. Per il nome Dumragmithres si
veda delaMarre
2004, p. 247.
Alcune considerazioni sull’ordinatio dei titu-li pertinenti questo gruppo: di norma il cogno-men del servo precede il gentilizio del padrone
ed è prevalentemente espresso in caso genitivo;
un’eccezione è rappresentata dal signaculum (n.
40) in cui è stato impiegato il caso nominativo
�¿J�� ���� ,O� cognomen del servus è normalmen-
te scritto in forma estesa; un’unica attestazione,
ammettendo che l’ipotesi di scioglimento50 sia
corretta, riporta invece i cognomina dei tre servi
della famiglia dei Quintilii abbreviati con la sola
LQL]LDOH� �Q�� ���� �¿J�� ����� 3HU� TXDQWR� ULJXDUGD� L�padroni si osserva una netta prevalenza51 di gen-tilicia declinati al plurale, negli altri casi52 di due
PHPEUL�GHOOD�VWHVVD�IDPLJOLD��¿JJ����������
3. Donne e uomini3DUWLFRODUPHQWH�VLJQL¿FDWLYR�q�LO�QXFOHR�GL�signacula riportante il nome di una don-
na associato a quello del marito o del fratello. Nei casi in cui, per indicare la donna, sia
stato utilizzato un unico elemento onomastico, risulta pressoché impossibile stabilire
il tipo di rapporto (matrimoniale o fraterno) che intercorreva tra i due, a meno di non
LPEDWWHUVL�LQ�LQGLYLGXL�FRQRVFLXWL�WUDPLWH�UHSHUWRUL�SURVRSRJUD¿FL�
50. Si veda la proposta di scioglimento di Ivan Di Stefano Manzella in questi Atti (cfr. nota n. 48).
51. Cat. nn. 33, 34, 35, 38, 39.
52. Cat. nn. 36, 37, 40.
¿J�����Signaculum�FDW��Q������&RFFR�������
¿J�� ����Signaculum FDW�� Q�� ��� �IRWR�del British Museum: © Trustees of the British Museum).
187
Le societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONETabella 3: Marito e moglie
Nr. Trascrizione InterpretazioneLuogo di
conservazione%LEOLRJUD¿D
46Q ARADI RVFINI ET IVNIE AIACIE MODESTAE
Q(uinti) Aradi 5X¿QL�HW�,XQLH�(!) Aiacie (!) Modestae.
CIL XV, 8087; BuonoPane 2014, pp. 546-547, nn. 25, 37.
47INSTEI TERTVLLI V C ET STEFANILLAE AEMILIANAE C F ·
Instei Tertulli v(iri) c(larissimi) et Stefanillae Aemilianae c(larissimae) f(eminae).
Roma, Museo Nazionale Romano (?)
CIL VI, 37126; EDR072186 (A. Ferraro); BuonoPane 2014, p. 545, nn. 9, 19.
48C BETITI PII ET FVSCINILLE
C(ai) Betiti Pii et Fuscinille (!).
Guarini 1834a , n. 97, p. 67; CIL IX, 6083, 28; di stefano Manzella 2011, p. 358; BuonoPane 2014, pp. 546, 548, nn. 26, 45; evangelisti 2014b.
49Q · SEVI · FORTVNATI · SEPPTࡂ ,0,$�ā�&6)&6)܁
Q(uinti) Sevi Fortunati, Sepptimia (!) Cresces (!) (scil. uxor).
CIL XI, 6719, 406; CIL XIII, 10022, 237; coMarMond 1846-1854, p. 457, n. 17.
50KALLIMORFVS V H ET LAVRENTIA H F EIVS
Kallimorfus v(ir) h(onestus) et Laurentia h(onesta) f(emina) eius.
grivaud de la vincelle 1807, p. 162; CIL XV, 8139; cenerini 2014.
Tabella 4: Fratello e sorella o marito e moglie?
Nr. Trascrizione InterpretazioneLuogo di
conservazione%LEOLRJUD¿D
51 FL · VERI ET IOBINE
Fl(aviorum) vel Fl(avi) Veri et Iobine (!).
orsato 1652, n. I, p. 171; CIL V, 8116, 27; CIL XII, 5690, 54; CIL XV, 8225.
52 ASTERII (9120,Æ(
Asterii (et) Eunomiae.
Berlino, Staatliche Museen, Antiken-sammlung
CIL XV 8093; EDR125661 (S. Orlandi); BuonoPane 2014, p. 548-549, nn. 48, 56; cenerini 2014.
188
Cristina Girardi
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONE53IVSTI · ET
SABINAE //
I E T S
Iusti et Sabinae // I(usti) et S(abinae).
lanciani 1882, n.
592, p. 170; CIL XV,
8289; di stefano Manzella 2011, p.
354; cenerini 2014.
54IVSTVS
SABINAIustus (et) Sabina.
Guarini 1834a, n. 40,
p. 42; CIL X, 8059,
218.
3DUWLFRODUPHQWH�VLJQL¿FDWLYD�q�OD�SUHVHQ]D��DOO¶LQWHUQR�GL�TXHVWR�JUXSSR��GL�EHQ�WUH�(un quarto incerto) senatori
53 menzionati insieme alla moglie. Se nei casi in cui sul
signaculum venga riportata l’indicazione onomastica di un’unica persona, le possi-
bilità di omonimia vadano sempre tenute in considerazione, qui invece si riducono
quasi a zero.
C. Betitius Pius54, patrono della colonia Canusium nell’anno 223, viene menziona-
to nel sigillo (n. 48) insieme alla moglie Seia Fuscinilla55. Da segnalare la presenza
di altri due signacula riferibili alla gens Betitia: uno56
appartenente al vir clarissimus,
e l’altro57
a Successus servo di Betitia Pia58,
SUREDELOPHQWH�OD�¿JOLD�RSSXUH�OD�VRUHOOD59 del
senatore. Il signaculum (n. 46) menziona Q. $UDGLXV� 5X¿QXV60, membro dell’importan-
te famiglia senatoria africana degli Aradii61, sposato con Iunia Aiacia Modesta��¿JOLD�GL�Q. Aiacius Modestus Crescentianus, consul bis ordinarius del 228
62. Un unico sigillo (n. 47)
adotta le sigle VC (vir clarissimus) e CF (cla-rissima femina) per segnalare il rango senatorio dei due coniugi Insteius Tertullus63
e
Stefanilla Aemiliana64. Il signaculum (n. 52), riportante solo due cognomina, potrebbe
menzionare o il senatore L. Turcius Secundus Asterius65 con la moglie [- - -]ae Pater-
53. Per i primi risultati di una ricerca riguardante gli appartenenti all’ordine senatorio si veda
BuonoPane 2014.
54. PIR2 B 118, p. 365; EOS, II, pp. 131-132; evangelisti 2014a, p. 638.
55. PIR2 F 597; S 250; EOS, I, p. 120; EOS II, pp. 131-132; settiPani 2000, p. 326, stemma.
56. CIL XIII, 10022, 46: C · BETITI · PII // VETVS.
57. CIL IX, 6083, 141: SVCCESSI / BETITI/AE · PIAE.
58. PIR2 B 121.
59. evangelisti 2014a, p. 638.
60. PIR2 A 1016; EOS, II, pp. 690, 691, 713.
61. Panciera 1987; christol 1978.
62. Panciera 1987, p. 549.
63. PIR2 I 37; PLRE, I, Tertullus 5; EOS, II, p. 743.
64. PIR2 S 893; PLRE, I, Aemiliana 2.
65. PLRE, I, Secundus 6; cfr. 1147, stemma 29.
¿J������6LJQDFXOXP�EHUOLQHVH�FDW��Q������IRWR�('5���������
189
Le societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEnae [Eu]nomiae66 - noti da un’iscrizione67 per una base di statua a Roma - oppure due fratelli68 della gens Turcia �¿J��������
Interessante sia per il non frequente utilizzo del caso nominativo, sia per le sigle abbreviate VH (vir honestus) e HF (honesta femina) che connotano i due titolari è il VLJLOOR��Q�������,QVROLWR�q�LQ¿QH�LO�signaculum (n. 49) riportante il nome della donna con onomastica bimembre in caso nominativo, anteceduto dal tria nomina del marito in caso genitivo.
4. Individui non imparentatiNon molti sono gli exempla di signacula riportanti associazioni di individui non
legati da evidente parentela; sarebbe particolarmente utile riuscire a individuare il preciso ambito di utilizzo di questo ristretto nucleo di signacula - ammesso che ve ne IRVVH�XQR�VSHFL¿FR����LQ�PRGR�GD�FDSLUH�VH�HVLVWHYDQR�GHL�SDUWLFRODUL�DPELWL�HFRQRPLFL�in cui membri di una stessa famiglia non potevano essere coinvolti, comportando così la necessità di fondare societates tra individui non legati da vincoli parentelari.
Tabella 5: Individui non imparentati
Nr. Trascrizione Interpretazione Luogo di conservazione %LEOLRJUD¿D
55 C AVIDI FLORINI CN · LVCRETIHERMETIS
C(ai) Avidi Florini (et) Cn(aei) Lucreti Hermetis.
Guarini 1834a, n. 70, p. 60; CIL X, 8059, 62.
56 CN LVCRETI FRVGI Q FABI TROPHIMI
Cn(aei) Lucreti Frugi (et) Q(uinti) Fabi Trophimi.
CIL XI, 6712, 260.
57 M · VAL · LARC LAN · NVNC
M(arci) Val(eri) Larc(- - -) (et) L(uci) An(- - -) Nunc(- - -).
Guarini 1834a, n.4, pp. 29-30.
58 M · RVTILI ·P · NAEVI · RVFI
M(arci) Rutili (et) 3�XEOL��1DHYL�5X¿�
CIL XI, 6712, 376; Poggi 1876, n. 63, p. 41, (Tav. III, n. 39).
59 C AELI FELICIS ET NONI PII
C(ai) Aeli Felicis et Noni Pii.
CIL XIII, 10022, 57coMarMond 1846-1854, p. 456, n. 3; di stefano Manzella 2011, p. 353.
66. PLRE, I, Eunomia 2; cfr. 1147, stemma 29. 67. CIL VI, 1773 = EDR125660 (S. Orlandi): [- - -]ae Paternae/ [Eu]nomiae, c(larissimae) m(emoriae) f(eminae), /uxori optumae /et merito/ dilectissimae/ L(ucius) Turcius Secundus/ Asterius, v(ir) c(larissimus), ex aere/ statuam dedit. 68. PLRE, I, 1147, stemma 29; PLRE, II, Asterius 3; PLRE, II, Eunomia.
190
Cristina Girardi
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONE
60L · RVL · MART
ET M · PATER
L(uci) Rul(- - - ) Mart(- - -) et M(arci) Pater(ni ?).
CIL XIII, 10022, 223
coMarMond 1846-
1854, p. 457, n. 11;
feugère, Mauné
2005-2006, p. 449,
456.
61 Æ7,�ā�393,/,��COELI FESTࡂ I
Ati Pupili (!) (et) Coeli Festi.
BuonoPane 2010, pp.
465-468; AE 2010,
572.
Quasi tutti i sigilli adottano un’onomastica trimembre; in un unico caso (n. 61) il
praenomen è omesso per entrambi i titolari del sigillo. In alcuni casi si nota l’assenza,
in uno solo dei due individui menzionati, del praenomen o del cognomen, forse per
evitare ripetizioni.
5. Casi particolari
Tabella 669: casi particolari
Nr. Trascrizione InterpretazioneLuogo di
conservazione%LEOLRJUD¿D
62
DVORVM IVLIO
RVM HERMETIS
ET SOTERICHI //
DCSCIP
Duorum Iuliorum Hermetis et Soterichi // DCSCIP.
CIL XIII, 10022,154.
63 ƮƮƮ62& ƮƮƮ�VRF�LRUXP��
CIL X, 8059, 3; di stefano Manzella 2011, p. 354; di stefano Manzella
c.s. b
64 ETG · CIRRI
TVRANNI
Et G(ai) (!) Cirri Turanni (!).
verMiglioli 1805, n.
LVI, p. 472; Poggi
1876, n. 5, p. 27,
(Tav. VI, n. 75); CIL
XI, 6712, 113; di stefano Manzella
c.s. b
Parecchi sono i signacula menzionanti liberti imperiali70, unica è però l’attestazio-
ne di un signaculum riportante due nomi di liberti della gens Iulia, o di discendenti di
liberti, in coppia (n. 62); altrettanto unica è l’indicazione del numerale scritto per este-
so (duorum). Sul castone secondario è presente la sigla DCSCIP, il cui scioglimento
69. Tabella 6: altre letture:
Cat. 64: ETG(- - -) Cirri Turanni (scil. servus) (di stefano Manzella 2011, p. 354, nota 44).
70. Si veda il contributo di Alfredo Buonopane in questi Atti.
2014
2014
CIL XIII, 10022,154.
191
Le societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONErisulta per il momento insoluto; è probabile però che si tratti di un’abbreviazione relativa alle mansioni svolte dai liberti. Le identità dei tre componenti della società71 PHQ]LRQDWD�QHO�VLJLOOR�VXFFHVVLYR��Q������ULPDQJRQR�LQYHFH�FHODWH��3DUWLFRODUH�q�LQ¿QH�il signaculum (n. 64), potrebbe infatti trattarsi del pendant di un altro sigillo; sarebbe quindi il secondo caso72��¿QRUD�ULQWUDFFLDWR��GL�XWLOL]]R�GL�signacula personali in asso-ciazione. Non è però da escludere, come suggerisce Ivan Di Stefano Manzella73, che nelle prime tre lettere non vada riconosciuta la congiunzione ET ma il nome abbre-viato del servo.
6. Casi dubbi
Tabella 774: casi dubbi
Nr. Trascrizione Interpretazione Luogo di conservazione %LEOLRJUD¿D
65IVL ASCAN ÊT VICTORIS // ramus palmae
Iul(iorum) Ascan(i) et Victoris vel Iul(iorum). Ascan(i) et Victoris (scil. servorum).
CIL XIII, 10022, 151.
66 FADIOR · FEL ÊT MARCIAN // pes
Fadior(um) Fel(icis) et Marcian(i) vel Fadior(um) Fel(icis) et Marcian(i) (scil. servorum).
Leiden, 5LMNVPXVHXP�van Oudheden
CIL XI, 6712, 177; donati 1967, n. 170, p. 110, Tav. XX.
67 TESTIMORVM · ONESIMI · ET HERMESIONIS · ·
Testimorum Onesimi et Hermesionis vel Testimorum Onesimi et Hermesionis (scil. servorum).
CIL XI, 6712, 434; Poggi 1876, n. 101, p. 52-53, (Tav. VI, n. 77).
68 MVCIORVM PAVLINI ÊT PROCVLI
Muciorum Paulini et Proculi vel Muciorum Paulini et Proculi (scil. servorum).
Como, Museo Civico Archeologico
sartori 2014.
71. Si veda il contributo di Ivan Di Stefano Manzella in questi Atti. 72. Cat. n. 14. 73. di stefano Manzella 2011, p. 354, nota 44. 74. Tabella 7: altre letture: Cat 68: Firmi Pup(orum) Umbriorum (servi) (cagnat 1914, pp. 46-47); Firmi pup(orum) / Umbriorum / sul manubrio P(- - -) E(- - -) M(- - -) (evangelisti c.s.).
192
Cristina Girardi
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONE69FIRMI PVP VMBRIORVM // PEM
Firmi (et) Pupi Umbriorum (scil. servorum) // PEM.
guarini 1842, p. 82 n. 5; CIL IX, 6083, 57; cagnat 1914, pp. 46-47; evangelisti 2014b.
70 FLORENTI ET LEONTI
Florenti et Leonti.
Roma, scavo del Campo Santo Teutonico
CIL XV, 8226; Pavolini 1992, p. 161.
71 ATTICI · ET SEVERI · Nࡄ
Attici et Severi n(ostrorum).
Biblioteca Apostolica Vaticana, magazzino del Museo profano
CIL XV, 8101; Buonocore 1984, pp. 160-161, n. 5; Buonocore 1990, p. 45, n. 36.
72CLAVDITI[- - -] ERIS ET APE[- - -]
Claudi Ti[- - -] eris et Ape[- - -].
Brunati 1837, n. 37, p. 43; de ruggiero 1878, n. 451, p. 129; CIL XV, 8327.
73AF VINISS V · ET 1$/9,1,Æ(
A(- - -) F(- - -) Viniss(- - -) V(- - -) et Nalviniae (!).
CIL XIV, 4119, 5; CIL XV, 8581.
74 CLARISI VERT CARPI · FILII
C(ai) Larisi Vert(- - -) (et) &DUSL�¿OLL�
CIL XI, 6712, 249.
75S · F · Z · ÊT S · F · ME // ramus palmae
S(exti) F(- - -) Z(- - -) et S(exti) F(- - -) Me(- - -).
Brunati 1837, n. 50, p. 44; de ruggiero 1878, n. 470, p. 131; CIL XV, 8206.
76Q · F · C · F · F Q · F · CQF · S P · F · Q · F · K
Q(uinti) F(- - -) C(ai) f(ili) F(- - -), Q(uinti) F(- - -) CQF S(- - -), P(ubli) F(- - -) Q(uinti) f(ili) K(- - -).
santarelli 1894b, p. 376; CIL XI, 6712, 171.
I tituli dei signacula (nn. 65, 66, 67, 68) presentano la medesima struttura: genti-licium seguito da due cognomina. Potrebbe trattarsi di signacula appartenenti a due servi di una familia, oppure di sigilli di età tarda menzionanti individui di rango nella FXL�RQRPDVWLFD�YHQLYD�VSHVVR�RPHVVD�O¶LQGLFD]LRQH�GHO�SUHQRPH��¿J������'LI¿FLOH� ULVXOWD� VWDELOLUH�� QHO� FDVR� GL� signacula caratterizzati da tituli contenenti
solo cognomina (n. 70), se fossero appartenuti a individui ingenui o di rango servile. Peculiare e raro è il caso del signaculum (n. 71) in cui si leggono due cognomina seguiti dall’indicazione n(ostrorum). Il possessivo noster connesso a un cognomen è
193
Le societates nel mondo romano: attestazioni dai signacula ex aere
COPIA P
ER L
A CONSU
LTAZI
ONEalquanto raro75�H��TXDOL¿FD�SHUVRQH�GL�FRQGL]LRQH�VRFLDOH�HOHYDWD��GRPLQL�GL�VHUYL�R�liberti). Il nome di una donna, Salvina76, compare nel sigillo (n. 73), ma è anteceduta GD�XQ¶LQGLFD]LRQH�RQRPDVWLFD��"��QRQ�LQWHOOLJLELOH��(G�LQ¿QH�GXH�signacula (nn. 75, 76) contengono solo lettere in successione che possono forse essere interpretate come sigle onomastiche di individui appartenenti a una medesima familia �¿J������
75. chantraine 1967, p. 193, nota 3. 76. Bormann nel commento del Corpus propone di leggere la lettera S in luogo della N rovesciata riportata sul codice Vat. lat. 9140, f. 266.
¿J������'LVHJQR�GHO�signaculum�FDW��Q�����(poGGi�������
¿J������'LVHJQR�GHO�signaculum�FDW��Q�����(sanTareLLi 1894b).































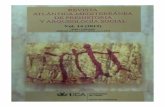
![[with H. Stilke] Spätmittelalterliche "Komforen" aus Emden und ihre niederländischen Parallelen. Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 61 (1992), 173-188.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631baae73e8acd9977058960/with-h-stilke-spaetmittelalterliche-komforen-aus-emden-und-ihre-niederlaendischen.jpg)













![Predestination and Hierarchy: Vallabhācārya's ... Puṣṭipravāhamaryādabheda (J of Indian Philosophy 39 [2011]: 173-227))](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631430bec32ab5e46f0cc519/predestination-and-hierarchy-vallabhacaryas-puipravahamaryadabheda.jpg)

