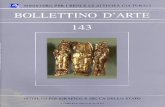L'impatto della politica regionale dell'Unione Europea. Uno studio sulle regioni italiane
Sulle attestazioni arcaiche del prefisso di coniugazione ti
Transcript of Sulle attestazioni arcaiche del prefisso di coniugazione ti
QUADERNI DI SEMITISTICA
15
MISCELLANEA EBLAITICA, 1
a cura di PELIO FRONZAROLI
Lavoro eseguito con il contr.ibuto dei C. N R:
1988 DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA
UNNERSITÀ DI FIRENZE
-
SULLE ATTESTAZIONI ARCAICHE DEL PREFISSO DI CONIUGAZIONE TI*
Marco Bonechi
Ad Ebla, il sistema dei prefissi di coniugazione, per il tema semplice, attesta "'a-, ta-, yi- e ni-l, analogamente al paleoaccadico. Fin dai primi lavori2 è stata anche notata la presenza di un prefisso ti- di non evidente collocazione strutturale.
*Desidero ringraziare il Prof, P. Fronzaroli ed il Dott. G. Conti per molte importanti osservazioni.
1 V. I. J, Gelb, Ebla and the Kish Civilization, LdE, p. 36; R. I. Caplice, Eblaite and Akkadian, LdE, p. 162; E. Lipinski, Formes verbales dans les noms propres d'Ebla et systéme verbal sémitique, LdE, pp. 191 es.; H.-P. Mtiller, Das eblaitische Verbalsystem nach den bisher veroffentlichten Personennamen, LdE, pp. 223 sa.; P. Fronzaroli, Per una valutazione della morfologia eblaita, SEb 5 (1982), pp. 107 es.; K. Petracek, Les catégories flexionnelles en Eblaite, QuSem 13 (1984), p. 40; G. Conti, Arcaismi in eblaita, QuSem 13 (1984), p. 164. Contro la possibilità di una ricostruzione */ya-/ per la 3a m. s. (v. D. O. Edzard, Sumerisch 1 bis 10 in Ebla, SEb 3 [1981], pp. 123 sa., e anche ARET 2 s. v. i-ti, ma cf, G. Pettinato, Testi cuneiformi del terzo millennio in paleo-cananeo rinvenuti nella CB.111pagna 1974 a Tell Hardikh = Ebla, Or 44 [1975], p. 373), v. ora J, Krecher , Sumerische und nichtsumerische Schicht in der Schriftkultur von Ebla, BaE, pp. 158 s., e, in attesa di una più ampia documentazione, P. Fronzaroli, loc. cit., p. 108, n. 36.
2 G. Pettinato, Ebla 1, p. 72.
122 M. Bonechi
A questo proposito bisogna però innanzitutto notare che una presenza sporadica di ti- non è ignota nei testi del III e II millennio che provengono da aree linguistiche che hanno di regola, come l'eblaita, i prefissi ->a-, ta.-, yi- e ni-. Se inquadrate in tale contesto, le attestazioni di Ebla documentano dunque la presenza, secondaria, del prefisso già in età tardo-presargonica; dopo quelle eblaite, che sarebbero sinora le più arcaiche, si hanno altre attestazioni, in un area che dalla Mesopotamia meridionale (Larsa) giunge sino al medio Eufrate (Emar), dall'età tardo-sargonica fino al Bronzo Tardo. In area semitico-occidentale, invece, il prefisso, che non è noto in amorreo, è regolarmente attestato, dal II millennio, nelle lingue nelle quali agisce la legge di Barth-Ginsberg.
Questa, in mesopotamici nei verbali a prefisso
a) Kish
ordine cronologico, la serie dei testi quali sono state identificate forme ti-:
La più antica attestazione del prefisso si trova in un incantesimo da Kish, edito da I. J. Gelb in MAD 5.8, e riletto da J. e A. Westenholz3, i quali lo datano al periodo tardo-sargonico e correggono l'interpretazione del precedente editore4:
s u-da-ra wa-a[r-d]a-da I da-me-iq-da tu-ub-dana-ma I ki-rf-sum tu-ur4 -da I 9 tu-ur4 -da-ma a-na GI$.KIRI6 I ru-rib-ti ga-na-ak-tim I ti-ib-da-ad-ga,
da intendere 6 wardata. I damiqta. tubta.nnama I kirisum
3 Help for Rejected Suitors - The Old Alladian Love Incantation HAD 5 8, Or 46 (1977), pp. 198-219; v. anche, precedentemente, di A. Westenholz, in sede di recensione a /fAD 4 e 5, JNES 31 (1972), pp. 381 s., e Old Akkadian School Texts, AfO 25 (1974/77), PP• 95 s.
4 Cf. per ti-ib-da-ad-ga i dubbi dello stesso Gelb in HAD 3, P• 104.
J
Il prefisso di coniugazione ti 123
turda I 9 turdama ana kirii(m) I rugti kanaktim I ..• "voi ••. , voi due belle ragazze, fiorenti voi siete,
al giardino scendete, al giardino scendete, voi ... incenso".
b) Mari Le attestazioni mariote provengono tutte dai testi
dell'epoca degli Sakkanakku. Questi testi, secondo la recente ricostruzione storica di J.-M. Durands, pur estendendosi per un lasso di tempo molto lungo, che si conclude con l'età di Isin-Larsa, e pur essendo, quelli di datazione arcaica, quantitativamente scarsi, conservano nel loro insieme caratteristiche linguistiche arcaiche. Vi è innanzitutto la serie ARM 19.38-45 che ha, nel complesso ed in modo omogeneo, la struttura:
n gurus I ru-si I tim-za-u I è-a I si-laI I I n u 4 i t i I NM.
C'è poi il testo edito da R. R. Jestin in RA 46 (1952), p. 190, n. 23 (= ARM 19.382), r. 4-v. 3:
(beni) Ix dub-sar I agax-us -su I 6 nar I 14 ka-é-gal I su 3 si/ ti-ku-lu,
"{beni): x scribi, 1 gendarme, 6 cantori, 14 (preposti) alla porta del palazzo che, per la terza volta, hanno consumato".
Infine, un'ultima attestazione del prefisso a Mari si ha ora nel testo M 10556, edito da Durands, 20-24:
(NP ••• NP) I é s - g id su sf-kà-tf I tim-ba-$6. I n in da ti-ku-lu I k a s ti-is-té.-u I 6. ì ti-il-tap-tu,
"(NP ••• NP) (sono) gli agrimensori che hanno battuto i picchetti: si è mangiato il pane, si è bevuta la birra, ci si è unti d'olio".
5 La situation historique des Sakkanakku: nouvelle approche, 11ARI 4 (1985), pp. 147-172.
6 Sumérien et aklradien en pays amorite, MARI 1 (1982), pp. 79 ss.
124 M. Bonechi
c) Larsa Il prefisso è attestato in una tavoletta edita da
W. Walters 7, di età paleo babilonese, che, per le sue peculiarità grafiche, si distingue all'interno di quel corpus di lettere:
B a-[na] ma-ma-an I sa. ti-KA-bi-u I 18 sum-ma be-lf I [a] t-ta I [la] ti-ba-da-ar, "per chiunque tu abbia designato ... se tu sei il
mio signore, non essere impaziente". Questa attestazione non è però isolata nel com
plesso delle coeve lettere da Larsa8; il prefisso si trova infatti anche in TCL 17.28:
1 a-na. be-el-su-nu I qf-bf-ma I ... 6 sum?!-ma ti-iq-bi-am I um-ma at-ta-ma, "al loro signore dì .. . se tu hai detto così
in TCL 18.98:7: ti-sa-Pl-ar, in contesto molto mentario.
d) Emar
" ••• ' e fram-
Alla fine del Bronzo Tardo si situano le attestazioni di Emar. Il primo testo è quello edito da J, Huehnergard9, 18-26 e 36-39:
i-nu-ma Ifbé-ba-te DAM-ti-a / EGIR-ki LU2 za-iari I ti-il-la-ak I TUG2.MES-si a-na GIS.SU2.A I lu-u tiis-ku-un / a-sar SA3-bi-si / lu-u ti-lik I sum-ma IfaJba-ti DUMU.MI2-ia I ti-im-tu-ut I ... I ù sum-ma I IfaJba-ti I ù 1a-bu-ya-qa-rù I ti-im-tù-ta ù NUMUN.MES NU.TUK,
"Se mia moglie ij. vorrà andare dietro ad uno straniero, metta le sue vesti su di uno sgabello e vada
7 w. Walters, Water of Larsa. An Old Babylonian Archive deal
ing with Irrigation (= YNER 4), New Haven - London 1970, p. 43 (da qui in avanti citato come YNER 4).
8 Come notato, in sede dì recensione al libro di Walters, da M. Stol in BiOr 28 (1971), P• 366,
9 Five Tablets from the Vicinity of Emar, RA 77 (1983), pp.
16 ss., n. 2.
Il prefisso di coniugazione ti 125
dove vuole. Se mia figlia A. muore ... E se A. e A. muoiono, e non hanno discendenti ... ".
A questo, va aggiunto il testo edito recentemente da D. ArnaudlO:
10' sum-ma fi-sa-ar-te / DUMU.MI2 -ia ti-im-tu-ut I ... , "se mia figlia I. muore ... ", e
20• ... sum-ma DAM-su I ti-im-[ t] ù-ut I ... , "se la sua sposa muore".
Quale è la funzione di queste forme verbali? Si può innanzitutto osservare che essa non è, a prima vista, unitaria.
Circa il testo kishita MAD 5.8, l'interpretazione di ti-ib-da-ad-ga come seconda persona duale del perfetto, anche se non riesce a chiarirne il significato, non essendo evidente un riferimento etimologico appropriatp11, è strutturalmente adeguata, venendo a riconoscere una simmetria con forme sicure di seconda persona duale alle linee precedenti, tu-ub-da-na-ma alla linea 7 (compiuto t/2 da baniinum, "fiorire"), e tu-ur4 -da alla linea 8 (compiuto 0/1 da wariidum, "scendere").
Riguardo a Mari, invece, la situazione è differente. Per i testi ARM 19.38-45, anche se il contesto non è chiaro, che si tratti di forme verbali di terza· maschile plurale è reso evidente dal confronto con i testi di struttura analoga ARM 19.46-50, dove si ha im-za-'à al posto di tim-za-u, con un soggetto singolare o duale, 1 o 2 guru s 12, Quanto al testo Jestin, l'interpretazione data da H. Limet13 di ti-ku-lu come terza maschile plurale da akiilu, superando quella del precedente editore che non dava senso accettabile, è perfettamente adeguata al contesto, trovando conferma strutturale nelle
10 EHAR VI/3.185. 11 v. J. e A. Westenholz, Or 46 (1977), p. 208, ad 1. 11. 12 v. D. o. Edzard, Die 3. Person m. pl. ti12V3u im Alt
akkadischen von Mari, Fs Birot, p. 85. 13 Observations sur la grammaire des anciennes tablettes de
Mari, Syria 52 (1975), P• 48, testo e n. 4.
126 M. Bonechi
altre attestazioni dello stesso schema ti12V3ii a Mari, ed è stata universalmente accettata14, A conferma di questa analisi può inoltre essere citato oggi il testo edito da Durand, che, in un contesto più facilmente comprensibile dei precedenti, la festa per la conclusione di un contratto, esibisce quattro forme verbali di terza maschile plurale di tipo ti12V3ii.
Per i testi di Larsa, il contesto, nei casi di ti-bada-ar e ti-iq-bi-am, indica chiaramente un riferimento alla seconda maschile singolare. Analogamente, anche tiKA-bi-ii è, con estrema verosimiglianza, una seconda maschile singolare del congiuntivo, anche se, come nota l'editore, ci sono ostacoli grafici per l'identificazione della radice; dato però che una interpretazione /tiqab bP-u/ si impone15, l'uso di KA = qà costituirà evidentemente un'ulteriore stranezza nella tavoletta, da aggiungersi alle forme con ti- e a i-ti-al-ku- ii per ittalkii alla linea 7. Quanto a ti-sa-PI-ar, inserito da Stol in questa serie, la frammentarietà del contesto ne ostacola l'interpretazione, e viene citato solo per completezza.
Infine, quanto ai testi di Emar, bisogna notare che le prime quattro forme del primo testo e l'attestazione del secondo sono ev.identemente delle terze persone femminili singolari, mentre la rimanente è una terza comune duale.
In conclusione, le forme verbali a prefisso ti- sin qui analizzate si distribuiscono nel modo seguente:
ti-qà-bi-ii ti-ba-da-ar ti-iq-bi-am ti-sa-PI -ar
Larsa " " "
14v, I. J, Gelb, LdB, p. 64, superando i propri dubbi espressi in On tbe Recently Published Economie Texts fro• Ha.ri, RA 50 (1956), p. 4, e Edzard, Fs Birot, p. 85.
15 V. CAD Q, p. 22a .
38 m. s.
2a f. d. 3a c. d. 2a m. p.
Il prefisso di coniugazione ti 127
ti-il-la-ak E mar ti-is-ku-un " ti-lik Il
ti-im-tu-ut Il
ti-im-tù-ut Il
ti-ib-da-ad-ga Kish ti-im-tù-ta. E mar tim-za-u Mari ti-ku-lu Il
tim-ba-$11 " ti-is-ta.-u Il
ti-il-tap-tu Il
In base a quale ipotesi si può dunque giustificare la presenza di questo prefisso ti-? Osserviamo in primo luogo che una motivazione fonetica unitaria, dovuta ad indebolimento o ad influenza della prima consonante della radice, è da escludersi. Infatti, a Kish, se in tuur4 -da la vocale del prefisso è motivata dall'influenza di w nella radice, per ti-ib-da-ad-ga non può essere ipotizzata una analoga motivazione, trattandosi di una radice verbale interamente forte. Per quanto riguarda Mari, si tratta di radici di prima consonante forte, con l'eccezione di ti-ku-lu da akii.lu, che è però di prima >1_ 2 ; anche tim-za-u, infatti, sebbene l'interpretazione rimanga dubbial6, è con tutta probabilità di prima consonante radicale forte. Circa i testi di Larsa, neppure la forma ti-ba-da-ar può essere spiegata con motivazioni fonetiche di questo tipo, derivando infatti da un verbo adii.ru/ badii.ru di prima >1_2 , e facendo le forme con b riferimento al tema 0/417, Ad Emar, infine, la situazione è la stessa, essendo alaku di ·prima , 1_2•
............................... .................... ............... .......... ............ ' 16 L'ipotesi di Gelb, Ld.E, p. 64 (mazìPum), che riprendeva
una delle due possibilità proposte dubitativa.ente da Li•et, Syria 52 (1975), p. 48, testo e nota 4 (maza>ua e masllm), è ancora considerata insicura da Edzard, Fs Birot, p. 85 , n. 5.
17 V. CAD A/l, pp. 106 e 108; l'editore, YNER 4, p. 43, preferisce considerare la forma co•e tema 0/1 per /tabaddar/.
128 M. Bonechi
In secondo luogo, va notato che la peculiarità morfologica costituita dalla presenza del prefisso è stata sinora spiegata alla luce di due differenti categorie interpretative, in qualche caso confuse fra loro: quella del dialettismo e quella dell'arcaismo. La prima coincide, di solito, con un riferimento all'influenza di dialetti semitico-nordoccidentali in area mesopotamica. Per Kish infatti i Westenholz18, considerando eccezionale questa attestazione in accadico, ne indicano i più stretti paralleli nella forma t/l ugaritica, e rimandano alle forme identificate da Limet per Mari e da Stol per Larsa. Il prefisso si inserirebbe in una serie di fenomeni linguistici che testimoniano un rapporto con il semitico occidentale, ma questo rapporto è dovuto non tanto ad una influenza diretta, quanto al carattere arcaico del paleoaccadico letterario. Per Mari, Limet osserva19 che • tper la terza plurale è insolito in accadico, ma è corrente nei testi dell'età di Amarna, e non raro in ugaritico, dove alterna con y-. A. Westenholz, da parte sua, nota20 come il prefisso sia un importante legame fra il dialetto arcaico di Mari ed alcuni dialetti semitico-occidentali, e che la sorprendente vocalizzazione rimanda ad altri sporadici casi analoghi in altri dialetti accadici, dove ti- è variante, forse libera, di ta-. La peculiarità del prefisso della terza plurale a Mari è ribadita anche da Durand21 e da A. Lemaire22: per entrambi si tratta di un tratto comune fra il mariota arcaico e il semitico di nord-ovest. Edzard, infine23, concordando con Limet, inserisce la forma verbale nel quadro della sua analisi generale della terza maschile plurale ti12V3ii.. Per Larsa,
18 Or 46 (1977), pp. 208 e 210. t 19 Syria 52 (1975), p. 48, testo e n. 4.
20 BiOr 35 (1978), p. 165, testo e nn. 49-50. 21 MARI 4 (1985), p. 172. 22 Mari, la Bible et le monde nord-ouest sémitique, MARI 4
(1985), p. 556, testo e nn. 67-68. 23 Fs Birot, p. 85.
r Il prefisso di coniugazione ti 129
sia E. Ebeling24 che Sto12s pensano ad un dialettismo; Walters, d'altra parte, pur non prendendo posizione, nota26 come sia probabile che lettere di provenienza eterogenea siano poi confluite in un unico archivio: questo può giustificare non solo la presenza di varie mode scribali, ma anche, va aggiunto, di varie forme dialettali. Per Emar, infine, Huehnergard27 valuta la presenza del prefisso tV- per la terza femminile singolare come una traccia dell'influenza dell'area assira o semitico-occidentale. Più in particolare, nelle note alla morfologia dei testi che egli edita, osserva che vi è in essi una sola eccezione al prefisso t- per la terza f emminile singolare, e che la maggior parte dei verbi alla 0/1, esclusi quelli di prima w, hanno ti-, e provengono, tutti dal testo 2; ne conclude che ta- e ti- sembrano essere ad Emar varianti libere, così come ad U garit28. In questo testo 2, ti-im-tù-ta. è una terza comune duale: mentre in accadico il prefisso è y-, ti- prefisso della terza comune duale è noto in Amarna; la presenza di tale ti- non comporta tuttavia, nei testi di Emar, anche ti- alla terza comune plurale, dove si ha invece y-.
Tornando alla tabella delle attestazione poco sopra riportata, è evidente però una sostanziale differenza che rende non unitario il quadro. Da una parte, nel paleoaccadico tardo di Mari, si ha uno schema morfologico ti12V3ii che si oppone a yi12V3 come terza maschile plurale a terza maschile singolare (e a ta12V3 come a
24 Altbabylonische Briefe der Louvre-SB.J11111lung aus Larsa, Leipzig 1942 (11AOG XV, 1/2), p. 130 ad 28:6.
25 BiOr 28 (1971), p. 366. 26 YNER 4, p. XXVII.
27 RA 77 (1983), p. 39, testo e n. 124. 2B Alla nota 124 Huehnergard dà anche il seguente quadro
della situazione per la terza femminile singolare: ad Emar si ha tie secondariamente ta-, in variazione libera; ad Ugarit, ta- e secondariamente ti-, in variazione libera; a Karkamis (da Ras Shamra), si ha y-, con una eccezione con ti- ed una con ta-; a Hattusa, y-; in Amarna si ha sia ti- che ta-; a Mari degli Sakkanakku si ha ta-, mentre ti- è alla terza maschile plurale.
130 M. Bonechi
seconda maschile singolare I terza femminile singolare); di più, nel corpus in cui è presente til2V3ii non si trova yil2V3ii. Dall'altra, si hanno attestazioni di forme a prefisso ti- non maschili plurali, isolate ed eccentriche in testi anomali o rari nell'ambito dei corpora che li attestano; in questi casi, ti- sembra svolgere la funzione che, nei testi "regolari", è propria di ta-.
In area semitico-nordoccidentale, nelle lingue in cui e operativa la legge di Barth-Ginsberg, il prefisso di coniugazione ti- è regolarmente attestato in presenza di vocale tematica a: tal2u3, tal2i3, ma til2a329. Il fenomeno descritto dalla legge di Barth-Ginsberg si inserisce in un più vasto fenomeno nord-occidentale, consistente nel passaggio a > i della vocale dei prefissi. Questo passaggio è noto sin dall'amorreo, ma le sue modalità e motivazioni sono differenti nelle singole lingue.
In amorreo, dove la vocalizzazione dei prefissi è generalmente a, si ha i, oltre che con temi particolari, e con verbi di prima w e y, anche, curiosamente, con verbi di media w3o. Nel cananaico di Amarna la tendenza a > i si generalizza maggiormente; d'altra parte, dato il particolare carattere delle attestazioni di Amarna, costituite da glosse semitico-occidentali in contesti accadici, è ragionevole pensare che quei casi che non sono giustificati né dalla legge di Barth-Ginsberg né dall'appartenenza della radice a particolari classi ver-
29 Per un inquadramento storico sulla lesse di Barth-Ginsbers v. l'ottimo studio Archaic Vocalisation in SC»UI Biblical Hebrer Naaes di c. labin in JSS 1 (1955), pp. 22 ss., e spesial .. nte pp. 25 s.; in seguito, v, A, P, lainey, 'l'he Barth-Cinsberg U.ws in the Amarna 'l'•blets, rs Ginsberg, pp. 8• sa., con bibliosrafia.
30v, I. J, Gelb, UI lingu• degli bloriti, Rendiconti ANL
VllI/13 (1958), p. 13, 3.3.6.1.5; G. Garbini, SNO, p, 148; R, Betzron, 'l'he Vocalisation of Prefi:1tes in s-itic Active and Passive Verbs, llUSJ 48 (1973/4), p. 40, n. 1. Per la possibilità che la legge di Bartb-Cinsbers fosse operati va in uiorreo v. I. J. Celb, sequential Reconstruction of Proto-Alrk•dian, p. 192.
Il prefisso di coniugazione ti 131
baU31 siano da attribuire a false analogie con l'accadico: più in particolare, si avrebbe ti- analogico di yi-, a sua .volta calco, al posto di ya-, del prefisso accadico, inserendosi questo calco fra i fenomeni di malcomprensione dell'accadico da 'parte degli scribi la cui lingua madre era semitico nord-occidentale32• In ugaritico33 si hanno eccezioni all'applicazione della legge di BarthGinsberg; queste però sono sporadiche, e motivate sia dalle tendenza evolutiva della lingua (sono infatti attestate solamente in documenti tardi e non letterari), sia da una certa propensione all'armonia vocalica34. In ebraico, dove a livello protostorico la legge di BarthGinsberg era evidentemente operativa35, la vocalizzazione in i dei prefissi è generalizzata36, con motivazioni legate all'accento37, se non ad una certa tendenza all'uniformità..
Facendo nuovamente riferimento alle attestazioni eblaite, un prefisso di coniugazione ti- è, come osservato all'inizio, ben attestato sia nei testi letterari che nell 'antroponomastica.
31 p, es. pri- laringale o pri- debole, cf, G. Garbini, loc. cit., p. 149.
32 V. /i., P. Rainey, Obaervations on Ugaritic Cr....ar, W 3 (1971), p. 164, e, più in particolare, dello stesso, rs Cinsberg, p. 13•. Già in precedenza Rabin, JSS 1 (1955), pp. 24 s., attribuiva le eccezioni alla legge di Barth-Ginsbèrs ad influenze dialettali.
33 Solo quando questo lavoro era in bozze è stato possibile prendere visione del recente sauio di I:• Verr-t, Di• CQltiSk•it des Cesetzes Barth-Cinsbergs 1a Ugaritischen., ait 1tinigen sprachversleichend1tn, aorphologischan und le%ikalischen Betrachtungen, OLP 14 (1983), pp. 81-101, che non è stato quindi qui utilizzato.
34 V. 11:. Verreet, Beobachtungen z,.. usaritisch1tn Verbalsystea 1. ur 16 < 1985 >. p. 310.
35 V. C. Rabin, JSS 1 (1955), pp. 24 s.
36 V. G. Garbini, SNO, PP• 152 sa.
37 v. s. Moscati (ed.) Introduction, p. 53.
i
j
132 M. Bonechi
Testi letterari38
ti-a-ba-an, ARET 5.3 r. I:2 (dUTU ti-a-ba-an SIG4 .GAR) Per l'interpretazione del passo, oltre l'editore, si veda ora l'elaborazione di P. FronzaroU39. Il problema se la forma rappresenti una terza femminile o una seconda maschile rimane; la prima soluzione è forse, dato il contesto, la più probabile40, anche se è da notare che, in un altro testo, dUTU è maschile41: il referente, però, sarà differente. Quale che sia il genere, è in ogni caso evidente, ed è ciò che conta in questa sede, che ti- è qui un allomorfo di ta- in un verbo a tre radicali forti.
ti-'à-ma-dfm, ARET 5.6 VII:2, 3 Sostantivo, "mare"42. V. anche s. v. ti-da-bu-ru12•
ti-'à-ma-du, ARET 5.4 !:6 (KI I ~U.DUa I ba-sa-nu I ba-sa-nu I ba I ti-'à-
38 Sono qui raccolte anche le attestazioni di formazioni no-minali a prefisso ti-. .
39 Tre scongiuri eblaiti (ARBT 5.3-5), VO 7 (1988), § 5, in corso di st-pa.
40 Nonostante l'attestazione, in · un testo economico, di duTU.MI2, All8T 3.637 1:6, possa suggerire l'esistenza di una paredra del dio Sole,
41 Nell'inno AB•T 5.6 dUTu è sicur-ente di sesso maschile, come dillostra, alla casella XI I: 2, 1 'epiteto gu-ra-du., "l'eroe Utu". Pi,ù difficoltoso potrebbe essere, nello stesso inno (VI :3) na-•u-ratum duTU, dove il suffisso /-at/ può indicare il femainile dell'aggettivo, ace. na.irtu. t però più ovvio pensare ad un astratto, equivalente all'ace. na.urratu, "splendore numinoso" (cf. D. o. ld.zard, AR8T S, p. 56, s. v.), forse in nesso di stato costrutto, "lo splendore di Utu" (v. sotto, X:4, --i-la-- duTU 11u-r11-di•)i tuttavia, ad Ibla, allo stato costrutto, al•eno nei testi ... inistrativi, nell'onOll8.st1ca e nelle liste lessicali, la •illazione non compare nel regens. Un'alternativa è quella di intendere un vocativo, "il (tuo) splendore, o Utu!",
42 V, All8T 5, P• 58, a. v.
Il prefisso di coniugazione ti 133
ma-du I [X]-na) Sostantivo di non facile interpretazione43 , anche in relazione ad un contesto non chiaro44. Connesso con il seguente?
ti-'à-ma-tum, ARET 5.6 X:4 (me-i-la-me dUTU gu-ra-dfm KI.A ti-'à-ma-tum) Il duplicato da Abu Salabikh45 è qui in rottura. L'editore intende pi~ 10(KI.A) ti-'à-ma-tum "Meereskilste"; tuttavia, la desinenza /-um/, in un testo che nota con precisione il genitivo, potrebbe costituire una difficoltà.. Alternativamente, se ti'à-ma-tum è riferito a me-i-la-me, un'etimologia *dhm, "essere scuro"46 può esser presa in considerazione, e sarebbe adeguata alla copertura terrificante e tenebrosa del melammu, che può coprire come una nube (il paese nemico), avvolgere come una coperta, ecc. 47.
ti-'à-tim, ARET 5.1 II:lO (1 K.A.NU I ti-'à-tim) Formazione nominale48.
43 V, ABZT 5, pp. 24 s.: /tihiiaatUll/, "-re", o /tilJ,)am(a)tua/, da *l~, "brulicare"?
44 V, P. Fronzaroli, L'avverbio eblaita ba, SZL 2 (1985), p.
35, n. 7.
45 I testi paralleli di Abu Salabikh sono IAS 326, per la parte iniziale, come osservato da M. G. Biga, apud D. o. ldzard, ARZT
5, p. 30, e IAS 342, per la parte finale, come osservato da M. Civil, AuOr 2 (1984), p. 290, in sede di recensione a L~ Cagni ed., La lingua di Zbla, Napoli 1981.
46 Ad Ibla la radice è nota al.-no nelle liste lessicali, nella fo~ ti-~j-•u (= Aà-Si5, HZE 4.(582); per l'interpretazione v. P, Fronzaroli, QuS89 13 [1984), P• 151).
4 7 Cf. i passi raccolti in W. H, Ph. ~· iw.er, Bei tdge ~..Lexikon des SIJlllerischen, BiOr 32 (1975), pp. 147 ss.
48 Per l'analisi v. P. Fronzaroli, vo 7 (1988), § 3, in corso di st.-pa.
134 M. Bonechi
ti-da-bu-ru12, ARET 5.6 XII:2 (gu-ra-dum dUTU UD.BU AN.AN ti-da-bu-ru12 )
Il testo parallelo di Abu Salabikh in questo punto è in rottura. Se ti-da-bu-ru12 è una forma verbale, il suo soggetto logico dovrebbe essere gura-dum dUTU, "l'eroe Utu"49; più analiticamente, gr1-ra-dum dUTU dovrebbe essere inteso come un vocativo, richiamato dal verbo alla 2a m. s.: questa è la struttura sintattica più frequente negli innis0• La grafia in -ru12 potrebbe riferirsi alla forma ti12V3u51; tuttavia, in questo insieme di testi52, una grafia -e u non individua necessariamente una 3a plurale, bensì denota di frequente un ampliamento per motivi grafici53 (o prosodici?) di una forma verbale terminante in consonante. Anche in questo caso, questa è la soluzione strutturalmente adeguata al contesto, sebbene l'etimologia del verbo, ed alcuni elementi del verso54, rimangano oscuri. Comunque, che strutturalmente si tratti di una forma verbale flessa è suggerito, per un verso, dal confronto con ti-na-bu-us (XIII:5), anch'esso preceduto da
49 Per quriidu. ad Ebla~v. lfBB 2, p. 17,' ad v. V:7-8, e ARET
5, p. 53. Nell'iJU10 eblaita, si noti l'inversione sintattica in X:4: --i-li-- duru gu-ra-dia KI .A ti-"'.t---tu..
50 v. p, es., in epoca più tarda, il grande Inno a Sa11&i, ora in W. G. Laabert, B~L, pp. 126-138,
51 V. D. O. ldzard, rs Birot, p. 86. 52 L'inno ARJIT 5.6 è stato verosillilmente scritto. in un cen
tro appartenente alla ste~sa scuola scribale di Ebla; infatti, nonostante certe peculiarità (v, sotto ti-na-bu-d~ e nota 85), l'uso di rUJ.2, e non di ru, per /ru/ è costante.
53 Cf, a-za---du nell'analisi di D. O. ldzard, Zur Syntax
der Ebla-rexte, Qus- 13 ( 1984), p. 109 (e v. anche Attadica 31 (1983), P• 8).
54 Per UD. BU cf. comunque u•-&id{-da). W.u ar-ku, "giorno lungo", v. G. Castellino, Urnam9u three Beligious Texts, .U 52 (1957), p, 33, ad 1. 19; Jf, anche Cl. Wilcke, Das LU/l&lba.ndaepos, Wiesbaden 1969, p, 114, 1. 246.
Il prefisso di coniugazione ti 135
AN.AN, e, per un'altro, dal parallelismo tra gu-radum dUTU UD.BU AN.AN ti-da-bu-ru13 I DIM:DIM:PI:PI xss dUTU MA2.ijU du-rf-is (XII:2-3), e na-mu-ra-tum dUTU AL8.GAL2 DU8 BUR.SAG igu-ul I AM.AM xs& dUTU MA2.UU a-bar-rf-il (VII:6-7). Questi ultimi due versi sono conservati nel duplicato di Abu Salabikh IAS 326, IV:ll-16: NIG2.SID A[L6 ] DUa X1 UUR.rSAG, / X AM MUS / "LUx" UTU U, / AMBAR [A]B[(.BA1)]. Il testo mesopotamico assicura la lettura U5 per il nesso eblaita MA2.ijU, che risulta essere variante, con scomposizione, di quello57; inoltre, suggerisce il riferimento all'ace. appii.ru, "laguna, canneto, palude", sulla base dell'occorrenza di AMBAR, per l'eblaita a-bar-rf-is 58: questa equivalenza è confermata dalla corrispondenza fra AB[(.BA7)] e ti'à-ma-dfm, immediatamente successivo, alla casella seguente, nel testo di Ebla59. D'altra parte, abar-rf-is può essere morfologicamente parallelo a du-rf-is. La variante "LUx" di Abu Salabikh, poi, in corrispondenza del solo KIS ad Ebla, suggerisce anche per quest'ultimo una lettura "LUx"1,
sia qui che, verosimilmente, in XII:360.
55 Il segno è KI§.
5& Il segno è KI§.
57 Per u, ad Ibla v, p, Steinlteller, rhe 8blaite Preposition
qidimay "before", OA 23 (1984), p. 34, n. 8; v. anche H. Waetzoldt, "Diploait•n", Bot•n, llaufleute und Ve.rwandtes in 8bla, Ba8, pp. 421 s.
58 Diversamente, v. l'editore a p, 49, L•equivalenza fra AHBAll e •-bar-ri-i6 ai ritrova più avanti: Ibla AB8r 5.6 VII:3 ~ Abu Salabikh IAS 326 IV:16.
59 Anche altrove la copia eblaita sembra rompere il verso.
60 [Solo quando questo lavoro era in bozze è stato possibile prendere visione delle importanti osservazioni di P. Steinkeller, in Seal of 1-..-11,., son of tbe Governar of Hatar, VO 6 (1986), pp. 27 sa., relative ai due testi paralleli, e che coincidono con quelle qui riportate.]
136 M. Bonechi
ti-ga-la-tum, ARET 5.6 VIII:l (BA,, TI URU, GIS.APIN ti-ga-la-tum a-ba-'à-zu) Il contesto suggerisce per ti-ga-la-tum la connessione con il campo semantico dell'aratura61.
Strutturalmente il verso (perduto nel duplicato di Abu Salabikh) potrebbe mostrare simmetria fra BA,.TI URU, (sostantivo + verbo62) e GIS.APIN tiga-la-tum a(-) ba-'à-zu63, In questo quadro, tiga-la-tum sembra essere l'equivalente eblaita dell'accadico tiikaltum, citato in paleobabilonese in relazione all'aratro seminatore, e, più in generale, indicante una specie di contenitore64,
ti-gi, ARET 5.4 II:7 ( en-ma ti-gi I si-in I zi-ne-éb-ti I dUTU I ... I NU.ijI.MU.DU) Il contesto non è chiaro. Forse un nome personale per l'editore65, che anche sospetta la possibilità di un rapporto "apofonico" fra ti-gi e daga-(ma) (II:l), attestato poco sopra in contesto analogoss. L'ipotesi di un prefisso ti- alternante con ta- non è da escludere a priori; in ogni caso ti-gi non è da confrontare con t i - g i, attestato in un altro testo letterario, però sumerico, rinvenuto ad Ebla, ARET 5.20-21 (p. 37: ti- rg i 1 a [ ... N]E [ ... ] [A XIII:3] // ti- g i na 2 NE U[D]
61 Al verso precedente, AL& può infatti essere il verbo relativo all'operazione che si compie con il GI§.AL&·
62 Cf. coaunque B. Hruika, in sede di recensione a D. O. Edzard, ARET 5, in Aror 53 (1985), p. 289, per un significato di arnesi per la lavorazione della terra riferito a URU• e GI§.APIN.
63 Ace. pa'a~u, riferito anche alla terrà?
64 BA,.TI è forse da leggere pisan-TI, un contenitore analogo al ti-ga-la-t1111. Un'altra possibilità è costituita da una grafia arcaica per il più tardo sostantivo sumerico ba-ti-'IJll!, var~ pa,-ti-wa, "(un contenitore?)", cf. PSD B, pp. 21 s.
65 ARET 5, p. 25; cosi anche c. H. Gordon, ~by, Possessor oE Horns and Tail, UF 18 (1986), p. 130. Cf. sotto il NP ti-gi-dUTu.
66 Loc. cit.
Il prefisso di coniugazione ti 137
[G]AN2 ijl NE [B XIV:l]), dato che qui il numerale 2, che segue in uno dei due testi, fa pensare piuttosto a TI.GI.NA, attestato nelle liste lessicali, come variante di TI.GI.NUM2, quest'ultimo glossato67 con una parola, zu-zu-a, di non chiaro significato, ma di possibile analisi morfo logica come forma di duale. Inoltre, TI.GI.NA è noto anche nei testi economici68, con la variante TI.KI.NA69 , cui è da aggiungere verosimilmente TI.GI.NJ70, Dal significato non chiaro71, TI.GI.NA e varianti potrebbero essere o il risultato della semitizzazione di un sumerogramma72, o degli accadogrammi. La parola in Mesopotamia aveva comunque la forma Tl.GI/GI 4 , come risulta dal duplicato, da Abu Salabikh 73, di ARET 5.20-2174,
ti-gi-li, ARET 5.6 III:2; XIV:3 ( ti-gi-li DIM.DIM dEN.KI AGA2• U~;
dUTU mu-ga.-lii ti-gi-li) Non chiaro; forma verbale?
ti-ig-da-ra-ab, ARET 3.112 II:4 ( ma-lik-tum I 3 MA I wa-a I ti-ig-da-ra-ab I
67 !1EE 4, ( 902). 68 ARET 2, 8; cìt. in Archi, SEB 4 (1981), P• 4b, CRRAI 28
(1982), p, 176, e HARI S (1987), p. 52c; cit. in Cagni, BaE, p. 384. 69 ARET 2, 3; !1EE 2; cit. in Cagni, loc. cit. 70 ABET 8. 534 XVI 11: 7; la parola è seguita da un non chiaro
nesso PES;i NA (PES;i collazionato sulla fotografia), 71 Cf. ARET 2, s. v.; HEE 2, pp. 98 ad v. VI:lO, e 313 ad v.
Il :2.
72 v. s. A. Picchioni, Le varianti s1.111eriche delle liste bilingui di Ebla, BaE, p. 300, testo e n. 16.
73 Per l'identificazione del duplicato (IAS 278), v. ARET 5, p. 39, con bibliografia; per la lettura del passo v. H. Krebernik, BFE, PP• 203 ss.
74 Qui l'editore ricostruisce [ti-Si n]a 2 !;i.AN in B XIV:6, !;i.AN è variante di LAK 358, attestato nel passo parallelo da Abu Salabikh (IAS 278 VI':l6'),
138 M. Bonechi
DAM I [) Questa forma verbale è attestata in un frammento che è stato recentemente identificato da P. Fronzaroli come parte di un rituale (e non come testo economico), connesso con ARET 3.178, che costituisce la parte più cospicua del testo7s. L'occorrenza di ig-da-ra-ab in ARET 3.178 v. IV:lO suggerisce la contrapposizione delle due forme: igda-ra-ab attesta /yiktar(r)ab/, da krb, "benedire"; ti-ig-da-ra-ab, di conseguenza, indicherà un'altra forma verbale della medesima radice, non plurale né 3a m. s.: /tiktar(r)ab/, 3a f. s. o 2a m. s. Dato però che l'analisi del testo sembra escludere un riferimento alla 2a persona, e dato che il contesto, pur frammentario, rende verosimile un soggetto femminile, si avrà in questo caso un esempio di ti- per la 3a f. s. con il verbo forte.
ti-ma-u., ARET 5.6 II:6 ( ti-ma-u9 URU".AN) Da un punto di vista formale potrebbe far riferimento allo schema ti12V3u76. Purtroppo il testo parallelo di Abu Sala:bikh è, in questo punto 77, rotto, e non permette ipotesi, diversamente dal verso precedente. Nella casella precedente il passo parallelo di Abu Salabikh 78 ha, contro gàrga-ra UUR.SAG di Ebla, LAK. 154 UUR.SAG. Sebbene il valore n i mg i r di LAK. 154 sia noto ad Ebla79, in questo contesto, con riferimento ad
75 In questo volw.e, PP• 1 ss.
76 v. D. o. Bdzard, Fs Birot, p. 86.
77 IAS 326 I: 18.
78 IAS 326 I: 17.
79 Cf, la 1. 28 del cosiddetto Sillabario di Ibla, v. H•• 3, p, 197 (= ne-11i-rui.2 -m).
Il prefisso di coniugazione ti 139
Utu, non sembra verosimile8o. D'altra parte sarebbe difficile interpretare gàr-ga-ra come una grafia fonetica per n i mg i r 81. Diversamente, una derivazione dell'eblaita dalla radice semitica *kr(kr) come designazione di qualche cosa di circolare82 può accordarsi con la lettura aga, ed il significato "corona", per il duplicato di Abu Salabikh. Quanto a ti-ma-u9 , l'etimologia resta oscura (mHH?, HmH?); l'uso di U9 è d'altra parte problematico, e il termine può rimandare anche ad una forma nominale (DmH?), fors'anche a prefisso ti-.
ti-na-bu-6A, ARET 5.6 XIII:5 (AN.AN ti-na-bu-us) Come osservato sopra per ti-da-bu-ru13, l'analisi come forma verbale flessa83 è strutturalmente adeguata. Nonostante il senso del contesto, tanto ad Ebla quanto nel duplicato di Abu Salabikh84,
non sia evidente, tale analisi non contrasta con quelle motivazioni che, come si vedrà, sono alla base delle attestazioni di sicure forme verbali flesse a prefisso ti-. Da segnalare, in ogni caso, l'uso anomalo di U~a con valore fonetico semitico:
80 (gal-)niagir, "(grande) araldo", non è difatti noto coae epiteto di Utu, cf, K. Tallqvist, COttert1pitheta, p. 135; H. Beherens - H. Steible, rAOS 6, P• 127; CAD N/l, s. v. nii.giru.
81 Si noti in particolare l'uso di GA.
82 Per le attestazioni nelle varie lingue s•itiche v. c. Conti, Studi sul bilitteriBIM) in s-itico e in egiziano, QuSfHl!I 9 (1980), p. 85. Ad !bla, la radice è attestata anche nelle liste lessicali, cf p, Pronzaroli in A. Archi, Varianti grafiche negli antroponi•i di 8bla, VO 6 (1986), p. 244.
83 Proposta da M. Krebernik, lforllholo/IY al the Verbal 81 ... nt in s-itic Personal Naaes, dattiloscritto distribuito in occasione del convegno !'he Ono9asticon al 8bla, lloaa. 1985, I 2, 3 ( incoapiuto 0/1 2• •· s.).
84 IAS 342,
,·
li
I ~
140 M. Bonechi
a quanto risulta, questa ne sarebbe l'unica attestazione eblaita8S.
ti-na-NI-si-du, ARET 5.1 IV:6; 3 VI:l (na-zi-a-du I MI2 I 1 SUD I mi-nu I ti-na.-NI -si-du; 'ax(NI)-ma-ti I ti-na-NI -si-du) Non chiaro per l'editore86. Equivalente eblaita del sostantivo accadico tene~tu' "umanità, persone".
ti-NE-ù, ARET 5.6 VI:l (TUM3 i-ru12-ga KUR.KUR ti-NE-ù i-la-me) Strutturalmente potrebbe essere, come ti-da-buru12, una attestazione dello schema ti12V3ii87; tuttavia, a causa della posizione nel verso, parallela a quella di sa-sa-ru12 in VI:388, e a causa della più agevole interpretazione di i-la-me come forma verbale flessa89, una interpretazione più soddisfacente è quella di forma nominale90,
ti-ra-du-~, ARET 3.178 III':8" (10 udu I nfdba I dingir-dingir-dingir I ti-radu-~ I [ ... )
85 D'altra parte, questo testo si distingue per l'uso aoo11alo di altri segni, quali LU2 e U2, con valore fonetico; per un'altro ese•pio di lu v. il NP a-na-lu (ARET 3; cit. in A. Archi, The Perso1J11.l NIU8es in the Individual Cities, QuSe. 13 [1984], p. 249: .tak
mi-w.ki) e a-na-lu (cit. in Archi, art. cit.: kak-•i-w.ki); v. comunque anche le note 52 e 152.
86 Che nota come in ARBT 5. 3 VI: 1 ti-na-NI-si-du chiuda il verso; lo stesso ldzard, rs Birot, p. 86, inserisce la parola fra le possibili attestazioni eblaite dello schema til2V3u.
87 V. D. o. !dzard, Fs Birot, p. 86. 88 Ace • .ias.iarmi, "sega"?, cf. D. o. ldzard, AllllT 5, p. 57. 89 Ace. i-a, "•uovere in cerchio, circondare"?
90 Verosimilmente un sostantivo al no11inativo: il tiNlu (di Utu) circonda i KUJl,KUR, parallelo alla sega (di Utu) che • • • la nontagna.
Il prefisso di coniugazione ti 141
Per le possibili interpretazioni, che comunque verosimilmente escludono un riferimento ad una forma verbale flessa, v., in questo volume, P. Fronzaroli, p. 10 (3').
ti.-rf-da-a, ARET 5.6 XIII: 1 (dEN.KI ZI LA TI ZU ba.-ti-ig AB.ZU AN.AN du-u9 -sum [(X)) EN ti-rf-da-a} Il contesto non è chiaro, ed il duplicato di Abu Salabikh91 inizia solo tre linee dopo. La derivazione da *rdy è possibile92, ma il senso del passo resta oscuro; in ogni caso è probabile che Enki, un cui frequente epiteto è en93, sia definito, al verso precedente, /patiq AB.ZU/, "colui che ha formato l'Apsu"94,
[t]i-rf-bu-um, ARET 5.6 I:5 ([ ••• t]i-rf-bu-um SU NE-si-gi-im) Si noti la complicazione costituita dal confronto con il passo parallelo di Abu Salabikh: [ T]I URU [ij]U UM SU NE SI Gl IM / EN.KI i-lr1 rf-sadfm (ARET 5.6 1:5-6) = DA TI URU SU NE I NIG2
SlG dEN.Kl (IAS 326 1:7-8)95,
t[i~..rJ-.ma[(-..r)], ARET 5.6 XI:l (K[A X] t[i-x]-ma[(-x)] RU GIS.USTlL in KISAL
9l IAS 342. 92 In una ricostruzione /tirday/ la grafia -ri- per /r/ è llO
tivata dalla vocalizzazione del segno precedente. V. anche la nota 231.
93 v. I'!. w. Green, 8ridu in Suaerian Literature, Dies. Chicago 1975, pp. 78 a.
94 La lettura della casella da parte del! 'editore è differente. Pra gli appellativi comuni di lnlti vi è "signore, re dell' Apsu", cosi come "creatore di tutto, ecc.", v. Gr-n, op. cit., pp. 78 s. e 82 s.; v. anche l'appellativo ddi• in Tallqvist, GiJtterepitheta, p. 287.
95 Si noti ne-ai-gi-i• fonetico per nl-sig secondo H. Civil, Studies on Karly Dynastic Lexicography III, Or 56 (1987), P• 235.
142 M. Bonechi
UUR.SAG) Frammentario; il duplicato da Abu Salabikh è qui perduto.
Antroponomastica
Quanto ai NP che iniziano per ti-, non necessariamente questi sono da analizzare tutti come contenenti forme verbali coniugate. Difatti, mutatis mutandis, un NP del tipo ib-gi-ND potrebbe formalmente essere inteso come compiuto 0/1, terza maschile singolare, da una radice *bky, "piangere". t una possibilità.96. Potrebbe però essere inteso diversamente come forma nominale da *"pq, "grazia" (/>ipq-i/, "mia grazia"97). :a: un'altra possibilità. Non vi sono motivi interni per preferire una delle due interpretazioni; i motivi devono essere esterni al NP, e possono essere di vario genere: propri del sistema onomastico eblaita (l'attestazione di una varietà di forme coniugate: p. es. ig-rf-i~-ND/dag-rf-is-ND), o esterni all'eblaita (l'attestazione, nell'onomastica di altre lingue semitiche, di analoghe forme verbali coniugate). Mancando una riprova di tale genere, è difficile poter decidere fra le varie ipotesi98, Di conseguenza, qui di seguito, quei NP per i quali vi è evidenza di un prefisso di coniugazione precederanno quelli per i quali tale evidenza non c'è.
96 V. p, rronzaroli, 1ypolo11i11s onomastiques 4 8bla, relazione presentata al convegno rhe Onausticon of' 8bla, Boma 1985, §
3.3.3 del dattiloscritto.
97 v. H.-P. MUller, Ld8, p. 220, n. 51, e 1. Sollberger, AR81
8, P• 13. 98 In particolare, nel caso dei NP terminanti in /-u(•)/,
qualora non sia nota, nel -teriale edito, una corrispondente fo~ lunga (con -ND), è difficile acesliere fra la possibilità costituita dall'ipocoristico e quella costituita da una fo~ noainale.
Il prefisso di coniugazione ti 143
ti-gi~UTU, ARET 4.3 r. IV: 13. NPF, come da contesto, e da identificare sicuramente con da-gi~UTU (ARET 8.533 [14]), entrambe DAM ìr-"à-ag-da-mu99. L'alternanza da/ti- rende verosimile che l'elemento predicativo faccia riferimento ad una forma verbale flessa, e che la radice sia di prima debole, per analogia a da-b11-/ du-bfJ-lOo. La presenza nell'onomastica di Ebla del tipo i-gi-Nn101 rimanda ad un sistema coerente di forme verbali flesse. Un'etimologia adeguata per questo insieme è l'ace. waqii"um, "aver cura11 102. La vocalizzazione i in questo caso è dovuta al fatto che, in eblaita, il comportamento dei verbi di prima w di stato è analogo a quello accadico103•
Cf. il NP ti-gi-da-NE-a-du?
ti-bir-ma.-lik, TM. 76.G.89 v. III:7104
La lettura bir di KES2 105 deriva dal confronto con il ben attestato NP femminile da-bir-ma-lik106,
99 v. P. Pronzaroli, CllRAI 33 (1987), P• 72.
100 Cf. da-bll-da-•u e du-bll-da-•u, varianti del ftOlle di una stessa persona, v. P. Pronzaroli, rypologles, cit., §§ 1.4 e 3.3.1.
101 v. p. es. i-gi-1-1,.. in ~r 8, s. v., • p. 14. 102 Per tale etilloloaia, relativ-ente a da-s.i-dUTu, v. 1.
Sollberaer, AB8r 8, p. 15. La radice non è produttiva nell'o~stica paleoaccadica; in alternativa, si può pensare a •nqy, "libare, sacrificare", per le cui attestuioni nell'onomastica pal-ccadica v. HAD 3, P• 204.
103 Per il coaport-ento dei verbi di priaa w di stato ad Ibla v., in questo stesso vol\198, G. Conti, particol&r11ente P• 76.
104 Cf, G. Pettinato, 8bla 1, p. 120.
105 Non nota, · nelle 1losse, a K. Krebernik, zu Syllabar und
Orthogra.ph.ie der lexikal1schen reit• aus 8bla. reil 1, %A 72 (1982), p. 193. Per K1!2 = bir nelle liste lessicali v. &il p, Pronzaroli, rhe 8blaic Lex1con: Probl ... and Appraisal, '1US .. 13 (1984), P• 134, L'editore, e I. J, Gelb in Ld8, p. 35, leaaono il NP t1-k~I-.
106 AB8r 1.3 v. VI:S (DUKU-Kl2 ib-rl-,.. DAM-DIMGIR), 11 v. IV:2 (DUKU-Kl2 ib-rl-,..); AB8f 3.457 r, 1:1 (DUKU-Kl2 1b-ri-,..),
144 M. Bonechi
noto anche nella variantel07 da-bi-ir-ma-Jikl08, che ne assicura la lettura. L'attestazione di tibir-ma-lik proviene da una lettera inedita; dal documento, così come è notol09, non si può dedurre il sesso del portatore del nome, ma, poiché nella lettera si fa riferimento a personaggi della famiglia reale, è verosimile che ti-bir-ma-lik sia una ulteriore variante di da-bir-ma-lik. Un'etimologia adeguata, comune anche a i-bir-ma-Jikllo, è *byr, "scegliere"lll. In tal caso, ti- è variante di da- con un verbo di media y.
ti-ni-fb-da-mu, ARET 3.215 v. V:5 ti-ne-fb-da-mu, MEE 2.12 r. III:3', V:l ti-ni-ib-da-mu, cit. in Archi, SEb 2, p. 21 ( =
TM. 75.G.1935 r. VIII:8) La scelta del valore dei segni (varia presso i differenti editori), è resa obbligatoria dalle possibilità combinatorie delle alternanze. *ib deriva dalla citazione in un inedito, che non stato quindi possibile controllare. In tutti i testi si tratta verosimilmente della stessa persona: è una sposa nella tavoletta inedita, mentre in ARET 3 il suo nome è preceduto· da ni-za-mu I BUR-KAK, e in MEE 2 da ne-zi-mu I x x-za. Ni-za-mu I ni-zimu / ne-zi-mu è un "anello"ll2, mentre il BUR-KAK
107 V. ARBT 3, P• 400, l08 ABBT 3.91 III:2; per l'eleaento predicativo cf. anche da-
bir-cla-•u, ABBT 3.869 II:3 (DAH ib-ri-Ull),
109 v. anche /fllB 1,6301, e Pettinato, Bbla 2, p. 401. 110 ABBT 3.322; cit. in A. Archi, '1uSeta 13 (1984), P• 249, lll v. P. rronzaroli, SBb 5 (1982), p. 109. llZ Ni-za-•u 6 grafia isolata propria di questo testo, già
connessa con ne/ni-zi-•u da A. Archi in ABBT 3, s. v. Quest'ulti110 è una parte del grJ-li-lUll o del GI!.PI-1•, un "cerchio" in ABBT 1 e 3, s. v., e secondo anche L. Milano, Due rendiconti di ••talli da Bbla, SBb 3 (1980), p, 15c, o un "ornamento" per llBB 2, p. 83 ad v. 1:5. Una differente ipotesi è quella di r. Pomponio, The Heanins or the rezw uitil in tbfl Bbla DocUIHlnts, ArOr 51 (1983), p, 375, n. 6, che
Il prefisso di coniugazione ti 145
è un recipiente liturgico per la cui connessione con le nozze ed il culto di dNI-DA-KUL lu-ba-ank1
v. ARET 1, 3 e 8, s. v.113. Qualora la lettura dell'inedito fosse un errore di stampa per fb, una lettura ti-ne/ni-tum sarebbe di possibile etimologia semitica: v. ad Ebla la glossa ti-ni-du/tum ( :siAp è A )114. D'altra parte, una desinenza /-um/ dell'elemento predicativo, con mimazione, presupposta da quest'ultima lettura, non ha esempi in NP del tipo nome + Nn11s, e sarebbe in ogni caso grammaticalmente poco chiara. Perciò, qualunque sia il valore dell'esempio dedotto dalla citazione in SEb 2, una lettura con *ib, riferita ad una forma verbale flessa, è sicuramente preferibile, ed è in accordo con la possibile attestazione della corrispondente forma maschile nel NP i-ne-fb-dulum 116. Quanto all'etimologia, l'elemento predicativo fa riferimento alla radice *nyb/nwb, "crescere, prosperare"117, produttiva di NP in area amorreall8.
pensa ad un teraine che si riferisce ad una tecnica di lavorazione del aetallo.
113 E cf, anche H. G. Biga, FHilles de la f-ille royale d'Ibla, CHRAI 33 (1987), p. 45, n. 21.
114 H8B 4.(368a); per l'interpretazione "fico" v. già G.
Pettinato, lfB8 2, p. 128, ad v. X:lO. 115 L'eccezione principale è costituita da 1-lwm.
116 lf88 2.37 r. 1v:12. Cf, forse an~he il NP i-NE-~ (ARBT 1. 8), confrontato da D. Charpin, Tablettes prtlsarsoniques de Jfari, lfARI 5 (1987), p. 70, con il NP aariota arcaico [i]n-~.
117 Per le attestazioni in s .. itico v. HAL, p. 640. 118 v. CAAA, P• 330: in-ne-bu, in-ne-bi, in-ni-bu(-u.). Una
possibile derivazione da •nwp, "essere alto", è esclusa dalla attestazione ad Ibla del NP i-nu-ub-il/HI (AJIBT 3, p. 278). che a questa radice aeglio si riferisce, cf, il HP aaorreo ia-nu-bu-u. ( CAAA, p. 330),
r i I
t ,,
146 M. Bonechi
Il rapporto fra questo NP e DI-ne-fb-du-lum e varianti119 (NP femminile, relativo in tutti i casi alla medesima persona120), rapporto già suggerito da Archi121, è problematico; tuttavia, nonostante alcune analogie, sembra preferibile distinguere i due antroponimi in modo netto. Le analogie sono costituite dal fatto che in entrambi i casi si tratta di due donne122, dalla comune alternanza -ne/ni-fb-, dall'occorrenza del NP i-ne-fb-dulum, già notata sopra, e infine dalla possibilità di una lettura di. Per quanto riguarda l'elemento predicativo, si dovrà ancora conservare la lettura sa-ne-fb-, nonostante la mancanza di una evidente etimologia123, sia per l'assenza di una prova sicura per una lettura di in età arcaical24 (cf. anche il NP DI-EREN-da-mu ), sia per la• circostanza che ti-ni-ib-da-mu è sempre scritto con il segno ti, mentre il nome della NIN-NI EN è sempre scritto con DI, fatto che mal si spiegherebbe presupponendo un medesimo elemento predicativo, sia infine perchè i testi che usano DI hanno anche, per altri NP, il segno ti, e questo
119 DI-ne-ib-du-lum: AREr 1.12 (NIN-NI IN); ARET 3.200, 274, 469, 660; AREr 4.11; cit. in Biga, CRRAI 33 (1987), P• 43; DI-ni-ibdu-lum: laE 1.1460, 6349-6351: cit. in Archi, Ancora su Ebla e la Bibbia, SEb 2 (1980), p. 21; cit. in Biga, art. cit., p. 43.
120 Per l' i•piego del termine DAM ad Ibla come sinoni11<> di NIN-NI v. H. G. Biga, art. cit., p, 42,
121 ARET 3, p. 400. 122 Mentre però, come visto sopra, ti-ni-ib-da-•u è una
sposa, DI-ni-ib-du-lum è sempre definita come una principessa eblaita: cf . A. Archi, Diffusione del culto di dNI-DA-lWL, SEb 1 (1979), p. 109, testo e n. 8, e recente11ente Biga, CRRAI 33 (1987), p. 42.
123 Per l 'uao di a nella resa dei fonemi /{s/, /i/, v. H. Krebernik, Zur Entricklung der Keilschrift 1- III, Jahrtausend anhand der Texte aus Ebla, AfO 32 (1985), p. 56.
124 Cf, per il paleoaccadico HAD 2, p. 105, n. 266, e llAD 3, p. 272, e per Ibla D. O. ldzard in AllET 2, p. 121; v. inoltre H. Krebernik, ZA 72 (1982), p. 185, e AfO 32 (1985), p. 56.
Il prefisso di coniugazione ti 147
suggerisce una differenziazione nell'uso del va
lore dei due segni12S.
ti-nu-ud, ARET 1.26 v. 1:2; MEE 2.42 v. 1:4. I contesti non specificano il sesso del portatore
del nome, cosa che può essere ritenuta indizio di
un genere maschile. Per quanto riguarda l'etimo
logia del NP, da considerarsi un ipocoristico128' si
veda il verbo *nwd "muoversi intorno"127. Questa
radice, produttiva nell'onomastica amorreal28, non
è ignota altrove ad Ebla, essendo attestata anche nei NP i-nu-udl29 (già connesso da Milller130 con
ti-nu-ud), i-nu-du131, i-nu-ud-da-mu132; a-nu-
125 L'attestazione di i-ne-ib-du-11111 può essere sicuraaente connessa solo con ti-ni-ib-da-•u, contrapponendosi la forma maschile del verbo a quella femminile; la curiosa assonanza con DI-ne-ib-du-11111 suscita comunque qualche perplessità: da notare però .che i NP con da-•u e quelli con du-lWI condividono frequente11ente gli stessi ele•enti predicativi.
126 Seppur raramente, sono noti ad Ibla altri NP ipocoristici completamente privi di qualsiasi desinenza dopo l'ele•ento predicativo costituito dalla sola forma verbale flessa; cf. p. es. ig-ri-18 in ABBr 1, 2, 3, 4, 8.
127 Per il significato della radice v. CAAA, p. 27; cf. però anche Huff110n, APNN7', p, 237, s. v. nd, con bibliografia. Per il riferimento alle attestazioni eblaite v. ff,-p, MUller, LdB, p. 228, e M. Krebernik, B~, p. 141.
128 V. CAAA, p; 330. Si noti qui la vocalizzazione del prefisso del NP fe11minile ta-nu-da.
129 ABB'r 1. 8 •
130 Neue Brwigungen .rlJlll eblaitischen Verbalsystel9, BaB, p. 181, con il confronto, nell'ambito di una stessa radice di llfldia w, fra i NP i-nu-ud e ti-nu-ud, e le glosse nu-du-um = DI.CAN e du-dadu-1111 = DI.CAN.CAN, rispettivaimente llBB 4.(828) e (829); cf. allora anche 1188 4.(831) nu-d1111 = CAJf.DI. Le attestazioni delle glosse, facendo riferiaento ad una radice di 3a w (cf. M. Civil, Bilinaualisa in Logographica.lly rlritten Languages: Su.erian in Bbla, BaB, p. 83), sono però da separare da quelle dell'onomastica. v. più sotto, pp. 170 ss.
131 ABr 3.361
148 M. Bonechi
ud-ba-Jaml33 e a-nu-ud134 (var. a-nu-du135). Fuori dall'onomastical36, sembra attestata anche in un incantesimo edito da Krebernik137, nella forma a-nu-udl38.
ti-rf-ig-da-mu, ARET 1.17 r. III:2 (= MEE 2.22) (DAM EN ba-zu-wa-anki ). NP femminile, parallelo a i-ri-ig139, i-rf-ig-damu 140, i-ri-ig-da.-si-in 141, i-rf-ig-da-sè-Ji142, i-rfig-gàr143, i-rf-ig-gr1-nu144, i-rf-ig-iJ145, i-rf-ig-
132 ARET 1.11 (=Hllll 2.19); ARET 3.134, 263, 274, 401, 467, 802, 862, 924; ARET 4.2, 10, 11, 12; cit. in A. Archi, QuSe9 13 (1984), p. 249.
133 ARET 3.527: DUKU-NITA EN .a-nu-M1-adki, 134 Hllll 1.1086: DUKU-MI2 ib-ri-ua, cf. P. rronzaroli, La for
mation des IJOlaS personnels Féminins à llbla, CRRAI 33 (1987), p. 68.
135 ARET 1.3.
136 Altre possibili attestazioni nell 'on011astica sono quelle dei NP i-nu-d&a-.a-ga-nu (ARET 4) e i-nu-sar (ARET 1), se derivabili da •nMf con assimilazione della dentale.
137 Bl'll, p, 131 VII:4.
138 Cf. M, Krebernik, Bl'll, p, 141 per la connessione tra il NP i-nu-ud-da-•u e a-nu-ud, foraa verbale di la c. s.
139 ARET 1.11 (1, 44) (= HEE 2.19); ARET 2.15; ARET 3.138, 210 (dur-Nl-duki), 477, 860; ARET 4.15; HllE 2.25, 29, 33.
140 ARET 1.3; ARET 2, 13, 14 (= HEE 2.14); ARET 3.193, 335, 458, 464, 471, 543, 587, 940 (i-ra[-ar]ki); ARirT 4.5; ARET 8.521 (13), 526 (53), 534 (32), 540 (4); P. rronzaroli, Un verdetto reale dagli archivi di Ebla (TH.75.G.1452), Sllb 3 (1980), P• 35 r. IV:4; M. C, Biga, Tre testi ..,.inistrativi da Ebla, SEb 4 ( 1981), p. 31 v, 1:2; A. Archi, Wovon lebte .an in llbla?, CRRAI 28 (1982), p. 27 (2); cit. in A. Archi, Kis nei testi di Ebla, Sirb 4 (1981), p. 80 [14].
141 Cit. in A. Archi, Qus- 13 (1984), p·. 249,
142 ARET 8.523 (43); la lettura della casella è corretta, aa in vista del NP precedente, si potrebbe adottare una lettura i-ri-igda-s,.-in! (LI>.
143 ARET 1.11 (= HEE 2.19); ARET 3.329.
144 ARET 1.10 (= Hllll 2.17) (ib-bur-NI lu i.); ARET 3.628; HEE 2.12. Variante sicura è i-ri-gu-nu: ARET 1.30; ARET 3.15, 167, 342, 466 (ub-bUZ'-Nl lu i.), 587; ARET 4.11; HEE 2.32, 34, 36, 38; A. Ar-
Il prefisso di coniugazione ti 149
ma-Jik146, i-rf-ig-NI147, i-rf-ig-PI148, i-rf-ig-zé149, i-rf-ig[-150, i-rf-gul51, i-rf-gu-6152, i-rf-gu-uml53 (3a m. s.), e a a-ri-ig-ND (la c. s.)154. L'etimologia
di questi elementi predicativi sembra condizionata
dall'attestazione degli ipocoristici con -gu-, che,
a causa della tendenza ad esprimere /q/ con
gul55, escludono precedenti interpretazioni156•
chi, SEb 4 (1981), p. 164; cit. in A. Archi, Les rapports pol1t1ques et écona.ioues entre Ebla et Mari, ltARl 4 (1985), p. 82.
145 Cit. in p, rronzaroli, SEb 3 (1980), p, 46; cit. in A. Archi, Hardu in the Ebla Texts, rs van D1jk, P• 12 (22) (ugula NI-raarki); la citazione i-ri-ig-11 da un inedito in A. Archi, SEb 2 (1980), p. 19, è probabil•ente da intendere i-ri-.
146 AREr 3.43, 106, 324, 499, 594, 917; AREr 4. 6, 13, 18; HEE 2.12; cit. in A. Archi, SEb 2 (1980), p. 23; cit, in P. rro~roli, SEb 3 (1980), p. 46;
147 ARET 1.5; ARET 3.261 (ugula NI-ra-arki, cf. i-ri-ig-il alla n. 145), 628, 682 (na-za-ri-.ùtki; si noti, in r. 11:5 ss.: 3 '&u•' ni&-•u-sa i. DUMU-Mla ga-si-da, "3 buoi come (pag-ento del) prezzo della sposa da parte di i. pér (il suo (?) 11atri110nio con) la figlia di g."), 958; AREr 8.524 (13), 528 (9), 534 (9), 535 (2, 6);
HEE 2.32; cit. in P. rronzaroli, SEb 3 (1980), p. 46; cit. in A. Archi, SEb 4 (1981), p. 82 [38); cit. in A. Archi, lfAlll 4 (1987), p. 82.
148 ARET 2.28; cf. anche p. 108, s. v.
149 ARET 3.132, 226, 252, 401, 470, 908; ARET 4.13; HEE 2.14; cit. in A. Archi, QuSe11 13 (1984), P• 249.
l 50 ARET 3 .153,
151 ARET 1.3, 6 (dag-ba-al5ki); AREr 3.5 ( ba-t.t-nuki). 82, 420, 663, 942, 959; ARET 4.5, 13; A. Archi, CllllAl 28 (1982), p, 27 (4).
152 ARET 1.29. Cf. p. 180, dove è notata la possibilità che 1-rf-gu-u corrisponda al lugal 1-ri-gu-nu. Un ipocoristico -u non risulta noto ad Ibla, ed è inoltre da osservare la rarità dell'uso di tale segno nel sillabario s-itico eblaita; per una sua utilizzazione, in un incantesi110, COiie segnale della 3a •· p., vedi P. rronzaroli, SEb 5 (1982), pp. 108 s. V. sopra anche la nota 85.
153 Cit. in P. rronzaroli, SEb 3 (1980), p. 46.
154 Attestato nel NP a-ri-.tg-llAD, cit. in A. Archi, Le synchron1sae entre les rois de /fa.ri et les ro1s d'Ebla au 1119 ailléna1re, ltARl 4 (1985), p. 56 (16-kar aa-r1ki),
155 Cf. w. von Soden apudM. Krebernik, ZA 72 (1982), P• 208.
150 M. Bonechi
Escludendo anche *rbq, "esser distante"l57, cui meglio si adatta il ben noto elemento predicativo eblaita i'r-'à-ag-ND (var. il-'à-ag-ND), nel quale b è appropriatamente notata in grafia, è difficile decidere fra *ryq, "esser vuoto"l58 e *wrq, "esser verde"l59. Foneticamente, infatti, entrambe le etimologie sono adeguate, ma nessuna delle due ha paralleli convincenti nei sistemi onomastici vicini; è forse comunque preferibile la seconda, sia intendendo un nome di compiantol60, sia intendendo un nome di augurio: "possa ella/egli prosperare, o ND!".
ti-rf-in-da-111u, ARET 3.507 I:2; MEE 2.48 r. VIII:l (Juba-anlti); Archi, SEb 7, p. 64 [11] r. I:2. Se da confrontarsi con i-rf-in-na-bal61, NP che potrebbe forse attestare una grafia in legatura di 'Abu, ti-rf-in-da-mu documenta una forma a prefisso ti- da una radice di media (o prima) debole. Da notare la mancata assimilazione di n alla dentale. Analogamente a quanto osservato sopra per DI -ne-fb-du-lum, potrebbe essere citato qui anche il NP DI-EREN(LAK 6~1)-da-mul&2, sicuramente, dato il contesto semitico, da leggersi DI-rinx/rimx-damul63, Una lettura di del primo segno non è però
156 Cf, I. J, Gelb, Ldll, p, 40: *"r.t "essere lungo". 157 Bti11<>losia proposta da B. Sollberser in ABllf 8, p. 12. 158 Cf. ff,-p, Milller, Ldll, p. 228: "GN war? untitiS"• 159 Cf, p, rronzaroli, CllllAI 33 (1987), p. 64, testo e n. 3. 160 "Blla/egli è pallido, o HD!", come propone rronzaroli,
loc. cit. 161 llBll z.u. 162 AllllT 3.274 (NIN-NI); Allllf 4.11 (80), 12 (44) (DAM
DINCIR), Il noae, f.._inile (cf. P. rronzaroli, CllllAI 33 (1987), p. 72), ai riferisce a .. pre alla stessa persona.
163 Cf. p. es. P. Steinkeller, JIZllll 77 (1987), p. 191, per tali letture in paleoaccadico.
Il prefisso di coniugazione ti 151
evidente per il fatto notato sopra che vi è differenziazione nell'uso di DI e TI, e per il fatto che il NP non può essere confrontato su base prosopografica164 con ti-rf-in-da-mu. Una lettura sarimx-da-mu può forse meglio rimandare, a causa della peculiare grafia con sa e nonostante l'uso anomalo di EREN, a §almuml65, "sano, salvo", che nel NP s8-li-mu166 è attestato sicuramente ad Ebla167.
ti-iA-te-da-mu, ARET 1.3 v. IV:9, VII:9; ARET 3.140 r. II:3; ARET 4.22 v. IX:8, 24 V. III:8.
tél-te-da-mu, cit. in Fronzaroli, CRRAI 33, p. 72168. NPF, come chiaramente indicato dai contesti, che fanno riferimento ad un'unica persona (DUMU-MI2
EN). L'etimologia di questa forma verbale non può che rimandare ad un verbo ad una o più radicali
164 Nonostante alcune analogie (in particolare l'associazione con lu-ba-anki), che per il -ento però a-brano essere solamente casuali; non vi è tra l'altro prova evidente che ti-ri-in-da-•u sia una donna.
165 V. HAD 3, PP• 272 s.
166 ARET 8.532 (34) (a-bù-aki; v. anche p. 33); cit. in A. Archi, HARI 4 (1985), pp. 55 e 57 (aa-r1ki),
167 Difficoltà connesse nella resa di una sequenza sibilante - liquida - • si ritrovano anche nelle liste lessicali eblaite, in HEB 4.(379) gii-lu-•e = s'-ri-•i-nu, tfa-•i-nu, per la cui connessione con l'accadico surme/inu, "cipresso", v. c. Pettinato, I vocabolari. bilingui di. Bbla, LdB, p. 258, n. 79. M. Civil, Or 56 (1987), p. 235, adduce altri due esempi di questa difficoltà, uno dei quali presenta la sequenza liquida - sibilante.
168 L'inseri•ento in tale contesto di Ull-TB (ABET 2.14 (65) = HBB 2. 30, ur-kar), che, con lettura ttJs-te, potrebbe essere considerato ipocoristico di questo NP, non è sicuro per una serie di motivi. Innanzitutto, come nota Pronzaroli, CBRAI 33 (1987), p. 72, non vi è evidenza che ai tratti di un NPP; in secondo luogo, secondo D. O, Bdzard, ARET 2, p. 110, a. v., non è neanche sicuro che si tratti di un NP; infine, anche la lettura à insicura, ed anzi, dalla foto pubblicata in HEE 2/A, tav. XXXIX, appare preferibile una lettura uaKAR.
152 M. Bonechi
deboli, *sty, "bere" secondo Gelbl69, Ora, nell'onomastica di Ebla questa radice è meglio attestata nel tipo da8-da-ND e variantil7°. Nel caso di tiis-te-da-mu, non casuale deve essere in effetti la scelta dei segni ti e te; sembrano infatti indicare due realtà fonematiche differenti, sia fra loro sia rispetto a dal71. In particolare, si noti l'uso di te: in paleoaccadico, è differenziato da ti, ed appare connesso con la presenza di "3-:s nella ra·dice172. Anche ad Ebla l'uso di te è verosimilmente indizio della presenza di "3_:s: si veda p. es. il tipo onomastico ib-te-ND173, /yiptab-ND/174 "ND ha aperto (il ventre materno)". Tale fenomeno non è limitato a questo segno, ma è connesso con l'uso di sillabogrammi con vocale e per rendere " 3-:s; quanto è stato ipotizzato da Fronzarolil75 per i segni del tipo eC può essere infatti specularmente valido per almeno una parte dei segni
169 LdE, p. 35; di questo parere anche H.-P. Milller, BaE, pp. 180 e 183, e p, Fronzaroli, Typologies, cit., § 3.3.1, Precedentemente, Mùller, LdE, p. 224, faceva riferi•ento ad una radice •se, con infisso t.
170 Come dubitativa.ente propone P. rronzaroli, CRÌlAI 33 (1987), p. 66; per una possibile attestazione dell'i•perativo nel tipo si-ti-ND v. l. J, Gelb, LdE, P• 41.
171 P. Fronzaroli, SEb 5 (1982), p. 111, ipotizza nell'armonia vocalica ·1•origine della vocalizzazione del prefisso nel NP ti-is-te-da-•u.
172 V. HAD 2, p. 97, n. 218. Si noti anche la sopravvivenza arcaica dell'uso di TE per de4, differenziatò da di, nelle lettere di Amarna da Gerusale .. e, in connessione con le forme del verbo idO, cf. w. L. Moran, The Syrian Scribe o-f the Jerusalem Amarna Letters, Unity and Diversity, p. 161, n. 34.
173 V. ib-te-da-•u in ARET 1, 3, 4, 8 s. v., HEE 3,60 11:3 e G. Pettinato, Il COll9ercio internazionale di Ebla: econa.ia statale e privata, OLA 5 (1979), P• 222, v. lV:26, V:8; ib-te-ma-lik in ARET 4 s. v.
174 V, H,-p, Milller, LdE, P• 226, 175 La contribution de la langue d'Ebla à la connaissance du
s'-iitique archaique, CRRAI 25 (1978), pp. 132 e 135.
Il prefisso di coniugazione ti 153
del tipo Ce (si veda p. es. l'uso di BE per /bac(al)/ nei NP). Oltre a ib-te- e ti-is-te-, le attestazioni di te nell'onomastical76 sono assai scarse: si vedano i NP gi-te 177, NI -su-te-L UM178 e da-te...dUTU179. Non si ha per ora prova che tali NP alternino con forme con ti, e per da-te...dUTU è possibile una etimologia di 3a e quale *wdc, "conoscere", in opposizione a da-ti (-) (mai attestato con dUTU), /dad-I(-)/, "(ND è) mio zio paterno". Sembra preferibile per ti-is-te-, nonostante le difficoltà che ne derivano, una etimologia *scy, "cercare", ace. se'iìm, produttivo nell'onomastica18o, piuttosto che *sty, non produttivo di NP nell'onomastica accadica. Ne consegue un'interpretazione /tistacay-/, a meno di non voler ammettere come già avvenuta in eblaita, almeno in alcuni casi, la caduta di e ed il conseguente passaggio a > e (/tistey-/)181, Comunque stiano le cose, è significativo il fatto che la vocale del prefisso non può dipendere dalle alterazioni fonetiche connesse con il consonantismo della radice: difatti, nel primo caso, conservandosi la a del tema, non può aver avuto luogo una assimilazione regressiva e ci si dovrebbe aspettare /tastacay-/; nel secondo caso, l'eventuale assimilazione regressiva avrebbe dovuto esser notata in grafia da un segno te e non ti. Se l'assimilazione avesse già avuto luogo, l'attestazione di ti-is-te- documenterebbe la maggiore arcaicità della presenza del prefisso ti- nei confronti di
176 Nelle liste lessicali, sono sisnificative le glosse tB-ri-11-du e tB-ri-i§-tum di priaa e, e te-ra-za, var. di da-la-za.
l77 AR8T 8.522 (13),
178 AR8T 3.226.
179 AR8T 8.542 (25),
180 Cf. AH~, p, 1233,
181 Analogamente alle attestazioni accadiche, sin dal pa
leoaccadico.
154 M. Bonechi
tale fenomeno. L'unica possibilità fonetica che rimane per giustificare una alterazione ta- > ti- è quella costituita dalla presenza di y nella radice.
NP di dubbia interpretazione sono i seguenti:
dib-ar-ru12 , ARET 3.467 r. III: 12.
ti-a, ARET 8.523 (18)182 (= Pettinato, OLA 5)183. L'interpretazione di questo NP184 e dei seguenti è dubbia; sembra in ogni caso poco probabile un riferimento ad una forma flessa del verbo (v. i NP del tipo TI- e ti-la-).
ti-a-ba.r-zu, ARET 1.3 v. VI:6 (DUMU-MI2 ib-ri-um DAM-DINGIR). V. il NP precedente.
ti-a-da-mu 185, Edzard, III:l.
ARET 2.32 XI:l; ARET 3.193 r. VI:4; SEb 4, p. 41 (17); Archi, SEb 7, p. 65
V. i due NP precedenti.
ti-a-du, ARET 1.9 v. II:2 (a-zuki ).
ti-a-ga-mu, ARET 4.23 v. V:l4.
182 Edito come ti-(z)a.
183 NP secondo gli editori e P. rronzarqli, CRRAI 33 (1987), p, 72; il contesto non rende però ovvia l'identificazione come NP.
184 Per un confronto in area paleoaccadica v, il NPF te-a, HAD 1.119 x+ll: SAL.BALAG.DI.
185 Confrontato da D. o. Edzard, ABET 2, p. 106, eon i-a-da•u (con riferi•ento errato: questo secondo NP non sembra attestato in ABET 2). Per un'attestazione di i-a-da-•u, v. ora A. Archi, Alleva-19f1nto e distribuzione del besti-e ad Ebla, SEb 7 [1984), p, 66 [14)).
Il prefisso di coniugazione ti 155
ti-ba-:mu, ARET 3.531 VIII:3.
ti-ba-ra-nu, ARET 3.528 1:2'; ARET 4.1 r. 1:23; ARET 8.522 (18).
ti-ba-ra-num, ARET 2.31 II:5. Dopo Waetzoldt186 è verosimile che in tutti i testi ti-ba-ra-nu/nrim sia un sost.antivo denot.ante un oggetto prezioso o un aggettivo connesso con i tessuti, e non un NP187.
ti-ba-ù, ARET 4.2 r. X:19. NP maschile; cf. ti-ba-ùki (MEE 2)188.
TI-da-ba-nu, ARET 3.517:2. V. il commento a TI-ba-lam.
ti-da-na-ù, Archi, SEb 2, p. 12 r. VIII:6. NP maschile. Di non evidente collocazione tra le forme verbali flesse a prefisso ti-, anche se forse confront.abile con i NP i-da-NE, i-da-NE-ù (e i-ti-NE?), largamente diffusi ad Ebla.
ti-ga-LUM, ARET 3.468 r. III:3 (NAR), 498 v. II:4' (NAR). NP di un medesimo cantorel89.
186 Che in Ohne Parallelstellen geht es nicht - oder LesUIJ(I eblaitischer ~6rter und N,,.,,n - eine Clucksache?, JAOS 106 (1983), p. 553, ha stabilito per ti-ba-si-LUM di AJlrJ' 2.31 (non chiaro per l'editore) la lettura ti-ba-ra-nU., "(un s;ioiello)",
187 Solo il caso in AR•T 3 s-bra differente. Si noti però che, sebbene ti-ba-ra-nu sia inserito in una apparente lista di MP di 'b-suki (per la cui collocazione v. A. Archi, qus .. 13 (1984), p. 229 e Fs van Dijk, p. 10), il contesto fa riferillento ai tessuti.
188 Largaaente c011m&ntato da H. Dahood, v. p. es. •bla1te and Bibl1cal Hebrer, CBQ 44 (1982), p. 22.
189 Si notino le due seguenti liste parallele di HAil (e cf, in questo volwae, il contributo di H. V, Tonietti), che si riferiscono alle stesse persone: AR•r 3.488 r. III:l ss.: i7-da-11i-gd I 1-ti-dlH.KI I ti-ga-LUH I ••. I gd-lu-ga I zi-rl-111; All8T 3.498 v.
156 M. Bonechi
ti-gi-da~-a-du, Cit. in Archi, QuSem 13, p. 244. NP isolato proveniente da un inedito. Forse da
confrontare con i-gi-da-ga-mu (MEE 2), da *gyd "essere buono(?)"190?
TI-ba-lam, ARET 3. 771 II:2; ARET 8.526 (51). Questo NP (in entrambe le tavolette riferito ad
una medesima persona), può attestare un tipo
onomastico TI-ND, unitamente a TI-da-ba-nu. Per
il valore dell'elemento onomastico TI (noto anche
in ultima posizione, v. p. es. il NP fl-gu-us-TI in
ARET 1, 2, 3, 4), si noti sia la diffusa attesta
zione nei NP eblaiti di ti-lu (e var.) sia la possi
bilità di una lettura tll di TJ191.
ti-in-da-mu, ARET 3.170 III:3 (NI-ra-arki). L'interpretazione dell'elemento predicativo del
NP192 come forma verbale flessal93 è dubbial94,
ii;·z-;--;~-: .. ;-·- -;~:4;-.:~·i-=8;-;·--i=-i1:a· ;j-·1-····t·i:;;:1:Ui1 ... / .. ... ;:;·:;1:·;"d ··;···-··:··::·-·---; -··· ;;;: lu-ga. La variante zi-ri-ig/gu rill&llda al tipico fen<>11eno di oscillazione. nella resa della desinenza nei NP eblaiti. La variante i-tid1N .KI/ >à documenta la grafia semitica del ND, paragonabile a quella nota nelle liste lessicali (lfE~ 4.(803): den-ki = d>à-U9; per la lettura v. M. Krebernik, ZA 72 [1982), p. 233; per la glossa v. w. G. Lambert, The Section AN, Ba8, p. 399). Nella variante i7/>à-da-•i-gu, l'alternanza rende verosimilmente >3-4 + V.
190 Cf. CAAA., P• 19.
191 V. H. Krebernik, ZA 72 (1982), p. 203, e J, Krecher, BaE, p. 154, n. 115.
192 Per il quale si noti la 118.Dcata assiailazione di n alla dentale.
193 Ad un iaperativo del verbo "dare" fa riferiaento H.-P. Muller in Ba8, p. 178.
194 In alternativa, tuttavia, un'etimologia "giudizio", ace. dinu (noto nell'onomastica accadica, v. lfAD 3, pp. 105 s., e CAD D, p. 152, e amorrea, v. CAAA., pp. 191 s.; per il significato v. J, J.
st-, ANG, p. 172) s-brerebbe urtare contro le regole della fonetica eblaita e contro l'attestazione delle liste lessicali (v. 1188 4.[1327) di-ku~ = ba-da-gu da-ne-u(•]). D'altra parte, il NP potrebbe essere interpretato coae di tipo non eblaita, o, non essendo necessariaaente la linsua delle liste la stessa dell'onomastica, come altro
Il prefisso di coniugazione ti 157
anche se potrebbe essere suggerita dall'attestazione dell'elemento predicativo i-in- (noto ad Ebla nei NP i-in-11'à-da195, i-in-iJ 196, i-in-ì-lum 197, iin-lum 198, i-in-Nl199 e i-in-zé200); l'interpretazione di quest'ultimo elemento resta comunque insicura201.
ti-ir, ARET 1.29 r. V:2, 30 r. 111:6; ARET 3.339 v. 111:7, 343 r. Vl:l, 470 r. IV:2, 485 1:2; ARET 4.4 bd.8, 16 r. Vl:6; MEE 2.13 r. 11:3, 15 v. II:2, 33 r. IV:2, 34 r. IV:2, 36 r. 1:4, 38 v. II:6, 44 r. Vl:4, 47 r. 1:3, 50 r. V:7; Sollberger, SEb 3, p. 154; Archi, SEb 7, p. 79; cit. in Pettinato, Ebla 1, p. 154; cit. in Archi, CRRAI 28, p. 177; cit. in Archi, SEb 7, p. 35.
es-pio della dicotomia tra da-an (e var.); da •dnn, "esser forte", e -ti-ni, da •dyn, nota già in palaoaccadico.
195 ARET 2.14 (= HEE 2.30); ARBT 4.13.
196 ARBT 3.137, 173; ARBT 4.10. 197 ARBT 3.130.
198 ARET 1.15 ( = HEB 2, 8), Per un• interpretazione dell 'elemento teoforo v. r. Pomponio, Notes on the Fara Texts, Or 53 (1984), p. 13, n. 42.
199 ARET 1.5; ARBT 3. 203 (a-sa-lu-guki), 795, 942; ARET 4.14 ( a-S.-lu-guki).
200 ARBT 1.15 (= HEE 2.2); ARET 2.28, 30; ARBT 3.212, 626, 637, 866; ARBT 4.13, 17, 19; ARET 8. 538 (13) ('i-ga-en-nuki); HBE
2. 9, 33; cit. in A. Archi, SEb 4 (1981), p. 79 [8) e p. 83 [43].
201 Per un'interpretazione v. M. Dahood, Hebrelff Hapax Lego•ena in Bblaite, BaE, p. 466. La identificazione di i-in- con l'accadico inu, "occhio" (analoga a quella proposta da E. Sollberger, ARlfT 8, p. 13, per in-, i-na-) darebbe una soluzione semanticaaente adeguata e di larga attestazione se•itica (per l'on<>11astica accadica v. CADI, p. 156; per quella ugaritica v. Crondhal, Personenruuten, p. 110). Tuttavia, c<>11e già notato sopra per dinu, una tale interpretazione urta contro le regole della fonetica eblaita; inoltre, nelle liste lessicali eblaite, come è noto, il sostantivo si presenta alla foraa a-na( -a).
158 M. Bonechi
NP202 di difficile interpretazione; con vari altri NP ad esso connessi è con ogni probabilità un sostantivo203. V. anche il tipo ti-ra-.
ti-ir-rf, Cit. in Archi, QuSem 13, p. 250. V. s. v. ti-ir e var.
ti-iA-ga-nu, ARET 1.8 v. IV:4 ( t. 'à-ti-ir SES ba-daLUM bal-sumki); ARET 3.458 v. III:8 (li-ma....dda
. gan t. 'à-ti-ir bal-sumki ).
ti-il-ga-num, ARET 1.2 v. VII:2 (li-ma....dda-gan t. 'à-tiir bal-sumki); ARET 3.345 v. I:l (t. 'à-ti-ir balsumki).
ti-si-ga-num, Cit. in Archi, MARI 4, p. 58 (li-ma....ddagan t. 'à-ti-lu a-NAM ma-rfki ). L'analisi prosopografica dimostra che, in tutti i casi citati, si tratta della stessa persona204.
ti-la-NI, ARET 1.1 v. XI:13, 5 v. III:6, 9 v. IV:6, 10 r. X:7 (= MEE 2.17), 15 v. VI:5 (= MEE 2.2); ARET 2.30 V:l3; ARET 3.61 III:7, 203 V:3, 336 r. IX:2, 458 r. V:8, 730 r. IV:3, 938 r. VII:ll, 941 1:2; ARET 4.1 r. IX:22, 2 v. V:22, 4 v. VI:3 (= MEE 2.3), 6 v. IV:8, 7 v. VIII:18, v. IX:2, 8 v. IH:14, 9 r. II:5, 14 v. IV:ll, 19 r. II:ll, 22 v. II:14; ARET 8.522 (6, 11), 525 (11, 12), 527 (11, 18), 529 (14, 31), 531 (61), 538 (20, 23), 540 (39), 542 . (40); MEE 2.40 r. III:5, v. I:l; Pettinato, RSO 50, p. 4 r.
202 In alcuni casi (specie quelli in SBb 3) è anche dubbio che si tratti real•ente di un NP, v. r. Pomponio, I IJOl9i divini nei testi di Bbla, UF 15 (1983), p. 153, n. 54.
203 Cf, forse l'ace. ti'ru, "(un cortigiano)", Per la connessione di ti-ra-NI con tale termine v. B. Lipinski, LdB, p. 205.
204 La provenienza da Mari di ti-i.1-ga-nu e var. non s-bra certa: •entre >j-ti-ir/lu è sicuramente connesso con bal-sUllki, e aNAM è sicuramente un mariota, non è possibile provare l'origine mariota di ti-i.1-ga-nu, essendo questi seguito, nello stesso doc\mento, da 'j-ti-lu, che, come si è visto, è connesso con bal-su.ki, e non con Mari.
Il prefisso di coniugazione ti 159
IV:3, 12, p. 6 v. III:12, p. 7 v. V:7; Pettinato, Culto, p. 158 v. VI:24, VII:14; Archi, SEb 7, p. 79. Verosimilmente un sostantivo, cf. il diffuso elemento onomastico -ti-lu; v. anche i NP del tipo ti-a-, ti-ra-205 e ti-li-.
· ti-li-li-im, MEE 1.1742.206
ti-lu-du, Edzard, SEb 4, p. 37 r. II:4, p. 41 r. X:6. NP femminile; connesso etimologicamente con ti-laNI, oppure da * cJy207 o da * wld?
ti-ma-ti, ARET 3.1 II:4.
ti-mi-za-ù, ARET 8.533 (60) (lu-kar du-ra-ba-ziki), Benchè attestato solo in questo caso, indica con sicurezza un NP2os. Se a Mari l'analisi di tim-za-u come forma verbale flessa è, lo si è visto, resa sicura dall'analisi dei contesti, e dall'occorrenza parallela di im-za-'li, qui l'attestazione in ARET 3.178 di a-ma-za-ù non può essere usata con motivazione analoga, poiché, data la tipologia di quest'ultimo testo, difficilmente può essere intesa una prima persona del verbo209. Nel caso di ti-mi-za-ù, se come più probabile non si tratta di una forma nominale, le attestazioni eblaita e mariota potrebbero anche avere la stessa etimologia, ma non presentano in ogni caso la stessa forma del verbo, dato che nei NP eblaiti, come in paleoaccadico, non si hanno esempi di una 38 plurale.
205 Di cui è variante, cf , A. Archi, VO 6 (1986), pp. 245 s.
206 V, p, P<>11ponio , Or 53 (1984), p. 16. Cf, anche A. Tsuki-11e>to, lfine neue Urlcunde des Tili-§arruma, Sohn des K6nigs von Karluuiis, ASJ 6 (1984), p. 67, con bibliografia.
207 Cf, P. rronzaroli, CRBAI 33 (1987), p. 66. 208 In un altro testo, ARlfT 8.529 (29), è noto ti-•i-za-ùki, 209 Cf, anche, in questo volt.me, P. Pronzaroli, p. 22, (19'),
160 M. Bonechi
ti-NI-mi-IJa, ARET 4.10 r. V:8.
TIN-PI-ga-ba-ale, ARET 1.30 v. II:l.
ti-ra-n, ARET 3.3 VI:3, 19 II:2, 215 v. II:8, 502 I:2, 934 I:3; ARET 4.11 r. XII:lO, 12 r. VII:13, 13 v. VIII:22, 17 r. IV:3, r. XI:13; MEE 2.37 r. III:14; MEE 3.50 v. I:3, 56 v. II:14; Pettinato, RBI 25, p. 240 r. VI:4; cit. in Archi, SEB 2, p. 18. Verosimilmente un sostantivo; v. il NP ti-la.-NI, di cui è variante.
ti-rf, ARET 3.972 II:3; ARET 4.2 v. VI:5, 12 r. VI:l. V. s. v. ti-ir e var.
ti-ru12, ARET 1.17 r. III:16 (= MEE 2.22); ARET 3.684 IV:2', 885 II:7; MEE 2.17 v. X:18. Nome di uno stesso NE.DI in ARET 1.17, MEE 2.17 e ARET 3.684210, V. s. v. ti-ir e var.
ti-sa, ARET 3.495 v. 1:4. Cf. ti-sa-LUM (e TI-~ar?).
ti-sa-LUM, ARET 3. 74 III:3. Cf. ti-sa (e Tl-~ar?).
ti-la-li-im, ARET 1.1 v. Vl:2, v. VII:20; ARET 2.27a III:2, VI:3; ARET 3.277 II:4, 340 r. II:4, 460 v. V:7, v. Vl:7; ARET 4.9 r. IX:6; MEE 2.40 r. X:7; Fronzaroli, SEb 7, pp. 2-4 e 14-18; cit. in Archi, QuSem 13, pp. 247 s.
ti-lè-li-im., ARET 1.15 r. X:13, v. VIII:3 (= MEE 2.2); ARET 3.772 III:l; ARET 4.5 v. 1:6, 6 v. X:16; MEE 2.39 r. V:19; Fronzaroli, SEb 7, p. 3 r. II:l; cit. in Archi, QuSem 13, pp. 24 7 s.
210 Qui correai probabilllente KA.DI in Hl.DI.
Il prefisso di coniugazione ti 161
téA-li-im, Cit. in Archi, QuSem 13, p. 248211. Ben noto nome della regina di Emar. Nonostante alcune possibili etimologie212, la presenza della variante tés-li-im rende improbabile la derivazione dell'elemento predicativo da una forma verbale a prefisso ti-.
ti-sa-LUM, ARET 4.23 v. 1:13. Cf, ti-sa-nu? Una connessione con ti-sa-li-im, la regina di Emar, è stata proposta dall'editore.
ti-sa-nu, ARET 4.3 r. VIII:15 Cf. ti-sa-LUM?
ti-sar, ARET 3.939 r. III:7. Cf. ti-sa-LUM e ti-sa-LUM.
ti-ti, MEE 2.18 r. 1:4, III:l; cit. in Archi, MARI 4, P• 58. Formazione reduplicata213?
ti-ti-na, ARET 1.28 r. V:2; ARET 2.4 VIII:7; MEE 2.14 r. 1:3, v. III:8, 15 r. V:6, 27 r. X:6, v. X:9, 36 r. V:6; Archi, SEb 4, p. 159 v. II:ll.
ti-ti-nu, ARET 3.85 V:4, 468 r. IV:lO, r. VIII:13, 469 r. VI:13, 490 III:2, 799 v. II:3, 860 v. II:2, 885 III:2; ARET 4.5 v. IX:7, 10 r. IV:3, 11 r. VIII:!, 13 v.
211 Per la lettura tifi (UR), v. p, Pronzaroli, CRRAI 33 (1987), p. 72,
212 • yfw, cf. P. rronzaroli, Disposizioni reali per TifawLi >m (Tl'f.75.G.2396, Tl'f.75.G.1986+), SEb 7 (1984), PP• 6 s.; •ys<, cf. H.-P. MUller, BaE, p. 180 (ma in questo secondo caso la sibilante non è adesua ta) •
213 v. r, Pomponio, La terninologia -inistra ti va dei test
di Ebla. I: iu-•u-tasx. UF 17 (1985), p. 245, testo e n. 12, e A. Al berti - r. Pomponio, Pre-Sargonic and Sargonic Tezts rro. Ur Edite.
in UET 2, Supplement, Studia Pohl (Series Maior) 13 (1986), p. 5'.·; per altre attestazioni •esopotamiche di questo antroponino, v. l'fAD
1fAD 5, HSS 10, Li•et, Anthroponi•ie, p, 532, e r. Jlasheed, The k
cient Inscriptions in Himrin Area, Baghdad 1981, 21 1:5.
162 M. Bonechi
VI:3, v. X:22; ARET 8. 524 (5); MEE 2.16 r. III:5 (= SEb 4, p. 137), 33 v. VII:14, 41 r. IV:14; Pettinato, Ebla 1, p. 221 r. VI:4; Pettinato, AfO 25, p. 20 v. IX:25; Pettinato, RSO 50, p. 3 r. 1:4 e p. 4 r. IV:8; cit. in Pettinato, OA 19, p. 233; cit. in Archi, SEB 4, p. 87; cit. in Archi, MARI 4, p. 70, ( d). Probabile formazione nominale di tipo raddoppiato214.
ti-(z)a, ARET 8.523 (18) (dam) (= Pettinato, OLA 5). Così secondo l'editore. Se effettivamente NP, la lettura ti-a (q. v.) sembra preferibile.
In conclusione, il prefisso di coniugazione ti- ad Ebla è attestato nei seguenti casi:
Testi letterari
ti-a-ba-an ti-ig-da-ra-ab ti-da-bu-ru12
ti-na-bu-us
/tilabban/ /tiktar(r)ab/ /tiDabbur/ ? /tiHtab(b)ur/ ? /tinabbuS/
Antroponomastica
ti-ni-fb- /tinyib-/ ti-gi- /tiwqi>-/ ti-bir- /tibyir-/ ti-nu-ud /tinwud/ ti-rf-ig- /tiwriq-/ o
/tiryiq-/ ti-rf-in- /tiHrin-/ ? ti-iS-te- /tiAtey-/
3a f. 3a f. 2a m. 2a m. 2a m.
3a f, 3a f. 3a f. 2• m. 3a f. 3• f, 3a m. 3a f,
forte forte forte 1a deb. forte
2a y 3a , 2a y 2a w 1• w 2• y? 1• H 2• e, 3a y
214 Per un'interpretazione del tipo onomastico v. lfEE 2, p.
106, ad r. 1:3-4, e AR:rr 1, p, 177. Per inciso, è interessante notare i contesti di ARET 3.885 e ABET 4.11: in entrambi i casi si tratta dello stesso ti-ti-nu, maìiltlll /}a.-ra-11, connesso con un HG che è scritto sia ar-'j-ni-igki che 'j-ra-ne-igki, Le sequenze VC-V e V-CV denotano chiaraaente in questo MG un'identica realizzazione fon-tica.
Il prefisso di coniugazione ti 163
L'insieme delle attestazioni delle forme verbali a prefisso ti- ad Ebla ed in Mesopotamia non si è dimostrato omogeneo. Questa mancanza di omogeneità non è però indice di casualità: difatti, a ben analizzarlo, il materiale si viene a suddividere in gruppi omogenei.
Il primo è quello costituito dalle attestazioni dello schema ti12V3ii, con valore di 3a m. p. L'intero insieme di queste attestazioni proviene dalla Mari degli Sakkanakku, è noto esclusivamente nei testi amministrativi e non è attestato nei NP. Questo schema verbale non è conosciuto in accadico, ma è presente in cananaico, interrompendosi con Biblo215. Recentemente è stato analizzato da Edzard216, il quale, dopo aver passato in rassegna alcune delle attestazioni sopra studiate, e dopo aver ricordato le principali teorie esplicative di questa forma verbale217, conclude che ti-, che non indica mai la prima persona, e che, nelle attestazioni arcaiche di Mari non è condizionato dalla legge di Barth-Ginsberg, è il prefisso di coniugazione, analizzabile in /t+i-/, della forma ti12V3ii. Inoltre, nel gruppo di testi marioti, il prefisso ti- assolve le funzioni del prefisso yi-, che non è mai attestato per la 3a m. p. A proposito della forma ti- Edzard si domanda se essa sia secondaria e analogica, se sia invece propria del semitico arcaico, e sostituita poi da i12V3ii, o se, infine, sia una forma originaria, parallela a i12V3ii.
Alla luce degli esempi raccolti è ora . possibile sciogliere alcuni dei quesiti posti dà. Edzard. La pre-
215 v. G. Garbini, SNO, PP• 149 e 155 s. 216 Ps Birot, P• 85.
217 Quella di r. H. Th. BOhl, LSS 5; P• 52, per il quale, alla ~a•· p., il passaggio *Y > t avviene per influenza del passaggio *Y > t della 3a f, p., a sua volta condizionato dalla t della 3a f, s.; quella di w. r. Albrisht - w. L. Horan, A Re-interpretation of
an Aaarna Letter fra. Byblos (BA 82), JCS 2 (1948), p. 243: /ti-/ prefisso di una forma verbale femminile singolare a soggetto collettivo espresso dalla 38 •· p., con la correzione seguente di !toran, Ne"' Bvidence on Canaanite taqtulii(na), JCS 5 (1951), p. 33: /ti-/ della 38 P•
•
164 M. Bonechi
senza a Mari dello schema ti12V3ii va probabilmente considerata come la sua più antica attestazione, dato che nelle tavolette eblaite non è possibile identificare con sicurezza una sola presenza di tale schema verbale218; da notare poi che in un incantesimo eblaita si ha una 3a m. p. a prefisso yi-: i-da-ba-U.219. Di conseguenza le attestazioni di Mari non possono essere considerate traccia di un tratto arcaico, forse protosemitico, b~nsì, con aderenza alla documentazione, la più antica testimonianza attualmente nota di questa innovazione "cananaica".
Messe da parte queste attestazioni, riferite alla 3a m. p., e frutto di sostituzione di morfemi, quelle che restano fanno riferimento alla 2a m. s. o alla 3a f. s.: sono in ogni caso allomorfi di ta-220. Queste attestazioni, poi, possono essere ulteriormente suddivise in quelle provenienti dai testi letterari (quasi tutte con il verbo forte) da un lato, e in quelle provenienti da testi non letterari, quali lettere o contratti, e dall'onomastica, dall'altro (quasi tutte con radici deboli).
218 COiie si è visto, nessuno dei quattro potenziali t:i.1ZV3ii eblaiti indicati da D. o. Bdzard, Fs Birot, p. 86, con certezza può cosi essere interpretato: ti-da-bu-rui.2 è verosimilmente singolare, ti-na-NI-si-du è foraa n011inale, ti-NB-ù sintattic .. ente non è un verbo; resta ti-.a-ag, che è, per il 110111ento, inc011prensibile. Per un'ipotetica attestazione di questo prefisso t- per la 3a plurale, ma al tema 0/2, v. però P. Fronzaroli,_ alle pp. 11 s. di questo volUJ11e,
219 v. M. Krebernik, BFE, 22 (a), e cf. P. Pronzaroli, SEb 5 (1982), p. 5. Questa presenza contrasta con la più tarda attestazione mariota (a Mari, come si è visto, til2V3ii esclude yil2V3ii) ed ugaritica.
220 Diversaaente, è stato sostenuto che ti- è anche un allomorfo di yi- per la 3• •· s., v. c. Pettinato, Ebla 1, p. 72; H.-P. MUller, LdE, pp. 223-225 (dello stesso v. anche Der .TahwenaJOe uncl seine Deutung Ex 3,14 i• Licht der Textpublikationen aus Ebla, Biblica 62 (1981), p. 316, e BaE, p. 185, testo e nota 74); M. Dahood, The LilJlfuistic Classifica.tion of Eblaite, LdE, p. 183, n. 26. Dubbi contro tale ipotesi sono stati coaunque a suo t-po già espressi da I. J, Celb, LdE, p. 34,
Il prefisso di coniugazione ti 165
Non necessariamente le stesse motivazioni devono valere per tutti e due i gruppi. Un indizio in senso contrario può già vedersi nel fatto che un gruppo si oppone all'altro essendo presente quasi esclusivamente col primo il verbo forte, con l'altro il verbo debole. D'altra parte quale è il referente della lingua nei testi letterari, e quale è il referente della lingua dei NP, delle lettere e dei contratti? Il referente di questi ultimi è l'insieme dei sistemi linguistici diffusi nella zona, in uso al momento221. Nei casi di Larsa ed Emar, la presenza di ti-, sporadica e limitata a tre soli documenti, andrà intesa come un 'alterazione occasionale: in ogni caso un dialettismo. La situazione di Ebla è invece più complessa. Il prefisso ti- è attestato nell'onomastica con una certa larghezza, con radici deboli, ma quasi mai di prima debole, in un sistema linguistico che attesta regolarmente ta-222. Bisogna però a questo punto osservare che i sistemi che hanno regolarmente la vocalizzazione i nei prefissi, quando entrano in contatto con sistemi che hanno regolarmente la vocalizzazione a li possono contaminare223, come dimostrano alcune attestazioni di prefissi a vocale i in alcuni dialetti arabi orientali224. Di conseguenza è verosimile pensare che i NP eblaiti in
221 Sull'instabilità del sistema on09llstico (opposta alla conservatività della toponomastica) v. I, J, Gelb, Suaerians and Aklcadians in Their 8thno-Linguistic Belationship, CRRAI 9 (1960), p, 257, e P. rronzaroli, West Semitic Toponi•Y in Northern Syria in the Third Hillennir.m B. c .• JSS 22 (1977), p. 146.
222 Per la 3a f, s. in particolare v. P, rronzaroli, The Concord in Gender in 8blaite Theophoric Personal Na.es, Ul' 11 (1979), passi•·
223 !d è vero anche il contrario: v. p. es., nelle glosse cananaiche di Allarna, la grande quantità di vocalizzazioni del preformante in a, laddove ci si aspetterebbe, "cananaicaaente", i, cf, A.
r. Bainey, I's Ginsberg, p. 13•. 224 c. Babin, JSS 1 (1955), pp. 25 a.; più in particolare v.
A. A. Bloch, The Vowls o:f the I•IJ"r:fect Pret'ozwa.tives in the Old Dialects o:f Arabic, ZDHC 117 (1967), pp. 22 as., e H. B. Schub, A Note on the Dialect ot' r,..r. and Barth's Law, ZDHG 124 (1974), pp. 13 s.; cf. anche A. r. Bainey, art. cit., p. 9•, n. 27.
166 M. Bonechi
ti- altro non siano che attestazioni di "dialettismi". Una buona prova a favore di questa affermazione è costituita dal caso di ti-nu-ud (e vedi, più tardi, a Emar anche ti-im-tu/tù-ut e ti-im-tu-ta): qui non si potrebbe spiegare il passaggio di a in i del prefisso in presenza di media w etimologica, senza notare che questa curiosa alterazione è un fenomeno tipico dell'amorreo, come già notato sopra.
Vero è che la presenza di ti- nei NP eblaiti è quasi sempre connessa con verbi di media o ultima y, e che questo potrebbe far pensare ad una alterazione fonetica relativa alla presenza della semiconsonante. Questo è possibile, ma non può trovare motivazione all'interno dell'eblaita: esso infatti conserva la y, che non sembra cambiare, di conseguenza, il timbro della vocale vicina225 (anche se qualche eccezione può forse essere segnalata226). ·Vi è poi il caso costituito dal tipo onomastico dar-ib-Nozz7 che documenta la buona forma eblaita con verbi di media y (riabum). Le motivazioni, seppur fonetiche, devono allora essere esterne all'eblaita, e considerate, in questo, un dialettismo: questa presenza di ti- sarà quindi una prima attestazione di quel passaggio a > i, la cui origine, in tutte le lingue in cui è noto, è sempre limitata ad alcune classi verbali, generalizzandosi poi, e di cui anche il fenomeno descritto dalla legge di Barth-Ginsberg228 non rappresenta che una modalità.
225 v. p, rronzaroli, SEb 5 (198Z), p. 111. 226 v. H. Krebernit, ZA 73 (1983), p. 23, n. 78. 227 Attestato nel NP dar-1b-da-•u (AREf 3.140; ARET 4.Z2,
NPr; dar-1b-da-•u in lfEE 2.19 v. VI:l è da correggere in gul-da-•u, cf. AllET 1.11). La citazione da parte di I. J. Gelb, Ld8, p. 35, di un HP da-ri-1b-da-eu, riferita a Pettinato, Ibla 1, p. lZO, s-bra dovuta ad errore di staapa.
228 Legae che, ad Ibla come a Mari, non sembra· essere nota: v. già G. Pettinato, Or 44 (1975), p. 373, e I. J, Gelb, Thouahts about Ibla, SlfS 1/1 (1977), p. 22, 7.9.1; cf, anche JI, Caplice, LdE, ..
p, 16Z, e 1. Lipinsti, Ld8, p. 196. Più tardi, della !ledesi.a opinione si è manifestato anche D. o. lclzard, 's B1rot, p. 86, correg-
Il prefisso di coniugazione ti 167
~ il referente del gruppo ora analizzato lo stesso dei testi letterari? Non necessariamente. Per la loro stessa natura, i testi letterari fanno infatti riferimento ad una loro propria lingua funzionale, arcaica e conservativa. Le motivazioni della presenza di ti- nei testi letterari sono in ogni caso differenti da quelle dei testi non letterari: esso vi è difatti attestato con radici forti.
Secondo le teorie tradizionali e non229, il morfema della 2~ m. s. e della 3a f. s. a livello semitico comune è sempre ta-. La possibilità di un prefisso ti-, protosemitico, era stata suggerita dall'analisi di Kuryfowicz, secondo il quale la vocale dei prefissi flessionali non era autonoma, ma accordata alla vocale tematica230, I casi attestati ad Ebla e a Kish non si adeguano, a stretto rigore, a questa ricostruzione; potrebbero però, fqrse, tramandare il ricordo di una più arcaica fase linguistica, così congegnata, e i cui relitti, oramai sciolti da un vero e proprio sistema, potrebbero a buon diritto trovarsi in testi di questo tipo. Non sembra tuttavia questa una buona spiegazione, essendo in realtà incontrollabile e troppo macchinosa.
Una via alternativa potrebbe essere costituita da una motivazione fonetica. Si è già osservato che ti- è quasi sempre attestato con verbi interamente forti. La motivazione fonetica non potrà quindi che fare riferimento alla posizione o all'accento. Analizzando poi gli esempi disponibili, ti- si trova sia in sillaba aperta che chiusa, ma sempre in sillaba atona: la sillaba che segue, poi, aperta o chiusa, è accentata e ha la vocalizzazione
gendo i•plicitaaente la precedente assunzione di AB•r 5, P• 23 (1) e p. 25 (2). Diversamente, M. Dahoocl, •blaite and Biblical Hebre..,, CBQ 44 (1982), p. 13, ritiene tale legge operativa ad Ibla, nei NP del tipo il-ba-.
229 v. in particolare, oltre a s. Moscati (ed,), Introduction, p. 169, anche J, Kurylowicz, L'apophonie en sfft8itique, Wroclaw - Warszawa - Krak6w 1961, p. 30, § 41 ss.; I. M. Diakonoff, Lan-
6Ull8BS, PP• 75 ss, i R, Hetzron, rhe Vacalisation of Prefi1les in Se•itic Active and Passive Verbs, llUSJ 48 (1973/4), pp. 35 ss.
230 J, Kurylowicz, ibidem.
j
i
i ;
168 M. Bonechi
in a231. Sembra dunque ragionevole pensare che, in
questi testi, la sequenza sillabica *ta-Ca(C)- sia pas
sata in ti-Ca(C)-, con un processo analogo a quello at
testato, con maggior fortuna, nel nome, dal protosemi
tico all'accadico232. Una controprova della validità di
questa ipotesi è costituita dalla presenza di una chiara
2a f. s. nell'incantesimo kishita. Una forma come da-basa-bi-ni233, attestata alla 1. 38 di MAD 5.8, documenta
infatti, in un testo che presenta l'alterazione ta- > ti-, la conservazione di a nel prefisso, motivata dalla posi
zione differente che, nel sintagma, occupa l'accento:
/tapaàsabini/234: la a del prefisso, non più seguita da
una a accentata, non si è infatti alterata in j23s. Mentre
nel nome questo sviluppo ha avuto, in accadico, grande
231 La possibile eccezione costituita da ti-ri-da-a, se interpretabile COile /tirday/, troverà 11<>tivazione o nella presenza di y
nella radice, o nell'analogia con il ti- del verbo forte, o, più probabilmente, nell'unione di queste due cause. Si noti c011unque che la grafia permette anche un'interpretazione come energico /tirday-an/, o come 3a duale /tirdayi./, con una possibile differente posizione dell'accento nel sintagma (il congiuntivo in -a non sembra più tardi modificare la vocale del prefisso eblaita, v. ta-u-bi-a nell' iscrizione di Ibbii-Lim, e cf. I. J, Gelb, The Inscription of Jibbit-Lf•,
StOr 55/8 [1984], pp. 9 ss.). Per la possibilità dell'interpretazione come fol'lla di duale di i-ba-na(-a)' (/yipannawi/) v. p, Pronzaroli, a p, 16 in questo volume.
232 v. A. Dolgopolsky, On Phoneti.c Stress in Proto-Semitic,
IOS 8 (1978), p. Se, per quanto riguarda il nome. V. anche M. Krebernik, Zu Syllabar und Orthographie der lexilcalischen Texte aus
Bbla. Teil 2 (Glossar), ZA 73 (1983), p. 22 e n. 72, che postula uno a in schemi del tipo la2i3 > li2i3, e, per wia estensione analogica al verbo, /forphology, cit., § 2.3.
233 Per questa lettura, che corregge quella dell'editore (-i), e la sua interpretazione, v. A. Westenholz, JNBS 31 (1972), p. 382.
234 Cf, A, Westenholz, Or 46 (1977), p, 210, s. v.
235 La presenza di una 2a f, s., ad Ebla, potrebbe forse essere identificata, secondo M. Krebernik, BFB , p. 116 (f), in da-rada-bi: se l'identificazione è esatta, la for11a dovrebbe essere interpretata COiie compiuto 0/1 da una radice forte, /taraDDabi/ (v. forse ace. rat;abum, "esser fresco"), Il contesto è però poco chiaro, e questo rende difficile ogni speculazione.
Il prefisso di coniugazione ti 169
successo, con larga diffusione dello schema nominale li23-, nella morfologia del verbo la tendenza all'uniformità ha avuto evidentemente il sopravvento. Una prova ulteriore di questo fatto, si ha nei deverbali a prefisso ti- attestati nei testi letterari. Essi sono ti-ga-la-tum (/ti-'kal-at-um/), e, forse, ti-'à-ma-du, se da *lbm236 (/ti-ll;i.am-at-um/), e presentano un passaggio ta > ti davanti a a237.
La presenza di ti- in questi testi rappresenta dunque un tratto, forse conservativo, che documenta uno schema verbale tipico della arcaica lingua funzionale dei testi letterari semitici presargonici e sargonici; questo tratto è noto sinora solo ad Ebla e Kish, e potrebbe costituire un'isoglossa significativa per un'analisi linguistica all'interno della "Kish Civilization" 238.
ADDENDUM Il prefisso ti- nelle glosse.
Oltre che nei testi letterari e nell'onomastica, il prefisso ti è noto anche nelle liste lessicali eblaite, in relazione a formazioni nominali, deverbali; le sue attestazioni sono state largamente studiate, e le motivazioni sono verosimilmente di origine f onetica239, anche se non necessariamente analoghe a quelle identificate per le
236 V. ARET 5, PP• 24 s,
237 un analogo passaggio ta > ti, con analoga motivazione, si trova in arabo, v. H. Fleish, Trait~ de philologie arabe, vol. I, Beyrouth, 1961, p. 421; per le attestazioni di questa forma v. c. Brockelaann, Crundriss, vol, I, pp. 384 s.; v. i.noltre J, Kurylowicz, Apophonie, cit., p, 137.
238 Per quest'ultima v. 1. J. Gelb, LdE, special•ente pp. 52 ss.
239 Per il prefisso nelle glosse v. recent-nte · M. Krebernik, Verbalna.ina •it pri- und inFigerte. t in Ebla, SEb 7 (1984), p. 204, secondo il quale ti- se•bra fungere qui da allomorfo di tu-. Precedentemente, v. B. Kienast, Ba.E, pp. 227 s., 233 s. e 241; K. Hecker, Ba.E, pp. 218 s.
..
•
170 M. Bonechi
attestazioni del prefisso di coniugazione e del prefisso deverbale nei testi letterari.
Per qualcuna delle glosse a prefisso ti- seguono alcune brevi osservazioni:
ti-'à-me-du-um = GAN.DI, MEE 4.(831) I lemmi MEE 4.(828, 829, 831) possono essere util
mente confrontati tenendo conto delle varie fonti:
1 (=MEE 4, testo A•-e) 828 DI.GAN 829 DI.GAN.GAN 831 GAN.DI
2 (= MEE 4, 'testo B) 828 DI.GAN 829 DI.GAN.GAN 831 GAN.DI
828 829 831
3 (= MEE 4, testi AU + AV) DI.GAN DI.GAN.GAN GAN.[DI]
4 (= MEE 4, testo AK) 828 DI.GAN 829 DI.GAN.GAN 831 GAN.DI
du-da-du-um ti-"à-r e 11-du-um
nu-du-um du-da-du-um ti-"à-me-du-um
na-za-LUM da-da-zi- rL UM, nu-dum
na-za-LUM
nu-dum
Alcune glosse sono già state commentate: a) Civi1240 deriva du-da-du-um da *ntw, "colpire
con un bastone"; nel sumerogramma, DI = sé., indicatore fonetico di sag 7 (GAN);
b) Hecker241 pensa ai corrispondenti dell'accadico nasaku, "gettare a terra" e nadiì, "gettare"; per l'o-
240 Ba8, P• 83,
241 K. Becker. Ba8, p. 222, testo e n. 93.
Il prefisso di coniugazione ti 171
scuro sumerogramma DI.GAN(.GAN) ipotizza una connessione tra sa e sag(PA.GAN);
c) Kienast242 pensa, con Civil, a *ntw e, per naza-LUM, all'accadico naAaru, "dividere"; per il sumerogramma, concorda con Civil nel vedere in GAN.DI una connessione con sapiibu, "distruggere";
d) Krebernik243 nota l'assimilazione di n in duda-du-um e da-da-zi-rLUMl, derivate da nu-du-um e na-za-LUM, leggendo SA2.GAN(.GAN) il sumerogramma; inoltre deriva244 ti-"à-me-du-um da una radice *HmD.
Si può dunque pensare che s&sag 7 e s&sa~t? -sa g 7 siano glossati con forme 0/2 di * ntw nelle recensioni 1 e 2, che come di frequente concordano, mentre 3 e 4 usano un'altra radice, probabilmente *nsk, forse sinonimo del precedente. A GAN.DI, invece, le fonti 3 e 4 riferiscono *ntw, mentre 2 ha ti-"à-me-du-um; in quest' ultima glossa andrà cercato un sinonimo eblaita di sapiibu, "distruggere"245. La redazione principale (1 + 2) distingue nettamente l'equivalente di sag 7 , *ntw, da quello di si g 1 6 -di (*HmD o *HmH?); una grafia GANdi non è d'altra parte ignota ad Adab come scrittura fonetica di sì g (PA)/s i g 11(PA.GAN)-di, "eliminare, distruggere"246.
tìl-"à-ma-du = n ì-1 u-1 u, MEE 4.(64) Connesso con a/la-i-mu = nì-IU247. Entrambi i su
merogrammi fanno riferimento al verbo l u ( -1 u), "es-
242 B. Kienast, Na.ina •it t-Prifiz und t-Infiz in der Spra-che von Bbla und ihre sumerischen Aouivalente, aa., p. 247.
243 ZA 73 (1983), p. 40, n. 142, 244 SBb 7 (1984), p. 208, 245 Per sig16-di = sapiibu cf, A. ralkenstein, SCL 1, p. 44,
e, dello stesso, rluch aber Aklcade, ZA 57 (1965), P• 93; J, Krecher, SllLy, pp. 104 a. v. inoltre K. Civil e R. D. Bigga, Notes sur des teztes su.4riens archllIQues, RA 60 (1966), pp. 5 a. Per s&g/sigt6 v. anche A. Sjoberg, In Praise of the Scribal Art, JCS 24 (1971/72), p. 128.
246 v. J, Bauer, ZA 61 (1972), p. 324, nr. 119. 247 llBB 4,(63),
1
I
172 M. Bonechi
sere abbondante"248, accadico dussu, mii.du; la corrispondenza eblaita è differente da quella accadica, ma il senso di *Lòm249, "brulicare, affollare", ben si adatta al sumerogramma.
ti-rf(-u9-)um = ì-gar, MEE 4.(162) Formazione nominale a prefisso ti- da confrontare
con l'accadico wariim, "condurre, portare". Il sumerogramma attestato ad Ebla è differente da quello noto nelle liste mesopotamiche (tu m, t ù m), e rimanda ad un significato "mettere", accadico sakiinu; in questo caso, ì - g a r 250 suggerisce per l'equivalente eblaita un significato analogo a quello attestato in semitico di nordovest {ebr . . yiirii, "gettare"251 ), piuttosto che a quello accadico. Si tratta quindi non dell'uso di sinonimi, ma del riferimento a valori semantici differenti.
248 In sumerico classico il nesso ni-lu-lu va inteso "(quello che) rende tutto abbondante", con ni = mimma, cf. SKIZ, p. 179, e Klein, Sulgi A, 1. 55; per un altro esempio analogo di ni ••. lu-lu v. anche Alster, Suruppak, 11. 134 e 181.
249 Per l'etimologia v. M. Krebernik, ZA 73 (1983), p. 3, n. 9, e, · dello stesso, BFE, p. 114; per un sig_nificato "mangiare" di *ltun v. K. Hecker, BaE, p. 218, n. 79. Una differente connessione etimologica è invece proposta da F. Pomponio e P. Xella, Ricerche di lessico eblaita. I, AfO 31 (1984), p. 28.
250 La corrispondenza di forme verbali sumeriche con glosse nominali eblaite è attestata anche in altri lemmi, cf, M. Civil, BaE, P• 82.
251 Per un significato "guidare, condurre" in ebraico, si veda la nota di G. Rinaldi, Bibbia e Oriente 14 (1972/3), p. 142.