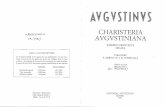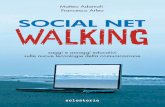Sotto-sopra: considerazioni sulle aperture nelle volte delle cripte medievali
Note etnolinguistiche sulle varietà locali della Lucania
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Note etnolinguistiche sulle varietà locali della Lucania
DIPARTIMENTO DI ISTITUZIONI LINGUISTICO-LETTERARIE,
COMUNICAZIONALI E STORICO GIURIDICHE DELL’EUROPA
Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne
Indirizzo: Lingue per le istituzioni, le imprese e il commercio
Note etnolinguistiche
sulle varietà locali della Lucania
RELATORE:
Prof.ssa Barbara Turchetta
CANDIDATO:
Romeo Ierone
Matricola 34
Anno accademico 2011/2012
2
INDICE
Introduzione ................................................................................................ 3
Trascrizione fonetica ................................................................................... 6
1. Dove siamo
1.1 I luoghi: la Basilicata e la valle del Sinni ............................................ 11
1.2 Storia .................................................................................................. 12
1.3 Su Senise ............................................................................................ 17
1.4 Senise oggi ......................................................................................... 19
2. Il quadro linguistico
2.1 Lo sviluppo nel tempo ....................................................................... 21
2.2 Vocalismo ........................................................................................ 26
2.3 Consonantismo ................................................................................ 30
2.4 Verbo................................................................................................ 33
3 Il corpus dei dati
3.1 Il punto di vista etnolinguistico ....................................................... 35
3.2 La raccolta ........................................................................................ 42
3.3 Il tempo ............................................................................................. 51
3.4 I numeri ........................................................................................... 68
Conclusioni ................................................................................................ 78
Bibliografia ................................................................................................ 82
Sitografia ................................................................................................... 85
3
Introduzione
Con questo lavoro ci proponiamo di condurre, come lascia intuire il
titolo stesso, uno studio etnolinguisitico su alcune varietà dialettali
della Lucania. Prima di tutto precisiamo che non si ha la minima
pretesa di realizzare uno studio esaustivo e completo sull’argomento,
ma una semplice descrizione di alcune peculiarità offerte dalla lingua
parlata. L’area che verrà privilegiata sarà quella della Valle del Sinni
con punto di riferimento il paese di Senise. E’ un’idea che nasce dalla
volontà di preservare in primo luogo e poi riscoprire e valorizzare non
solo un patrimonio, ma un intero universo esistente proprio sotto i
nostri occhi. “ I dialetti, non solo della Basilicata, cadono in oblio ed è
un peccato che questo tesoro linguistico inestimabile stia perdendosi’’
diceva il grande studioso tedesco Rainer Bigalke, lasciando intendere
che queste ricchezze potrebbero presto scomparire a causa di stili di
vita in continua evoluzione. L’ indagine nasce per svelare cosa si
nasconde dietro a ciò che viene detto. Vogliamo dare una coscienza alle
parole, e per farlo ci avvarremo di mezzi quali la linguistica
antropologica e l’etimologia in questo caso subordinata ad essa. Questo
è il primo studio del genere; non ci è pervenuta nessun’altra ricerca
simile operata in passato. Ai fini di una ricostruzione sostratica nel
primo capitolo tenteremo di dare un volto ed una carta d’identità
all’ambiente di ricerca, tramite una rassegna geografico – storica. In
4
questa parte è doveroso specificare come non tutte le fonti siano
documenti ufficiali o ricerche archeologiche organizzate; certo, di
testimonianze scritte e di scavi rilevanti ce ne sono ma in altri contesti
se esistono degli studi essi risultano quantomeno datati e non
accessibili, quindi si segue anche la semplice tradizione orale o la
ricerca amatoriale. Ad ogni modo questi limiti alla precisione possono
essere considerati di poco conto, dato il carattere generale della
descrizione. Nel capitolo numero due verrà descritto brevemente il
sistema linguistico, attraverso una descrizione generale accompagnata
da una parte sul vocalismo, una sul consonantismo e qualche cenno sul
verbo. Ciò viene reso necessario al fine di facilitare la buona
comprensione della varietà dialettale e delle parole sotto esame. Non si
scenderà nel dettaglio, elencando solo le particolarità più evidenti.
Questo secondo capitolo risulterà propedeutico al terzo, dove
inizieremo ad addentrarci nel cuore vero e proprio della trattazione,
presentando i principi teorici che hanno ispirato questa tesi ed
analizzando, sotto la loro luce, i dati raccolti. Dopo tutto ciò trarremo
le nostre conclusioni: si valuterà in quale grado la cultura popolare sia
rimasta conservata ed esprimibile sul piano linguistico, considerando
sia l’oggi che il domani. Il lavoro è stato reso possibile grazie al lavoro
svolto da Patrizia Del Puente e dai suoi collaboratori e documentato
nell’A.L.Ba.1 Oltre al materiale già disponibile, si è svolta un’ulteriore 1 Del Puente, Patrizia, A.L.Ba. (Atlante Linguistico della Basilicata), vol. II, Rionero in Vulture, Caliceditore
5
indagine, operando entro determinati limiti geografici e intervistando
un campione di persone ristretto. Questi dati statistici sono stati
utilizzati come prova empirica da confrontare con quelli di altri
ricercatori, ottenuti su una più larga scala.
2010.
6
Trascrizione Fonetica
In questo lavoro è stato fatto largo uso di trascrizioni fonologiche,
pertanto di seguito un elenco con i segni utilizzati. Per ragioni di
uniformità la trascrizione qui presente è la stessa che compare
sull’Atlante linguistico della Basilicata.
Vocali
Simboli Descrizione Esempio
Centrale bassa non labializzata It. Mano
Posteriore bassa non labializzata Ingl. Father
Æ Anteriore bassa non labializzata Ingl. Man
Anteriore medio-alta non
labializzata
It. Rete
Anteriore medio-bassa non
labializzata
It. Sette
Centrale medio-bassa non
labializzata
Ingl. About
Centrale medio-alta non
labializzata
Fr. Je; ingl. Girl
7
Centrale medio-alta non
labializzata tendente a vocale
piena
Anteriore alta non labializzata It. Vino
Anteriore semi-alta centralizzata Ingl. Fish
Posteriore medio-alta
labializzata
It. Fonte
Posteriore medio-bassa
labializzata
It. Corpo
Anteriore medio-alta labializzata Fr. Peu; ted. Hören
U Posteriore alta labializzata It. Culla
Centrale alta labializzata
Anteriore alta labializzata Fr. Lune
Posteriore semi-alta labializzata Ingl. Full
8
Consonanti
Simboli Descrizione Esempio
Occlusiva bilabiale sonora It. Banca
Fricativa bilabiale sonora Sp. Cabeza
Occlusiva velare sorda It. Cane
Occlusiva palatale sorda It. Chiesa
t Affricata alveo palatale sorda
t Affricata palatoalveolare sorda It. Cena
Occlusiva dentale sonora It. Dado
Occlusiva retroflessa sonora Sicil. Bed:a
Fricativa dentale sonora Ingl. That
Fricativa labiodentale sorda It. Filo
Occlusiva velare sonora It. Gatto
Occlusiva palatale sonora It. Ghiotto
d Affricata alveo palatale sonora
d Affricata palatoalveolare sonora It. Gente
9
Fricativa velare sonora Sp. Agua
Soluzione aspirata
Laterale alveolare It. Lana
Laterale palatale It. Paglia
Laterale retroflessa Sicil. Carlo
Laterale alveolare velarizzata Ingl. Full
Nasale bilabiale It. Mano
Nasale labiodentale It. Invio
Nasale alveolare It. Nave
Nasale velare It. Fango
Nasale palatale It. Gnocco
Occlusiva bilabiale sorda It. Porta
Vibrante alveolare It. Riva
Monovibrante alveolare
Fricativa uvulare sonora Fr. Jour
Fricativa alveolare sorda It. Sale
10
Fricativa alveolare sonora It. Asma
Sibilante palatoalveolare sorda It. Scena
Occlusiva dentale sorda It. Torre
Occlusiva retroflessa sorda Sicil. Carta
Affricata prepalatale sorda Sicil. Patre
Fricativa dentale sorda Ingl. Thief
Fricativa labiodentale sonora It. Vedo
Affricata alveolare sorda It. Pazzo
Affricata alveolare sonora It. Mezzo
Approssimante palatale It. Ieri
Approssimante labiovelare It. Uomo
11
1. Dove siamo
« ... La Lucania è il territorio posto tra la costa del Tirreno,
dal Sele al Lao, e quella dello Ionio, da Metaponto a Turi... »
Strabone
1. I Luoghi: la Basilicata e la valle del Sinni
La Basilicata è una delle venti regioni d’ Italia ed è situata nel sud della
penisola, compresa tra Campania, Puglia e Calabria. Affaccia con pochi
chilometri di costa sul Mar Tirreno mentre dispone di un lungo
corridoio sul Mare Ionio. Il suo territorio è montuoso, essendo
attraversato dall’Appennino Lucano di cui si ricordano i monti della
Maddalena e le cime del Pollino al confine con la Calabria. Il resto è
prevalentemente collinare. Il suo capoluogo è Potenza, mentre Matera
costituisce la seconda provincia. I fiumi principali sono Il Basento,
l’Agri e il Sinni. E’ La valle formata da quest’ultimo ad essere al centro
dell’attenzione in questa tesi. Essa giace nell’ area sud-occidentale
della Basilicata e prende il suo stesso nome. Il fiume nasce dal versante
nord-ovest del massiccio del monte Sirino per poi sfociare nel Golfo di
Taranto. Lungo il suo percorso di 94 chilometri costeggia il massiccio
del Pollino e raccoglie le acque di altri corsi d’acqua minori
(Serrapotamo, Sarmento e Frido) per poi sfociare nel Golfo di Taranto.
12
Sulle sue acque sono sorti numerosi abitati tra i quali troviamo Senise,
del quale verrà tracciato di seguito un profilo storico inquadrato
all’interno di quello, più generale, dell’area circostante.
1.2 Storia
L’ospitalità di queste terre ha fatto sì che numerosi popoli vi si
insediassero e vi costruissero le loro case nel corso della storia, sin dai
tempi più antichi. La maggior parte dei centri esiste ancora oggi e
riporta, attraverso varie manifestazioni, i segni dei secoli passati e delle
realtà conosciute. Ci sono stabilimenti che testimoniano la loro antica
esistenza attraverso prove tangibili, come reperti archeologici, mentre
altri invece rimangono sospesi nel dubbio, trovando conferme su testi
storici o nelle supposizioni di pochi studiosi . Ai fini di questo studio la
conoscenza delle molteplici culture, senza dimenticare le relative
lingue, che si sono alternate o che hanno convissuto insieme è
imprescindibile. E’ interessante notare come la maggior parte delle
scoperte archeologiche, di seguito citate, siano avvenute per puro
caso2.
Le testimonianze più antiche, proprio nei dintorni di Senise, risalgono
all’età del ferro con il ritrovamento di oggetti quali vasi, kantharoi e
piatti, e la scoperta di una necropoli nei pressi del torrente
2 Quilici L. e Quilici Gigli S., (a cura di), Carta Archeologica della valle del Sinni, Roma, L’Erma di
Bretschneider, 2003
13
Serrapotamo. Questi rinvenimenti sembrano confermare la già nota
presenza degli Enotri sul territorio; un popolo che allora doveva
ricoprire un ruolo molto importante in quest’area della penisola.
Questa presenza è rilevante se si pensa alla loro mitica città, Pandosia.
La sua esistenza l ungo il corso del Sinni è ancora materia di dibattito,
ma si pensa che fu il più importante centro della zona. I suoi resti, in
Lucania, la posizionano nei pressi della contemporanea Anglona,
proprio tra le due valli formate dal Sinni e dall’Agri. Fiumi che a quel
tempo favorivano l’economia locale in modo decisivo, se pensiamo che
anticamente erano navigabili; oltre al commercio la loro presenza era
significativa per la ricchezza delle terre. In seguito, Pandosia fu
conquistata dai greci, i quali la ribattezzarono così. Testimonianza
della presenza ellenica dovrebbe essere anche il nome del fiume Agri,
perché veniva accostato all’ “Acheronte”.
I greci in questione erano arrivati verso la fine dell’ VIII secolo A.C.,
erano gli ioni di Colofone. Essi fondarono la loro prima colonia sulla
costa ionica, dandole il nome Siri, dallo stesso fiume che passava di lì e
che avevano battezzato Siris. Questo darà poi il suo nome all’intera
regione dove veniva esercitato il potere amministrativo dei coloni: la
Siritide. Pochi chilometri più a nord i greci fonderanno anche
Eracleopoli. I nuovi arrivati non dovettero affrontare molte difficoltà
14
dato che gli Enotri, dediti alla pastorizia e all’agricoltura, non
ambivano a possedere il territorio in prossimità del mare.
La loro decadenza comincerà con l’arrivo, nel V secolo A.C., dei Lucani,
popolazione di lingua osca che premeva per arrivare sulla costa. Ed è
difatti del V secolo una sepoltura lucana riportata alla luce dal fondo
della valle. L’antica regione della Lucania aveva come territori
principali le terre tra basso Sele, Bradano e Sinni.
Passano pochi anni e la regione diventa oggetto delle conquiste
romane, a partire dal III secolo A.C. Per arrivare a controllare l’intera
aerea i nuovi conquistatori sconfiggeranno i Lucani prima e i Greci
comandati da Pirro poi. Deterranno il possesso del territorio fino alla
decadenza dell’Impero. Negli anni del loro dominio praticarono una
politica di coltivazione intensiva e usufruirono degli ampi spazi a
disposizione per l’edificazione di diverse ville , alcune delle quali così
belle da meritare le lodi di Cicerone.
La dominazione romana si rivelerà tappa fondamentale sotto tutti i
punti di vista. Ai nostri fini è importante sottolineare importanti
sviluppi come quelli che videro coinvolte le vie di comunicazione :
sotto quest’aspetto basti pensare che per la valle del Sinni passava la
via Popilia, che collegava Reggio Calabria a Capua. Cosa ancora più
importante: i romani con il loro modello di società e soprattutto con la
15
lingua latina trasmisero alle popolazioni lucane conquistate concetti
fino ad allora sconosciuti, in larga parte astratti. Un impatto che
segnerà, come vedremo più avanti, il lessico che andrà a costituire la
gran parte delle varietà dialettali.
Dopo la caduta di Roma il via vai di genti e di culture diverse
ricomincia: per un breve periodo la regione sarà amministrata dai
bizantini prima di cadere sotto il controllo del ducato longobardo di
Benevento. Uno scontro, questo, che interessa molto la nostra causa:
come ci viene riferito da “I dialetti italiani”3 la differenziazione tra i
dialetti meridionali coincide proprio con quelli amministrativi e
militari dei bizantini e dei longobardi; anche su questo ci
soffermeremo più avanti.
Complici le continue invasioni saracene, il medioevo si rivela molto
duro per chi vive in terra di Lucania. Le continue guerre, la
distruzione, l’anarchia e soprattutto la malaria (uno dei grandi mali
che durerà fino al XX secolo) spingono le persone ad abbandonare
luoghi troppo “esposti” a questi pericoli per rifugiarsi su altopiani
protetti da un castello a qualche centinaio di metri sopra il mare. Uno
dei più importanti centri saraceni della regione sarà Tursi, come ci
testimonia ancora oggi la sua Rabatana; già questa parola di per sé
3 Cortelazzo, M., et al., (a cura di), I dialetti italiani: storia, struttura, uso, Torino, UTET 2002.
16
lascia intuire come i saraceni abbiano lasciato tracce anche a livello
linguistico.
Dopo un’altra parentesi bizantina nel 1059 il territorio passa nelle
mani dei Normanni e del Regno di Sicilia. Comincia così a delinearsi,
anche sul piano politico, quella che sarà la società: con il barone-
feudatario a governare il villaggio e i contadini a lavorare nei latifondi.
Nel corso di questa dominazione e di quella spagnola assistiamo alla
cacciata dei saraceni rimasti, all’arrivo di profughi bizantini in fuga
dopo la caduta di Costantinopoli e a quello di albanesi e greci sempre
dovuto alla conquista ottomana della loro patria.
Grandi stravolgimenti,o novità, a livello di popolazione, di società o di
lingua non ve ne saranno più; almeno fino all’arrivo delle innovazioni
tecnologiche e della cultura di massa del secondo novecento. Prima di
ciò ci saranno il Regno d’italia ed il regime fascista che da un punto di
vista linguistico cercheranno di incoraggiare l’uso della lingua italiana:
con metodi diversi uno dall’altro ma con lo stesso risultato di fallire nei
loro intenti.
17
1.3 Su Senise
Circa le origini di Senise si è ancora incerti; sussistono tuttora diverse
versioni . Una di esse vorrebbe l’attuale paese essere sorto durante il
secondo secolo del primo millennio presso il convento di alcuni
francescani giunti in cerca di rifugio dalla peste. Ma il paese potrebbe
essere molto più antico: un’altra versione infatti, confermata anche da
scoperte archeologiche, trova l’origine in epoca antecedente, per opera
di uno dei fedeli di Cesare: Narsete Servillo, che dopo la morte del suo
leader decise di sottrarsi ai continui contrasti dei quali viveva Roma e
ritirarsi nel sud. Forse era possessore di una villa in questa zona e lì vi
riunì i pastori che vivevano nella valle. Ciò sarebbe confermato anche
dal recupero di alcuni reperti risalenti al’epoca del primo impero.
Invece una terza versione, avente come prova l’attuale stemma del
paese raffigurante una lupa nell’atto di allattare un bambino4, racconta
di un cavaliere crociato di Siena che durante il suo tragitto verso la
Terra Santa avrebbe fondato il paese; così si spiegherebbe anche
l’assonanza tra i due nomi. E ancora, nei primi anni del novecento
furono portati alla luce degli ori di età barbarica conosciuti come “Ori
di Senise”, oggi conservati nel Museo Nazionale di Napoli. Essi
testimoniano l’invasione e l’occupazione del villaggio da parte dei
longobardi e dei goti. Si dice inoltre che il primo centro doveva trovarsi
4 Lo stemma di Siena è proprio una lupa nel gesto di dar del latte ad un bambino.
18
più a valle; poi con l’arrivo delle guerre e della malaria dilagante fu
spostato più in alto, nella sua attuale posizione. Anche per quanto
riguarda l’origine del toponimo non si è sicuri: Giacomo Racioppi
sostenne l’idea secondo la quale ‘Sentia’, luogo di spine, sarebbe stato il
nome originario del borgo5, poi c’è l’ipotesi secondo la quale il nome
deriverebbe dal greco bizantino “ξύνεσίς” <<confluenza>>, poiché il
paese è posizionato la dove il Serrapotamo si immette nel Sinni. Quella
più veritiere dovrebbe essere quella del de Grazia, che rimanda la
nomea al fiume stesso6, ipotesi che sembra trovare conferma anche nei
versi di Isabella Morra “terra che da te deriva il nome”7
Durante l’occupazione normanna e del Regno delle Due Sicilie il paese
rimase sotto l’amministrazione della famiglia Chiaromonte per poi
passare ai Sanseverino, ai Pignatelli, ai Di Sangro e ai Donnaperna. Nei
secoli che trascorsero il carattere agricolo del paese non mutò, né subì
particolari cambiamenti: l’agricoltura e l’allevamento sono sempre
stati al centro dell’economia del paese. Dal cinquecento in poi non
accadrà niente di rilevante a livello storico fino al XX secolo.
5 Racioppi, G., Storia dei popoli lucani e della Basilicata, vol. II, Roma, 1889.
6 De Grazia, P., Basilicata, Torino, Paravia 1926.
7 Morra, I., Rime, Roma, Biblioteca italiana 2004.
19
1.4 Senise oggi
Senise sorge lungo la sponda sinistra del Sinni sul versante di un
monte a 335 metri sopra il livello del mare. Come tutta l’area
occidentale della regione rientra nella municipalità di Potenza ed è il
centro più importante, per numero di abitanti, di tutta la vallata
percorsa dal fiume. Da trent’anni ormai, ai suoi piedi, là dove prima si
estendevano campi agricoli, sorge la diga di Monte Cutugno, la diga in
terra battuta più grande d’Europa. Dalla cima del paese si scorgono
alcuni comuni limitrofi, anche loro posti su alture: Noepoli,
Chiaromonte e Sant’Arcangelo mentre altri come Colobraro, S.Giorgio
Lucano e Roccanova rimangono nascosti alla vista.
Secondo le statistiche ISTAT nel ventennio che va dal 1931 al 1950 si
registrò un notevole incremento, di circa 2.000 persone, della
popolazione che permise di raggiungere gli stabili e costanti 7.000
abitanti dell’ultimo sessantennio. Incremento demografico dovuto alla
fine del regime fascista e della guerra ed al miglioramento delle
condizioni di vita. Anche Senise è stata colpita dal flusso migratorio
per il quale i suoi abitanti lasciavano casa verso lidi più ricchi di
opportunità, sia in Italia che nel mondo. Tornando al presente, i dati
ISTAT aggiornati al Gennaio 2011 rivelano che il totale degli abitanti
ammonta a 7129; considerando solo i parlanti nativi del dialetto la
popolazione è composta da 2299 individui sotto i 30 anni, 3036 con
20
l’età compresa tra i 30 ed i 59 anni e 1665 sopra i 60. A differenza di
quello che accadeva fino cinquanta anni fa, oggi è più facile per gli
adulti e per i giovani diplomati trovare opportunità lavorative o
semplicemente studiare in altre regioni con l’eventualità poi di
stabilirvisi, viste le poche scelte che offre la vita di paese; ciò comporta
logicamente una regressione nell’uso del dialetto nella comunicazione
orale dell’individuo. Per quanto riguarda il numero di stranieri
residente in paese, esso è in crescita e conta di 154 individui.
L’economia del paese è, per tradizione, essenzialmente agricola; a
sostegno di ciò c’è il dato che ci rivela che una buona parte degli
abitanti, oltre alla propria casa in paese, possiede anche porzioni di
terra nei dintorni. Va comunque precisato che rispetto a prima questo
tipo di economia si è ridotta. L’abituale mercato che da anni si tiene
ogni mattina nelle strade del paese offre sempre prodotti freschi, con i
contadini che dispongono su cassette di legno la loro frutta e verdura. I
prodotti principali sono peperoni, finocchi, legumi e pomodori. Il
prodotto principale è sicuramente il peperone, che nel 1996 ha
ottenuto il marchio I.G.P. Rilevante è anche la lavorazione della carne
e la produzione di formaggi e vini locali.
21
2. Il quadro linguistico
2.1. Lo sviluppo nel tempo
Le varietà dialettali considerate rientrano nella famiglia dei dialetti
dell’area meridionale intermedia nella classificazione di G.B.
Pellegrini8. Proprio questa classificazione ci dimostra come la
Basilicata non sia proprio unitaria dal punto di vista linguistico:
Pellegrini la divide in quattro aree: Lucano nord-occidentale,
Materano, Lucano centrale e Area Lausberg. Dell’area nord-
occidentale troviamo Tito, Picerno, Pignola, Vaglio e Potenza, che si
distinguono per essere alcune delle isole gallo-italiche individuate da
Rohlfs negli anni ’30 in Lucania. A questi aggiungiamo 5 comunità
arbëreshë. Il Materano è si avvicina molto alla parlata della vicina Bari
e l’area centrale si distingue per il vocalismo del Vorposten e per una
maggiore conservazione di lemmi greci. Il dialetto oggetto di questa
tesi rientra nell’Area Lausberg: più avanti verranno elencati alcuni
tratti caratteristici.
Nell’età preromana le lingue conosciute in questi territori sono state in
ordine cronologico quella degli enotri e l’osco, con la prima che forse
era affine alla seconda, ma è solo un’ipotesi. A queste aggiungeremo il
greco antico, anche se parlato da una netta minoranza. Le possiamo
8 Pellegrini, G. B., Carta dei dialetti d’Italia, Pisa, Pacini editore 1977.
22
definire come il nostro punto di partenza, il sostrato del dialetto che
tornerà a manifestarsi durante la decadenza dell’impero romano con
quello che Cattaneo chiamò ‘’rinvigorimento’’9. Ma procediamo con
ordine: un primo punto di svoltà, come è stato già affermato in
precedenza, è stata l’avanzata del latino. Le varietà protagoniste di
questa ricerca trovano le loro fondamenta in esso. Possiamo affermare
che è con il latino che nasce il dialetto; da un punto di vista
morfologico e sintattico lo strato linguistico principale è il latino. Senza
contare che la quasi totalità del lessico poggia su di esso. Il latino
assoggetta le lingue italiche preesistente e le livella: una volta entrato
in contatto e cominciato ad essere usare periodicamente dalle
popolazioni non verrà mai abbandonato. Questo si verificò in quasi
tutta la Lucania: i romani diffusero la loro lingua per quasi tutta la
regione. In quegli anni il concetto di dialetto come lo conosciamo oggi
non esisteva in Italia, era legato solo alla situazione linguistica della
Grecia,essendo ‘dialetto’ stesso una parola greca. La lingua parlata in
queste regioni poste alla “periferia” di Roma, dove la realtà romana si
incrociava con un’altra completamente diversa, veniva definita
‘rusticas’, proprio da ‘rus’, contado. La ragione delle differenze è ovvia,
le tribù italiche dovevano imparare una nuova lingua e nel farlo
mantenevano tratti della loro, che si palesavano nella pronuncia.
9 Cattaneo in Grassi C, e Sobrero, A., Fondamenti di dialettologia italiana, Roma; Bari, Laterza 1997, p. 40.
23
Dopo la caduta dell’impero romano ed il passaggio alle lingue romanze
e poi al volgare avvenne quel ‘’rinvigorimento’’ accennato poche righe
sopra. E questo si verificò per tutte le altre regioni d’Italia. In questo
periodo il vocabolario dialettale verrà anche arricchito dalle parole dei
suoi futuri dominatori e cittadini: parole greche e galliche soprattutto,
che con il passare dei secoli si adatteranno alla pronuncia locale e
contribuiranno, alcune più e alcune meno, all’arricchimento lessicale.
Per quanto riguarda il contributo greco potremo citare ad esempio:
/‘vrotk/ <<rana>> che viene dal greco βάτραχος, lagan <<pasta
sfoglia>> da λαγάνον, /’kruop/ <<letame>> da χόπρος; tra i verbi
ricordiamo /ndi’a/ <<inaugurare>> da εγκαινιάζω e /nia’na/
<<salire>> da αναλαβαίνω. Oltre all’area sud-occidentale che ora
stiamo analizzando, alcuni di questi lemmi si possono riscontrare
anche nella Lucania settentrionale, circostanza dovuta alla prossimità
del confine campano, anch’esso sede di grecismi. Questi offrono un
interessante spunto di riflessione: il Rohlfs, colui che per primo li ha
raccolti, sostiene che essi siano frutto dell’influenza della prima
ellenizzazione e poi della seconda, implicando che le conseguenze
linguistiche della prima fossero sopravvissute all’ondata latina. Altri
studiosi, al contrario, come Parlangeli10 e Alessio11 sostengono invece la
10
Parlangeli, O., Storia linguistica e storia politica nell’Italia meridionale, Firenze, Le Monnier 1960.
24
non continuità fra le due fasi, e che la presenza di tratti ellenici sia da
ascrivere solamente al periodo bizantino, vale a dire nel VII
secolo(nota). Ciò verrebbe testimoniato dalla discriminante delle zone
di montagna: le terre occupate dai primi coloni greci non erano che in
prossimità della costa, mentre i bizantini nei periodi in cui sono giunti
in queste terre, sia da conquistatori che da immigrati, riuscirono a
raggiungere anche i monti. Tutt’oggi il dibattito è ancora aperto e
sembra difficile possa mai avere risposte data la totale assenza di fonti
originali.
Il contributo gallico è presente in quantità minore nel dialetto di
Senise, rispetto alle aree più settentrionali; qui ricordiamo
/penden’dif:/ <<collier con ciondoli>> proveniente da pendentif e
/:e()’m:is/ <<camicia>> da chamise. Già da questi pochi esempi
possiamo notare come i diversi contributi ricoprano anche aree
culturali: le parole greche le incontriamo quando parliamo di animali e
di strumenti ed oggetti di tutti i giorni (qui ancora potremmo ancora
riporta /’grast/ <<vaso da fiori>> e /kuk:u’ved:/ <<civetta>>), una
scienza “primitiva”. Il francese, al contrario, viene fuori quando si
tratta di capi d’abbigliamento, gioielli o in maniera più generale di
oggetti legati al mondo della moda.
11
Alessio, G., Saggio di toponomastica calabrese, L. S. Olschki 1939.
25
Un caratteristica che troviamo nel lessico è l’uso di parole in origine
legate ad un concetto astratto per designare significati concreti o
comunque ristretti; sono i cosiddetti cultismi, legati alla cultura
materiale, che possono avvalersi di una presenza importante nel
vocabolario dialettale. Essi possono derivano dalla letteratura ma
anche dal confronto della gente con le istituzioni civili e la religione. Di
seguito tre esempi di cultismo utilizzati a Senise12:
/teta’ts:/ << persona insopportabile >>
/k’frt/ << condoglianze >>
/ku’m:/ <<gran confusione>>
12
Cortelazzo, M., et al., (a cura di), op. cit., p. 771.
26
2.2 Vocalismo
I dialetti di Senise e dei paesi limitrofi condividono caratteristiche
comuni, come vocalismi, coniugazioni verbali, pronomi ecc. Proprio a
causa di alcune di queste caratteristiche, la valle del Sinni fa parte della
zona Lausberg, dal nome del suo scopritore. L’area Lausberg è definita
principalmente dal vocalismo tonico. Secondo la tradizione questo tipo
di vocalismo si è venuto a creare a cavallo del passaggio dal latino alle
lingue romanze: le vocali lunghe e brevi latine si fondono in un’unica
vocale e non prende luogo l’opposizione qualitativa vocale chiusa-
vocale aperta.
Nel periodo classico il latino volgare contava 3 gradi e come già detto
distingueva quantitativamente le vocali13.
ī ĭ ū ŭ
ē ĕ ō ŏ
ā ă
Con il passaggio alle lingue romanze si passa ad una opposizione
qualitativa, cioè vocale aperta- vocale chiusa andando a formare
teoricamente un sistema a 5 gradi con 9 vocali. Nella realtà invece si
verificò una fusione di vocali di grado contiguo: si sviluppa così un
13
Rohlfs, G., Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, vol. I, Torino, Einaudi 1966, pp. 5-6.
27
sistema a 4 gradi con 7 vocali in cui l’antica ĭ breve aperta e l’antica ē
lunga chiusa si fusero nel fonema /e/ e le antiche ŭ breve aperta ed ō
lunga chiusa nel fonema /o/, così da ottenere il vocalismo del futuro
italiano:
i u
e o
a
Invece nel dialetto senisese si è avuto nel corso del tempo un esito
differente: un vocalismo a 3 gradi con 5 vocali che a differenza di
quello sopracitato mantiene separate ĭ breve aperta ed ē lunga chiusa
oltre a ŭ breve aperta ed ō lunga chiusa fondendo in un unico suono
ogni opposizione breve-lungo tra stesse vocali. E’ un sistema
pentavocalico ed asimmetrico, in quanto l’asse palatale ha subito uno
sviluppo diverso da quello velare. Di seguito è riportata una tabella
esemplificativa tratta da “I dialetti italiani”14:
14
Cortelazzo, M., et al., (a cura di), op. cit., p.759.
28
Latino Senise Italiano
Meridionale
AURĬC(U)LA /’ric:/ /’rec:/
PĬPE(R) /’pip/ /’pep/
RESPŌNDĔRE /r’spon:/ /r’spn:/
CRŬCE /’krut/ /’krt
I suddetti tratti, a parte qualche eccezione, sono condivisi con il sardo e
sono unici in Italia. Per quanto riguarda il perché queste particolarità
siano sopravvissute, la tradizione fa risalire il tutto all’isolamento della
regione, mentre Varvaro15 prova a fornire una spiegazione basata sul
contatto linguistico: il fenomeno prende luogo là dove nel Medioevo
coesistevano più realtà, e la popolazione aveva bisogno di distinguere
la propria lingua, quindi anche la propria cultura dagli altri
accentuandone i tratti distintivi. Stando alla voce inerente la Lucania,
sempre presente ne “ I dialetti d’Italia”, ciò sarebbe dovuto alla
contrapposizione di genti di lingua greca con quelle di lingua latina;
dai quali deriverebbero gli arcaismi e i tratti conservativi. Oppure
15
Varvaro, A., in Cortelazzo, M., et al., (a cura di), op. cit., p.757.
29
potremmo citare qualche parola sopravvissuta alla latinizzazione dei
longobardi.
Parlando del vocalismo senisese, e volendo entrare un po’ nello
specifico, vanno considerate le particolari condizioni metafonetiche,
che lo rendono ancora più difficile da classificare essendo oggetto di
metafonia condizionata sia da –i che da –u (seguendo quel modello di
vocalismo detto siciliano), proprio come accade nei dialetti meridionali
non estremi. Cortelazzo ci riporta alcuni esempi, rilevati proprio a
Senise: per quanto concerne la metafonia da –i abbiamo /m:s/ al
plurale /mi:s/ che deriverebbe dal protoromanzo *mēnsī e /npo:t/
che diventa /npu:t/ da *nepōtī; per quella da –u riportiamo /kji:n/
*plēnu e /su:l/ *sōlu16.
Sono da ascrivere a metafonia anche i casi di dittongazione; quando si
indeboliscono le vocali toniche esse tendono a dittongarsi nei frangenti
“-ie-“ e “-uo-“. Come ci spiega Rohlfs, il tutto avviene tramite un
processo di “armonizzazione fra la vocale della sillaba tonica , molto
aperta (// ed /o/) e la vocale i ovvero u, estremamente chiuse”.
Sempre lo stesso Rohlfs ci spiega poi come “il grado di apertura della
16
Cortelazzo, M., et al., (a cura di), op. cit., p.760.
30
sillaba che si trova sotto accento tonico viene a subire una chiusura che
giunge fino a un grado vocalico”17.
Le vocali finali sono atone, risultando indebolite nella fonetica che
percepiamo oggi; come naturale conseguenza subiscono il fenomeno
dell’ammutinamento e vengono prodotte con //.
2.3 Consonantismo
Il consonantismo del senisese può essere illustrato senza problemi
elencando i suoi tratti, di cui alcuni sono comuni ad altri dialetti del
sud. Come questi, ma come anche il toscano e quasi tutte le varietà
nazionali, è stato oggetto di alcuni casi di assimilazione regressiva, cioè
basata sulla trasformazione della consonante che precede. Ad esempio
il latino NŎCTEM diventa /no:tt/, assimilando la c come del resto
accade in quasi tutto il territorio della penisola. L’assimilazione
progressiva, al contrario, non può essere indicata con sicurezza; infatti,
solo poche parole subiscono i suoi effetti.
Un altro tratto è sicuramente la palatalizzazione: come ci spiegano
Grassi e Sobrero “quella tendenza a conguagliare, in tutto o in parte, gli
esiti dei gruppi con consonante labiale sul modello degli esiti dei
gruppi con velare”18. Espresso in parole povere, i gruppi consonantici
17
Rohlfs, G., op. cit., p.13
18 Grassi, C., e Sobrero, A., op. cit., p.113.
31
che si trasformano sono CL-, PL- > KJ- ; GL-, BL- > (L)J-. In altre
varietà dialettali viene coinvolto anche il gruppo FL-, ma non nel
nostro caso. Per rendere più chiara la spiegazione ecco alcuni esempi:
lat. CLĀVE > /’kjav/ <<chiave>>
lat. PLĀNU > /’kjan/ <<pieno>>
lat. volg. BLANCUS > /’jang(k)/ <<bianco>>
Una caratteristica che distingue Senise anche dai paesi limitrofi è il
rotacismo molto accentuato; come ci informa Devoto questa è una
caratteristica dell’umbro antico. Consiste nella trasformazione della
velare sorda d iniziale in una vibrante r. La d iniziale pertanto non
viene mai pronunciata, di conseguenza avremo i vari /ru’menk/ <<
domenica>>, /’kar/ <<cadere>>, /’ri:r/ <<ridere>> ecc.
La d invece la possiamo trovare alla fine della parola, quando va a
sostituire la approssimante laterale l geminata dando luogo ad un
fenomeno di retroflessione: /ka’vad:/ << cavallo>>, /kwod:/
<<collo>>. Le parole pronunciate con la geminazione della l che si
possono ancora trovare sono prestiti letterari.
Fa parte del consonantismo anche la fricativa velare sonora γ che si
presenta al posto dell’occlusiva velare sonora g quando essa si trova a
32
inizio parola davanti a vocali: /’γam:/ <<gamba>>, /’γont/
<<gomito>>.
Inoltre ci sono casi in cui la fricativa labiodentale sonora /v/ è
sostituita da una fricativa bilabiale sonora: /’as/ <<bacio>>,
/ar()a/ <<barba>>.
Alcuni monosillabi tendono al raddoppiamento enfatico: /’k:ju/
<<più>>.
33
2.4 Verbo
Il tratto riguardante il verbo che spicca tra tutti, è la conservazione
delle desinenze –s e –t della coniugazione latina. E’ una caratteristica
tipica del latino ed è molto raro da incontrare nelle altre aree d’Italia;
gli unici dialetti ad aver conservato questo arcaismo sono quelli della
zona Lausberg e il sardo. Riportiamo ancora un esempio proveniente
da “I dialetti italiani”19 ,la coniugazione del verbo cantare:
latino Senise
CANTO /’kad/
CANTAS /’kads/
CANTAT /‘kadt/
CANTAMUS /ka’dam/
CANTATIS /ka’dats/
CANTANT /‘kadn/
19
Cortelazzo, M., et al (a cura di), op. cit., p. 760.
34
E’ possibile riscontrare altre desinenze latine anche nel passato
remoto, anche se ormai in pochi verbi.
Come in tutto il meridione, l’utilizzo del tempo futuro non è popolare,
anzi, è praticamente inesistente. Per esprimere azioni che prenderanno
luogo o nell’immediato o comunque più in là nel tempo si ricorre o al
presente oppure al futuro analitico del tipo ‘’habeo ad cantare’’: un
futuro in cui si implica ancora un poco l’idea della necessità. Forma
peraltro simile a quelle francese, per esempio la frase /’ad: ka’da/
potremmo trasporla in italiano come <<devo cantare>> o
<<canterò>> a seconda dei casi.
Il participio passato si accorda al pronome personale accusativo che
precede; le sue desinenze sono: -ut, -st, -at e -it.
In aggiunta agli elementi latini ancora conservati vi è il
piuccheperfetto, utilizzato oggi come condizionale.
Comune ad altri dialetti della zona meridionale è anche lo spostamento
dell’accento nelle forme verbali : il caso più lampante è l’imperativo,
che si forma con un pronome personale enclitico:
/mada’ti:l/ << mangiatelo >>
/v:’ti:l/ << venditelo >
35
3. Il corpus dei dati
3.1 Il punto di vista etnolinguistico
Da tutto quello che è stato detto sin d’ora, sia dal capitolo storico che
da quello linguistico, risulta come la multiculturalità sia sempre stata
al centro delle vicende della valle del Sinni, a partire da diversi secoli
prima di Cristo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Per multiculturalità
noi intendiamo l’incontro, il confronto tra almeno due culture. Esse
hanno lasciato le loro tracce, sia a livello fisico che a livello astratto.
Hanno definito quelli che ora sono i vari usi e costumi. Riprendendo
ciò che è stato scritto nella parte introduttiva di questa tesi non sono
stati prodotti lavori di linguistica antropologica in quest’area, lavori da
poter commentare e da arricchire. Partiremo da zero cercando di fare
della chiarezza un punto di forza e di riuscire a trasmettere quello che
le parole non dicono.
Al fine di asservire al meglio lo scopo di questa trattazione e
comprendere meglio quali aspetti si vogliono cogliere partiamo dalle
sue vere e proprie basi: la lingua, nel nostro caso un dialetto, e la
cultura. Certo, non staremo a spiegare e ad esaminare tutti i vari studi,
definizioni ecc. Vogliamo solo esporre la nostra indagine e illustrare
come essa sia stata approcciata, con i principi teorici che l’hanno
mossa e ne costituiscono le fondamenta.
36
In questa ricerca i due elementi sopracitati sono inscindibili: la lingua
permette l’elaborazione del pensiero e rappresenta la lente con la quale
noi osserviamo il mondo; citando Cardona “ l’apprendimento della
lingua veicola la cultura”20, e continuando la citazione affermiamo che
essa è “ l’elemento primario nella vita di una comunità “. Ed è proprio
in virtù di questa sua inevitabile rilevanza che essa è “ fatto sociale “,
come la definì Saussure. E’ chiaro adesso come all’apprendere della
lingua avvenga al tempo stesso quel processo per il quale cominciamo
a muovere i nostri primi passi per ambientarci alla realtà esistente
intorno a noi ; essa ne è il filtro. E’ organica ed esiste in correlazione
con la vita e gli usi di chi se ne serve. Una volta definita la lingua in
questi termini scatta automaticamente il legame con la cultura: quella
della visione antropologica, cioè quel “ patrimonio sociale che
comprende regole di comportamento, criteri organizzativi, principi
ideologici che governano la collettività ecc”21. Cultura come insieme di
conoscenze condivise, come memoria comune di una società.
Una volta introdotti i concetti di lingua e cultura, è necessario
esplorare meglio anche l’ottica con il quale il dialetto va a porsi fra
questi due elementi: esso è costituito, come scrivono Grassi e Sobrero,
da due sistemi di segni: quello ‘secondario’ è costituito da segni
20
Cardona, G., Introduzione all’etnolinguistica, Novara, De Agostini Scuola SpA 2006, p. 4.
21 Cardona, G., op. cit., p. 4.
37
linguistici i quali si coordinano con il sistema ‘primario’, quello delle
“classificazioni sistematiche (tassonomie) che ogni cultura elabora”22.
Noi muoviamo dalla diversità dei segni ‘primari’ fra dialetto e lingua
ufficiale. Soprattutto in Italia questa differenza si esalta, visto che ogni
regione, ogni località rappresenta un microcosmo in sé; ognuna con le
sue unicità geografiche: monti, mari, valli ecc. Ecco, la cultura
“primaria” parte per prima cosa da un habitat che determina la vita
dell’uomo e ne plasma la conoscenza scientifica. Da qui, ogni cultura
ha un proprio linguaggio in cui si esprime. “ Il contadino che parla il
dialetto è padrone della sua realtà” scrive Pasolini; e in effetti se
proviamo ad immaginare idealmente un contadino parlare l’italiano
standard percepiamo che c’è qualcosa che non va; mantenendoci su
quest’esempio, diremo che in Italia coltivare la terra è un’azione che si
ripete da millenni, è un’attività che ha sempre avuto pochi margini di
cambiamento: come svolgerla, cosa utilizzare e cosa ricavare sono, se
escludiamo le novità tecnologiche, questioni che di non molto
discostano da quella che era l’agricoltura secoli fa; a maggior ragione
da un punto di vista linguistico. Di ciò ce ne renderemo conto più
avanti, quando sarà il momento di lavorare su esempi pratici; quando
analizzeremo e daremo interpretazione, in un certo qual modo, le voci
raccolte. Questo perché l’habitat decide come si dovrà vivere, cosa si
22
Grassi, C., e Sobrero, A., op cit., p.25
38
dovrà mangiare, come ci si dovrà spostare e così via. Tutto ciò si
manifesta con un linguaggio; ogni parola è collegata a un pensiero,
ogni parola ha una storia; se vogliamo, anche quelle inutilizzate ci
raccontano qualcosa, come dice Santoli “la popolarità delle parole non
dipende dall’origine o dalla forma ma dall’uso e dall’ambiente”23 ;
solitamente soltanto quelle che trovano applicazione nel parlato
“sopravvivono”, mentre le altre si disperdono lentamente. Nei dialetti
di oggi, questo fatto è uno dei maggiori pericoli per la sua integrità.
Con un po’ di fantasia, potremmo paragonare le parole a una valigia
che si porta dietro adesivi e toppe da diverse destinazioni; ricostruendo
la cronologia dei voli troviamo il luogo di partenza e le tappe
intermedie fino ad arrivare a noi. La nostra intenzione, qui in questa
sede, è ripercorrere questo viaggio, anche se in ambito ristretto, per
quel dialetto che viene parlato a Senise.
Nel tentativo di presentare uno sfondo culturale adatto alle
argomentazioni presenti nei prossimi paragrafi, non si può non
menzionare Carlo Levi, che con il suo “ Cristo si è fermato a Eboli ”
traccia una descrizione storico-culturale della Lucania pressoché
completa. Durante i suoi anni di confino egli è stato osservatore acuto
della vita lucana, raccontando le sue riflessioni, ciò che aveva visto,
quello che aveva sentito. Le sue testimonianze, oltre ad essere un
23
Cirese, A., Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo, Palumbo 1992, p. 15.
39
importante contributo alla letteratura, sono un ideale punto di
partenza per un’indagine etnolinguistica. Le sue parole ci trasportano
nella regione e nei suoi piccoli paesi arroccati sui colli, ci racconta
come essi facciano parte di un “mondo fuori dalla storia”. Emblematica
la storia che ci racconta riguardo a questa “seconda Italia”, così come la
definisce lui, destinata ad essere sempre dominata da un qualche
estraneo; che fosse greco, romano o borbone poco importasse. Già ai
tempi dello sbarco dei primi coloni, guidati da Enea, ci narra di uno
scontro tra due civiltà completamente diverse: “ da un lato c’era un
esercito, con armi splendenti forgiate dagli dèi; dall’altro, come le
descrive Virgilio, c’erano delle bande di contadini, a cui nessun dio
aveva dato delle armi, ma che impugnavano a propria difesa le scuri, le
falci e i coltelli del loro lavoro quotidiano”24. La sottomissione degli
abitanti nativi ai greci è stato il primo passo verso la formazione, il
mantenimento ed il rafforzamento di quello che Cirese chiama
“dislivello” culturale25. Cioè viene a crearsi un parallelo tra la cultura
vincitrice dei conquistatori e la cultura dei nativi subordinata ad essa.
Un rapporto, questo, che rimarrà costante nel tempo, fino alla
contemporaneità dove è ancora attuale la distanza tra il Mezzogiorno
ed il resto d’Italia, oggi cambia solo l’unità di misura: l’economia
24
Levi, C., Cristo si è fermato a Eboli, Torino, Einaudi 2010, p.124.
25 Cirese, A., op. cit., p. 10.
40
industriale. Storicamente cambiano solo i dominatori e le loro
credenze e conoscenze nei vari settori. Come si evince dalle parole di
Carlo Levi sopracitate uno dei primi scontri sul livello culturale è stato
quello spirituale-religioso; il politeismo ellenico contro un antico
paganesimo italico, contro un credo di superstizione. E’ proprio la fede
è un parametro fondamentale se ci si occupa di storia della lingua,
l’istruzione del popolo avveniva anche tramite testi sacri. E’ stata già
sottolineata l’influenza della romanizzazione in materia di lingua,
tramite l’insegnamento del latino, i nuovi membri dell’Impero vennero
a contatto con nozioni astratte come civiltà, stato, la religione stessa.
Per di più, a distanza di pochi secoli seguiteranno a conoscere la
religione cristiana che contribuirà in modo decisivo all’evoluzione
culturale. In ogni caso c’è sempre la sensazione che il popolo rimanga
sempre un po’ escluso dalle dinamiche e dai processi culturali, non ne
avrà mai un contatto diretto. Il popolo sarà sempre quello che dovrà
sudare e pagare quell’autorità, alle volte mai conosciuta, che chiedeva
tributi. Per sopravvivere non c’era che il lavoro, la terra. La terra è
sempre stata l’unica ricchezza di cui la popolazione abbia mai disposto.
Averne un pezzo poteva significare sopravvivenza e questa rilevanza
sarà lampante anche nell’organizzazione linguistica.
Cosa si può aggiungere a quanto già detto su Senise: va tenuta presente
la sua natura di centro abitato molto ristretto. Ne consegue che la sua
41
rete sociale è coesa, è un circolo chiuso in quanto la maggior parte
della comunicazione prende luogo all’interno del paese tra i suoi stessi
abitanti. Altri paesi, in altre regioni, sono riusciti, grazie anche a
diversi fattori (es. turismo), a cambiare la loro cerchia sociale, ad esser
casa anche di chi non fosse nativo; con il risultato però di perdere
alcuni tratti dialettali, più o meno marcati. Il turismo a Senise non ha
mai avuto modo di svilupparsi, come del resto in tutta la Lucania,
eccezion fatta per talune località. Logicamente anche questa
preclusione ha rappresentato una buona ragione per il mantenimento
di una solida tradizione dialettale. Le generazioni più giovani tendono
a imparare la parlata locale sin da piccoli e costituisce il mezzo
principale per i loro scambi. Ad ogni modo, complice la comunicazione
di massa e uno stile di vita profondamente diversi da quello dei loro
genitori o nonni, il loro vocabolario tende ad essere meno ricco e in
alcuni casi più vicino all’italiano standard.
Il dialetto senisese è sempre stato marcato dall’assenza di una propria
letteratura, o almeno, non ci sono pervenuti scritti dialettali tipici. Per
inverso constatiamo come la tradizione orale si sia fatta padrona e
custode della trasmissione della maggioranza degli elementi culturali.
Prova ne sono i numerosi detti, proverbi, filastrocche ancora oggi
dette, raccontate e conosciute da gran parte dei senisesi. Da non
dimenticare anche le storie, le fiabe popolari che, ricche di elementi
42
culturali, al giorno d’oggi sono purtroppo ricordate, la maggior parte,
solo dalle persone più anziane.
3.2 La raccolta
Le sfere di interesse poste sotto analisi sono quelle dei numeri
cardinali e del tempo, quest’ultimo inteso come misurazione dei giorni,
dei mesi e delle stagioni dell’anno. Come già detto, il corpus è stato
ricavato consultando l’A.L.Ba., frutto del lavoro dei ricercatori
dell’università di Potenza. Riguardo le parole in esso contenute, si
precisa che sono state registrate cercando la pronuncia più naturale da
parte dell’intervistato, soprattutto per la parte riguardante i numeri.
Nel caso di una scelta multipla tra più lemmi è stata sempre preferita
la forma più antica.
Sono state ottenuti, inoltre, ulteriori risultati tramite un modesto
lavoro di ricerca personale basato su interviste ad un ristretto numero
di persone. A questo proposito si dirà che il campione intervistato
rientra nell’ordine della decina di individui e comprende parlanti di
tutte e tre le fasce 20-30, 30-60, 60-90. I risultati saranno dati solo
come materiale supplementare per notare fatti interessanti o
comunque possibili e assolutamente non per formulare ipotesi o
interpretazioni addizionali.
43
Introducendo brevemente l’insieme di voci raccolte, ad una prima
analisi possiamo individuare come negli ambiti culturali considerati la
stratificazione latina manifesti la sua egemonia nel lessico e
44
nell’organizzazione all’interno della quale le parole sono raggruppate:
esse appartengono allo stesso sistema. Questa affermazione potrebbe
sembrare scontata ma, in presenza di una cultura profondamente
diversa in età preromana, questo fatto doveva essere precisato. Non
dimentichiamo che non tutte le società tendono a classificare eventi e
oggetti secondo un criterio comune al nostro; alcune non tendono a
classificare per niente. Nel nostro caso l’acculturazione subita dai
romani, attraverso la lingua latina, ha avuto una portata enorme se
pensiamo che è arrivata a regolare due campi fondamentali nella
conoscenza. Anche la calendarizzazione e la numerazione possono
essere considerati concetti scientifici, anche se non siamo abituati a
vederli come tali; sono saperi che utilizziamo tutti i giorni e non ci
poniamo la questione della loro relatività, nel senso che potrebbero
benissimo essere organizzati diversamente.
Osservando le carte linguistiche individuiamo facilmente le isole
galloitaliche della Basilicata: Potenza, Vaglio di Basilicata, Pietragalla,
Tito, Picerno, Pignola, Albano di Lucania e Trecchina; come ci informa
l’atlante linguistico, Albano di Lucania ha perso alcuni tratti della sua
galloitalicità, fatto in primo luogo da attribuire alla loro scomparsa
nelle parlate delle generazioni più giovani.
Appartenenti al gruppo delle parlate arbëreshë sono invece le aree di
San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Barile, Ginestra e
45
Maschito, facili peraltro da individuare a causa della quasi totale
divergenza dal punto di vista lessicale e morfologico.
Introducendo la nostra analisi delle carte a disposizione, la prima
verifica che andremo ad effettuare, essendo oggetto di quest’indagine,
coinvolgerà i tratti linguistici che distinguono tutt’oggi la valle del
Sinni, in particolar modo Senise. Illustreremo in maniera molto
generale gli esiti dei moderni vocalismo e consonantismo. A questo
scopo prendiamo come esempio le trascrizioni di “marzo” dove la
vocale tonica non compare come //, seguendo così tutte le altre
pronunce limitrofe, ma si differenzia o registrando una // in
compresenza con /æ/:
46
Passando al punto di vista culturale, di grande interesse è la
distribuzione delle trascrizioni inerenti a “pomeriggio”. Guardando la
carta osserviamo come la variante // sia diffusa solo nelle
47
aree della valle del Sinni, oltre alla più comune / /.
Sempre riguardo quest’ultima rilevazione, notiamo come l’alternanza
vibrante-occlusiva ad inizio di parola divida in due parti la regione: nel
settore occidentale si presenterà una vibrante, con la sola eccezione di
quelle zone prossime al confine con la Calabria, dove è possibile
rilevare questo contrasto anche in altre voci. Nel settore orientale
un’occlusiva sarà la norma. Nei prossimi paragrafi torneremo su
queste circostanze in maniera più accurata.
Se a questa aggiungiamo la carta di “ dodici “, quel che risalta di più ad
una prima occhiata è sicuramente lo sviluppo di un forte rotacismo
nell’area corrispondente a Senise. In questo caso le zone confinanti
non mostrano un esito simile, mantenendosi sempre sull’uso di una
dentale e seguendo così il consonantismo di quei territori vicini al
confine calabrese.
48
Senise è l’unica area dove è stata registrata la dittongazione di a in –je-
anche per “martedì”; in nessun altro paese della regione compare
questa pronuncia, potrebbe trattarsi di un cambiamento per analogia
con “mercoledì” e “venerdì”.
49
Sempre restando nel tema dei giorni, se andiamo a vedere la tavola di “
lunedì “ Senise ci offre un altro spunto: è uno dei pochi paesi a non
aver indebolito la posizione della seconda vocale “ u”.
Nelle trascrizioni di “ dopodomani”, “ due giorni dopo domani” e “tre
giorni dopo domani” le aree di Colobraro, Valsinni, Tursi, Rotondella,
Nova Siri e Policoro sono le uniche a presentare metatesi.
Per quanto riguarda la distribuzione di “ mattina “ potremmo tracciare
un’isoglossa per evidenziare l’alternanza delle varianti maschile-
femminile nelle diverse aree della regione. Si osserva infatti come nella
parte meridionale venga prediletta l’uso di / æ/ << la mattina
>> , nella fascia centrale la versione maschile << il mattino >>, mentre
nelle zone al confine pugliese viene utilizzata per lo più la variante
femminile.
51
3.3 Il tempo
Che cos’è il tempo? Questa è una delle domande più difficili che
potremmo mai porre a qualcuno. Forse non saremo mai in grado di
dare una definizione comprensiva di questo fenomeno, ma una
descrizione parziale possiamo sicuramente formularla. Ad esempio
possiamo ricordare Einstein, che lega il tempo allo spazio; legame che
trova conferma anche nella linguistica, in diverse locuzioni; si guardi
ad esempio gli esempi proposti da Cardona : “ diciamo infatti <<alle
7>> come << a casa >> , << in, per, tra due ore >>, come diremmo <<
in, per, tra due chilometri >> , << prima delle due, dopo le due, fino
alle due >> come diremmo << prima del semaforo, dopo il semaforo,
fino al semaforo >>”26. Come sostiene Leroi-Gourhan il tempo viene
separato dallo spazio solo in via convenzionale dalla scienza, se il
tempo esiste su un livello etnologico esso è “una semplice astrazione”27.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant, nella critica della ragion pura,
scrive che la sua “intuizione” è il principale compito del nostro
pensiero e senza questa capacità non potremmo far nulla perché
incapaci di percepire tutto il resto. La rappresentazione del tempo è un
fatto alla base di ogni società, è uno dei fondamenti attorno cui essa
ruota in quanto il calendario rivela i giorni di lavoro, le festività, i
26
Cardona, G., I sei lati del mondo, Roma; Bari, Laterza & f. i. 2001, p. 67.
27 Leroi-Gourhan, A., Gesture and speech, Cambridge, The MIT Press 1993, p.315
52
giorni sacri ecc. Noi siamo stati abituati, sin da piccoli a sentirlo, a
percepirlo in un certo modo. Eppure ci sono culture diverse dove
quest’esperienza assume un forma completamente diversa dalla
nostra. Pensiamo a tanti secoli fa, pensiamo ai popoli che occupavano i
territori della Lucania da molto prima dell’arrivo dell’impero. Sarebbe
molto interessante avere più informazioni su qual era il loro sistema
per misurare la ciclicità del tempo. Appare ovvio che il metodo da noi
oggi usato in Italia e in Europa derivi proprio dai romani, che con il
loro dominio su vaste porzioni di territorio trasmisero questa coscienza
temporale. Con la loro si allargò anche l’uso del calendario giuliano,
calendario solare avente dodici mesi che inquadrava il ciclo di 4
stagioni. Più tardi verrà poi rimpiazzato da quello gregoriano, ma la
sostanza era già stata posta. Questo modello culturale di
rappresentazione ciclica del tempo si impose così in Europa. Facendo
un passo indietro, prima di quello giuliano c’era il calendario romano,
strumento lunare che contava dieci mesi (l’originale settembre, tanto
per dirne uno, viene di là in quanto era il settimo mese dell’anno).
Continuando ancora a viaggiare indietro nel tempo scopriamo che i
romani si erano basati sul sistema greco che a loro volta avevano preso
l’ispirazione da quello babilonese. Insomma, non si è mai potuto fare a
meno di modellare questo alternarsi di giorno e notte, di stagioni e
anni; sin dall’antichità c’è questo istinto, questo impulso dell’essere
53
umano a calendarizzare la sua esistenza, a regolarla. Nella nostra
cultura europea è diventato sempre più difficile cogliere differenze
culturali tramite l’organizzazione del tempo, il sistema è unico;
Cardona28 ci porta come esempio la divisione della giornata: lo schema
è sempre quello a causa delle comuni abitudini di lavoro ma potremo
cogliere qualcosa lo stesso se ci avviciniamo ancora di più e andiamo a
cogliere quelle che sono le abitudini regionali. L’unica eccezione è
rappresentata dal nome dei giorni della settimana, che varia a seconda
della famiglia linguistica. Nelle lingue romanze per esempio, anche
questi risalgono ai romani e devono il loro nome a motivi religiosi. Lo
stesso tipo d’esempio lo potremmo applicare ai dialetti d’Italia: stessa
famiglia linguistica ma diverse abitudini, diversi modi di pensare.
Se si guarda al tempo come una linea retta ci si rende conto di come sia
possibile suddividerlo in segmenti e misurarlo. Dal nostro punto di
vista ci sono due modi possibili per rappresentare il tempo e renderlo
oggetto di misurazione: o come una linea retta o come un cerchio. Per
la prima rappresentazione, il tempo è un susseguirsi di eventi che
scorrono in una certa direzione per non tornare più indietro; da un
punto di vista linguistico diciamo “domani”, “dopo domani”, “ieri”,
“l’altro ieri”, “due giorni prima di ieri” ecc. Secondo la visione che vede
il tempo come un ripetersi continuo di momenti, che tornano sempre
28
Cardona, G., op. cit., p. 74.
54
ecco che possiamo chiamare in causa le stagioni, i giorni, le settimane e
i mesi. La collocazione di eventi lungo queste due visioni risponde a
criteri pratici, ideologici o religiosi.
La folklorizzazione del tempo delle diverse comunità lucane appare
molto chiara nei suoi adattamenti e nelle sue innovazioni, in quanto
possiamo subito distinguerne le utilità pratico-religiose. Queste utilità
portano ad un tipo di rappresentazione non cronometrica, bensì basata
su alcune costanti come il ciclo agricolo; fino a pochi anni fa questa
visione era piuttosto comune nelle comunità rurali italiane. Citando
Fabietti << in verità il senso di un tempo non quantizzato , ma carico
di significati speciali, è presente in tutte le società che hanno bisogno
di rievocare periodicamente l’atto che considerano il fondamento della
propria esistenza >>29 ; così appare molto più logica e sensata la scelta
dei nomi. Per la comunità lucana non poteva essere altrimenti visto
che essa non è mai venuta direttamente a contatto con la ricchezza
economica e che ha sempre vissuto nella e della sua essenzialità, fatta
di lavoro e preghiere. Proprio a questo proposito non esiste descrizione
migliore di quella di Carlo Levi, descrizione di un tempo a ripetersi
all’infinito: << l’altra parola che ritorna sempre nei discorsi è crai, il
cras latino, domani. Tutto quello che si aspetta, che deve arrivare, che
deve essere fatto o mutato è crai. Ma crai significa mai. Il crai
29
Fabietti, U., Elementi di antropologia culturale, Milano, Mondadori Università 2004, p.104.
55
contadino, fatto di vuota pazienza, via dalla storia e dal tempo. In
questa landa atemporale il dialetto possiede delle misure del tempo più
ricche che quelle di alcuna lingua >>30. E se leggiamo le trascrizioni dei
mesi dell’anno possiamo individuare significati molto eloquenti dietro
ai loro nomi. Significati che ancora vanno a puntare all’eterna
ripetitività del tempo. Tornando alla rappresentazione temporale che
ci danno le diverse varietà dialettali della Lucania, abbiamo detto come
il modello di base è quello romano con una visione del tempo continua,
cioè il tempo è un flusso di ore, giorni, mesi ecc.
Di seguito vedremo che tipo di calendarizzazione è possibile
riscontrare. Si può rilevare che, non essendo mai stato scritto, questo
fenomeno potrebbe aver subito diverse evoluzioni lungo i secoli,
almeno fino al dopoguerra quando le abitudini quotidiano
cominciarono a subire i primi cambiamenti, o meglio, le prime
standardizzazioni. Inoltre è chiaro che l’elaborazione popolare si sia
svolta e si svolge all’interno di un contesto collettivo.
Nella varietà dialettali considerate, e quindi anche nel senisese,è
proprio questa ripetitività ad acquistare una certa rilevanza rispetto a
tutte le altre possibili rappresentazioni: se andiamo a leggere i nomi
delle stagioni la prima cosa che salterà all’occhio sarà sicuramente il
30
Levi, C., op. cit., pp.184.
56
nome che viene attribuito all’estate, proprio la “stagione” per
eccellenza.
-cartina estate
Non fatichiamo per nulla ad individuare il motivo di questa scelta, cioè
la coincidenza del periodo più caldo dell’anno con quello più ricco per i
contadini della zona. Le coltivazioni più tradizionali infatti sono quelle
che si raccolgono in estate: i pomodori, i peperoni ed il grano su tutti. I
pomodori specialmente, sono importantissimi anche per la stagione
più fredda, in quanto dopo la raccolta una parte di essi verrà lavorata
in modo da ottenere una salsa, destinata a fare da conserva per
l’inverno.
Le rimanenti stagioni mantengono la loro forma consueta riportando
cambiamenti sul solo piano linguistico:
/l’ / << l’autunno >>
/u / << l’inverno >>
/ / << la primavera >>
Queste forme sono tutte riconosciute anche dagli individui più giovani,
eccetto per quella valida per l’estate, dove nel corso delle poche
interviste effettuate si è constatato il suo avvicinamento a quella
italiana: //.
57
Altro nome che rimanda ad un qualcosa di concreto, di fisico, è quello
di Ottobre, che anche se nella cartina compare come //
non dobbiamo pensare subito che indichi il lasso di tempo all’interno
del mese perché, nonostante l’assonanza, commetteremmo una grossa
imprecisione. Noi presumiamo che nel produrre quest’enunciato la
mente del parlante si riferisca non tanto al periodo di tempo di 31
giorni che inizia dopo settembre, quanto ad una parola che in italiano
renderemmo come “ torbido”, ossia //, e considerando il
periodo dell’anno, quest’immagine ci rimanda a quella del mosto in
fermentazione; è tempo di vendemmia, tempo di produrre il vino.
Questa lettura ci viene suggerita anche dalla trascrizioni che
osserviamo essere state rilevate a San Chirico Raparo e Laurenzana. La
nostra ipotesi è che il nome del mese “ottobre“ abbia subito una
traslazione di significato per andare ad identificarsi con quello che
viene svolto manualmente nei suoi giorni. Il vino è un bene non solo
molto diffuso in queste zone, ma anche molto importante da un punto
di vista culturale. Non manca mai sulle tavole e solitamente per berlo si
usa un apposito bicchiere di dimensioni ridotte rispetto a quelli a cui
siamo abituati per l’acqua.
58
Nei due esempi appena fatti scorgiamo l’utilità pratica del calendario
dialettale come vero e proprio strumento agricolo oltre un esempio
ideale per mostrare la forza di un processo di folklorizzazione. Essendo
59
stata l’agricoltura l’unico mezzo per la sopravvivenza ed il lavoro anche
il tempo è stato relativizzato ad essa.
L’esperienza temporale che si pone davanti analizzando le carte
linguistiche della Lucania ci offrono numerosi spunti riguardo la loro
religiosità e il loro essere in qualche modo strumento liturgico. Qui
incominciamo a vedere quali grandi cambiamenti culturali abbia
portato la cristianizzazione. Se guardiamo più attentamente la cartina
nella pagina precedente rileveremo come in alcune aree il mese di
ottobre è anche conosciuto come // a Tricarico da
San Francesco d’Assisi che si festeggia il quarto giorno del mese, come
//a Vaglio di Basilicata dal santo Gerardo la Porta, ieri
vescovo e oggi patrono di Potenza, celebrato il 30 o come /
/ << San Luca >> a Salandra, Oliveto Lucano e Grassano da San
Luca Evangelista che si festeggia il 18 oppure da San Luca di Demenna
che si festeggia il 13, con quest’ultimo che si trasferì proprio in Lucania
concludendo la sua vita ad Armento. Da questi nomi si evince
l’importanza della fede nella cultura popolare e anche una certa
differenziazione nella scelta dei santi.
A Senise ed in altri paesi il mese da associare ad un altro santo è
Novembre, popolarmente conosciuto come //
molto probabilmente da San Martino di Tours, celebrato il 18.
60
Sempre rimanendo sui mesi dell’anno andiamo a leggere come viene
espresso il mese di “ dicembre “: nella quasi totalità dei casi non
troveremo per niente il nome vero e proprio, bensì l’evento principale
che si svolge nel suo corso, cioè il Natale.
61
I nomi degli altri mesi, qui di seguito riportati, sono ancora conservati
secondo il modello latino:
/()/ << gennaio >>
/()/ << febbraio >>
/()/ << marzo >>
/ / << aprile >>
/() / << maggio >>
// << giugno >>
// << luglio >>
/ / << agosto >>
// << settembre >>
Anche nel caso dei mesi dell’anno le informazioni derivanti dalle
interviste rivelano una tendenza verso l’italiano, soprattutto per gli
esempi sopracitati: novembre non fa più riferimento a San Martino ma
può diventare semplicemente novembre con una vocale debole alla
fine,idem per dicembre a cui verrà tolta ogni menzione alla festività
natalizia.
62
Nella parte introduttiva di questo capitolo avevamo già accennato ai
alla distribuzione delle varianti per “pomeriggio”, di seguito
analizzeremo più da vicino la sua rilevanza a livello culturale: essa
appare in linea con il carattere agricolo-religioso della percezione
dialettale, notiamo come nei lemmi usati per riferirsi a questo
momento della giornata entrambe le dimensioni vengono palesate da
diverse parole:
63
Dalla cartina già vediamo come i termini in questo caso siano
molteplici, ma in questa sezione a noi interessa rilevare come esistano
sia // << l’ora bassa >> e sia // << ai
vespri >>. La seconda abbastanza chiaramente fa riferimento ai vespri
, sarebbe a dire le preghiere del tramonto che viene celebrata
64
quotidianamente in chiesa. La prima potrebbe riportare alla mente il
calare del sole, proponendo così anche una metafora con l’ora.
Gli altri momenti principali della giornata sono:
/ æ / << il mattino >>
// << mezzogiorno >>
// << sera >>
Per completare la descrizione di questo esempio va detto che in alcuni
paesi, Senise incluso, l’uso di // è posticipato sulla
linea temporale, alternandosi così nell’uso con //, ma
all’interno di un numero molto ristretto di parlanti, in quanto i più
giovani usano sempre la variante più vicina alla rappresentazione
italiana.
Ad evidenziare il carattere “arcaico” che contraddistingue il linguaggio
dialettale ci sono anche le forme per fare riferimento a giorni passati o
prossimi molto vicini:
// << oggi >>
/()/ << domani >>
/() / << dopo domani >>
65
// << due giorni dopo domani >>
// << tre giorni dopo domani >>
//<< ieri >>
/ / << l’altro ieri >>
// << due giorni prima di ieri >>
Le forme latine ancora oggi utilizzate ci raccontano piuttosto
chiaramente, tramite la loro conservazione, l’assenza di particolari
evoluzioni culturali. Altro fatto che potremmo osservare è che questi
riferimenti coprono potenzialmente un periodo maggiore della
settimana e rendono così inutili le denominazioni dei giorni, senza
contare che nella varietà senisese non sono state rilevate le forme per
indicare “ quattro giorni dopo domani “ e “ tre giorni prima di ieri “
presenti invece in alcune zone limitrofe. Ciò rispecchierebbe molto
proprio quello stile di vita essenziale che si conduceva fino a meno di
cento anni fa. Si potrebbe presumere che i vari lunedì, martedì ecc.
fossero usati solo in vie ufficiali, ma comunque queste sono solo
ipotesi. Osservando il resto della regione troviamo forme più “
moderne “ come // solo nei pressi dei confini
abruzzesi e campani.
66
Il campione intervistato evidenzia per l’ennesima volta il passaggio dal
dialetto all’italiano quando si tratta di utilizzare queste forme. In
questo caso il mutamento riguarda “ due giorni prima di ieri “ che
anche in questo caso prevede un enunciato più vicino alla lingua
standard con la forma “due giorni fa“.
I giorni della settimana si presentano completamente in linea dal
punto di vista lessicale, cambiando solo sul piano fonologico e
morfologico:
// << lunedì >>
// << martedì >>
// << mercoledì >>
// << giovedì >>
// <<venerdì >>
/()/ << sabato >>
// <<domenica >>
Da un punto di vista prettamente linguistico sono da notare alcuni
cambiamenti comuni che si verificano nella pronuncia di tutto questo
insieme di lemmi. Se guardiamo i giorni infatti ci accorgeremo come
67
venga regolarmente aggiunta alla fine la sillaba -j a quelli aventi
l’accento sulla vocale finale e come venga dittongata la vocale anteriore
medio bassa di “ mercoledì “ e “ venerdì “. Un altro fenomeno
morfologico di rilevante interesse è quello che si presenta nella
trascrizione di “ febbraio “: anche qui si presenta l’aggiunta di una
sillaba, -l- , che in questo caso però viene inserita prima della vocale
accentata. Si noterà inoltre l’aspirazione della geminata nelle pronunce
di “settembre“ e “ottobre ”.
Per dare anche uno spunto sociolinguistico è giusto menzionare alcuni
comportamenti del campione intervistato. Invero durante la
conversazione fra parlanti nell’ordine dei venti/trenta anni d’età,
quando si devono fare riferimenti temporali non è da escludere che si
verifichi un cambio di registro verso l’italiano standard solo per la
comunicazione dei giorni della settimana o dei mesi; fatto che
comunque necessita di una ricerca più ampia, con un maggior numero
di persone.
68
3.4 I numeri
Il concetto di numero è il nucleo più antico che possiamo mai trovare
all’interno di una lingua. Come asserisce Leonard Conant31, il gruppo
di parole è tra i primi a formarsi. A pensarci bene poi, l’utilizzo dei
numeri, l’atto del contare sono le cose più naturali del mondo. E’ un
processo che avviene per prima cosa all’interno della mente umana,
nell’astratto; Platone scrisse che i numeri non fanno parte del mondo
da noi percettibile, di conseguenza soltanto tramite la ragione potremo
usufruirne. In effetti se guardiamo agli stadi primitivi dell’uomo, il
concetto di numero non era ancora sviluppato così come lo conosciamo
oggi: basta provare ad immaginare qualcuno che non sappia contare,
esso si affiderebbe perlopiù al suo istinto, ad una sensazione; il numero
rimane come un’entità non definita, alla ricerca di una forma. A questo
proposito non è un caso che nelle numerazioni più elementari la base
sia cinque, in quanto il primo strumento utile in questo senso erano le
dita della mano. Verosimilmente, la stessa etimologia delle parole
usate per indicare i numeri potrebbe indicare i nostri arti, le mani, le
dita ecc. Possiamo affermare ciò anche in forza di quello che sappiamo
sulle diverse denominazioni attribuite ai numeri da altre lingue e
culture del mondo, ed anche in ragione di come alcuni processi
cognitivi avvengano allo stesso modo nella mente di qualunque
31
Conant in Squillacciotti, M., Antropologia del numero, Brescia, Grafo Edizioni 1996.
69
individuo. Il metodo dell’associazione del segno numerico astratto ad
un oggetto fisico è detto in matematica “corrispondenza biunivoca”.
Anche il sistema scritto romano si richiama a questo “trucco” dato che i
numeri rappresentano idealmente la posizione delle dita. Logicamente
nell’applicazione di questo procedimento le sole quantità ad essere
considerate sono quelle espresse da numeri interi, visto che non si era
ancora sviluppata quella capacità astratta di calcolo comune oggi nella
nostra società.
I numeri nell’immaginario comune fanno parte prima di tutto del
regno della matematica, che è una scienza principalmente teorica. Allo
stesso tempo non possiamo non notare come l’atto dell’enumerazione
sia legato indissolubilmente con la realtà concreta; è anche una
necessità fisica e pratica. Secondo Squillacciotti il numero <<nasce
come strumento e forma d’espressione del pensiero” in quanto esso va
a legarsi alla tecnica ed al linguaggio, alla concretezza e alla parola,
entrambi prodotti delle capacità umane>>32. Il linguaggio è un mezzo
fondamentale per l’espressione e la formazione del pensiero così come
l’interrelarsi dell’uomo con l’ambiente circostante tramite l’invenzione
e la realizzazione di oggetti concreti; bene, in questo sfondo poniamo il
numero sullo stesso piano della parola e del manufatto, in quanto esso
è una nozione che già ci appartiene e con cui ci dobbiamo confrontare.
32
Squillacciotti, M., op. cit., p. 35.
70
In Lucania la nozione di numero esisteva forse in maniera molto
primitiva ai tempi dei suoi primi popoli, dopodichè è indubbio che una
sterzata importante arrivò con i romani, che portarono il loro sistema
imponendolo come modello di riferimento al posto dell’eventuale
sistema nativo antecedente.
Con la caduta dell’Impero e le continue invasioni, il tutto si perdette in
quel caos di guerre, malattie ed emigrazioni. Per anni regnò
l’oscurantismo più totale, che lasciò l’aritmetica ad un livello piuttosto
basico, in quanto i numeri romani non permettevano elaborate
operazioni algebriche; di conseguenza anche tutte le altre scienze
furono pressoché inesistenti. In Lucania comunque questo fatto non
peserà molto come in altri paesi dato che la cultura veniva svolta
altrove. In Europa la ripresa dell’undicesimo secolo portò la rinascita
del commercio che fece conoscere il sistema decimale usato dagli arabi,
particolarmente malleabile e duttile per ogni tipo di calcolo
matematico. In seguito, con il rinascimento i simboli numerici
assunsero una forma grafica più vicina a quella odierna e cominciò a
svilupparsi l’aritmetica per come la conosciamo oggi.
A Senise e nelle altre comunità lucane i segni numerici erano
conosciuti con la denominazione latina e data la natura contadina della
popolazione, non si è mai presentato il bisogno di produrre documenti
scritti, anche perché la maggioranza non era alfabetizzata. Però il
71
bisogno di fare calcoli era comunque presente, nonostante il mercato
fosse molto limitato e l’economia regnante era quella di sussistenza,
bisognava essere in condizione di saper operare con i numeri. Inoltre
c’erano anche i pastori, che dovevano verificare il numero delle loro
pecore al rientro dopo il pascolo. Come facevano a verificare se erano
tornate tutte quante? Quale sistema utilizzavano? Questo non potremo
saperlo per certo, però abbiamo visto come il metodo più antico, ma
anche il più affidabile, fosse quello della corrispondenza biunivoca: i
pastori antichi usavano dei sassolini come riferimento per le pecore, se
i sassolini si esaurivano allora gli animali erano tutti, altrimenti
bisognava uscire e ritrovare quelli mancanti33. Non escludiamo
l’utilizzo di questa prassi o di una quantomeno simile in epoche
medievali o successive, ma comunque rimane probabile la capacità
autonoma di conteggio del pastore. All’incirca, gli ambiti di utilizzo dei
numeri nell’area di cui ci stiamo occupando sono questi; sono contesti
molto pratici e “primari”.
Da un punto di vista linguistico grandi cambiamenti non ce ne sono
stati, la struttura lessicale richiama quella latina mentre su un piano
fonologico abbiamo cambiamenti rilevanti nel consonantismo.
33
Zichichi, A., L’infinito, Milano, Tropea 2009.
72
Del dialetto senisese è proprio il consonantismo a stravolgere le parole,
e questo lo notiamo subito con la pronuncia del numero uno:
Osserviamo immediatamente come la fricativa velare sonora venga
regolarmente prodotta prima della vocale posteriore, tratto, questo,
che contraddistingue la pronuncia della maggior parte della regione.
73
Questo tipo di consonantismo si ripete nella pronuncia del numero
undici che diviene // e in quella di “ottanta”, il quale viene
reso come /()/. Per quanto riguarda quest’ultimo lemma
l’uso della fricativa su scala regionale è meno frequente rispetto agli
altri due. Allo stesso tempo rileviamo come nel materano l’utilizzo
della fricativa corrisponda a quello di una approssimante mentre
questa caratteristica risulta assente nella prevalenza delle aree al
confine campano. Ad ogni modo il suono -γ- si presenta solo a inizio
parola, per cui avremo /ventuno/. Per il vocalismo menzioniamo
l’abbassamento della vocale accentata di // presente nella
parte settentrionale, al confine con la Puglia e la vocale anteriore che
compare negli enunciati materani // <<uno>> e //
<<undici>>.
74
Come abbiamo già avuto modo di vedere in prima istanza, il rotacismo
del senisese ha un carattere molto forte e nell’analisi linguistica del
corpus numerico ciò viene maggiormente rafforzato. Come primo
esempio prenderemo il numero “due” che si presenta nel seguente
modo:
75
La cartina ci presenta una situazione in cui la produzione della
vibrante sarebbe un tratto non molto comune nella valle del Sinni, solo
Senise e poche altre parlate la presentano come variante principale.
Per di più si presenta ancora una volta l’analogia con il consonantismo
76
dei territori lungo il confine campano. La stessa situazione si ripete per
quasi tutti quei numeri presentano una occlusiva dentale sonora ad
inizio o seguito da vocale all’interno della parola, come //
<<dieci>> e // <<sedici>>. Diciamo quasi perché nei
numeri composti può presentarsi anche una forma del tipo
// <<ventidue>>. Anche nel caso del due il materano di
distingue in maniera molto netta presentando una variante
monosillabica come //.
Circa la pronuncia del tre, //, possiamo dire che dato il suo essere
monosillabico è una delle poche parole a non terminare con una vocale
debole. Osservazione peraltro non così scontata visto che nelle aree
limitrofe come Valsinni e Colobraro viene aggiunto un nesso
approssimante-vocale debole -j. Inoltre nella pronuncia di
// <<tredici>> notiamo come la stessa vocale rimanga
accentata e si alzi ad .
Molto ricorrente è l’aspirazione dell’occlusiva dentale sorda nei casi in
cui si presenti geminata come // <<quattro>> e //
<<sette>>; nel caso del quattro la vibrante non compare in quanto
nell’originale latino essa si trova a fine parola. Apparentemente non c’è
nessun altro paese che presenti questo tipo di aspirazione della t così
77
frequentemente come Senise, qui infatti sembra essere un fenomeno
costante e regolare, mentre laddove lo possiamo ritrovare, sembra
ricorrere di meno.
Cartina quattordici
A Moliterno, Lagonegro, Lauria e Sant’Arcangelo la pronuncia della -t-
aspirata coesiste insieme ad altre forme che non la prevedono.
Così come avevamo notato per altri enunciati, l’inserimento di una
sillaba prima di quella accentata si verifica anche per quello di
// <<diciotto>>, peculiarità, questa, condivisa da
poche altre varietà.
Per la formazione dei numeri a partire dal quaranta abbiamo il suffisso
/-()/, equivalente a quello dell’italiano -anta mentre per la
formulazione di quelli nell’ordine delle centinaia ecco il suffisso /-
/ indicante il nostro cento. Alcuni esempi :
/()/ << cinquanta >>
/()/ << settanta >>
// << duecento >>
// << trecento >>
78
Conclusioni
L’indagine ha portato alla luce diversi fatti, soprattutto quelli
concernenti lo stato di conservazione delle varietà analizzate. Lo scopo
di dare visibilità ad uno spaccato culturale lontano nel tempo così
come nella lingua ha anche portato con sé le conseguenze prodotte da
nuove abitudini e dal radicamento di un nuovo tipo di società.
Abbiamo visto come l’enunciazione di giorni, mesi e numeri possa
rivelarci un altro punto di vista, un altro modo di pensare, un’altra
visione del mondo. Vivendo ora in queste comunità, alcune parole
potranno risuonare come un guscio vuoto, altre saranno dimenticate e
altre ancora sapranno adattarsi ai cambiamenti e resistere. Dopotutto
il dialetto rappresenta un’identità forte che distingue le persone. Certo,
parlare il dialetto è anche socialmente riconosciuto come un atto quasi
negativo, da non fare in pubblico. In uno dei suoi articoli Pasolini ci
spiega come il nuovo modello di società, la cultura massificata stava
riuscendo là dove il fascismo aveva fallito, ovvero a soppiantare il
dialetto34. Questo soprattutto attraverso i nuovi mezzi di
comunicazione e l’utilizzo di tecnicismi, fenomeni peraltro ancora
attuali. Oggi potremo parlare non tanto della televisione, ma di
internet come mezzo unificatore del linguaggio, esportatore di nuove
espressioni, di innovazioni linguistiche e utilizzato unicamente nello
34
Pasolini, P., Scritti corsari, Milano, Garzanti Libri 2008
79
standard linguistico. E’ sotto gli occhi di tutti che la vita è
profondamente cambiata dal secondo dopoguerra, le possibilità si sono
moltiplicate, per esempio adesso non è più vitale possedere una
porzione di terra e coltivarsela, non è come cento anni fa. Questo è
valido per il principio che la pressione per il cambiamento linguistico
parte innanzitutto dagli usi per poi trasferirsi sulla lingua parlata.
Adesso ancora non vediamo nella lingua quelle importanti
trasformazioni avvenute nella realtà, perché le grandi evoluzioni
culturali sono solite a presentarsi con ritardo nelle strutture
linguistiche, però possiamo intravedere i primi segnali come alcuni
campi semantici caduti in disuso e dimenticati; tornando all’esempio
fatto prima il lessico contadino potrebbe essere uno dei primi a
perdere la sua ragion d’essere ed essere dimenticato. Complice di
questo processo è anche l’istruzione ovviamente, le scuole e le
università sono una forte spinta verso la lingua standard. Essa è
proprio con le istituzioni che legittima la sua egemonia su tutte le altre
varietà, il suo prestigio consolida la sua posizione. D’altra parte non va
ignorato il forte carattere tradizionale che è proprio di queste
comunità. Ci sono altri campi linguistici che per via della loro fisicità e
del loro significato sono profondamente radicati alla conoscenza
culturale di ogni generazione, parole che ancora ricoprono una
funzione importante nella vita sociale di ogni individuo.
80
Parlando a livello pratico di questa ricerca, abbiamo constatato come il
dialetto senisese, ed anche altri, abbiano ancora conservato
ottimamente vocaboli del lessico temporale e numerico, rilevando allo
stesso tempo il pericolo al quale alcuni di essi sono esposti di essere
rimpiazzati da varianti più vicini alla lingua standard. La rete sociale
chiusa garantisce senza ombra di dubbio maggiori possibilità di una
più lunga difesa del patrimonio linguistico. Circa i pericoli che gravano
pesantemente sul deterioramento dialettale riportiamo i dati presenti
nell’A.L.Ba., secondo cui in alcune zone si sarebbero sviluppate delle
“microaree di transizione” ai danni dei tratti più arcaici. Tramite i
pochi colloqui effettuati si è potuto notare come il dialetto
padroneggiato risulti più povero di lemmi al confronto con quello
parlato da persone appartenenti già alla generazione precedente.
Riguardo gli ambiti linguistici esaminati c’è da aggiungere che alcune
persone hanno confessato di esprimere taluni gruppi come mesi e
giorni della settimana in italiano, idem dicasi per i numeri.
Durante lo svolgimento di questo lavoro siamo stati testimoni
dell’evoluzione di una terra, delle sue vicissitudini storiche e politiche e
di come riesce ancora oggi a raccontare la sua storia con le sue persone
e le loro parole. Dalla nostra analisi riemergono i tratti di
quell’appartenenza, di questa parte di sud, ad un mondo arcaico e
magico pieno di storie e leggende di cui parla Carlo Levi, nonostante
81
tanti anni siano ormai trascorsi; in qualche modo possiamo sentirlo e
ci auguriamo che non possa svanire mai.
82
Bibliografia
Alessio, Saggio di toponomastica calabrese, L. S. Olschki 1939.
Antonini, Giuseppe, La Lucania: Discorsi, vol. II, Napoli, F. Tromberli
1745.
Bastanzio, Francesco, Senise nella luce della storia, Bari, Palo del Colle
1950.
Cardona, Giorgio Raimondo, Introduzione all’etnolinguistica, Novara,
De Agostini Scuola 2006.
“ I sei lati del mondo, Roma; Bari, Laterza & f. i. 2001
Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo, Palumbo
1992.
Conant, Levi Leonard: The number concept: its origin and
development, in Squillacciotti, Massimo, Antropologia del numero,
(v.), p. 48
Cortelazzo, Manlio et al., (a cura di), I dialetti italiani: storia,
struttura, uso, Torino, UTET 2002.
De Grazia, Paolo, Basilicata, Torino, Paravia 1926.
Del Puente, Patrizia, A.L.Ba.(Atlante Linguistico della Basilicata), vol.
II, Rionero in Vulture, Calice 2010.
83
Fabietti, Ugo, Elementi di antropologia culturale, Milano, Mondadori
Università 2004.
Grassi, e Sobrero, Fondamenti di dialettologia italiana, Roma; Bari,
Laterza 1997.
Leroi-Gourhan, Andrè, Gesture and Speech, Cambridge, The MIT
Press 1993.
Levi, Carlo, Cristo si è fermato a Eboli, Torino, Einaudi 2010.
Morra, Isabella, Rime, Roma, Biblioteca italiana 2004.
Parlangeli, Storia linguistica e storia politica nell’Italia meridionale,
Firenze, Le Monnier 1960.
Pasolini, Pier Paolo, Scritti Corsari, Milano, Garzanti Libri 2008.
Pellegrini, Giovan Battista, Carta dei dialetti d’Italia, Pisa, Pacini
editore 1977.
Quilici Lorenzo e Quilici Gigli Stefania, (a cura di), Carta Archeologica
della valle del Sinni, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2003.
Racioppi, Giacomo, Storia dei popoli lucani e della Basilicata, vol. II,
Roma, 1889.
Rohlfs, Gerhard, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi
dialetti, vol. I, Torino, Einaudi 1966.
84
Squillacciotti Massimo: Antropologia del numero, Brescia, Grafo
edizioni, 1996.
Varvaro, Alberto, Sulla nozione di area isolata: il caso della Lucania,
in Cortelazzo, Manlio et al, (a cura di), I dialetti italiani: storia,
struttura, uso, p.757.
Zichichi, Antonino, L’infinito, Milano, Tropea 2009.
85
Sitografia
www.basilicata.cc
www.istat.it
www.treccani.it
86
Ringraziamenti
Grazie.
Grazie alla mia famiglia.
Grazie a tutti coloro che mi sono stati sempre vicino.
Grazie agli amici conosciuti in questi anni universitari, grazie per aver
condiviso con me la vostra “avventura”, tra lezioni, interminabili
esami, pranzi al sacco e tanto altro…
Un grosso ringraziamento va anche alla professoressa Patrizia del
Puente ed ai suoi collaboratori dell’Università di Potenza per il loro
prezioso aiuto e la loro gentile disponibilità.
Grazie.