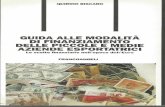Cristianizzazione e scelte politiche : il caso della Caria (Lecture)
PIO F. PISTILLI - GIOVANNI BARCO, Lavoro, economia, strutture e scelte insediative del monachesimo...
-
Upload
uniromatre -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of PIO F. PISTILLI - GIOVANNI BARCO, Lavoro, economia, strutture e scelte insediative del monachesimo...
FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDISULL’ALTO MEDIOEVO
SPOLETO
2015
TEORIA E PRATICA DEL LAVORONEL MONACHESIMO ALTOMEDIEVALE
Atti del Convegno internazionale di studio
Roma - Subiaco, 7-9 giugno 2013
a cura diLETIZIA ERMINI PANI
INDICE
MAURO MEACCI, Presentazione ........................................
Programma del Convegno internazionale ....................
ALBA MARIA ORSELLI,Del lavoro monastico - o dei monaci e illavoro? (tardoantico e alto medioevo) ...............................
GIOVANNI SPINELLI, San Benedetto d’Aniano e il lavoro mona-stico nel suo tempo ........................................................
GLAUCO MARIA CANTARELLA, Inutile et ociosum opus: illabor a Cluny .............................................................
FRANCO DEVIVO,Rappresentazioni del lavoro intellettuale neimonasteri inglesi dell’alto medioevo ................................
FRANCESCO SANTI, Cultura politica e spiritualità nel liber decultura hortorum (hortulus) di Walahfrido Strabone.Un’ipotesi di lettura .....................................................
MARIA CARLA SOMMA, …Cum ingenti toedio et labore…(Chronicon Casauriense, RIS II, 2, coll. 797-798) scrip-toria, biblioteche ed archivi nei monasteri benedettini alto-medievali ................................................................
GIUSEPPA G.ZANICHELLI,La strutturazione del lavoro all’internodello scriptorium ........................................................
FRANCESCA ROMANA STASOLLA,Celle e dipendenze per l’orga-nizzazione del lavoro monastico in area laziale .................
CHIARA CARLONI,Celle e dipendenze del monastero di Farfa inarea laziale ..................................................................
pag. VII
» IX
» X1
» 29
» 37
» 57
» 71
» 89
» 119
» 141
» 163
INDICEVI
PAOLO ROSATI,Celle e dipendenze del monastero dei S.S. Sco-lastica e Benedetto in area laziale ....................................
GIULIA MAGGIORE, Celle e dipendenze del monastero del SanSalvatore al MonteAmiata in area laziale ......................
FEDERICO MARAZZI, I luoghi della produzione artigianale neimonasteri altomedievali europei.Un excursus sulla base dellefonti scritte e archeologiche ...........................................
PAOLA GALETTI, I mulini monastici tra IX e XI secolo: tecnolo-gia e organizzazione del lavoro e della produzione .............
FABIO REDI,Da Equizio alle grance del XII secolo. I monaci be-nedettini e la pastorizia nel territorio aquilano ..................
MICHELE VOLTAGGIO, Perambulatio per monasteria.Acco-glienza monastica lungo le vie di pellegrinaggio in terrasanta ..........................................................................
LUCHINA BRANCIANI,Vere monachi sunt si labore manuumsuarum vivunt (R.S.B. , ): la Regula Sancti Bene-dicti nella narrazione delle Cronache Sublacensi tra l’altomedioevo e l’età moderna .............................................
MARIANNA CERNO,Ora, lege et labora: martiri, monaci e la-voro nell’agiografia dell’alto medioevo italiano ....................
PIO F. PISTILLI - GIOVANNI BARCO, Lavoro, economia, strutturee scelte insediative del monachesimo benedettino nella Ma-rittima medievale. Un caso di studio .........................
SONIA ANTONELLI, Impianti di produzione ceramica in ambitomonastico: alcune considerazioni ..................................
pag. 191
» 213
» 231
» 267
» 293
» 321
» 347
» 395
» 425
» 453
Cosa sia stata la Marittima nel corso del Medioevo, soprattutto inrapporto alla sua antropizzazione e allo sfruttamento del territorio,resta un capitolo storiografico ancora aperto, anche alla luce dei pio-neristici lavori di Maria Teresa Caciorgna 1. D’altronde, sin da unaprima osservazione, il lembo meridionale dello Stato della Chiesa 2
e, in precedenza, del Ducato romano,manifestava un ecosistema me-no monolitico rispetto a quanto una consolidata tradizione ha vo-luto tramandare, e non solo perché tra le dune del litorale tirrenicoe la fascia pedemontana dell’antiappennino s’incuneava un’inospi-tale, e talvolta impenetrabile, pianura palustre, con la quale – pare ora
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVEDEL MONACHESIMO BENEDETTINO
NELLA MARITTIMA MEDIEVALE. UN CASO DI STUDIO
1. M.T.CACIORGNA,Marittima medievale.Territori, società, poteri,Roma, 1996; EAD.,Assetti del territorio e confini in Marittima, in Sermoneta e i Caetani. Dinamiche politi-che, sociali e culturali di un territorio tra medioevo ed età moderna.Atti del Convegno del-la Fondazione Camillo Caetani (Roma, Sermoneta, 16-19 luglio 1993), a cura di L. FIORA-NI, Roma, 1999 (Studi e documenti d’archivio, 9), pp. 49-75; EAD., Una città di frontiera.Terracina nei secoli XI-XIV, Roma, 2008, pp. 23-68. Per un quadro storico generale si ri-manda a P.DELOGU,Territori e domini della regione pontina nel Medio Evo, in Ninfa unacittà, un giardino. Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani (Roma, Sermone-ta, Ninfa, 7-9 ottobre 1988), Roma, 1990 (Studi e documenti d’archivio, 2), pp. 17-32.2. Sulla cartografia storica della Marittima si rinvia a P. A. FRUTAZ, Le carte del Lazio,
3 voll., Roma, 1972 e, nello specifico, alla raccolta di mappe edite da D. SALVI, Coscienzadel patrimonio lepino nella cartografia di Età Moderna, in Tra memoria dell’Antico eidentità culturale.Tempi e protagonisti della scoperta dei Monti Lepini, a cura di M.CAN-CELLIERI - F. M. CIFARELLI - D. PALOMBI - S. QUILICI GIGLI, Roma, 2012, pp. 116-125 eschede 4-6 a pp. 152-154.
finalmente di capire – i Latini prima, i Romani poi, avevano con-vissuto senza particolari preoccupazioni 3.Di fatto, una netta diversificazione del paesaggio demico e pro-
duttivo era presente pure nell’entroterra abitato, accostando più re-altà e, nella fattispecie, separando per la sua naturale vocazione agri-cola il distretto a Settentrione, l’ager coranus 4, dal resto della re-gione pontina quale fosse un corpo estraneo, così come lo era statoin Antico perché appendice dell’Agro romano e quindi nel me-dioevo sino alla peste del 1763, quando le autorità di Cori – in cer-ca di soccorso presso il Buon Governo – avevano accolto con scon-certo l’estromissione della cittadina dall’area di intervento, il Lazio,toponimo che qui stava a indicare il più stretto circondario di Ro-ma 5. Ormai a ridosso della bonifica di papa Braschi venivano me-no i rapporti con l’Urbe a favore della Marittima, né era di aiuto perla propria causa l’essere feudo del Senato di Roma dal 1312 6.Dunque, è su questa modesta e fertile porzione di Marittima (Fig.
1), raccolta tra Cori e Ninfa lungo la costa occidentale dei Lepini, chesi appunterà la mia breve introduzione al lavoro di Giovanni Barco,pur condizionata da un quadro storico pressoché evanescente per isecoli altomedievali.Anzi, prima del Duecento – periodo segnato, co-m’è noto, dalla fioritura del monachesimo cistercense tramite l’ope-
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
3. G.TRAINA, L’immagine imperiale delle paludi pontine, in La valle pontina nell’an-tichità. Atti del Convegno (Cori, 13-14 aprile 1985), Roma, 1990, pp. 39-44, e inoltre M.CANCELLIERI - G.M. DE ROSSI, L’organizzazione del territorio antico, in Ninfa una città,un giardino. Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani (Roma, Sermoneta,Ninfa, 7-9 ottobre 1988), Roma, 1990, pp. 33-38.4. Sull’ager Coranus vedi ora D.PALOMBI,Cora.Bilancio storico e archeologico, in Ar-
cheologia Classica, n.s., 54 (2003), 4, pp. 233-235.5. Cori, Archivio storico comunale, PRE, Registri di lettere, reg. 6, cc. 5r/v e 20r/v.
Dell’esistenza del documento sono stato informato da E. Di Meo, che qui ringrazio per ilsuggerimento, e che lo ha reso noto nel saggio Osservazioni sulla carestia del 1763-1764.Misure adottate ed effetti demografici: il caso di Cori, in Annali del Lazio Meridionale, 8(2008), 1, p. 46.6. G. FALCO, I comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo, in ID., Stu-
di sulla storia del Lazio nel Medioevo,Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di sto-ria patria, XXIV), II, pp. 581-582; in ultimo, P.L. DE ROSSI, Cori all’epoca di Ambrogio:nuovi assetti istituzionali, in La carriera di un uomo di curia nella Roma del Quattrocen-to. Ambrogio Massari da Cori, agostiniano: cultura umanistica e committenza artistica, acura di C. FROVA - R.MICHETTI - D. PALOMBI, Roma, 2008, pp. 127-130.
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
ratività dell’abbazia diValvisciolo presso Sermoneta 7 – poco o nullasi conosce in termini sia documentari sia materiali, adeguandosi inquesta sorte alle conoscenze relative agli abitati arroccati sui Lepini,com’è proprio il caso di Cori. Questi centri avevano superato a fati-ca tanto le avversità del tardo antico,quanto le scorrerie saracene nel-l’evo carolingio, che viceversa avevano definitivamente messo a tace-re quanto era sopravvissuto del Patrimonium Appiae radicato, con isuoi santuari devozionali, lungo l’arteria consolare 8.
Fig. 1 -Territorio tra Cori, Ninfa e Cisternanella mappa del catasto Alessandrino (1660 circa).
7. C. CIAMMARUCONI, Da Marmosolio aValvisciolo. Storia di un insediamento cister-cense nella Marittima medievale (XII-XVI secolo), Pontinia, 1998.8. Per il caso della basilica consacrata a sanTeodoro da papa Sergio II (844-847) e ubi-
cata al XXX miglio della via Appia, peraltro arricchita da splendide picturis fulgentibus, siveda in particolareV. FIOCCHI NICOLAI,Monumenti paleocristiani del territorio di ForumClodi, in Antichità tardoromane e medievali nel territorio di Bracciano. Atti della Gior-nata di studio (Bracciano, 15 giugno 1991),Viterbo, 1994, pp. 246-247; ID., “Topografia” cri-
Sicché, anteriormente al Mille, l’unico appiglio cui fare riferi-mento per ricostruire – con un certo grado di attendibilità – una sto-ria economica locale resta la famosa donazione a papa Zaccaria dellemassae di Ninfa e Norba nel 743 da parte dell’imperatore bizantinoCostantinoV 9. In sostanza, entrambe le massae rappresentavano nelledistinte finalità le due vocazioni produttive del nostro territorio, datoche ne sfruttavano,Ninfa (ora a discapito di Cori 10), l’ubertosa fasciapedemontana,Norba, le strategiche risorse dell’economia d’altura, fe-nomeno che,per quanto riguarda la pastorizia,da sempre,e per via so-prattutto della transumanza, metteva in relazione il versante occiden-tale dei Lepini con l’oltregiogo, vale a dire con la valle del Sacco equindi con l’appenninica regione sublacense.Altrettanto risaputo è cheil passaggio in mano pontificia della landa ninfesina (Fig. 2), e per tra-scinamento della massa montana di Norba, si ancorava anche alla fon-dazione di due domuscultae, avvenuta per volontà dello stesso Zacca-ria: l’una sul litorale ad Antius, l’altra in località ad Formias, nell’en-troterra e ai margini meridionali dei Colli Albani 11.Se qui non entro nella discussione sulla identità giuridica o me-
no dei termini domusculta e massa poiché si tratta di una materia al-quanto spinosa e per giunta estranea alle mie strette competenze, daun siffatto quadro si evince in particolare la contiguità geograficadella domusculta di Formias – il cui sito va individuato nel conta-do tra Velletri e Cisterna 12 – con la massa di Ninfa, che invece si
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
stiana di Velitrae e territorio in età Tardoantica: una messa a punto, in Augusto aVelletri.Atti del Convegno di studio (Velletri, 16 dicembre 2000), Roma, 2001, pp. 150 e 158.9. Le Liber pontificalis.Texte, introduction et commentaire, éd. L. DUSCHESNE, II, Pa-
ris, 1955, pp. 220 e 433.10. In precedenza l’imperatore Costantino, al tempo di papa Silvestro I, aveva fatto do-
no a diverse chiese romane di numerose massae e possessiones situate in agro Corano, co-me riferisce il Liber pontificalis, éd. L. DUSCHESNE, I, Paris 1886, pp. 36, 185 e 187; inoltrePALOMBI 2003 (nota 4), p. 239, che allarga il quadro anche alle proprietà agrarie del pre-fetto urbano Q.Aurelio Simmaco.11. F.MARAZZI, Il patrimoniumAppiae: beni fondiari della Chiesa Romana nel terri-
torio suburbano della via Appia tra il IV e il IX secolo, in La via Appia. Decimo incontrodi studio del Comitato per l’archeologia laziale, a cura di S. QUILICI GIGLI, Roma, 1990(Quaderni del Centro di studio per l’archeologia etrusco-italica, 18), pp. 117-126; ID., I Pa-trimonia Sanctae Romanae Ecclesiae nel Lazio (secoli IV-X). Struttura amministrativa eprassi gestionale, Roma, 1998.12. Più precisamente tra Campomorto (l’attuale Campoverde) eTorre del Padiglione,
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
estendeva – e non solo per motivi idro-geologici – a Settentrionedella città murata medievale, laddove ancora oggi è in uso l’esplica-tivo toponimo di “Pezze di Ninfa” (ricadente per lo più nell’attua-le distretto di Cori): il che fa sospettare un rapporto funzionale trale due istituzioni, la domusculta e la massa, che andasse ben oltre ilsemplice vicinato.Di sicuro, tuttavia, l’acquisizione della regione corano-ninfesina di-
mostra da un lato le sue forti potenzialità agricole in continuità con
Fig. 2 -Veduta dell’abitato murato di Ninfa e del suo circondario agli inizi del XVIIIsecolo (Archivio di Stato di Roma, Camerale II, Paludi Pontine, b. 16, t. III, c. 517r).
come affermava O. BERTOLINI, La ricomparsa della sede episcopale di « Tres Tabernae »nella seconda metà del secoloVIII e l’istituzione delle « domuscultae », in ID., Scritti scel-ti di storia medievale, Livorno, 1968, II, pp. 695-701.
l’epoca romana e ragionevolmente in sovrapposizione per ciò checoncerne le medesime strutture produttive – come d’altronde atte-stano i ruderi di ville rustiche, talune su imponenti podi in opera po-ligonale risalenti alla fase repubblicana 13 (Fig. 3) –, dall’altro il suo
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
Fig. 3 - Contado di Cori, ruderi di una villa rustica di età repubblicanaai piedi del monte Arrestino (foto G. Barco, Roma).
permanente gravitare nell’Agro romano e dunque verso l’Urbe, qua-si a preconizzare la netta separazione amministrativa dal fronte meri-dionale dell’Agro pontino,per lo più pianeggiante, selvaggio,paludo-so e inabitabile, che – superata di poco Ninfa – dall’XI secolo ricadràquasi in toto nella diocesi di Terracina, allorché quest’ultima vennecomprendendo anche i declinanti episcopati di Sezze e Priverno 14.Chiusa tra le dolci e terrazzate pendici del monte Arrestino e il
percorso dell’Appia, che là più che altrove segnava a mo’ di righel-lo già dall’età romana il limite tra il colto e l’incolto in direzione del-
13. BRANDIZZIVITTUCCI, Cora,Roma, 1968 (Forma Italiae I,V), pp. 116-124, e in par-ticolare P.ATTEMA, An Archaelogical Survey in the Pontine Region, Groningen, 1993, pp.115-123.14. CACIORGNA 2008 (nota 1), pp. 187-188, e C. CIAMMARUCONI, Terracina, in Le
diocesi d’Italia, a cura di E. GUERRIERO - L. MEZZADRI - M.TAGLIAFERRI, III, CiniselloBalsamo, 2008, pp. 1258-1259.
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
la costa tirrenica, servita trasversalmente dalla via Pedemontana e inparallelo sul lato della marina dalla via Setina 15, solcata da depres-sioni naturali talvolta tentacolari e con terreni in leggero falsopianoche rinviavano più a valle il cronico problema del deflusso delle ac-que sorgive e meteoriche, questa subregione risultava l’eccezioneper la fertilità del suolo nel contesto della Marittima, né poteva con-dividerne il destino anche al tempo della bonifica fascista degli an-ni Trenta del secolo scorso, peraltro finalizzata a risolvere problemisociali e politici del tutto estranei al contesto locale.Attualmente divisa tra il tenimento di Cori e il comune di Ci-
sterna, che ne ha ereditato una cospicua porzione (tra cui la stessaNinfa) dalla trascorsa signoria Caetani, essa ha mantenuto quasi deltutto integro il suo ecosistema così come ha ereditato dal passato lasua frammentazione spesso in modesti poderi, piegati di volta in vol-ta alle esigenze del mercato domestico e urbano, ormai da temponon più di esclusivo appannaggio di Roma.Distese di uliveti e di vigneti, affiancati ora da moderne pianta-
gioni di kiwi, sin dal secondo Settecento al tempo della bonifica diPioVI e ancor più negli ultimi decenni ne hanno modificato alla ra-dice il paesaggio, sostituendosi via via alle coltivazioni tradizionali diortaggi, legumi, cucurbitacee e in misura minore di cereali, che untempo convivevano con una fiorente arboricoltura, dominata dallepiante da frutta, fossero ciliegio, visciole, melo o pesco 16.In definitiva, un territorio rimasto pressoché intatto nelle sue
prerogative agricole, anche perché ancora fonte di benessere, nono-stante un habitat produttivo ormai lontano da quello medievale, asua volta invece debitore dell’evo antico.Ma tornando nel merito dell’argomento, va da sé che sul finire
del IX secolo, la disintegrazione del patrimonio fondiario gestito inpresa diretta dalla Chiesa romana e il progressivo trasferimento giu-
15. Sulla rete stradale si rinvia a J. COSTE, La via Appia nel Medio Evo e l’incastella-mento, in Scritti di topografia medievale. Problemi di metodo e ricerche sul Lazio, a cu-ra di C. CARBONETTI - S. CAROCCI - S. PASSIGLI - M.VENDITTELLI, Roma, 1996 (Nuovistudi storici, 30), pp. 489-501; ID., Strade da Roma per Sermoneta, in Sermoneta e i Cae-tani, dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra Medioevo ed Età Moder-na. Atti del Convegno della Fondazione Camillo Caetani (Roma, Sermoneta, 16-19 giu-gno 1993), Roma, 1999, pp. 95-105.16. CIAMMARUCONI 1998 (nota 7), pp. 21-24.
ridico dei fundi in mano privata, ovvero a chi ad agrorum curamcontinuam deputari, non comportò il collasso dell’attività agricola.Al contrario, il sorgere per sinecismo e forse per volontà dei Fran-gipane dell’abitato murato di Ninfa in un’oasi ricca di acque sorgi-ve, ma vergine di qualsiasi emergenza romana, ne attesta indiretta-mente l’opposto. E soprattutto le potenzialità economiche manife-state dalla regione corano-ninfesina costituivano un motivo più chesufficiente per stabilire lì, a Ninfa, la sede di chi intendeva domina-re anche l’Agro pontino, prima che gli Annibaldi e poi i Caetani in-nalzassero l’incastellamento di Sermoneta a baricentro operativo del-le loro rispettive signorie sulla Marittima 17.Sarebbe quindi un luogo comune imputare al fenomeno mona-
stico nei secoli centrali del Medioevo un ruolo da protagonista nel-la gestione e rivitalizzazione economica del nostro territorio. Ciòvale non solo per il mondo benedettino entro il XII secolo – che quiin effetti non ha alcuna forma di radicamento se si eccettua, forse,l’evanescente cenobio di S. Eleuterio 18 –, ma anche per lo stessomondo cistercense 19.A dispetto di quanto avveniva per l’abbazia diFossanova, insediatasi nella diocesi di Terracina, con la fondazionedi Marmosolio – istituita nel cuore del contado ninfesino alla metàdel XII secolo – i monaci bianchi incorsero in un vero e proprio in-successo, a tal punto che al principio del Duecento furono obbliga-ti a trasferirsi aValvisciolo, ridimensionando nel tempo ogni forma
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
17. M.T. CACIORGNA, Ninfa prima dei Caetani (secc. XII e XIII), in Ninfa una città,un giardino. Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani (Roma, Sermoneta,Ninfa, 7-9 ottobre 1988), Roma, 1990, pp. 39-63;A. CORTONESI, Ninfa e i Caetani: affer-mazione della signoria e assetto del territorio (secoli XIII-XIV), in Ninfa una città, ungiardino. Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani (Roma, Sermoneta, Nin-fa, 7-9 ottobre 1988), Roma, 1990, pp. 65-96.18. R. GRÉGOIRE, Presenze religiose e monastiche a Ninfa, in Ninfa una città, un
giardino. Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani (Roma, Sermoneta,Ninfa,7-9 ottobre 1988),Roma, 1990, pp. 153-166, e soprattutto C.CIAMMARUCONI, Insediamentimonastici e identità culturale: il caso della Marittima medievale, che qui ringrazio peravermi sottoposto il testo in corso di pubblicazione.19. Per un quadro complessivo, oltre a CIAMMARUCONI (nota 7), vedi Il monache-
simo cistercense nella Marittima medievale. Storia e arte.Atti del convegno (Abbazie di Fos-sanova eValvisciolo, 24-25 settembre 1999), Casamari, 2002, e di nuovo C.CIAMMARUCONI,Nuovi contributi alla «riscoperta» di Fossanova, in Rivista cistercense, 20 (2003), pp. 50-52.
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
diretta di controllo sull’area che li aveva inizialmente ospitati 20; ealtrettanto periferica fu in quegli stessi anni la presenza dell’insedia-mento florense del Mirteto, seppure sostenuto da Gregorio IX an-cor prima di salire sul soglio pontificio 21.In sostanza, qualsiasi compagine cenobitica fu il più possibile mar-
ginalizzata e costretta a rivolgere altrove le proprie mire espansionisti-che, che come vedremo si orienteranno in special modo alla coloniz-zazione del versante montano dei Lepini, laddove era stata centrale inetà altomedievale la massa di Norba.Sicché il rinvenimento casuale diuna struttura produttiva duecentesca in opera saracinesca (Fig. 4), si-
Fig. 4 - Contado di Ninfa verso Cori, grangia duecentescain opera saracinesca (foto G. Barco, Roma).
ta lungo la via Pedemontana nell’immediato circondario di Ninfa,obbliga a riflettere se esistesse in loco un’architettura rurale di altramatrice rispetto alla categoria delle grange monastiche e per il XIII
20. Su questo punto si rinvia agli atti dibattimentali del 1393 che contrapponevanol’abbazia sermonetana ai popolani di Cori sopra i diritti di proprietà da loro accampatisulle tenute di San Eleuterio e di San Romano (CIAMMARUCONI 1998 (nota 7), pp. 28-29).21. M. CASSONI, La badia ninfana di S.Angelo o del Monte Mirteto neiVolsci fonda-
ta da Gregorio IX,Roma, 1924 [estratto da Rivista storica benedettina 14 (1923), pp. 170-
secolo ai modelli edilizi cistercensi, che per tradizione sono i para-metri di lettura in ogni dissertazione sulla Marittima medievale.Dunque, in attesa di una risposta convincente, bisogna spostare
l’attenzione al contesto montano per inquadrare l’attività di sfrutta-mento del territorio da parte degli ordini monastici. In questa dire-zione si muovono anche gli insediamenti disposti alle pendici deiLepini, comeValvisciolo e il Mirteto, i quali nel corso del Duecen-to finiranno per sostituirsi alla più antica realtà benedettina, da iden-tificare qui nell’abbazia della Trinità nella montagna di Cori, la cuiesistenza è certificata soltanto dal 1114 22.Ma questa è un’altra storia che lascio a chi l’ha studiata con fati-
ca e abnegazione il compito di illustrare.
PIO FRANCESCO PISTILLI
LA TRINITÀ DI CORI, LAVORO ED ECONOMIA
DI UN INSEDIAMENTO MONTANO
Lo studio degli insediamenti monastici sui monti Lepini soffredi una notevole sfortuna editoriale 23, causa la generale difficoltà diricognire territori piuttosto impervi e il ridotto panorama delle fon-ti documentarie, pressoché nullo per quanto riguarda i secoli del-l’alto Medioevo 24. Di fatto i dati relativi allaTrinità di Cori sono il
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
189 e 252-263; 15 (1924) pp. 51-77], eV. DE FRAJA, L’Ordine florense dai Normanni agliSvevi (1190-1266), in Atlante delle fondazioni florensi. Schede - Iconografia - Storia. I, acura di P. LOPETRONE, Soveria Mannelli, 2006, pp. 268-269.22. Per il caso cistercense, fu Fossanova piuttosto cheValvisciolo a farsi carico dell’azio-
ne di radicamento nel territorio montano con la filiazione diValvisciolo carpinetano, abba-zia istituita nel 1247 e localizzata sul versante marittimo dei Lepini, a breve distanza da Nor-ma (CIAMMARUCONI 1998 (nota 7), pp. 75-81). Sulle vicende del Mirteto in relazione all’ac-quisizione della badia corese dellaTrinità, si rimanda al contributo di Giovanni Barco.23. Resta comunque piuttosto consistente la produzione di studi locali, con una certa at-
tenzione anche ai secoli del medioevo. In questa direzione vanno gli studi promossi dall’ Isti-tuto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, in particolare si veda: Insediamenti medioevalisui Lepini Orientali e centrali, a cura di G.GIAMMARIA,Anagni,2008 (Biblioteca di Latium,20).24. Per un veloce sunto che centra geograficamente l’area di nostro interesse si rinvia
a GRÉGOIRE 1990 (nota 18), pp.153-166.
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
prodotto di sopralluoghi e rilievi che per ora non permettono diesprimere il massimo del potenziale archeologico del sito,ma auto-rizzano a formulare, forse pioneristicamente, ipotesi relative a talu-ne dinamiche della vita della fondazione benedettina.Ritengo importante partire da uno sguardo al contesto oro-geo-
grafico, essenziale per comprendere che tipo di attività lavorative le-gavano il cenobio al luogo che l’ospitava. I ruderi dellaTrinità sonolocalizzati a 800 m slm in un’area distante in linea d’aria circa 3,5 kmdalla cittadina di Cori, in quel settore noto come la “Montagna (oMacchia) di Cori”. Il toponimo Abbadia fissa nel territorio la me-moria (Fig. 5), mentre tutta una serie di riscontri raccolti in alcuni
Fig. 5 - Mappa IGM del territorio di Cori, percorsi montani.
studi sulla regione montana e pedemontana dei Lepini occidentali,consente di affermare con buona sicurezza che ci si trovi di frontead un sito di lunga-lunghissima frequentazione (Figg. 6-7) 25.
25. Ci si riferisce ai risultati del “Pontine Region Proget” dell’Università di Groningen,recentemente pubblicati inT.C.A. DE HAAS, Fields, farms and colonists. Intensive field sur-vey and early Roman colonization in the Pontine region, central Italy, Groningen, 2011.Spetta a Xavier Lafon la formulazione di una tipologia di complesso residenziale-produtti-vo in base alle caratteristiche più o meno costanti nei casi studiati, si veda X.LAFON,Villa Ma-rittima. Recherches sur les villas littoralesde l’Italie Romaine (IIIe siècle av. J.-C. / IIIe siè-cle ap. J.-C.), Roma, 2001 (Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, 307).
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
Fig. 6 - Platform Sites sulle pendici dei Lepini tra Cora e Norba (da De Haas 2011).
Fig. 7 - Insediamento-tipo lepino a scopo residenziale e produttivo (da Lafon 2001).
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
É ancora difficile stabilire con certezza quale tipo di realtà mo-nastica s’insediò sul pianoro in località Abbadia, ma la dedica allaTrinità e alcune dinamiche comuni ad altri centri monastici dei Le-pini portano ad ipotizzare che ci fosse stata una prima iniziativa dicarattere eremitico, poi affiancata o sostituita da una comunità ce-nobitica (Figg. 8-9). Questa era già operativa nel 1114, quando Pa-
Fig. 8 - Cori, Badia della Trinità, pianta generale delle strutture superstiti (dis. G. Barco).
Fig. 9 - Cori, Badia della Trinità, sezioni A-A1 e B-B1 della pianta generale (dis. G. Barco).
squale II pose sull’abbatiam sanctae trinitatis de Cora la protezionepapale 26. L’importante terminus ante quem fornito dall’atto ponti-ficio, se correlato ai reperti materiali di superficie e alla lettura de-gli alzati, rafforza l’idea della presenza di un insediamento monasti-co, forse già a partire dal Mille 27 (Fig. 10).
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
Un primo passo che si è inteso compiere per determinare la vi-ta lavorativa di questo piccolo cenobio, è stato quello di risalire al-l’entità del territorio di sua diretta competenza. Non si dispone,purtroppo, di carte relative alle fasi più antiche e le notizie utili ri-salgono ai passaggi di proprietà del monastero nelle mani dei florensi
26. La notizia è tramandata in Regesta Pontificum Romanorum, Italia pontificia, II,Latium, a cura di P.F. KEHR, Berlin, 1907, p. 108.27. È da ridimensionare, in assenza di riscontri, l’ipotesi circa la vicinanza della Trini-
tà ai Benedettini di Montecassino.
Fig. 10 - Cori, Badia dellaTrinità, lettura cronologica delle strutture murarie (dis. G. Barco).
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
di S.Maria in Monte Mirteto prima (tardo XIII secolo) 28, e dei be-nedettini di Subiaco poi (XV secolo) 29.Per provare ad avere la percezione di quale fosse la consistenza del
patrimonio fondiario dellaTrinità, ci si è avvalsi dei documenti pub-blicati a più riprese da Gioacchino Giammaria, conservati nell’ar-chivio sublacense di Santa Scolastica, che coprono un arco crono-logico che va dal XV al XVIII secolo 30. Se il supporto ottocente-sco del Catasto Gregoriano traduce graficamente (Fig. 11) l’entitàdelle particelle dove insistono le strutture e le proprietà monastiche,la lettura dei documenti di età moderna comunica invece ulterioriinformazioni: vuoi la problematica amministrazione della selva diCori (un settore era di proprietà del monastero), vuoi le mire espan-sionistiche del Comune sui territori un tempo della SS. Trinità, par-te di essi sul Colle Nino, parte in località la Badia e San Leonardo 31.
28. Le Registres de Nicolas IV, ed. E. LANGLOIS, Paris, 1890, n. 3538. Il monastero eragià stato oggetto di lasciti testamentari: si vedano anche i documenti editi in ChroniconSacri Monasterii Sublaci (anno 1573) di Guglielmo Capisacchi da Narni, a cura di L.BRAN-CIANI (di seguito citato Chronicon), Subiaco, 2005, p. 535 (f. 74 r); pp. 935-937 (f. 145 r.).La storia di S. Maria del Monte Mirteto e la successione delle acquisizioni sono state ri-costruite già da CASSONI 1923 (nota 21) pp. 170-189; pp. 252-263 e ID. 1924 (nota 21) pp.51-77; più di recente in G. GIAMMARIA, Le proprietà sublacensi in Marittima: un inventa-rio della metà del secolo XVI riguardante S.Angelo di Ninfa, in Scritti in onore di Filip-po Caraffa, a cura di G. GIAMMARIA,Anagni, 1986, pp. 339-354; inoltre F. CARAFFA, I mo-nasteri florensi del Lazio meridionale, in Storia e messaggio in Gioacchino da Fiore. Attidel I Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti, S. Giovanni in Fiore, 1980, pp. 451-471. Per il contesto delle presenze monastiche del territorio di Ninfa, si veda M. L. DESANCTIS, Insediamenti monastici nella regione di Ninfa, in Ninfa una città, un giardino.Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani (Roma, Sermoneta, Ninfa, 7-9 ot-tobre 1988), Roma, 1990, pp. 262-266.29. Con una bolla di Eugenio IV era sancito il passaggio di proprietà dalle mani flo-
rensi al patrimonio sublacense. Per la bolla conservata nell’Archivio di S. Scolastica, arcaXXXVI, n. 24, si veda G. GIAMMARIA, Le proprietà dei benedettini sublacensi in Cori I,in Latium, IV (1987), p. 39.30. GIAMMARIA 1987 (nota 29), pp. 37-101; ID., Le proprietà dei benedettini sublacen-
si in Cori II, in Latium,VII (1990), pp. 85-175.31. GIAMMARIA 1990 (nota 30), in part. pp. 85-95. Già all’inizio del Quattrocento, in
un sintetico inventario del Comune, non compare nessuna particella del patrimonio mo-nastico: Il Catastum bonorum di Cori (1668-1696) con un inventario dei beni comunali(1401), a cura di P.L. DE ROSSI - E. DI MEO, Cori, 2009, pp. 197-200. Per quanto riguar-da la località San Leonardo, il toponimo è dato dalla presenza di una piccola chiesa rurale
In sostanza il demanio monastico risultava essere poco frazionatoancora nel Settecento e la gestione di querceti, noceti e castagneti an-cora in mano ai benedettini.Tra il XV e XVI secolo si produssero al-cuni inventari che permettono di focalizzare la rilevanza del patri-monio e di isolare i terreni che furono della Trinità: nello specifico,da un inventario stilato da Guglielmo Capisacchi intorno al 1530 32,si ottengono delle descrizioni sulla destinazione d’uso delle particel-le e si evince che, nel tenimento di Cori, Subiaco possedesse 21 ap-
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
nei pressi della strada che saliva all’abbazia della Trinità. Questa, in stato di rudere, ricordale forme di altre chiese lepine, mononavate, del tardo XIII secolo. Si veda N. BERNAC-CHIO, Camille Enlart 1862-1927, in Tra memoria dell’antico e identità culturale. Tempi eprotagonisti della scoperta dei monti Lepini, a cura di M. CANCELLIERI, F. M. CIFARELLI,D. PALOMBI, S. QUILICI GIGLI, Roma, 2012, pp. 233-236; E. PARZIALE, L’abbazia cistercen-se di Fossanova: le dipendenze in Marittima e l’influenza sulla produzione artistica localetra XII e XIV secolo, Roma, 2007, pp. 107-108.32. G. GIAMMARIA, L’inventario di Guglielmo Capisacchi delle proprietà sublacensi
in Marittima, in Latium, III (1986), pp. 199-212.
Fig. 11 - Catasto Gregoriano, Fontana del Prato, Sezione II di Cori,in bianco le particelle corrispondenti al patrimonio dellaTrinità.
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
pezzamenti di terreno e 4 case. Ai fini del discorso va portata l’at-tenzione sulle notizie relative ai fondi localizzati circum moenia dic-te abbadie vulgo dictaTrinità; sulla proprietà della sylvam et castanetaet querqueta e in loco dicto Sancto Leonardo di un altro terreno aseminativo. Di tutte le proprietà corane che confluiscono nel patri-monio di Subiaco, all’incirca 21 rubbia, 14 sono concentrati intornoalla Trinità, il resto è spartito in 18 appezzamenti di modesta entità,ciascuno pari a meno di mezzo rubbio. Si è potuto notare come lasuddivisione catastale del territorio attiguo al sito monastico gene-ralmente rispetti ancora i beni che nel Quattrocento furono inven-tariati per volere dei monaci sublacensi.Non si conoscono carte che facciano pensare ad una frammen-
tazione del patrimonio dellaTrinità già durante il Medioevo, anzi daidocumentati passaggi prima all’Ordine florense, poi ai Benedettinidi Subiaco sembra che si tratti di una proprietà unitaria e ben defi-nita. Pertanto la Trinità possedeva terreni concentrati nel suo stret-to circondario, caratterizzati da una vegetazione mista e, soprattut-to, alcuni campi coltivabili. Inoltre deteneva la proprietà della selvadi Cori, in una percentuale che solo nelle fonti di metà XV secoloè specificata di un dodicesimo del totale.Bisogna immaginare un insediamento fortemente vincolato alla
montagna e al bosco circostante, la cui disponibilità di orti nelle piùimmediate vicinanze assicurasse l’approvvigionamento di verdure elegumi. Credo quindi che la motivazione che giustifichi le reitera-te iniziative di occupazione del sito, anche in epoche anteriori alMedioevo, risiedano proprio nelle potenzialità economiche e lavo-rative legate all’habitat montano e alla possibilità di ottenere gene-ri ortofrutticoli nei pressi dell’insediamento.Alcuni materiali di superficie, rinvenuti durante il rilevamento
delle strutture abbaziali, costituiscono l’occasione per ritornare sualcuni punti che ritengo piuttosto interessanti. Nell’area N, in unazona esterna a quella che è da interpretare come recinzione mona-stica, è stata rinvenuta una macina in calcare compatto locale (Fig.12), di circa 1,20 m di diametro e 30 cm di larghezza 33.Un altro ri-
33. La macina è con buona probabilità da accostare ad un impianto di produzione olea-ria o per la macinazione, sfruttando la trazione animale, per cui non è possibile proporre
trovamento, tale da fornire un ulteriore spunto di approfondimen-to, è quello di un ciottolo, inciso (Fig. 13), da interpretare probabil-mente come pondus da bilancia 34. La presenza di una macina a que-sta altitudine inserisce tra le attività del monastero anche la macina-zione: in base alla disponibilità locale va ipotizzato che servisse perprodurre farina di castagne o di ceci oppure per la produzione diolio di noci, fonte di ricchezza offerta dalla selva locale.
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
una datazione. In generale A. CORTONESI, L’olivo nell’Italia medievale, in Reti Medievali- Rivista,VI (2005), 2, pp. 1-30 e G. PASQUALI, Tecniche e impianti di lavorazione dell’olioe del vino, in Olio e vino nell’alto medioevo. Settimane di studio CISAM, LIV (Spoleto,20-26 aprile 2006), Spoleto, 2007, pp. 405-446.34. Si tratta di un ciottolo di ca. 4 cm, che presenta una piccola incisione rettilinea vi-
stosamente intenzionale. Per un caso simile, e per la serie di ragionamenti che ruotano at-torno ad un reperto di tale natura, si rimanda a L.QUILICI,Ricerche e scavi nel castello diGerione, in Spazi, forme e infrastrutture dell’abitare, a cura di L.QUILICI - S. QUILICI GI-GLI, Roma, 2008, pp. 193-194.
Fig. 12 - Cori, Badia della Trinità, macina in calcare.
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
L’ampio ventaglio di utilizzi che offrivano le noci, spinge il di-scorso in direzione di un uso (anche qui non esclusivo) del frutto inrelazione alle proprietà benefiche e curative ben note alla tradizionalemedicina classica confluita nella cultura monastica benedettina 35.Non voglio andare troppo oltre il dato materiale, ma ammetto chenon sarebbe totalmente peregrino immaginare monaci addetti allaselezione delle noci e alla loro macinazione, e quindi alla produzio-ne del prezioso olio. A tale proposito va riportato un indizio del-l’importanza di questa pianta come risorsa economica, anche semolto più tarda: in un catasto dei beni sublacensi a Cori, risalente al
35. Anche per la proposta alimentare elaborata dal monachesimo benedettino, Massi-mo Montanari ha messo ben in risalto la continuità di alcuni elementi culturali e coltura-li propri della tradizione romana. Si veda M. MONTANARI, Cereali e legumi, in Uomo eambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle ottave giornate normanno-sveve.(Bari, 20-23 ottobre 1987), a cura di G.MUSCA. Bari, 1989, pp. 89-110.
Fig. 13 - Cori, Badia della Trinità, pondus (?).
1709, per alcune particelle, dopo una sommaria descrizione, è ri-portato il numero degli alberi di noce 36.Sia la possibilità di conservazione prolungata, sia le potenzialità
insite nei molteplici impieghi del frutto del noce, cui potremmo ag-giungere per completezza nocciole e castagne, ha spinto BrunoAn-dreolli a dichiarare che l’importanza di questa categoria di prodotti,nell’Italia altomedievale, dovette essere tale da caratterizzare forte-mente i siti monastici particolarmente votati al loro sfruttamento 37.La relazione bosco-monastero implicava necessariamente una se-
rie di regolari attività lavorative, tra cui lo sfruttamento del legname,ma anche mansioni in direzione di una tutela delle potenzialità pro-duttive delle selve e delle aree arbustive 38. Trovo molto calzanti al-cuni spunti legati alla metrologia altomedievale in relazione a terre-ni boschivi che, attingendo ancora da Andreolli, sono legati ad unconcetto di produttività e di tutela: l’estensione di un bosco potevaessere calcolata in base a quanti porci poteva mantenere (Fig. 14),così come si adatta al nostro caso ciò che Massimo Montanari misein rilievo nella sua lezione spoletina sulla foresta come spazio eco-nomico, e cioè come i poderi ritagliati nelle selve e le selve conser-vate tra i campi siano il risultato di un’oculata strategia 39.Se, in base ai precetti della Regola, ai monaci era sconsigliato re-
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
36. GIAMMARIA 1990 (nota 30) pp. 114-115.37. B.ANDREOLLI, Il ruolo dell’orticoltura e della frutticoltura nelle campagne dell’al-
to Medioevo, in L’ambiente vegetale nell’alto Medioevo. Settimana di studio CISAM,XXXVII (30 marzo-5 aprile 1989), Spoleto, 1990, in part. p. 201 e bibliografia. Negli stes-si atti, M.MONTANARI, La foresta come spazio economico e culturale, pp. 301 e ss.38. Questo aspetto emerge piuttosto chiaramente nelle fonti documentarie di ambito
regio e imperiale, per cui si veda A.A. SETTIA, Boschi e controllo del territorio nel me-dioevo. Atti della giornata di studi (La Mandria,Venaria, Borgo Castello, 20 ottobre 2007),a cura di G.CHIARLE,Nichelino, 2008, pp. 11-20; per quanto riguarda specificatamente losfruttamento del legno, si rimanda a P.CORRAO,Boschi e Legno, in Uomo e ambiente nelMezzogiorno normanno-svevo.Atti delle ottave giornate normanno-sveve. (Bari, 20-23 ot-tobre 1987), a cura di G.MUSCA. Bari, 1989 pp. 135-164.39. B.ANDREOLLI, Misurare la terra. Metrologie altomedievali, in Uomo e spazio nel-
l’alto medioevo. Settimane di studio CISAM,L (4-8 aprile 2002), Spoleto, 2003, pp. 151-188;MONTANARI 1990 (nota 37), in part. p. 306 e nota 16. Su questo “equilibrio” tra attivitàagricole e silvo-pastorali, si veda anche C.WHICKAM, European forest in the early MiddleAge: landscape and land clearanche, in L’ambiente vegetale nell’alto Medioevo. Settimanedi studio CISAM,XXXVII (30 marzo-5 aprile 1989), Spoleto, 1990, pp. 479-545.
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
stare per molto tempo fuori dalle mura claustrali 40, si sarebbe dovutoesaurire il “lavoro di tutela” nei confronti della selva con un con-trollo e un’amministrazione indirette di essa, attraverso una regola-mentazione che veniva osservata dai coloni o da chiunque avesseinteragito con il bosco di proprietà monastica.Una serie di compiti che dovevano impegnare direttamente o
indirettamente i monaci erano quelli legati alle tradizionali attivitàstagionali connesse all’allevamento e alla transumanza. Questi spa-ziavano dalla gestione dei ridotti pascoli d’altura, utili alle soste del-le greggi transumanti, alla produzione di lana e formaggio, agliscambi con altri beni provenienti dalle zone pedemontane; ma an-
Fig. 14 - Maestro Ermengaut, Novembre, raccolta delle ghiande, f. 59v(Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial).
40. Regula S. Benedicti L-LII.
che in relazione ai contatti commerciali, si vuole qui marcare la stret-ta relazione del cenobio con l’ambiente montano: la vicinanza aicampi di Montelanico e di Segni, crocevia da tempi antichissimi ditracciati a lunga percorrenza tra gli Appennini interni e la pianurapontina 41 (Fig. 15), rende più che plausibile una naturale proiezio-
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
Fig. 15 -Vie di comunicazione e centri demici medievali nel territorio di Montelanico.
41. Uno di questi tracciati è stato ricostruito in E. DE MINICIS, Il Monastero diVilla-magna e il suo territorio nell’alto medioevo, in Bollettino dell’Istituto di Storia e di Artedel Lazio Meridionale, XI (1979-1982), pp. 59-75.
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
ne dell’insediamento verso le realtà che si confrontavano in queimercati di bestiame e di prodotti silvo-pastorali 42 (Fig. 16).
Non sembrerebbe affatto fuori luogo l’interpretazione data delciottolo inciso come pondus da bilancia se accostata alle attività discambio.Certo resta problematica l’affidabilità cronologica di un re-perto tale per cui i pochi confronti denunciano una datazione mol-to alta, ma nulla vieta un suo riutilizzo o una sua realizzazione inepoche più recenti.Materialmente eseguito dai monaci invece poteva essere il lavo-
ro sui terreni arabili nei pressi del monastero.Credo che quello chedoveva essere lo spazio dedicato alla coltivazione dei prodotti or-tofrutticoli si localizzasse a N-O del sito, dove si estende un’areapianeggiante, ben delineata da confini naturali e da ripidi salti diquota.
Fig. 16 - Percorso degli armenti transumanti.
42. G.M.DE ROSSI, I Monti Lepini interni: note storico topografiche, in Bollettino del-l’Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, XI (1979-1982), pp. 19-26.
La salvaguardia del terreno arativo dalla naturale espansione dispecie infestanti come rovi o edere era una delle attività svolte re-golarmente dai monaci soprattutto in tarda primavera o nei mesi dimassimo rigoglio. L’attività della runcatio (Fig. 17) ben nota nelle
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
fonti altomedievali e medievali, acquisiva un valore notevole cheben si avvicina nel caso della Trinità a ciò che più volte è stato ri-chiamato in letteratura come la conquista dell’incolto: mi riferiscoa quello che poteva essere il primo insediamento monastico sul pia-noro dell’Abbadia e quindi l’importanza della “riconquista” deglispazi atti alla produzione agricola necessaria alla sussistenza dellacomunità 43.Viene da interrogarsi, inoltre, se l’estrema vicinanza dello spazio
coltivabile alle strutture cenobitiche debba evocare l’esistenza di unvero e proprio orto monastico. In tal caso è utile richiamare il ruo-lo formativo e didattico dell’ortus conclusus proprio del monaste-
Fig. 17 - Novalesa, cappella di Sant’Eldrado, Sant’Eldrado contadinonell’attività della runcatio (fine XI sec.).
43. M. BARUZZI - M.MONTANARI, Silva runcare. Storie di cose, di parole, di immagi-ni, in Il bosco nel medioevo, a cura di B.ANDREOLLI - M. MONTANARI, Bologna, 1988,pp. 125-138.
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
Fig. 18 - St. Gallen, Stiftsbibliothek, cod. Sang. 1092, pianta di San Gallo,particolare dell’orto monastico.
rebbe dalla realtà fortemente silvestre dell’insediamento benedetti-no qui interessato.Credo che si possa intravedere, nel tardo XIII secolo, la crisi di
un sistema montano cui la Trinità di Cori non fu affatto estranea.Questa crisi generalizzata, dovuta a fattori noti e ancora in parte dachiarire, va probabilmente collegata anche allo sfruttamento inten-sivo del territorio boschivo che portò di conseguenza all’esauri-mento delle risorse, e quindi alla fine di una stagione che aveva trat-to dal lavoro degli insediamenti montani fonte per il proprio so-stentamento44. Voglio portare all’attenzione un caso che ritengo
44. In realtà l’argomento meriterebbe una ben più ampia trattazione, per cui cfr. ingenerale G. CHERUBINI, Il bosco in Italia tra XIII e XVI secolo, in L’uomo e la foresta.Secc. XIII-XVIII. Atti della XXVII settimana di studi dell’Istituto internazionale di sto-ria economica F. Datini (8-13 maggio 1995), a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze, 1996, pp.
ro ideale, come insegna per l’evo carolingio la pianta di San Gallo(Fig. 18), ma si tratta – a mio avviso – di una via che ci allontane-
molto utile per comprendere alcuni processi legati sia alla Trinitàche ad altre realtà monastiche dei Lepini: il 2 agosto 1246 è rifon-dato il monastero di S. Stefano diValvisciolo, comunemente chia-matoValvisciolo carpinetano 45. Il documento che testimonia l’even-to è molto esplicito nel motivare le ragioni di tale riforma: si fa ri-ferimento a ventisette monaci il cui compito sarebbe stato quello diattendere esclusivamente alla preghiera, alla lettura e allo studio,mentre la gestione delle rendite e delle prime necessità della comu-nità dovevano essere demandate ad un procuratore. Compito del-l’abate era di officiare perpetuo et eam non destituere come aveva-no fatto i precedenti monaci di Vallecupa che governavano la co-munità. Di fatto, l’ambizioso progetto non ebbe fortuna 46, anzi, nondecollò affatto (“un’imprudenza” stigmatizzò Filippo Caraffa).L’indizio, forse negativo, di una precedente gestione della comu-
nità, oltre ad offrire spunti per una ricerca archeologica atta a chia-rirne la cronologia, pone in risalto – anche qui – la qualità del la-voro svolto dalla comunità. In sintesi, nel caso diValvisciolo carpi-netano è evidente che l’intento era di evitare ogni attività manualeda parte dei monaci, ma la motivazione di tale ordine programma-tico da dove traeva origine? Un cambiamento di regola o anche quila crisi dell’economia montana spostava gli interessi economici piùa valle?La domanda rimane senza risposta, ma l’indipendenza econo-
mica e la possibilità di lavorare per il proprio sostentamento resta-no fattori di vitale importanza almeno per quanto inizia ad emer-gere in relazione agli insediamenti monastici ancorati al contesto le-
PIO FRANCESCO PISTILLI - GIOVANNI BARCO
357 e ss.; A. CORTONESI, La silva contesa. Uomini e boschi nel Lazio del Duecento, in Ilbosco nel medioevo, a cura di B.ANDREOLLI - M.MONTANARI,Bologna, 1988, pp. 303-320.45. Il documento è pubblicato in G. CAETANI, Regesta chartarum.Regesto delle per-
gamene dell’archivio Caetani, I, Perugia, 1922, pp. 31-33; per l’inquadramento e l’analisidella testimonianza si veda F. CARAFFA, I monasteri medievali nella parte Nord-orientaledei Monti Lepini, in Bollettino dell’Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, XI(1983), pp. 47-50.46. Fornisce un indizio in tal senso il fatto che il cenobio, a circa dieci anni dalla fon-
dazione, non compare in un testamento che annovera tra i molti beneficiari un buon nu-mero di realtà religiose lepine: F. CARAFFA, Il testamento di Stefano d’Anagni cappellanodi Alessandro IV (4 dicembre 1256), in Archivio della Società romana di storia patria, CIV(1981), pp. 97-117.
LAVORO, ECONOMIA, STRUTTURE E SCELTE INSEDIATIVE
pino. Il forte grado di isolamento rispetto ai circuiti pedemontanie vallivi imponeva indipendenza, autosufficienza e libertà senza lequali sarebbe molto difficile immaginare tali realtà. « Qualsiasi isti-tuzione umana », scriveva ancora Caraffa, « compresa quella mona-stica, ha bisogno di libertà; dove si riscontra una ingerenza esterna(…) questa (…) tende a spegnersi o spostarsi altrove » 47. Davveropuò ancora richiamarsi la norma della Regula per cui vere mona-chi sunt si labore manuum suarum vivunt, inteso, il lavoro manua-le, come esperienza necessaria all’identità della comunità e alla suasopravvivenza.
GIOVANNI BARCO
47. CARAFFA 1983 (nota 45), p. 50.