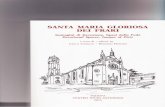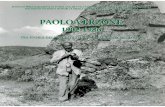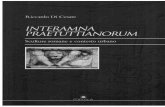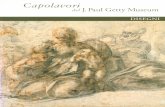Il doge Giovanni Gradenigo, lo scultore Andriolo de' Santi e i disegni di Grevembroch
Exempla dell'architettura europea del Settecento nella Biblioteca della Scuola Politecnica di...
Transcript of Exempla dell'architettura europea del Settecento nella Biblioteca della Scuola Politecnica di...
V Convegno di Storia dell’Ingegneria - Napoli 2014International Conference on History of Engineering - Naples - Italy - 2014
Alfredo BuccAro
Exempla dell’architettura europea del Settecentonella Biblioteca della Scuola Politecnica di Napoli:
i disegni del Sito sabaudo di Venaria Reale
AbstractIn the Historical Library of the School of Engineering of Naples, in addition to many thousands of rare printed texts about which we recently proposed an essay of catalogue documenting the high level of scientific and professional update of Neapolitan engineers since the birth of the Scuola di Applicazione di Ponti e Strade (1811), now we have found a precious manuscript album representing the architectures that formed the prestigious Savoy Site of Venaria Reale in the neighbourhood of Turin in the last eighteenth century.
It is one of two repertoires on the Real Sites of Venaria and Stupinigi that Ferdinando IV requested to the Savoy court in 1785, after he had visited Vittorio Amedeo III in Turin. Although we don’t know anything about the second album actually, the first one, among the valuable materials acquired during the 19th century by the Neapolitan School of Engineering, is an important document for the historical value of example of Filippo Juvarra’s architecture and for the cultural and scientific opportunities generated from its presence there.
On the one hand the discovery shows how much the Bourbon Court and its architects were interested to the European architectural debate and to the important examples from other courts; on the other hand it shows that, during the post-Unit age, the acquisition of this documentation by the School of Engineering was very useful to teach architecture, a subject never considered secondary despite of the development of new branches of engineering.
IntroduzioneIl presente studio1 ci offre l’occasione per tornare sul tema del patrimonio della Biblioteca Storica della Scuola d’Ingegneria di Napoli, di cui più volte, nel corso di oltre un decennio, abbiamo sottolineato l’importanza con riferimento al gran numero di rari testi a stampa sette-ottocenteschi ivi custoditi, proponendone anche, recentemente, un saggio di catalogazione2. Tale cospicuo corpus librario si è dimostrato quindi una chiara testimonianza dell’attenzione che, in seno alla Scuola di Applicazione di Ponti e Strade fondata da Murat nel 18113, veniva posta
2 3
Alfredo Buccaro Exempla dell’architettura europea del Settecento nella Biblioteca della Scuola Politecnica di Napoli: i disegni del Sito sabaudo di Venaria Reale
riguardo alla formazione e all’aggiornamento tecnico-scientifico e professionale degli ingegneri napoletani preposti alla progettazione, esecuzione e cura delle opere pubbliche nel Mezzogiorno. Ma a tali iniziative da noi messe in campo per la valorizzazione di tali importanti fonti per la storia dell’ingegneria nel Sud d’Italia prima e dopo l’Unità si aggiunge ora l’opportunità di aprire un inedito filone di ricerca, riguardante alcune fonti manoscritte pure presenti in quella sede: tra esse, abbiamo individuato un prezioso album4 contenente quattordici disegni relativi alle architetture del prestigioso Sito sabaudo di Venaria Reale presso Torino.
Ferdinando IV e la vicenda dei disegni di Stupinigi e Venaria RealeSebbene il progetto originario di Filippo Juvarra fu realizzato solo in parte, venendo l’opera completata da altri architetti nella seconda metà del Settecento, l’album ci offre non solo l’occasione per una riflessione sugli interessanti aspetti storico-architettonici del complesso, ma per tentare una ricostruzione della vicenda relativa alla provenienza di questi grafici sulla base delle fonti esistenti presso l’Archivio di Stato di Torino5, vista l’assenza di qualsiasi documentazione ad essi allegata.
Ferdinando IV di Borbone, all’indomani della propria visita ufficiale a Vittorio Amedeo III nella capitale sabauda nella primavera del 1785, richiese alcuni disegni riguardanti le architetture di Stupinigi e Venaria, che tanto lo avevano appassionato nel corso della trasferta.
Sebbene non siano reperibili le vedute di Stupinigi, di cui più innanzi faremo cenno, esiste invece quest’album riguardante Venaria, un tempo presente nella Biblioteca Reale di Napoli e acquisito sul volgere dell’Ottocento dalla R. Scuola d’Ingegneria di Napoli per vie, in verità, ancora poco chiare: in ogni caso esso rappresenta un documento importante, sia per l’intrinseco valore storico-artistico, sia per l’indotto culturale e scientifico che dovette derivare dalla sua presenza in quella sede.
Quanto poi all’esplicita richiesta da parte del sovrano borbonico, a ben giudicare i prevalenti contenuti tecnici di quei grafici non dovette trattarsi di un semplice intento ‘collezionistico’ rivolto alle iconografie dei più prestigiosi esempi dell’architettura coeva (pure accertato in Ferdinando IV, se si considera la consistenza del repertorio cartografico di provenienza estera presente nella sezione Palatina della Biblioteca Nazionale di Napoli) né di una specifica passione per l’architettura del Sito sabaudo: vi fu invece un reale interesse, da noi segnalato in più occasioni6, del re Borbone e dei suoi architetti – segnatamente Francesco Collecini e Carlo Vanvitelli, all’epoca ancora impegnati nei cantieri di numerosi Siti Reali7 – verso il dibattito europeo e i più noti programmi di committenza reale promossi negli altri Stati tra Sette e Ottocento.
Quanto sopra avvalora pure la tesi circa la diffusione di una ‘fortuna’ juvarriana nel Mezzogiorno ancora negli ultimi anni del XVIII secolo e per una via diversa da quella dei già noti influssi del maestro torinese sulla formazione vanvitelliana. Si comprende, d’altro canto, come ancora in epoca postunitaria l’acquisizione di tale documentazione da parte della Scuola napoletana sarebbe stata considerata di grande importanza per la didattica dell’architettura, pur nel costante sviluppo delle nuove branche dell’ingegneria.
Nel trarre dagli studi del Cornaglia sui documenti dell’Archivio di Stato di Torino8 interessanti spunti circa la citata richiesta di Ferdinando IV ai Savoia, va sottolineato, a valle del ritrovamento del nostro album, come l’episodio consenta di meglio comprendere il clima di fervore di idee e di programmi di cui il sovrano si rese protagonista prima della cieca reazione anti-rivoluzionaria, all’interno di una politica di autentico respiro internazionale nel campo dell’architettura e dell’urbanistica.
Del resto è ben nota la cifra delle iniziative promosse dai Borbone negli anni ’80 in materia di progettazione o trasformazione dei Siti della Corona, da San Leucio a Carditello, da Persano a Venafro al Fusaro: si riteneva quindi prioritario, da parte del sovrano, recuperare un repertorio di modelli di riferimento per programmi che
Fig. 1 – V. Poma e altri, Facciata del Palazzo Reale a mezzogiorno verso il Parco, con sezione della Cappella, 1785. Napoli, Biblioteca Storica della Scuola d’Ingegneria.
Fig. 2 – V. Poma e altri, Pianta e sezione della Galleria Grande, 1785. Napoli, Biblioteca Storica della Scuola d’Ingegneria.
4 5
Alfredo Buccaro Exempla dell’architettura europea del Settecento nella Biblioteca della Scuola Politecnica di Napoli: i disegni del Sito sabaudo di Venaria Reale
risultassero al passo, in termini di immagine e magnificenza, con quelli attuati dai sovrani stranieri.
Se è vero, però, che l’esperienza compiuta da Vanvitelli a Caserta era assurta ai massimi livelli europei nel campo della progettazione alla scala territoriale e dell’architettura aulica nel linguaggio del classicismo tardobarocco, e che, nei successivi decenni, allievi come Francesco Sabatini, Giuseppe Piermarini o Antonio Rinaldi9 avevano esportato il linguaggio del maestro, contaminandolo anzi con le istanze degli Stati ospiti e con i nuovi principi dell’architettura dell’Illuminismo, la stessa sorte non toccherà certo a quanto realizzato dai suoi epigoni ‘napoletani’, segnatamente da Collecini e da Carlo Vanvitelli. Ma a costoro va almeno riconosciuta la sensibilità che sempre mostrarono per i modelli d’oltralpe di cui re Ferdinando continuava ad arricchire la propria collezione grafica.
La vicenda di cui ci occupiamo va dunque collocata nell’ampio contesto culturale e politico della Napoli del primo periodo borbonico – purtroppo destinato ad essere turbato negli anni ‘90 dagli eventi rivoluzionari – che aveva già favorito le illuminate iniziative di Carlo di Borbone, avvertendosene i riflessi anche sul territorio della capitale e dei Siti Reali, come a Portici, Persano, Quisisana, Venafro, e ancor più con Ferdinando, negli anni ’80, a Carditello, a San Leucio, al Fusaro. Proprio per San Leucio il re adotterà il grande progetto di Collecini per una città operaia disposta in forma radiale intorno alla residenza reale, in una sorta di esperimento di socialismo ‘illuminato’10, ispirato alla nota proposta di Ledoux per la città ideale di Chaux.
L’album napoletano e il suo significatoSebbene, a seguito della richiesta da parte del re Borbone, venisse avviata presso l’archivio reale di Torino un’alacre ricerca dei disegni di Juvarra e di Benedetto Alfieri per Stupinigi e Venaria11, furono ritrovati soltanto progetti non eseguiti o rilievi di parti di quegli edifici. Si rese quindi indispensabile, tra l’ottobre 1785 e il gennaio 1786, a quasi vent’anni dagli interventi di Alfieri, procedere alla redazione di prospetti e sezioni delle principali architetture presenti a Venaria, venendone incaricato l’architetto Vincenzo Poma, posto a capo di un gruppo di misuratori e disegnatori12.
Di Stupinigi, invece, si decise di inviare due incisioni di Ignazio Sclopis13 riguardanti rispettivamente la facciata verso il giardino – ove si era tenuta una riunione di caccia in onore dei reali di Napoli – e il fronte verso Torino, con la rappresentazione della caccia al cervo14: in realtà la prima, l’unica ritrovata nell’archivio reale all’atto di preparare il materiale da inviare a Napoli, come ha dimostrato la Peyrot15 era stata redatta da Sclopis sin dal 1773, probabilmente in occasione delle nozze di Maria Teresa, sorella di Vittorio Amedeo, o forse all’epoca di un precedente viaggio del re di Napoli a Torino; volendo allora fare il paio con quella già disponibile, si
decise di far redigere allo stesso autore la seconda incisione, venendo poi entrambe finemente colorate a tempera, come già si era fatto per spedirle all’erede al trono di San Pietroburgo. Ma neppure di queste vedute resta traccia a Napoli.
I grafici di Venaria redatti tra il 1785 e il 1786 ai fini dell’archiviazione, oggi conservati presso l’Archivio di Stato di Torino, mostrano, rispetto alla documentazione napoletana, solo alcune diversità nei titoli16. Fino ad oggi quest’omologo del nostro album era l’unico conosciuto e, non essendone ancora individuabile l’epoca di redazione, era stato datato al 1763 ca., venendo attribuito genericamente all’équipe di Alfieri oppure al disegnatore Francesco Martinez, con riferimento ad altri suoi elaborati già noti17: esso va invece datato a vent’anni più tardi e ascritto non al Martinez (morto nel 1777) ma ai disegnatori i cui nomi emergono dai documenti studiati dal Cornaglia18. Del resto l’album differisce dagli altri due anche nelle dimensioni, nella legatura e nella coperta, identiche invece a quelle del repertorio napoletano.
Va allora evidenziato il valore di quest’ultimo sia in relazione ai documenti sopra descritti, sia, in generale, alle trasformazioni eseguite nel complesso di Venaria nel corso del Settecento19, potendosene trarre la prima rappresentazione dettagliata, e persino – vista la finalità dell’opera – ‘sontuosa’, degli interventi di Juvarra e di Alfieri.
Su incarico di Vittorio Amedeo II, dal 1716 al 1727, Juvarra interviene a completare le opere intraprese da Michelangelo Garove tra il 1699 e il 171320. Sebbene il suo nuovo progetto prevedesse la costruzione della Galleria settentrionale e dei relativi padiglioni, egli si concentra in effetti sulla decorazione della Galleria Grande – autentico capolavoro del messinese –, sul completamento della manica meridionale, del Giardino a Fiori e di quello inglese, nonché sulla creazione della Grande Scuderia unita alla Citroniera e della monumentale Cappella di Sant’Uberto. Quest’ultima, una delle opere più importanti di Juvarra a Torino, resterà però incompiuta nella
Fig. 3 – V. Poma e altri, Piante della Cappella ai livelli terreno e delle tribune, 1785. Napoli, Biblioteca Storica della Scuola d’Ingegneria.
6 7
Alfredo Buccaro Exempla dell’architettura europea del Settecento nella Biblioteca della Scuola Politecnica di Napoli: i disegni del Sito sabaudo di Venaria Reale
facciata e nella cupola, oltre che priva della nuova piazza inizialmente ideata.Il rilievo della Galleria Grande mostra con dovizia di dettagli la struttura della
sala in pianta e in alzato con lo sfarzoso apparato decorativo, che ne fa tuttora uno degli esempi più significativi del tardo barocco europeo.
I grafici riguardanti la Cappella – rappresentata come se fosse ormai completa anche nella calotta della cupola – mostrano un’architettura che, se considerata in relazione alla pressoché coeva basilica di Superga, offre davvero la cifra del profilo internazionale del suo autore. Le tavole dell’album sono dunque preziose, in questo caso, ai fini di un’analisi dell’idea di Juvarra con riferimento alla struttura non eseguita, che avrebbe mostrato un carattere austero e mitteleuropeo, specie se raffrontata con la più tarda e incombente cupola del Sant’Andrea di Mantova, dello stesso autore.
Altri ambienti compiuti dal messinese, come la Grande Scuderia e la Citroniera, figurano in questi disegni nel loro assetto definitivo. In particolare la seconda, annunciata verso il parco da un’elegante facciata, mostra in sezione il ricco apparato decorativo concepito da Juvarra, che si svolge sulle fasce degli archi, sui pennacchi e sulle lunette in corrispondenza dei passaggi verso il Giardino a Fiori, anch’esso rappresentato con particolare cura nei suoi ornati parterres. L’album rappresenta poi una testimonianza di grande valore a circa un ventennio dalle opere eseguite dall’Alfieri (1751-1770), il quale progetta i nuovi corpi di collegamento tra le fabbriche principali, le scuderie piccole e il maneggio, rinunciando però definitivamente al completamento della corte d’onore in forma simmetrica: l’architetto persegue piuttosto l’intento di dare alle parti principali della residenza, ancora scollegate, l’assetto di un insieme unitario mediante un percorso interno atto ad integrarle. Le nuove rimesse per le carrozze, le due scuderie piccole unite a quella juvarriana e il maneggio vengono quindi realizzati nello spazio tra la cappella e la
Grande Scuderia; tra il padiglione a sud-est e la cappella, Alfieri crea una manica di collegamento e amplia l’appartamento dei duchi di Savoia con i celebri gabinetti cinesi21. Nel punto di comunicazione con la facciata convessa della Cappella viene creata una torre-campanile che, con la gemella prevista ad est ma purtroppo non realizzata, avrebbe dovuto richiamare il modello borrominiano di Sant’Agnese in piazza Navona. La torre funge anche da snodo del nuovo collegamento tra il palazzo e le scuderie, articolato con le anticamere, la Grande e la Piccola Galleria e infine il Rondò. All’interno, infine, Alfieri arreda l’infilata di stanze degli appartamenti prospicienti i giardini con sete verdi e bianche e con soffitti dorati22.
In conclusione, va sottolineato ancora una volta quanto la Biblioteca della prima Scuola Politecnica italiana sia una fonte inesauribile di testimonianze per la storia dell’ingegneria, offrendoci, con il progresso degli studi, sempre nuove conferme del respiro europeo che quella istituzione esigeva per la propria attività di formazione e aggiornamento professionale di docenti e discenti.
BibliografiaAlisio, G.C. (1976). Siti Reali dei Borboni. Roma: Officina.Alisio, G.C. (1979). Urbanistica napoletana del Settecento. Bari: Dedalo.Buccaro, A., Kiucarianc, G., Miltenov, P. (2003). Antonio Rinaldi architetto
vanvitelliano a San Pietroburgo. Milano: Mondadori Electa.Buccaro, A. (2012). Immagini di città europee e centri del Mezzogiorno nelle carte
della Biblioteca Reale di Napoli. L’iconografia delle città svizzere e tedesche dai prototipi alla fotografia. A cura di de Seta, C., Stroffolino, D. Napoli: Ediz. Scientifiche Italiane.
Fig. 4 – V. Poma e altri, Pianta della Citroniera con indicazione delle decorazioni della volta e pianta del Giardino a fiori, 1785. Napoli, Biblioteca Storica della Scuola d’Ingegneria.
Fig. 5 – V. Poma e altri, Facciata della Citroniera a mezzogiorno, 1785. Napoli, Biblioteca Storica della Scuola d’Ingegneria.
8 9
Alfredo Buccaro
Buccaro, A. (in c.d.s.). Modelli juvarriani nella Napoli borbonica: un album grafico di Venaria Reale nella Biblioteca Storica della Scuola d’Ingegneria. Filippo Juvarra 1678-1736 architetto dei Savoia. A cura di Cornaglia, P., Merlotti, A., Roggero, C. Vol. I.
Cirillo, O. (2008). Carlo Vanvitelli. Architettura e città nella metà del Settecento. Città di Castello: Alinea.
Cornaglia, P. (1994). Giardini di marmo ritrovati. La geografia del gusto in un secolo di cantiere a Venaria Reale (1699-1798). Torino: Lindau.
Cornaglia, P. (2007). 1563-1798 Tre secoli di architettura di corte. La città, gli architetti, la committenza, le residenze, i giardini. La reggia di Venaria e i Savoia. Arti, magnificenza e storia di una corte europea. A cura di Castelnuovo, E. Torino: Allemandi.
Cornaglia, P. (2007). Venaria Reale. La più importante residenza dei duchi di Savoia e dei re di Sardegna. La reggia di Venaria e i Savoia. Arti, magnificenza e storia di una corte europea. A cura di Castelnuovo, E. Torino: Allemandi.
Filippo Juvarra e l’architettura europea (1998). A cura di Bonet Correa, A., Blasco Esquivias, B., Cantone, G. Napoli: Electa N.
Gritella, G. (1994). Juvarra. L’architettura. Modena: Panini.I Libri Antichi della Facoltà di Ingegneria di Napoli nel Bicentenario della Scuola
di Applicazione (1811-2011) (2012). A cura di Buccaro, A., Maglio, A. Napoli: Cuzzolin Editore.
Lange, A. (1973-75). Un falso allarme a Palazzo Reale: “Il re ha perduto i disegni di Juvarra”(il re, Vittorio Amedeo III, nel 1785). Bollettino della Società piemontese di Belle arti, n.s., aa. 27-9, 72-81.
La reggia di Venaria e i Savoia. Arti, magnificenza e storia di una corte europea (2007). A cura di Castelnuovo, E. Torino: Allemandi.
L.Vanvitelli e la sua cerchia (2000). A cura di de Seta, C. Napoli: Electa N. Matteucci, A.M. (1988). L’architettura del Settecento. Torino: UTET.Peyrot, A. (1965). Torino nei secoli. Vedute e piante, feste e cerimonie nell’incisione
dal Cinquecento all’Ottocento, I. Torino: Tip. Torinese Editrice.Ruggiero, R. (2008). La raccolta Palatina della Biblioteca Nazionale di Napoli. Fonti
di ricerca e questioni tematiche. Le città dei cartografi. Studi e ricerche di storia urbana. A cura di de Seta, C., Marin, B. Napoli: Electa N.
Scienziati-artisti. Formazione e ruolo degli ingegneri nelle fonti dell’Archivio di Stato e della Facoltà di Ingegneria di Napoli (2003). A cura di Buccaro, A., De Mattia, F. Napoli: Electa N.
Serraglio, R. (2001). Francesco Collecini: architettura del secondo Settecento nell’area casertana. Napoli: Ediz. Scientifiche Italiane.
Torino ‘700 (1963). Torino: Famija Turinesia.
Note1. Sullo stesso tema si veda pure Buccaro, in c.d.s.2. I Libri Antichi della Facoltà di Ingegneria, 2012.3. Scienziati-artisti, 2003.4. Napoli, Biblioteca Storica Scuola d’Ingegneria, cass. 8, foll. s.n., grafici s.d. (ma 1785),
s.f. (ma V. Poma ed altri), ad inchiostro nero, inchiostro colorato e acquerello.5. Per il presente studio ho potuto avvalermi delle preziose indicazioni di carattere
bibliografico e archivistico fornitemi dal prof. Paolo Cornaglia, cui sono grato.6. Buccaro, 2012, pp. 51-78; Ruggiero, 2008, pp. 230-238.7. Alisio, 1976; Cirillo, 2008, pp. 51-53; L. Vanvitelli, 2000, pp. 46-52; Serraglio, 2001.8. Cornaglia, 1994, pp. 62-64.9. Buccaro, Kiucarianc, Miltenov, 2003.10. Alisio, 1979, pp. 41-43.11. Lange, 1973-75, pp. 72-81.12. Lange, 1973-75, p. 79. Se in un primo tempo si era pensato di spedire i grafici a Napoli
sciolti e arrotolati in un tubo di latta, nel maggio 1786 Vittorio Amedeo decide di farli rilegare in un album «in marocchino con guarnitura in oro» e di farne eseguire una copia da lasciare presso l’archivio dell’Azienda Fabbriche e Fortificazioni. L’unico disegno spedito in tubo sarà la grande planimetria del parco, in scala ingrandita dal disegnatore Bioglio nell’ottobre 1785 e montata su tela e bordato in seta, ma oggi purtroppo irreperibile. I grafici che compongono l’album napoletano (coperta cm 50,8x73,8), tutti su doppio foglio orizzontale (dimens. totali cm 49,0x135,7, tranne i nn. 2 e 14, rispettivam. 49,0x151,2 e 49,0x156,6), riguardano nell’ordine: le piante degli ambienti sotterranei e degli Appartamenti al primo e secondo livello; la pianta e il prospetto del Palazzo a mezzogiorno verso il Parco, con la sezione della Cappella e di parte degli Appartamenti; la sezione delle Gallerie del Palazzo, della piazza e di parte degli Appartamenti; la pianta e sezione della Galleria Grande con indicazione degli ornamenti della pavimentazione e del fronte interno; le piante della Cappella al pianterreno e al livello delle tribune; la sezione della Cappella e un’altra delle due cappelle laterali all’altare, con parte degli Appartamenti siti sulla stessa linea; il fronte della Galleria Piccola di passaggio dal Palazzo alle Scuderie, con il prospetto ovest della Citroniera verso il Parco; la pianta della Scuderia con il profilo verso la corte; la pianta della Citroniera e del Giardino di Fiori; la sezione della Citroniera e degli Appartamenti dei Pagi verso mezzogiorno; il prospetto della Citroniera e degli Appartamenti dei Pagi verso mezzogiorno.
13. Cornaglia, 1994, p. 64, nota 41.14. Torino ‘700, 1963, pp. 184 sgg.
15. Peyrot, 1965, pp. 321-322 e tav. 203; Lange, 1973-75, pp. 75-77.16. Torino, Archivio di Stato (ASTo), Corte, «Palazzi Reali - Disegni», Venaria, mazzo
1, diss. 1-15. Manca nell’album napoletano la planimetria generale del complesso secondo il progetto di Alfieri, dal titolo “Pian terreno del Palazzo Reale, che comprende gl’Appartamenti, Gallerie, Capella, Scuderie, Maneggio, Citroniera”, presente invece tra i grafici dell’archivio torinese (al presente sciolta ma già parte dell’album).
17. Si tratta di due album datati rispettivamente al 1761 e al 1763, riguardanti il «Reale
10 TM
Alfredo Buccaro
Castello» e le «Fabbriche Regie». Riguardo alle attribuzioni dei grafici, si vedano Gritella, 1994, pp. 328 sgg., 482-489; La reggia di Venaria e i Savoia, 2007, schede cat. 7/18 sgg.
18. Cornaglia, 1994, p. 64, nota 41. Si tratta dell’architetto Vincenzo Poma, dei disegnatori Giuseppe Bioglio ed Eusebio Gastaldetti, e dei rilevatori Mosso e Perattore. I documenti citati dal Cornaglia sono in ASTo, Sezioni Riunite, «Fabbriche e fortificazioni - Relazioni a S.M.», rg. 45, a. 1785.
19. Si veda pure sull’argomento: Matteucci, 1988, pp. 200 sgg.; Filippo Juvarra e l’architettura europea, 1998, passim.
20. Cornaglia, 2007b, pp. 191-194.21. Cornaglia, 2007b, pp. 194-195.22. Cornaglia, 2007a, pp. 140, 149 sgg., 170.