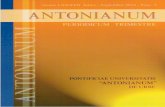Il concetto di "fructus" (spirituali) nei maestri di san Bonaventura, in Miscellanea Francescana 109...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Il concetto di "fructus" (spirituali) nei maestri di san Bonaventura, in Miscellanea Francescana 109...
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» (SPIRITUALI) NEI MAESTRI DI SAN BONAVENTURA
Aleksander Horowski, OFMCap
Il tema dei frutti spirituali nel pensiero di Bonaventura da Bagnoregio1
sembra quasi completamente inesplorato. Nel recente Dizionario bonaven-turiano tale concetto è stato del tutto trascurato2. Nel suo modello france-se, di quarant’anni fa, ossia nel Lexique saint Bonaventure, la voce “Fruc-tus” si limita a poche righe e contiene solo quattro rimandi ai testi bonaven-turiani3. La bibliografia sull’argomento ivi raccolta è molto esigua4.
J. G. Bougerol propone di tradurre il termine fructus in italiano con frui-zione (in francese: fruition, in inglese: fruit; in tedesco: Frucht, in spagno-lo: fruto), ma – visto che Bonaventura usa pure l’espressione fruitio, con unsignificato ben determinato già dai tempi di Pietro Lombardo e dei suoiprimi seguaci e commentatori5, che bisogna tradurre appunto con fruizione– per evitare confusione preferiamo parlare di “frutto spirituale”. Del resto
1 Si useranno le seguenti sigle ed abbreviazioni, a parte le consuete: GH – ALEXANDER
DE HALES, Glossa in quatuor libros Sententiarum Petri Lombardi, I-IV, Quaracchi 1951-1957; OOSB – Opere di san Bonaventura, Roma 1990 (edizione latino-italiana in corso);QAF – ALEXANDER DE HALES, Quaestiones disputatae “antequam esset frater”, Quaracchi1960; QH – Quaestio disputata (numerazione secondo l’elenco di V. DOUCET, Prolegome-na in librum III necnon in libros I et II “Summae fratris Alexandri”, Quaracchi 1948,clxxii-cxcvii; BONAVENTURA, Opera omnia, I-XI, Quaracchi 1882-1902; Sent – PETRUS
LOMBARDUS, Sententiae in IV libris distinctae, Grottaferrata 1971-1981.2 Cf. Dizionario Bonaventuriano. Filosofia – teologia – spiritualità (a cura di E. Caroli),
Padova 2008. Nell’opera mancano del resto anche altri concetti fondamentali per il pensierobonaventuriano. Si veda la recensione in CF 78 (2008) 385-387.
3 Cf. J. G. BOUGEROL, Fructus, in ID. (a cura), Lexique saint Bonaventure, Paris 1969, 73.I testi richiamati sono: In III Sent, d. 34, pars 1, art. 1, q. 1; Brevil, pars 5, cap 6; Sermo VIde Assumptione BMV; Hex, collatio 18, n. 26.
4 Vengono citati: la voce di É. LONGPRE, Bonaventure, DSAM, 1831-1832; due note nel-lo studio di J. F. BONNEFOY, Le Saint-Esprit et ses dons selon saint Bonaventure, Paris1929, 66 e 201; un commento di J. P. RÉZETTE alla parte V del Breviloquium (La grâce duSaint-Esprit), Paris 1967, 144-145.
5 Lombardo, nelle Sentenze, usa solo il termine frui, specialmente nell’opposizione alverbo uti. (cf. Sent I, d. 1, cap. 2-3). Esso sta alla base del sostantivo fruitio usato già daGuglielmo d’Auxerre come atto della volontà con cui l’anima umana gode della gloria div-ina; cf. N. WICKI, Die Lehre von der himmlischen Seligkeit in der mittelalterlichen Schola-stik von Petrus Lombardus bis Thomas von Aquin, Freiburg Schweiz 1954, 186-194.
MF 109 (2009) 439-469
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 439
ALEKSANDER HOROWSKI
i traduttori della collana “Opere di san Bonaventura” (di Città Nuova Edi-trice) traducono il termine fructus semplicemente con “frutto”.
I principali dizionari di teologia prima del Concilio Vaticano II – comeil Dictionnaire de Théologie Catholique del 19206, l’Enciclopedia Cattoli-ca del 19507 e il Dictionnaire de Spiritualité del 19648 – si limitano a par-lare dei frutti dello Spirito Santo, basandosi, per quanto riguarda il periodomedievale, quasi esclusivamente sulla dottrina di Pietro Lombardo e – ovviamente – di Tommaso d’Aquino. Solo il Dictionnaire de Spiritualité al-larga l’orizzonte di ricerca, offrendo anche un’ampia voce intitolata “Frui-tio Dei”9, dove si fa un fugace riferimento al pensiero bonaventuriano, conun rimandando all’articolo “Bonaventure”, composto da É. Longpré per ilvolume I dello stesso dizionario.
Nel primo passo dell’analisi, che qui proponiamo, si abbozzerà la dottri-na sui frutti spirituali nell’ambiente parigino della prima metà del ’200, incui si era formato anche Bonaventura. Solo su questo sfondo si potrà con-durre un’approfondita analisi delle opere bonaventuriane e cogliere sia ilsuo radicamento nella tradizione sia gli aspetti innovativi e originali del suopensiero. Come punto di partenza si propone ovviamente il Commento al-le Sentenze e il Breviloquio. Il Dottore Serafico, però, parla più ampia-mente dei frutti in quattro opere composte nel periodo più maturo della suaattività teologica e pastorale: nell’opuscolo spirituale Lignum vitae, total-mente dedicato agli frutti dell’albero della croce, scritto probabilmente nel126010; in un sermone, predicato nella festa di s. Andrea Apostolo11; nella
440
6 A. GARDEIL, Fruits du Saint-Esprit, DThC VI, 944-949.7 R. GARRIGOU-LAGRANGE, Frutti dello Spirito Santo, EC V, 1790.8 C. A. BERNARD, Fruits du Saint-Esprit, DSAM V, 1569-1575.9 T. KOEHLER, Fruitio Dei, DSAM V, 1546-1569; a Bonaventura viene dedicato un
breve passo nella colonna 1560.10 Cf. B. DISTELBRINK, Bonaventurae scripta authentica dubia vel spuria critice recen-
sita, Roma 1975, 27.11 Nell’Opera Omnia questo sermone è intitolato: Sermo I de S. Andrea Apostolo, IX,
463-470; è stato ripubblicato nell’Editio minor tra i sermoni teologici come Sermo III deVerbo Incarnato (Christus: Lignum Vitae), BONAVENTURA, Opera theologica selecta, V:Tria opuscula. Sermones theologici, Quaracchi – Firenze, 1964, 265-279. Nella nuova edi-zione critica (Saint Bonaventure, Sermons de diversis, curata da J. G. BOUGEROL, Paris1993) esso è stato diviso in due parti, numerate separatamente: De sancto Andrea ApostoloSermo I – Lignum vitae, desiderium veniens, 435-446 e De sancto Andrea Apostolo Colla-tio – Lignum vitae, desiderium veniens, 447-454. L’editore pubblicò inoltre una redazioneabbreviata dello stesso sermone (454-460). La collatio costituiva un tipo di discorso pronun-ciato di sera (spesso fuori la chiesa: nel refettorio, nell’aula scolastica o nella sala capitolare)che continuava o sviluppava il sermone predicato la mattina durante la messa. Il Bougerolpropone come possibile data del Sermo con la relativa Collatio il 30 novembre 1267.
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 440
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 441
collatio introduttiva delle Collationes de septem donis Spiritus Sancti; e nel-le Collationes in Hexaëmeron, l’ultimo ciclo di conferenze tenute a Pariginella primavera del 1273, nelle quali al tema dei frutti vengono consacratequasi interamente due conferenze (collationes 17-18, corrispondenti – se-condo un’altra reportatio – alla V e VI collatio della III visione, dedicata al-la conoscenza erudita dalla Scrittura).
Bonaventura raccoglie la tradizione teologica della prima generazionedella grande scolastica parigina. Tra i teologi di rilievo daremo dapprimauno sguardo al pensiero dei due maestri secolari che – benché non fosseropropriamente maestri del Dottore Serafico – tuttavia esercitarono un forteinflusso sulla scuola dei Minori: Guglielmo d’Auxerre († 1231) e Filippo ilCancelliere († 1236). Passeremo poi alla dottrina dei primi professori fran-cescani: Alessandro di Hales († 1245), Giovanni de La Rochelle († 1245) e Odo Rigaldi († 1275), alla scuola dei quali il Dottore Serafico ricevette la sua formazione teologica. Nella seconda parte del nostro studio, che sa-rà pubblicata nel prossimo numero della rivista – abbozzeremo il pensierodi alcuni teologi domenicani: Guerrico di Saint-Quentin († 1245), Ugo di Saint-Cher († 1263), Alberto Magno († 1280) e Tommaso d’Aquino († 1274). Nella terza parte si parlerà della dottrina bonaventuriana.
I. DUE MAESTRI SECOLARI CHE ESERCITARONO UN FORTE INFLUSSO SULLA
SCUOLA DEI MINORI: GUGLIELMO D’AUXERRE E FILIPPO IL CANCELLIERE
1. Guglielmo d’Auxerre
Guglielmo d’Auxerre († 1231)12 compose la sua opera maggiore, laSumma Aurea13, basandosi sulle questioni che aveva disputate nei primi an-ni del suo insegnamento, attorno ai contenuti delle Sentenze di Pietro Lom-bardo. Tuttavia la Summa Aurea non deve dirsi un commento alle Senten-ze, perché ricalca solo lo schema generale dell’opera lombardiana. Il suo in-flusso sulla scuola francescana di Parigi è notevole. Già Alessandro di Ha-les la conosce e cita – implicitamente – sia nella Glossa in IV libros Senten-tiarum14 sia nella sua Summa Theologica.
12 Per le notizie su questo teologo si veda: C. OTTAVIANO, Guglielmo d’Auxerre († 1231). La vita, le opere, il pensiero, Roma 1929, 7-29; J. RIBAILLIER, Summa aurea. Introduction générale, Paris – Grottaferrata 1987, 3-5.
13 Ci serviamo dell’edizione critica: GUILLELMUS ALTISSIODORENSIS, Summa Aurea,liber I-IV (a cura di J. Ribaillier), Paris – Grottaferrata 1980-1985.
14 La stesura della Glossa halesiana è parallela alla redazione della Summa Aurea: la
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 441
ALEKSANDER HOROWSKI
Guglielmo parla dei frutti nel libro quarto, all’interno del trattato sulla ri-surrezione, nel capitolo dedicato alle doti dell’anima. Infatti, riconosciutal’esistenza delle tre doti dell’anima glorificata, ossia: la visione, la dilezio-ne e la fruizione15, l’autore della Summa Aurea discute sui modi di fruire,ossia sui sensi spirituali e – in seguito – sui dodici frutti spirituali, elencatida san Paolo in Gal 5,22-23. Egli identifica questi frutti con quelli dell’al-bero della vita di cui parla Ap 22,2, perché essi provengono da tutta la Trinità, perciò si possono riferire sia allo Spirito Santo sia al Figlio, che è l’albero della vita in quanto sapienza eterna16.
I frutti si dividono sia in relazione alla loro materia che allo stato di per-fezione o imperfezione. Essi sono dodici, ma se si considerano in relazionealla specie specialissima delle virtù, allora se ne possono elencare di più17.
Guglielmo non definisce esplicitamente che cosa siano tali frutti, bensìesegue un’analisi descrittiva della fruizione, dalla quale risulta che i fruttisono legati alle virtù gratuite in quanto esse svolgono l’atto della fruizionedel sommo bene e del bene compiuto nelle opere spirituali. Egli distingueprincipalmente tra fruizione perfetta e imperfetta. Come il compiacimento(delectatio) che si realizza nella sola visione di un oggetto bello è imperfet-to, così in una pura visione del sommo bene non avviene ancora il pienocompiacimento e soddisfazione (delectatio sive fruitio), se simultaneamen-te da quella visione non nasce il desiderio. Perciò è necessario che l’uomoinerisca al sommo bene mediante l’amore. Da ciò però non segue che la ca-rità, che ci unisce al sommo bene in quanto causa movente (causa motiva),sia l’unico frutto. I frutti, infatti, secondo Guglielmo, si distinguono in rife-rimento alla materia e l’uomo può fruire anche nelle opere spirituali com-piute tramite altre virtù18.
Già nella stessa carità l’autore della Summa Aurea distingue tre fruttispeciali, poiché la carità si riferisce a Dio, a noi stessi (in quanto sottomes-si a Dio) e al prossimo19. Nella tabella sottostante riassumiamo la descrizio-ne degli atti relativi ai frutti che vengono suddivisi in riferimento ai tipi divita nella Chiesa20.
442
frequenza dei riferimenti all’opera dell’Altissiodorense cresce notevolmente tra il primo e ilquarto libro della Glossa.
15 «Tres sunt dotes, sicut dictum est. Due sunt secundum materiam, scilicet visio et di-lectio; et tercia que erit perfectio illarium, scilicet fruitio sive delectatio. Et erit fruitio pro-prie loquendo tantum in visione»: Summa Aurea, IV, tr. 18, cap. 3, q. 3, art. 1, 501.
16 Cf. Summa Aurea, IV, tr. 18, cap. 3, q. 3, art. 3, 516.17 Cf. Summa Aurea, IV, tr. 18, cap. 3, q. 3, art. 3, 517-518.18 Cf. Summa Aurea, IV, tr. 18, cap. 3, q. 3, art. 3, 520.19 Cf. Summa Aurea, IV, tr. 18, cap. 3, q. 3, art. 3, 521-522.20 Cf. Summa Aurea, IV, tr. 18, cap. 3, q. 3, art. 3, 525-256.
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 442
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 443
Come si è accennato, Guglielmo aveva inserito le questioni sui fructusnel trattato sulle doti dell’anima glorificata. Dalla descrizione dei loro atti
risulta però che essi esistono anche nello stato di viator (per esempio:
l’astinenza dalle cose lecite, la gioia nel soffrire). La Summa Aurea, però
non spiega espressamente quale sia la relazione tra i frutti spirituali nella
gloria e nella vita terrestre.
2. Filippo il Cancelliere
Un altro maestro secolare, Filippo detto il Cancelliere († 1236), scrisse
la sua opera maggiore, Summa de bono21, tra il 1225 e il 1229, certamente
prima del grande sciopero universitario22. Essa costituisce un originale
21 Ci serviamo dell’edizione critica: PHILIPPUS CANCELLARIUS PARISIENSIS, Summa debono (a cura di N. Wicki), Bernae 1985.
22 Il rapporto cronologico tra la stesura della Summa de bono e della Glossa halesiana
al III libro delle Sentenze è oggetto di controversia tra V. DOUCET, Prolegomena, in GH III,
Genus vitae Fructus Actus fructuum
communes
ad vitam activam
et contemplativam
caritas delectamur in Deo
gaudium delectamur in Deo
de bonis nostris
pax delectamur de bonis
Christi (vel Ecclesiae)
pertinentes
ad vitam activam
benignitas gaudium in agendo
mansuetudo
patientia gaudium in patiendo
bonitas
longanimitas gaudium de perseverantia
bonorum
pertinens ad perfectio -
nem contemplationis
fides perfecta (credere perfecte)
pertinentes ad opera
perfectionis
modestia ponit modum in factis
et dictis
continentia abstinet a licitis (religiosi)
castitas debitus usus rerum
Horowski:Layout 1 15/12/2009 08:19 Pagina 443
ALEKSANDER HOROWSKI
tentativo di comporre una sintesi filosofico-teologica a partire dalla catego-
ria trascendentale del bene. La sua articolata struttura affronta il bene in ge-
nere, il bene non diminuibile dal peccato e quello che può subire tale dimi-
nuzione nelle creature, per passare poi al bene della grazia. Indubbiamente
è una somma tematica, parziale, che non abbraccia – almeno nel suo stato
attuale – i temi della cristologia e della redenzione e che si allontana dal-
l’impostazione storico-salvifica, prevalente fino ad allora nella teologia
parigina.
Filippo accenna appena alla dottrina dei frutti spirituali, ma da questo
preavviso si intuisce un abbozzo di una teoria ben diversa da quella di Gu-
glielmo d’Auxerre. L’autore della Summa de bono, infatti, introduce il ter-
mine fructus, inteso come un abito gratuito, mentre spiega la differenza tra
le virtù e i doni dello Spirito Santo. Alla base di questa distinzione egli po-
ne la gradualità degli atti svolti dalle tre potenze dell’anima (ossia la razio-
nale, l’irascibile e la concupiscibile). Filippo distingue tra: gli atti primi, ai
quali corrispondono le virtù; gli atti conseguenti o medi, ai quali corri-
spondono i doni; gli atti ultimi e perfettissimi, ai quali corrispondono le bea-
titudini. Ciascuna delle tre potenze può quindi compiere atti di vario grado
di perfezione (primi, medi o perfetti), ossia svolgere gli atti delle virtù, dei
doni o delle beatitudini, ad essa appropriati. A queste tre categorie di abiti
gratuiti, appena elencante, Filippo aggiunge infine i frutti dello Spirito,
che vanno considerati come atti in un certo modo intermedi, e rimanda il
lettore a una futura spiegazione dell’argomento che però effettivamente
non si trova nella Summa de bono23.
La Summa de bono è evidentemente un’opera incompiuta, fatto finora
poco noto agli studiosi e non avvertito neanche da N. Wicki, l’editore del
trattato. Manca soprattutto l’esposizione sui doni in speciale, cosa che rima-
ne in contrasto con la sezione dedicata alle virtù, studiate in tutti i dettagli.
Ancora più palese è la carenza delle sezioni speciali sulle beatitudini e sui
frutti. Inoltre, l’andamento logico dell’intera opera dovrebbe trovare il suo
compimento in una parte dedicata al bene della gloria, come stato perfetto
verso il quale tende ogni bene creato.
444
8*-15*) che ritiene la priorità della Glossa, e N. WICKI, introduction a PHILIPPUS CANCELLAR-
IUS, Summa de bono, 63*-66*, che – benché in modo non del tutto convincente – antepone
l’opera del Cancelliere.23 «Sunt enim tres status actuum: quidam actus sunt primi, quidam medii, quidam ultimi
et perfectissimi. Primi sunt actus virtutum, quia virtus est habitus quo primo erigitur po-
tentia. Actus consequentes et medii sunt actus donorum, quia donum est datum in adiutorium
virtutis. Actus autem consequentes et ultimi et perfectissimi sunt actus beatitudinum. Inter-
ponuntur etiam actus fructuum et quodam modo sunt medii secundum alium modum, sicut
alibi exponetur»: PHILIPPUS CANCELLARIUS, Summa de bono, 1109.
Horowski:Layout 1 15/12/2009 08:19 Pagina 444
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 445
Comunque, dalla suddetta divisione risulta che per Filippo i frutti appar-tengono alla vita presente dell’uomo, si classificano come abiti gratuiti e se-guono i doni dello Spirito Santo.
Per trovare una dottrina sui frutti più sviluppata e completa (anche seesposta a più riprese e in occasioni diverse) dobbiamo rivolgere il nostrosguardo verso l’insegnamento di Alessandro di Hales.
II. PRIMI MAESTRI FRANCESCANI: ALESSANDRO DI HALES, GIOVANNI DE LA ROCHELLE E ODO RIGALDI
1. Alessandro di Hales
La dottrina sulla grazia di Alessandro († 1245) è stata recentemente ri-portata alla luce da due studiosi. L’uno, l’austriaco Hubert Philipp We-ber24, basandosi sulle opere già pubblicate, studia il tema della creazione,del peccato, della giustificazione e della grazia in sé, fino al suo compimen-to nella beatitudine celeste, ma tratta molto superficialmente il problema de-gli abiti gratuiti e il termine fructus non appare neanche nell’indice analiti-co del volume.
L’altro, il frate minore polacco Jacek Mateusz Wierzbicki25, offre inve-ce la prima edizione critica di due questioni disputate sulla grazia, corredan-dola di un dettagliato studio dottrinale. Mentre Alessandro di Hales nellaprima questione (QH 153-154) affronta la natura e la necessità della grazia,nella seconda (QH 155) propone un’articolata suddivisione degli abiti gra-tuiti, abbozzata già nei suoi scritti precedenti. Si tratta delle virtù, dei donie dei frutti dello Spirito Santo26, nonché delle beatitudini evangeliche. Il p. Wierzbicki nella sua dissertazione dottorale espone anche brevemente ladottrina halesiana sui frutti dello Spirito Santo, ma non esaurisce questo te-ma. Lo studioso, infatti, limita la sua ricerca sui frutti principalmente allaseconda questione da lui pubblicata, e solo per alcuni aspetti confronta il
24 H. P. WEBER, Sünde und Gnade bei Alexander von Hales. Ein Beitrag zur Entwicklungder theologischen Anthropologie im Mittelalter, Innsbruck – Wien 2003.
25 J. M. WIERZBICKI, Alexander de Hales: “Quaestiones disputatae de gratia”. Editiocritica. Un contributo alla teologia della Grazia nella prima metà del sec. XIII, Roma2008.
26Al temadeidonidelloSpiritoSanto inAlessandrohodedicato l’articolo:DonidelloSpi -rito Santo nella teologia di Alessandro di Hales, «Naturaleza y gracia»55(2008)477-517. Aifrutti spirituali avevo già accennato nella mia dissertazione dottorale: La “visio Dei” comeforma della conoscenza umana in Alessandro di Hales. Una lettura della “Glossa in quatuorlibros Sententiarum” e delle “Quaestiones disputatae”, Roma 2005, 115-116 e 142-144.
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 445
ALEKSANDER HOROWSKI
suo contenuto con l’inedita questione De fructibus spiritus (QH 210)27,basandosi in questo caso sulla mia trascrizione che gli avevo prestato per-ché potesse dimostrare la paternità halesiana della QH 15528.
È opportuno cominciare il discorso sui frutti nella dottrina dell’Irrefra-gabilis da una chiara e più generale distinzione che egli offre a questo pro-posito nella QAF 58 (De triplici fructu). Nel primo membro della secondadisputa Alessandro elenca le seguenti accezioni del sostantivo «frutto»: ilfrutto della natura, ad esempio quello di una pianta; il frutto della carne in-corrotta, come quando una donna gioisce dei suoi figli; il frutto della carnecorrotta, ossia l’opera del peccato oppure la pena del peccato, come si puòcapire da Gal 6,8; il frutto dello spirito secondo la grazia, come nell’elen-co dato dall’Apostolo in Gal 5,22-23; infine, il frutto dello spirito secondola gloria, ossia il premio celeste29.
Alessandro, però, attribuisce il valore fondamentale ai due significati difructus: il fructus spiritus in futuro per gloriam e il fructus spiritus in prae-senti per gratiam. Il Dottore Irrefragabile, quindi, raccoglie e organizza inun sistema unitario l’eredità di Guglielmo d’Auxerre, distinguendo chiara-mente tra lo stato presente e lo stato della patria celeste.
Il fructus in futuro per gloriam è un premio accidentale e secondario chespetta ai beati come un’aggiunta proporzionata ai diversi stati della conti-nenza osservata nella vita terrestre. Alessandro distingue infatti: la coronaaurea (ossia il premio essenziale, uguale per tutti, “guadagnato” dalle vir-tù teologali); l’aureola ossia un premio accidentale, relazionato al meritoparticolare delle virtù cardinali, ossia alla fortezza (nel caso dei martiri), al-la prudenza (nel caso dei predicatori e confessori) e alla temperanza (nel ca-so dei vergini); infine, il frutto, considerato come remunerazione della par-ticolare difficoltà che l’uomo affronta nel conservare la continenza30.
446
27 Cf. WIERZBICKI, Alexander de Hales: “Quaestiones disputatae de gratia”, 380-389.28 Nell’anno accademico 2005-2006, infatti, ho tenuto alla Pontificia Università “Anto-
nianum” il corso monografico: I doni di grazia nel cammino spirituale dell’uomo, in cui con-frontavo la dottrina del Doctor Irrefragabilis e quella di Bonaventura. Da questo corso sca-turisce anche il presente articolo.
29 QAF 58, De triplici fructu, n. 13, 1135; cf. n. 40, 1146 (le prime due dispute dellaQAF 58 esistono in doppia redazione, perciò quando esiste il testo parallelo, si indicheran-no i riferimenti anche ad altra versione).
30 Sulla varietà dei doni dell’anima glorificata secondo l’Halense si veda: A. HOROW SKI,La “visio Dei” come forma, 141-144; ID., Questione disputata «De dotibus animae» diAlessandro di Hales – Introduzione ed edizione, in Y. TEKLEMARIAM (a cura), Verum - pul-chrum - bonum. Miscellanea in onore di Servus Gieben, Roma 2006, 337-395. Per il con-testo più ampio dell’escatologia degli scolastici è indispensabile la monografia di WICKI, DieLehre, 298-318.
Horowski:Layout 1 15/12/2009 08:21 Pagina 446
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 447
L’aureola è un premio dell’anima, ma che rispecchia il suo legame conla corporeità dell’uomo. L’anima lo “guadagna” mediante il corpo, superan-do il disordine introdotto nelle tre forze dell’anima (rationalis, irascibilis,concupiscibilis) a causa del peccato originale. E poiché la forza concupisci-bile è stata corrotta più delle altre due, è giusto che il riordinamento di que-sta forza, che avviene tramite la virtù della temperanza, venga premiato inmodo particolare, ossia tramite il frutto. Esso si differenza a seconda dellaforma della continenza: quella verginale, quella delle vedove e quella deglisposi31.
Il frutto è l’infimo tra le tre forme di premio, l’aureola ne è il grado medio, mentre l’aurea è il premio sommo. Per questo motivo il frutto non possiede un nome proprio, ma solo generico (infatti, in senso largo, an-che l’aurea e l’aureola si possono chiamare “frutti”). Il frutto della gloriaviene quindi definito in corrispondenza alla fruizione, però, mentre l’aureaviene intesa come fruizione in quanto adesione amorosa al bene a causa di questo stesso bene, il frutto di gloria si definisce come uso connesso algaudio32.
Il frutto della gloria si addice soltanto alla virtù della continenza e allapotenza desiderativa (concupiscibilis)33 perché questa per prima era statacorrotta dal peccato e dalla concupiscenza e generava il frutto della corru-zione. Il frutto della gloria, ossia il frutto dell’incorruzione, le si addicequindi come premio della continenza e come rimedio alla ferita del pecca-to34. Il concetto di fructus per gloriam si fonda evidentemente sulla parabo-la del seminatore del capitolo 13 del vangelo secondo Matteo. Il frutto cen-tuplo si addice ai vergini, che hanno conservato la somma temperanza. Lacontinenza vedovile è raffigurata dal frutto che rende sessanta volte; men-tre la continenza degli sposi viene rappresentata dal frutto che rende trentavolte35.
Come spiega Alessandro nella Glossa, il frutto appartiene a chi ha fattoretto uso del suo corpo ed è riuscito a domarlo. Chi si astiene dal frutto del-la carne, ossia dal godimento sensuale, giustamente dovrebbe essere pre-miato fruendo del godimento intellettuale nella gloria e ciò ha il suo fonda-mento nella contrapposizione tra le opere della carne e le opere dello spiri-to, segnalata dall’apostolo Paolo nella Lettera ai Galati. Il frutto descrive
31 Cf. QAF 58, De triplici fructu, n. 19-28, 1137-1141; n. 58-65, 1151-1154.32 Cf. QAF 58, De triplici fructu, n. 11, 1133-1134; cf. n. 39, 1145.33 Cf. QAF 58, De triplici fructu, n. 10, 1132-1133; cf. n. 38, 1144-1145.34 Cf. QAF 58, De triplici fructu, n. 27, 1140.35 Cf. QAF 58, De triplici fructu, n. 56, 1151; n. 74-79, 1156-1158.
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 447
ALEKSANDER HOROWSKI
quindi l’intensità dello stato di perfezione nel conservare la continenza, ossia l’integrità del corpo, in modi o tempi diversi36.
Alessandro sottolinea la differenza tra il frutto della gloria, di cui siparla nel vangelo di Matteo, e i frutti della grazia, di cui tratta l’Apostolo inGal 5,22-23, ritenendo che i primi, in quanto appartenenti alla gloria, sonodei beni da desiderare a causa di se stessi, perciò sono propriamente oggettodella fruizione; in quanto, però, possiedono in sé qualcosa che fa di loro unmezzo per indirizzarci verso il fine, sono oggetto dell’uso (uti)37; mentre glialtri, ossia i frutti in praesenti per gratiam, principalmente sono oggetto del-l’uso, perché sono delle operazioni o delle azioni, e solo in quanto in essic’è qualcosa che è degno di essere desiderato per sé, possono diventare og-getto della fruizione (frui)38. Al problema dell’elemento comune tra lo sta-to di gloria e lo stato presente, che si verifica nei frutti, si ritornerà più avanti.
Con quest’ultima distinzione siamo entrati nel tema dei frutti in quantopertinenti allo stato presente. Alessandro – similmente a Filippo il Cancel-liere – parla della loro natura, mentre distingue le quattro forme in cui lagrazia discende nell’uomo, ossia le virtù, i doni dello Spirito Santo, i fruttie le beatitudini evangeliche, ossia le beatitudini dello stato terrestre. Per laprima volta egli introduce questa divisione in modo sistematico nella distin-zione 34 del libro III della Glossa; ma un breve accenno a una tale suddi-visione degli abiti gratuiti si trova anche nella QAF 22 (De gradibus cari-tatis)39.
Ecco come il Dottore Irrefragabile definisce i frutti dello stato presentein comparazione ad altri tipi di abiti gratuiti:
Segue [la trattazione] sulla convergenza e sulla differenza tra i doni, i frutti e lebeatitudini. Essa è tale: le virtù riguardano gli atti primi, i doni riguardano gliatti conseguenti, come è stato detto. Il frutto, invece, è un’operazione e un fine.Per ultimo segue la beatitudine, di cui si è parlato nel quinto capitolo di Matteo,la quale è un fine, non un’operazione. Perciò la Glossa afferma in questo pas-so40: Il frutto è un’operazione da desiderare per se stessa41.
È evidente la somiglianza di questa teoria con quella presentata da Filip-po il Cancelliere. Tutti e due gli autori, infatti, pongono alla base di questa
448
36 Cf. GH IV, d. 33, n. 3, III.a-IV.k, 529-534.37 Alessandro sottintende probabilmente che i frutti, in quanto premio creato, ci spro-
nano alla gratitudine verso Dio e perciò ad una lode più intensa.38 Cf. QAF 58, De triplici fructu, n. 12, 1134.39 «Quadruplex est perfectio: prima virtutum, secunda donorum, tertia fructuum, quarta
beatitudinum»: QAF 22, De gradibus caritatis, n. 14, 396.40 PIETRUS LOMBARDUS, Collectanea in epistulas Pauli, in Gal 5,22; PL 192, 160.41 GH III, d. 34, n. 20, IV (red. londinese), 420. Traduzione propria.
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 448
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 449
distinzione la gradualità di perfezione degli atti svolti dalle potenze dell’ani-ma (atti primi, medi, conseguenti e ultimi). Non è possibile dimostrare inmodo inconfutabile la priorità cronologica di uno o dell’altro teologo, mapoiché nella Summa de bono la teoria è soltanto un abbozzo che effettiva-mente non ha trovato la sua applicazione nei frutti (visto che tale trattazio-ne è assente), è più probabile che il suo inventore sia Alessandro.
I frutti vengono quindi messi allo stesso livello ontologico delle virtù,dei doni dello Spirito Santo e delle beatitudini. Nel corso dell’esposizioneil Dottore Irrefragabile precisa anche che queste quattro categorie sonodelle disposizioni permanenti (habitus), infuse insieme alla grazia gratumfaciens. I frutti sono operazione e fine dell’atto, mentre le beatitudini sonoil fine, ma non l’operazione, ossia gli uni appartengono all’attività, mentrele altre alla percezione (passio). I frutti rendono le potenze dell’anima ca-paci di dilettarsi durante l’atto e sono legati agli atti conseguenti delle trepotenze dell’anima. Come esempio Alessandro parla degli atti della poten-za razionale relativi al fine: all’atto della virtù della fede, ossia all’assensoalla somma verità, segue l’intelligenza saporita, alla quale dispongono i do-ni dell’intelletto e della sapienza. A questa operazione della potenza razio-nale segue il frutto della fede, ossia la certezza delle cose invisibili e – allafine – una perfetta purezza dell’intelletto, ossia la prima beatitudine, dopola quale (nell’ordine della perfezione) c’è ormai soltanto la visione beatifi-ca nel cielo42.
L’Halense sviluppa e chiarifica la distinzione tra le quattro categorie diabiti gratuiti, tra cui si trovano i frutti, in una questione disputata provenien-te dal periodo successivo al suo ingresso nell’ordine dei Minori:
Inoltre, [le virtù, i doni, i frutti e le beatitudini] in un altro modo si possono con-cepire propriamente. E così si chiamano secondo le loro proprietà, secondo ipropri nomi; e così nessuno di essi si identifica con l’altro. Così infatti la virtùsarà un abito nella potenza dell’anima, determinato a qualche cosa e non adun’altra funzione. E similmente si deve dire di qualsiasi altro abito. E ciò vachiarificato così: possediamo le potenze naturali motive, ossia la razionale, laconcupiscibile e l’irascibile, che da sé non possono pervenire al loro oggetto ottimo e perciò hanno bisogno di qualche disposizione affinché possano giun-gere al loro oggetto ottimo. […] E così va detto che le soprammenzionate po-tenze hanno bisogno dei convenienti abiti (in quanto l’abito viene concepito insenso ampio), mediante i quali esse vengono disposte al raggiungimento dei lo-ro obiettivi ottimi. E poiché quest’ottimo va determinato in modo quadruplice,anche gli abiti sono quattro. Conformemente a ciò si deve dire che le virtù dispongono le potenze principalmente all’agire, perché – se vi si incontra la
42 GH III, d. 34, n. 20, IV (red. londinese), 420.
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 449
ALEKSANDER HOROWSKI
sopportazione (pati), ciò si verifica in quanto la sopportazione è un’azione; i do-ni dispongono le potenze principalmente alla sopportazione, secondo la confor-mità con la passione di Cristo; i frutti le dispongono al dilettarsi nell’atto; lebeatitudini [le dispongono] al dilettarsi nel fine degli atti oppure delle passio-ni, ossia al dilettarsi dopo che è avvenuto il fatto43.
La distinzione tra i quattro tipi di abiti gratuiti si basa quindi non solo sulgrado di perfezione degli atti (primi, medi, conseguenti, perfettissimi), marispecchia anche la relazione all’azione e percezione, o attività e passivitàdelle potenze, sia a livello fondamentale, ovvero nel compimento di talifunzioni, sia a livello secondario, ovvero nel godimento legato all’azione o alla percezione, o perfino alla memoria del fatto già compiuto. Ciò si puòriassumere graficamente nella tabella sottostante:
Nella QH 210 l’Irrefragabilis cerca di determinare in quale senso si parlo dei frutti dello Spirito. Si tratta dello Spirito Santo o piuttosto dello spirito umano? La sua risposta è legata alla discussione riguardante la de-finizione del concetto di frutto e si serve della figura dell’albero. Leggiamoil testo:
A ciò che si domanda dopo: “quale è l’albero da cui provengono questi frutti?”si deve rispondere che i frutti – così come qui vengono intesi – o sono le stes-se opere delle virtù, secondo quanto sembra affermare qui la Glossa (a Gal5,22s) e similmente la Glossa al capitolo VII di Matteo, e allora la buona volon-tà viene chiamata “albero”, così come si afferma nella Glossa al capitolo 7 diMatteo; o vengono chiamate “frutto” alcune disposizioni oppure alcuni stati os-sia alcune forme date da Dio, che dispongono l’anima al dilettarsi nelle operebuone. E in questo <secondo modo> lo Spirito increato viene chiamato “albe-ro” da cui provengono tutti questi frutti, secondo quanto dice 1Corinzi 12,4: “Cisono molti generi di grazia, ma lo stesso Spirito”, e segue poi (12, 11): “tuttequeste cose le compie uno e lo stesso Spirito, distribuendo ai singoli così comevuole”. Affermiamo quindi che lo Spirito increato dà questi frutti, cioè tali
450
43 Per il testo latino si veda: ALEXANDER DE HALES, Quaestiones de gratia, q. II [QH155], membrum 2 (De quatuor in quibus gratia descendit), ed. Wierzbicki, 149-150 (righe307-332).
Aspectus Actus/Passio Delectatio
activus virtutes -disponunt ad agendum
in actu - fructus
passivus dona -disponunt ad patiendum
in passione vel post actum - beatitudines
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 450
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 451
disposizioni al dilettarsi in queste opere in quanto oneste. E la Glossa sembraindicare questa doppia spiegazione quando afferma: “I frutti dello spirito, cioèdello Spirito Santo oppure della ragione illuminata dalla grazia”. E la ragioneviene intesa ivi non come distinta dalla potenza affettivo-decisiva e da quellairascibile, ma così come comunemente comprende le tre forze, ossia la raziona-le, la affettivo-decisiva e l’irascibile, e come distinta dalla sensualità, la qualepure possiede le sue forze. E l’Apostolo intende questa sensualità per la paro-la “carne”, quando dice: “le opere della carne ecc.”44.
Alessandro si basa sul commento di Pietro Lombardo45 alla Lettera aiGalati, che ammette tutte e due le possibilità. Il nostro pensatore, anche senon esclude che si tratti dello spirito umano, sembra essere incline piutto-sto verso lo Spirito Santo come datore dei frutti. Visto, però, che nelle ope-re meritorie è sempre necessaria la collaborazione della libertà umana, sipotrebbe affermare così: lo Spirito Santo è l’autore principale o originariodei frutti, mentre lo spirito umano li genera in quanto accoglie la grazia. Siparla, infatti, dell’anima illuminata dalla grazia proveniente dallo SpiritoSanto. A favore dello spirito umano è anche il contesto della Lettera ai Ga-lati, dove per contrapposizione si parla dei frutti della carne. Questo passospinge l’Halense a precisare che nella glossa lombardiana la ratio va inte-sa come equivalente di tutta l’anima razionale che abbraccia le tre potenze(rationalis, concupiscibilis, irascibilis). Tale spiegazione gli permetterà poidi applicare i frutti all’attività di queste potenze.
44 «Ad illud quod queritur post: “que sit arbor a qua exeunt isti fructus” dicendum quodfructus, prout hic accipiuntur, aut sunt ipsa opera virtutum, secundum quod videtur hicdicere Glossa et similiter VII Matthei, et tunc bona voluntas dicitur arbor, prout in eademGlossa Matthei VII dicitur; aut dicuntur «fructus» quedam dispositiones vel status sivequedam forme a Deo date, disponentes animam ad delectandum in bonis operibus. Et sicSpiritus increatus dicitur arbor a qua sunt hii fructus, secundum illud I ad Corinthios XII,<4>: Divisiones gratiarum sunt, idem autem Spiritus. Et sequitur <11>: Hec omnia unusatque idem Spiritus operatur, dividens singulis, prout vult. Dicimus ergo quod Spiritus in-creatus dat hos fructus, id est, huiusmodi dispositiones ad delectandum in bonis operibus.Dat, dico, rationi illuminate gratia, secundum quas ratio potest frui, id est delectari in istisoperibus, tamquam in honestis. Et hanc duplicem expositionem videtur innuere Glossa,cum dicit: «Fructus spiritus, scilicet Sancti vel rationis illuminate gratia». Et sumitur ibi ra-tio non prout distinguitur contra concupiscibilem et irascibilem, sed prout communiter com-prehendit tres vires, scilicet rationalem, concupiscibilem, irascibilem, et prout dividiturcontra sensualitatem, que similiter habet vires suas, quam scilicet sensualitatem hic intelli-git Apostolus per carnem, cum dicit: opera carnis etc.): QH 210, De fructibus spiritus, inBAV, Vat.Lat. 782, f. 86rb (Assisi, Bibl. Sacro Convento, Fondo Antico Comunale, ms. 138,f. 10vb; Padova, Bibl. Antoniana, ms. 152, f. 139vb).
45 Cf. PETRUS LOMBARDUS, Collectanea in epistulas Pauli, in Gal 5,22-26, PL 192,160.
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 451
ALEKSANDER HOROWSKI
Si può notare inoltre che nel passo analizzato i frutti vengono interpre-tati in due modi diversi: come opere delle virtù oppure come disposizioniche rendono l’anima capace di godere nelle opere buone. Nella prima acce-zione essi provengono dall’anima umana; nella seconda, dallo Spirito in-creato e vengono definiti in linguaggio filosofico come “forma data daDio”.
Alessandro approfondisce questa analisi nel membro 3 della stessa que-stione disputata, dedicato al problema della connessione tra i frutti. Egli af-ferma espressamente che, secondo quanto sostiene l’Apostolo nella Lette-ra ai Galati, i frutti sono piuttosto delle opere provenienti dalla volontà uma-na trasformata (informata) dalla grazia. Intesi in questo senso, i frutti si pos-sono definire come “opere da desiderare per se stesse” e come tali i fruttinon sono necessariamente connessi, perché non tutti e non sempre devonoe possono compiere tutte le opere buone. Nella seconda accezione dei frut-ti – ed è quella preferita dal nostro teologo – si tratta delle disposizioni da-te da Dio per rendere l’anima capace di godere nelle opere buone. In que-sto caso i frutti sono degli abiti e possiedono la connessione nello stessomodo delle virtù e dei doni. Perciò anche un fanciullo battezzato possiedei frutti in quanto abiti, nonostante non abbia ancora il godimento stesso, os-sia l’uso della disposizione. Similmente negli adulti ci saranno sempre tut-ti quanti i frutti considerati come abiti, ma non è necessario che allo stessotempo ci siano tutti i godimenti ai quali essi dispongono46.
Nella redazione londinese della Glossa l’Halense cerca anche di giusti-ficare il numero dei dodici frutti elencati da san Paolo in Gal 5,22-23,
452
46 «Solutio. Dicimus quod fructus equivocatur ad determinandum scilicet ipsa opera, quesunt ex voluntate gratia informata, et ad determinandum quasdam dispositiones datas a Deoad delectandum in ipsis operibus. Tamen, secundum quod hic de fructibus intendit Aposto-lus, plus nominat vel determinat ipsa opera quam huiusmodi dispositiones; et sic proceduntGlossa et rationes supra posite. Nec tamen quecumque opera nominant vel determinant, sedopera propter se petenda, ut dicit hic Glossa. Cum autem dico “opera propter se petenda” duodico: unum quod opera; aliud quod propter se petenda. Primum est materiale respectu secun-di. Secundum autem formale est et completivum in ratione fructus. Unde hoc est illud quodfructus addit ex nominatione sua supra substantiam operis. Ex hiis patet solutio ad quesita.Ad primum de connexione dicendum quod fructus, in quantum nominant ipsa opera prop-ter se petenda, non habent connexionem; in quantum autem dicuntur quedam dispositionesdate a Deo, sive quidam habitus, sic habent connexionem, quia simul infunduntur disposi-tiones ad delectandum in hoc opere et in illo; et sic de singulis. Unde secundum hunc mo-dum est dicere quod etiam parvulus baptizatus habeat fructus, id est huiusmodi dispositiones;non tamen habet ipsas delectationes ad quas disponunt, sicut nec opera virtutum habet. Sicetiam in adulto bene est una delectatio in actu sine alia, nec est ibi connexio»: QH 210, Defructibus spiritus, in BAV, Vat.Lat. 782, f. 87va (Assisi, Bibl. Sacro Convento, Fondo Anti-co Comunale, ms. 138, f. 11va; Padova, Bibl. Antoniana, ms. 152, f. 140ra).
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 452
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 453
abbinando ad essi i loro atti, sistemati secondo le potenze dell’anima. Per ora
ci limitiamo a dare uno sguardo riassuntivo agli oggetti delle operazioni
corrispondenti ai dodici frutti. Osserviamo queste relazioni nella tabella47.
Gli atti, ai quali dispongono i frutti, si dividono in due gruppi: gli atti
esteriori che si svolgono mediante i cinque sensi corporali; e gli atti interio-
ri che si svolgono mediante le tre potenze dell’anima. Al primo gruppo ap-
partengono la castità, la continenza e la modestia; nel secondo vengono
classificati la carità, il gaudio e la pace, relativi alla potenza affettivo-
decisiva (concupiscibilis); la longanimità e la pazienza che si riferiscono al-
la potenza irascibile; la fede, bontà, benignità, mansuetudine, che vengono
attribuite alla potenza razionale.
Nella QH 155 Alessandro ribadisce che i frutti dispongono le potenze
dell’anima a dilettarsi nell’atto e ne dà solo alcuni fugaci esempi relativi al
47 GH III, d. 34, n. 20, VI (red. londinese), p. 420-421.
Operatio Fructus
quoad actus
exteriores
secundum
tactum et
gustum
licitorum castitas
illicitorum continentia
secundum alios actus sensuum modestia
quoad actus
interiores
secundum
concupisci -
bilem
actus in Deum caritas
actus in se ipsum gaudium de
bonis internis
respectu proximi pax
secundum
irascibilem
respectu finis longanimitas
respectu illorum quae ad finem patientia
secundum
rationabilem
sumptam in se respectu
veritatis
fides
respectu
bonitatis
bonitas
secundum
quod regit con-
cupiscibilem
et irascibilem
in regendo con-
cupiscibilem
benignitas
in regendo
irascibilem
mansuetudo
Horowski:Layout 1 15/12/2009 08:30 Pagina 453
ALEKSANDER HOROWSKI
frutto di fede e abbina alla carità, alla pace e al gaudio le opere relative a Dio, a noi stessi e al prossimo. Questo passo è per noi un’ulteriore confer-ma della paternità halesiana della redazione londinese della Glossa48:
Nei frutti diventa chiaro che essi dispongono le potenze dell’anima al dilettar-si nell’atto e ciò è evidente nel frutto [della potenza razionale] che si chiama fe-de. Infatti, secondo ciò che viene detto nella Glossa al capitolo V della Letteraai Galati, che la fede – in quanto frutto – viene detta “certezza delle realtà in-visibili”, in questo atto c’è il massimo godimento, come diverrà evidente piùtardi. Similmente è chiaro nel caso del frutto che è la carità, e in quello che è lapace e in quello che è la gioia. E similmente va pensato nel caso di altri frutti.I tre frutti soprannominati, invece, si distinguono così: la carità la si attende inriferimento al godimento che c’è in Dio; la gioia nel godimento che c’è in sé;la pace invece nel godimento che cé nel prossimo. E questa distinzione viene indicata anche rispetto ad altri frutti, e si vedrà in un altro luogo49.
Per scoprire di più sulla natura dei frutti dobbiamo analizzare la QH 210dedicata ex professo a questo argomento e alla quale con ogni probabilità ri-manda il passo appena citato della QH 155. Ci interessa soprattutto il pri-mo membro della questione De fructibus spiritus, dove si indaga sul signi-ficato della parola “frutto”. Secondo Alessandro questo concetto va intesocome proveniente dall’idea di “fruire” (frui) nella sua seconda accezione,presentata da Lombardo nelle Sentenze50 ossia: «fruiamo delle cose cono-sciute, in cui la volontà, dilettatasi a causa di esse stesse, trova quiete».L’Irrefragabile spiega che l’espressione quae appetuntur propter se, anchese originalmente si riferisce al bene increato, può essere applicata comune-mente anche ai beni spirituali a differenza delle cose temporali. Si dicequindi che esse sono desiderate per sé non in modo assoluto (come deside-riamo Dio), ma in quanto oneste. L’honestum, invece, viene definito comeciò che ci attira con la propria forza. La volontà, quindi, non può trovarequiete nelle cose temporali – ad esempio nelle ricchezze o nella bellezzacorporale – che non sono desiderate in quanto tali, ma in quanto relativi aibeni spirituali. A volte, infatti, i beni temporali possono essere usati male,perciò di essi non si può fruire propter se. Il frutto, allora, si riferisce soltan-to alle opere delle virtù, considerate come beni onesti, dei quali non si puòfare un uso disonesto. In queste opere oneste ordinate al fine ultimo la vo-lontà può trovare quiete51.
454
48 GH III, d. 34, n. 20 VI (red. londinese), 420-421.49 Per il testo latino si veda: ALEXANDER DE HALES, Quaestiones de gratia, q. II [QH
155], membrum 2, (De quatuor in quibus gratia descendit), ed. WIERZBICKI, 150-151 (righe359-369).
50 Cf. Sent I, d. 1, cap. 2, n. 5, 57.51 «Solutio. Dicimus quod fructus revera sumuntur ab eo quod est “frui” et hoc proprie
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 454
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 455
L’Halense ammette che i frutti, considerati in senso largo, non hanno unnumero determinato e si possono riferire a qualsiasi opera buona provenien-te dalla grazia santificante e desiderata in quanto un bene morale (hone-stum). I frutti considerati in modo proprio, però, non si riferiscono a qual-siasi opera della grazia, come ad esempio alle opere dello stato iniziale(opera inchoationis), ma si devono definire come il dilettarsi nelle operedella perfezione52.
Il nostro teologo puntualizza che ci sono due tipi di godimento (delec-tatio): l’uno nel fine stesso e si svolge nelle beatitudini; l’altro nelle operestesse che sono quasi legate al fine stesso o prossime ad esso, quasi perestrema vicinanza dello stato di via (ultima propinquitate viae), ed esso è proprio dei frutti. Questo avvicinamento al fine, ossia il grado della mas-sima perfezione è la condizione che determina le opere alle quali si riferi-scono i frutti53.
secundum descriptionem secundam, que est hec: “Fruimur cognitis in quibus voluntas” etc.Sed nota quod hoc quod est “propter se” dupliciter sumitur. Uno modo circa hoc quod estpropter aliud et hoc modo verum est quod in solo Deo propter se quiescit voluntas, sicut obi-ciebatur. Alio modo sumitur “propter se” communiter per accidens et hoc modo bona spir-itualia appetuntur propter se, quia scilicet honesta sunt. Honestum autem est quod vi sua nosallicit. Et in illis quiescit voluntas propter se, id est, non per accidens, sicut gratie rerum tem-poralium, utpote divitiarum, pulchritudinis corporalis et huiusmodi, appetuntur non propterse, sed solum in relatione ad bona spiritualia. Unde in huiusmodi, quibus contingit male uti,non quiescit voluntas hominis spiritualis propter se. Sed in operibus virtutum, que scilicet se-cundum se honesta sunt, secundum quod virtus dicitur “qua nemo male utitur” etc., quiesc-it voluntas hominis spiritualis propter se, id est, non per accidens <et> non dico quod exclu-ditur ordinatio ad finem. Et per hoc patet solutio ad illud quod primo obiciebatur de hoc quodest “propter se”»: QH 210, De fructibus spiritus,, in BAV, Vat.Lat. 782, f. 86rb (Assisi, Bibl.Sacro Convento, Fondo Antico Comunale, ms. 138, f. 10vb; Padova, Bibl. Antoniana, ms.152, f. 139vb).
52 «Ad illud quod obicit: “si accipiatur formaliter, tunc multo plures debeant esse fruc-tus” respondeo secundum quod expositum est supra “propter se”, prout scilicet ea que hon-esta sunt propter se appetuntur etc., sic verum est quod omnibus operibus virtutum commu-niter circa hoc et omnibus operibus gratuitis, a gratia – dico – gratum faciente, et secundumhoc verum est multo plures esse fructus, nec est ibi numerus determinatus; sed sic accipiturcommuniter et non proprie. Secundum autem quod proprie accipiuntur fructus, sic dicimusquod non sunt circa quecumque opera, utpote non circa opera inchoationis, immo hoc mo-do fructus sunt delectationes circa opera perfectionis»: QH 210, De fructibus spiritus, inBAV, Vat.Lat. 782, f. 86va (Assisi, Bibl. Sacro Convento, Fondo Antico Comunale, ms. 138,f. 10vb-11ra; Padova, Bibl. Antoniana, ms. 152, f. 139vb.
53 «Notandum tamen quod duplex est delectatio: quedam scilicet delectatio in ipso fine,et hec est beatitudinum; quedam autem in ipsis operibus, que sunt quasi coniuncta vel prox-ima ipsi fini, quasi ultima propinquitate vie et huiusmodi delectatio est fructuum. Unde fruc-tus secundum hoc, cum dicantur dispositiones operum, non dicuntur dispositiones quorum-cumque operum, sed solum operum secundum que est maxime appropinquare ad finem; sive
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 455
ALEKSANDER HOROWSKI
Un’altra condizione generale che determina la categoria di frutto, stabi-lita dall’Irrefragabilis, dice che niente può chiamarsi frutto in modo appro-priato se non possieda un aspetto comune nello stato del pellegrinaggio ter-restre e in patria54. Ne segue che i frutti sono delle disposizioni permanen-ti nello stato di gloria celeste. Questa condizione giustifica il fatto che nona tutti gli atti delle virtù teologali e cardinali corrisponda un uguale nume-ro di frutti. Così, ad esempio, alla virtù della speranza non corrisponde ilfrutto di tale nome, perché gli atti di questa virtù teologale sono molto dif-ferenti durante la vita terrestre e nella gloria. Alla virtù della carità, invece,corrisponde un frutto omonimo55.
Alessandro analizza anche le ragioni per cui il numero dei frutti non siadegua ai doni dello Spirito Santo e perché non ci siano frutti con il nomeuguale ad alcuno dei doni. Egli osserva che i frutti propriamente detti nonhanno una relazione tanto stretta ai doni dello Spirito Santo, mentre sono le-gati piuttosto alle virtù. La ragione della maggiore convenienza dei frutti
456
dicantur opera propter se petenda. Non sunt tamen quecumque opera propter se petenda, sedsolum ea que se habent per approximationem ad finem secundum modum vie. Et ita nonquecumque opera virtutum habent dici fructus, sed quedam. Hec autem accipimus ex eoquod statim post enumerationem fructuum subdit Apostolus <Gal 5, 25>: Si Spiritu vivimus,Spiritu et ambulemus. Vivimus quemadmodum per virtutes et dona et etiam ambulamus unomodo. Sed ambulare hoc modo, scilicet secundum carnem crucifigimus cum vitiis et concu-piscientiis – sicut ibidem dicitur –, hoc fit proprie per dona et non per fructus»: QH 210, Defructibus spiritus, in BAV, Vat.Lat. 782, f. 86va (Assisi, Bibl. Sacro Convento, Fondo Anti-co Comunale, ms. 138, f. 11ra; Padova, Bibl. Antoniana, ms. 152, f. 139vb).
54 «…nihil nominatur proprie fructus, nisi quod rationem habet communem vie et patrie,sicut fructus communis est vie et patrie» : QH 210, De fructibus spiritus, in BAV, Vat.Lat.782, f. 86va-vb (Assisi, Bibl. Sacro Convento, Fondo Antico Comunale, ms. 138, f. 11ra;Padova, Bibl. Antoniana, ms. 152, f. 139vb).
55 «Secundum hoc dicendum ad primum obiectum de spe, quod spes secundum ra-tionem suam importat expectationem rei dilate, ratione cuius dilationis affligit ut huiusmo-di, secundum illud Proverbiorum XIII <12>: Spes que differtur affligit animam. Afflictioautem opponitur fructui, qui scilicet importat in se delectationem. Et ideo spes sub suonomine non nominatur fructus, licet quantum ad quiddam perfectionis quod in ea est, scil-icet perseverantie vel certitudinis in exspectando, aliquid fructus habeat, sicut opinabatur se-cundum illud spe gaudentes; sed quoad hoc ibi comprehenditur sub longanimitate. Fides au-tem, licet ratione eius quod constituit eam in specie, id est, quia ipsa est per speculum et en-igma, quod quodam imperfectionis est, nec est commune vie et patrie, non habet hanc ratio-nem fructus. Tamen secundum genus suum, scilicet cognitionem, dicit aliquid quod habet ra-tionem communem vie et patrie, id est certitudinem et quoad hoc meritur nominari fructus.Unde Glossa: “Fides, id est de invisibilibus certitudo”. Similiter caritas, que de se dicit adhe-rentiam, que scilicet communis est vie et patrie. Spes autem, quia secundum nominationemsuam aliquid potius non commune importat – ut dictum est – non nominatur fructus»: QH210, De fructibus spiritus, in BAV, Vat.Lat. 782, f. 86vb (Assisi, Bibl. Sacro Convento, Fon-do Antico Comunale, ms. 138, f. ; Padova, Bibl. Antoniana, ms. 152, f. 139vb).
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 456
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 457
alle virtù, e non ai doni, consiste nel fatto che le virtù dispongono le poten-ze dell’anima all’azione (ad agendum), mentre i doni alla percezione piut-tosto passiva (ad patiendum, compatiendum vel recipiendum); i frutti, inve-ce, dispongono l’anima a godere nell’azione56.
Successivamente Alessandro si chiede perché non ci siano frutti cheabbiano un nome uguale a quello delle beatitudini e perché l’ordine degliuni non corrisponda alle altre. Secondo lui, anche se tutte e due le catego-rie considerate comunemente sono affini, tuttavia differiscono. Le beatitu-dini, infatti, sono relative al fine, mentre i frutti sono relativi alle opere pros-sime al fine. Per questo motivo i frutti esprimono l’uso dilettevole nelleopere per le quali si giunge al fine. Questa differenza tra i frutti e le beati-tudini è anche la ragione per cui le due categorie sono ordinate in manieradiversa. Le beatitudini, infatti, hanno come criterio della divisione la tripli-ce ordinazione al fine nello stato perfetto, mentre i frutti si dividono sia inrelazione ai tipi di godimento (secundum delectationes) sia in relazione al-le potenze dell’anima che usufruiscono del bene operato (secundum poten-tias vel vires utentes)57.
56 «Solutio. Licet communiter loquendo verum sit quod penes dona possent accipi fruc-tus, tamen loquendo appropriate non ita congruit ut penes dona accipiantur, sicut penes vir-tutes, quod sic patet. Sicut enim alias dictum est, virtutes per appropriationem sunt ad agen-dum; dona autem per appropriationem sunt vel ad patiendum, ut timor; vel ad compatien-dum, ut pietas; vel ad recipiendum, ut sapientia. Unde omnia dona respiciunt potentiam ani-me in quantum receptiva est, virtutes autem respiciunt potentiam in quantum activa est. Etideo, cum fructus sint opera propter se petenda, unde se habent ad usum delectabilem, incomparatione quoad hoc maiorem habent convenientiam cum virtutibus, que scilicet sunt adoperandum, quam cum donis, que sunt quasi ad patiendum vel recipiendum aliquo modo. Etpropter hoc non habemus fructus aliquos, qui vocentur nominibus donorum, sicut habemusquosdam qui vocantur nomine virtutum»: QH 210, De fructibus spiritus, in BAV, Vat.Lat.782, f. 87ra (Assisi, Bibl. Sacro Convento, Fondo Antico Comunale, ms. 138, f. 11rb; Pado-va, Bibl. Antoniana, ms. 152, f. 140ra).
57 «Solutio. Sicut nuper dictum est de donis, ita nunc dicimus de beatitudinibus, scilicetquod si communiter accipiatur fructus vel delectatio hoc modo contingit esse delectationemcirca beatitudines et etiam fructus communiter loquendo. Sed appropriate loquendo non esthoc verum. Aliunde enim accipitur beatitudo et aliunde fructus. Beatitudo enim accipiturpenes relationem ad finem fructus vero penes relationem ad opera que sunt proxima fini.Unde fructus dicit ipsum usum delectabilem in operibus per que devenitur in finem. Beati-tudo ergo magis respicit finem, fructus magis respicit opera. Et ex hoc etiam est quod aliteraccipitur divisio beatitudinum et divisio fructuum, secundum rationes eorum differentes.Quia enim beatitudo respicit finem secundum statum perfectum, ideo dividi habet secundumtriplicem ordinationem in finem in statu perfecto, ut supra habitum est in questione de bea-titudinibus. Quia vero fructus respicit usum delectabilem operum etc. ideo dividi habet tumsecundum delectationes, tum secundum ipsas potentias vel vires utentes, ut infra habebitur.Et propter hoc non oportet quod tot sint fructus precise quot beatitudines, nec etiam quod
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 457
ALEKSANDER HOROWSKI
Alessandro espone la divisione dei frutti nel membro quarto della QH210. Essa è consona a quella proposta nella redazione londinese della Glos-sa e presentata da noi poco sopra. Il godimento (delectatio) si divide in re-lazione a due tipi di atti: interiori ed esteriori. I frutti relativi agli atti inte-riori si suddividono in corrispondenza alle tre potenze dell’anima che svol-gono questi atti. Al godimento negli atti esteriori dispongono tre frutti: lacastità, la continenza e la modestia. Il nostro teologo quindi si mantiene fedele alla linea esposta nella Glossa, aggiungendo soltanto una giustifica-zione più approfondita e invertendo l’ordine dei frutti, ossia iniziando dainove relativi al godimento negli atti interiori58.
In seguito l’Halense cerca di dare ragione all’ordine dei frutti. I passiscritturistici, infatti, – ossia Gal 5,22-23, Rm 14,17 e 2P 1,5-8 – non sonoconcordi a questo riguardo. Egli ribadisce che il criterio da cui dipende lagerarchia dei frutti è sempre il godimento (delectatio). Allora, occorre cominciare da quel tipo di diletto che è più nobile di tutti, ossia dal frutto dicarità che gode direttamente del sommo bene. Questo ordine dei frutti vie-ne chiamato secundum viam nobilitatis. In esso si procede fino al frutto infimo che è la castità. Nella II Lettera di Pietro, invece, i frutti sono enu-merati secondo la via della generazione, perciò come primo frutto si men-ziona quello della fede, come ultimo quello della carità. In questo caso il
458
iuxta beatitudines accipiantur et sic patet solutio ad primo et secundo obiectum»: QH 210,De fructibus spiritus, in BAV, Vat.Lat. 782, f. 87ra (Assisi, Bibl. Sacro Convento, Fondo An-tico Comunale, ms. 138, f. 11rb; Padova, Bibl. Antoniana, ms. 152, f. 140ra).
58 «Solutio. Prius notanda est distinctio horum fructuum, qua visa, patebit leviter solu-tio ad obiecta. Notandum igitur quod fructus accipiuntur penes delectationes. Delectationesautem differunt penes delectabilia, quia delectabile finis est delectationis, ut dicit Philoso-phus. Delectationes vero aut sunt circa | actus interiores anime, scilicet trium virium, et sicaccipiunt novem primi; aut sunt circa actus exteriores, et sic tres ultimi. Si autem circa inte-riores, hoc est tripliciter: aut circa actus concupiscibilis, sic tres primi; aut circa actus irasci-bilis, sic quartus et quintus; aut circa actus rationalis, et sic alii quatuor. Tres autem primivariantur secundum triplicem ordinationem hominis: ad Deum, ad se, ad proximum. Penesenim delectabile quod est in ordinatione ad Deum, sumitur caritas. Penes delectabile in or-dinatione ad se sumitur gaudium, quod scilicet est delectatio in puritate conscientie, secun-dum illud Proverbiorum XV, <15>: Secura mens quasi iuge convivium; et illud Ecclesiasti-ci XXX, <16>: Non est oblectamentum super cordis gaudium. Penes autem delectabile in or-dinatione ad proximum accipitur pax. Ex quo etiam apparet differentia pacis, que fructus est,ad pacem, que beatitudo est, quia pax fructus attenditur in tranquillitate ad proximum. UndeGlossa: Pax quando non se inquietant». Pax vero beatitudo est plena quietatio in Deo secun-dum modum vie, et hec est completio beatitudinum, secundum illud ad Philippenses IIII,<7>: Pax Dei que exsuperat omnem sensum. Alie vero paces, scilicet hominis in se et homi-nis ad proximum, sunt dispositiones ad illam perfectam pacem»: QH 210, De fructibus spi-ritus, in BAV, Vat.Lat. 782, f. 87vb (Assisi, Bibl. Sacro Convento, Fondo Antico Comunale,ms. 138, f. 11va-vb; Padova, Bibl. Antoniana, ms. 152, f. 140rb).
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 458
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 459
frutto della fede viene nominato per primo perché corrisponde alla primaopera della virtù della fede, che è l’assenso alla prima verità. L’ordine deifrutti nella via della generazione riflette allora la gerarchia metafisica, riser-vando il primo posto alla prima verità come origine di tutto il creato. Ovvia-mente la generazione va intesa come acquisizione dell’uso dei frutti, vistoche essi – in quanto disposizioni – vengono infusi all’istante insieme agliabiti delle virtù e dei doni59.
2. Giovanni de La Rochelle
Giovanni de La Rochelle († 1245)60 nelle questioni disputate De gratiae nel trattato omonimo – pubblicati solo parzialmente da Ludwig Hödl61 –non si occupa dei frutti spirituali. La nostra ricerca si basa dunque sugliscritti esegetici del Rupellense: il commento alla Lettera ai Galati (cap. 5)e quello al vangelo di Matteo (cap. 13)62, luoghi scritturistici che – come siè potuto verificare negli scritti di Alessandro – costituiscono il fondamento
59 «Solutio. Notandum quod aliter ordinantur virtutes | et fructus. Virtutes enim dicun-tur habitus ad opera et ideo secundum ordinem operum ordinantur virtutes. | Unde quia pri-mum opus est assentire prime veritati, ideo fides prima ponitur. Sed fructus ordinanturpenes suas delectationes. Unde, quia delectatio in summo bono, que est per caritatem, estperfectio aliarum delectationum, ideo primo ponitur caritas. Inchoatur enim a nobiliori etproceditur usque ad minus nobile, scilicet ad castitatem. In via autem generationis aliter est,quia sic primus fructus est fides, ultimus caritas. Et sic ordinantur II Petri I. Ad aliud de gau-dio similiter solvendum quia sic preordinatur paci secundum viam nobilitatis, sed XIII adRomanos postponitur secundum viam generationis. Unde super illud dicit Glossa Ambrosii:“Hoc gaudium oritur de fraterna pace, sicut de disceptatione nascitur ira”»: QH 210, Defructibus spiritus, in BAV, Vat.Lat. 782, f. 88ra-rb (Assisi, Bibl. Sacro Convento, Fondo An-tico Comunale, ms. 138, f. 11vb-12ra; Padova, Bibl. Antoniana, ms. 152, f. 140rb).
60 Per notizie generali su Giovanni si veda: L. SILEO, I primi maestri francescani di Pa-rigi e di Oxford, in G. D’ONOFRIO (a cura), Storia della teologia nel medioevo, II: La grandefioritura, Casale Monferrato 1996, 657-662 (bibliografia: 691-692).
61 Cf. L. HÖDL, Die neuen Quästionen der Gnadentheologie des Johannes von RupellaOM († 1245) in Cod. lat. Paris 14726, München 1964.
62 Questi commenti sono ancora inediti e poco esplorati. Per ora non è stato stabilitol’ordine cronologico degli scritti esegetici. Uno status quaestionis a proposito delle opere diGiovanni de La Rochelle è stato presentato da J. G. BOUGEROL, Jean de la Rochelle. Les œu-vres et les manuscrits, in A. CACCIOTTI – B. FAES DE MOTTONI (a cura), Editori di Quarac-chi 100 anni dopo. Bilancio e prospettive. Atti del Colloquio Internazionale, Roma 29-30maggio 1995, Roma 1997, 99-108; lo stesso contributo era stato pubblicato precedentementein AFH 87 (1994) 205-215. Non è ancora sufficientemente comprovata la paternità rupellanadella Glossa alle Sentenze del ms. Vat.Lat. 691, proveniente dalla scuola francescana di Pa-rigi. Tale ipotesi fu lanciata da J. G. BOUGEROL, La Glose sur les Sentences du manuscritVat.lat. 691, «Antonianum» 55 (1980) 108-173.
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 459
ALEKSANDER HOROWSKI
biblico per la teoria dei frutti spirituali. Ecco il primo passo del commentorupelliano al testo paolino sui frutti:
Fructus autem spiritus etc. – In parte ista ponitur manifestatio fructusobservantie spiritualis. Et, quia omnis virtus est de bono et difficili, ideo primoostendit utilitatem observantie spiritualis, secundo ostendit difficultatemobservantie spiritualis, ibi: Adversus huiusmodi etc. Circa primum nota quodenumerat multas utilitates observantie spiritualis, cum dicit: Fructus autemspiritus etc., quarum numerus accipitur hoc modo: nam quedam illarum suntper conversionem anime in summam bonitatem secundum actus exteriores;quedam secundum actus interiores; quedam sunt per conversionemconcupiscibilis, ut: caritas, gaudium et pax. Sed caritas est per conversionem adDeum. De huiusmodi fructibus Apocalypsis XXII, <2>: Ex utraque partelignum vite afferens fructus duodecim per menses singulos. Dicitur caritas –sicut dicit Ysidorus – a “caris”, quod est gratia. Et dicitur latine dilectio, quasiduos in unam ligans. De hac Ad Colossenses III, <14>: Super omnia autemcaritatem habete, quod est vinculum perfectionis. Gaudium ex puritateconscientie per conversionem ad se ipsum, de quo Tobie V, <11> dixit angelusad Tobiam: Gaudium tibi semper sit, et Ad Philippenses IIII, <4>: Gaudete inDomino semper. Sed obicitur, quia fructus dicitur ad «frui» secundum quod“frui est uti cum gaudio” et gaudium est fructus. Ergo gaudio utitur cum gaudio.Respondeo: Cum dicitur: «rui est uti cum gaudio», gaudium sumitur prodelectatione; cum autem dicitur: “frui est uti cum gaudio”, intelligitur refectioilla, que consistit circa delectationem, que est in securitate conscientie,Proverbiorum XV, <15>: Secura mens quasi iuge convivium. Gaudium potestdici fructus omnium virtutum non in quantum moventur in fines suos, sed inquantum sunt thesaurus conscientie. Gaudium enim est animi exultantis superbonis habitis in conscientia. Pax autem est qua quieti sunt, ut dicit Glossa, percomparationem ad proximum. Et nota quod pax, secundum quod est perfectaconcordia ad Deum et ad proximum, est beatitudo; fructus autem est secundumquod est refectio consistens in delectatione, que est iuxta pacem ad proximum.De hac Ad Colosenses III, <15>: Pax Christi, que exultet in cordibus vestris; AdPhilipenses IIII, <7>: Pax Dei, que exsuperat omnem sensum, custodiat cordavestra et intelligentias vestras. Quedam inter fructus sunt per conversionemirascibilis, ut: patientia et longanimitas. Sed patientia est ex conversioneirascibilis ad sufferentiam presentis tribulationis; de qua Matthei X, <rectius:Luce 21,19>: In patientia vestra possidebitis animas vestras; et Iacobi I, <4>:Patientia opus perfectum habet. Longanimitas est ex conversione irascibilis adexpectationem future beatitudinis, de qua Iacobi V, <10>: Exemplum sumite,fratres, exitus mali et patientie et longanimitatis prophetas, qui fuerunt ante vos.Quedam vero sunt per conversionem ipsius rationabilis, ut: bonitas, benignitas,mansuetudo, fides. Ipsa autem rationabilis est apprehensiva secundum rationemet motiva secundum voluntatem. Et secundum hoc est duplex eius conversio.Secundum conversionem rationis, ut est apprehensiva, fructus eius est fides, idest de invisibilibus certitudo; Ad Hebreos XI, <1>: Fides est substantia rerumsperandarum, argumentum non apparentium. Secundum conversionemvoluntatis fructus eius est: bonitas, benignitas, mansuetudo. Sed bonitas est ex
460
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 460
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 461
conversione voluntatis ad se; unde Glossa: Bonitas est dulcedo animi.Benignitas et mansuetudo per conversionem ipsius voluntatis ad movendasvires alias: aut igitur ad movendum concupiscibilem, et sic est benignitas; autad movendum irascibilem, et sic est mansuetudo. Bonitas – Glossa: Largitasrerum, que debet fieri cum dulcedine animi, que est bonitas. Preterea dicitur IIAd Corinthios IX, <7>: Hilarem datorem diligit Deus; Ecclesiastici XVIII,<16>: Nonne ardorem refrigerabit ros, sic et verbum melius quam datum.Mansuetudo – id est: perfecta repressio motus ire; de qua Psalmus <36,11>:Mansueti autem hereditabunt terram; et Iacobi I, <21>: In mansuetudinesuscipite insitum verbum. Ita ergo utilitates determinantur secundum actusinteriores, quibus anima habet converti in Deum. Secundum actus exterioreshabet anima converti in summam bonitatem et sic sunt tres cetere, scilicet:modestia, continentia, castitas. Sed modestia est | fructus secundum debitumordinem sensibilis. Modestia enim ponit debitum moderamen sensuum; de quaAd Philippenses IIII, <5>: Modestia vestra nota sit omnibus hominibus; et AdColosenses III, <12>: Induite vos viscera misericordie: benignitatem,humilitatem, patientiam, modestiam, continentiam. Castitas est fructussecundum ordinationem vegetabilis. Sed continentia est abstinentia a licito.Unde Glossa: Continentia que est cum licitis se abstinet; II MachabeorumXIIII, <37-38> habetur de Razia, qui continentiam multis temporibus tenuit iniudaismo, corpus et animam contentus dare pro perseverantia. Castitas autemest in recto usu liciti; de qua I Ad Timotheum II, <2-3>: Quietam et tranquillamvitam agamus in omni pietate et castitate. Hoc enim bonum et acceptum coramsalutari nostro. Conversio igitur mentis in summam bonitatem secundum actusinteriores concupiscibilis, irascibilis, rationabilis et secundum actus exterioressensibilis, vegetabilis multiplicantur fructus duodecim63.
In questo testo Giovanni compie la suddivisione dei frutti in riferimen-to agli atti interiori ed esteriori dell’anima, con cui essa si indirizza verso ilsommo bene. In questa divisione, con cui egli cerca di giustificare il nume-ro dei dodici frutti, si vede un forte influsso della ramificazione dei fruttiproposta da Alessandro di Hales nella Glossa alle Sentenze64. I due teolo-gi sono concordi nella divisione fondamentale, che rispecchia gli atti inte-riori ed esteriori. Lo stesso si dica del secondo livello della ramificazionedegli atti interiori, relazionata alle tre potenze dell’anima.
Si vedono però non poche differenze tra i due maestri francescani. Soprattutto all’interno degli atti esteriori Giovanni introduce la suddivisio-ne che si riferisce all’ordinazione della potenza vegetabile e quella sensibi-le, mentre Alessandro si limitava alla potenza sensibile, distinguendo, però,tra gli atti dei vari sensi esteriori. Inoltre Giovanni definisce la castità come
63 IOANNES DE RUPELLA, Super epistulas Pauli, Gal 5,22-23, in BAV, Pal.Lat. 94, f.214vb-215ra.
64 GH III, d. 34, n. 20, VI (red. londinese), 420-421.
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 461
ALEKSANDER HOROWSKI
riordinamento nelle cose illecite e la continenza come astinenza dalle coselecite, mentre nella Glossa halesiana si afferma esattamente l’opposto.Un’altra differenza si nota nella distinzione tra la pazienza e la longanimi-tà. La pazienza, infatti, secondo Alessandro si riferisce alle realtà che sonomezzi al raggiungimento del fine, mentre per Giovanni essa riguarda la sop-portazione delle tribolazioni presenti. Nel caso della longanimità le discre-panze riguardano solo la terminologia: per Alessandro essa concerne il fi-ne stesso, mentre Giovanni è più esplicito e la definisce come attesa dellabeatitudine futura.
Nella tabella sottostante riassumiamo graficamente la suddivisione rupelliana dei frutti spirituali.
462
Conversio
ad summam
bonitatem
Secundum vires
vel potentias animae
(Materia/
Finis)
Fructus
secundum actus interiores animae
per conversionem concupiscibilis:
ad Deum caritas
ad se ipsum caudium
ad proximum pax
per conversionem irascibilis: ad sufferen-tiam praesentistribulationis
patientia
ad expectatio-nem futuraebeatitudinis
longanimitas
per conversionemrationabilis:
ut apprehensiva
convertendo sead veritatem
fides
ut motiva: convertendose ipsam (voluntas)
bonitas
ad movendumconcupiscibilem
benignitas
ad movendumirascibilem
mansuetudo
secundum actus exteriores animae:
secundum debitum ordinem sensibilis modestia
secundum ordinationem vege-tabilis:
in illicitis castitas
cum licitis seabstinet
continentia
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 462
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 463
Anche se nel commento alla Lettera ai Galati, riportato sopra, Giovan-ni non definisce la natura dei frutti in quanto categoria di doni gratuiti, masi concentra esclusivamente sui singoli frutti e sulla distinzione tra di essi,è tuttavia possibile rilevare alcuni termini che segnano in qualche modo uncerto spostamento di accenti nel considerare i frutti. Infatti, mentre Alessan-dro insisteva sul godimento (delectatio), Giovanni introduce il concetto direfectio. Secondo lui, infatti, quando la fruizione viene definita come “usolegato al gaudio”, il gaudio sta a significare il godimento (delectatio); men-tre quando si afferma che “il gaudio è un frutto”, allora s’intende il ristoro(refectio) che si riferisce al godimento proveniente dalla buona coscienza.I frutti, inoltre, vengono messi in relazione alle azioni delle virtù tendenti alloro fine – similmente fa Alessandro. Il ristoro spirituale (refectio) costitui-sce per il Rupellense l’elemento caratterizzante dei frutti, che li distinguedalle beatitudini o dalle virtù omonime65.
Dalle quaestiunculae, che seguono alla fondamentale esposizione deltesto paolino, possiamo ricavare ancora qualche precisazione riguardante lanatura dei frutti spirituali in via. Giovanni spiega in che senso i frutti sianooggetto di fruizione e di desiderio propter se. Dio, infatti, va amato a causadi se stesso in quanto fine del nostro amore, mentre le virtù vanno amatecome l’essenziale via che conduce a questo fine, rendendo l’uomo degnodel sommo bene66. All’obiezione che i frutti sono da desiderare per sestessi, perché ci attirano con la loro dolcezza, il francescano risponde checiò è vero solo parzialmente, perché materialmente si fruisce solo di Dio,mentre la fruizione nelle virtù è solo effettiva, perché le virtù ci fannofruire Dio e trovare in lui il godimento. I frutti, quindi, non vengonodesiderati a causa di qualche vantaggio esteriore (commodum extrinsecum),ma per la causa intrinseca che è Dio, il quale viene – per così dire – inclusonella definizione della virtù. E in questo senso si può dire che i frutti sonodesiderati sia per Dio sia per se stessi67.
65 Esiste, ad esempio, fede-virtù e fede-frutto; carità-virtù e carità-frutto; mansuetudine-beatitudine e mansuetudine-frutto; pace-beatitudine e pace-frutto. Notiamo tuttavia che –come avevamo segnalato in precedenza – Alessandro di Hales considerava come veramenteomonimi solo le virtù e i frutti, ma non ammetteva tale relazione tra i frutti e le beatitudini.
66 Come si vedrà tra poco, secondo Giovanni anche i frutti sono una specie di virtù.67 «Sed obicitur contra istos fructus. Et primo de hoc quod dicit Glossa, quod dicuntur
fructus quia per se appetenda sunt, ergo per se diligenda. Sed nonnisi propter bonum quodin eis est. Ergo, eadem ratione, angelus <et> proximus propter se diligendi sunt, quia bonumsunt. Item, frui est inherere alicui rei propter se ipsam. Ergo fruendum est virtutibus. Contra.Augustinus in libro De doctrina christiana: Res, quibus fruendum est, sunt: Pater et Filiuseademque Trinitas. Respondeo: Dicimus quod Deus diligendus est propter se ut finis
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 463
ALEKSANDER HOROWSKI
Rispondendo alle seguenti obiezioni, Giovanni de La Rochelle affrontail classico problema della provenienza dei frutti, ossia se essi si devono im-mediatamente allo Spirito Santo oppure allo spirito umano illuminato dal-la grazia. In questo caso segue la linea di argomentazione battuta già daAlessandro, ma dedica più spazio ad un’altra questione, ossia ad un appa-rente “conflitto di priorità” tra la carità e la fede in quanto principi originan-ti dei frutti68.
464
dilectionis; virtutes vero diligende sunt propter se sicut via essentialis ad finem, faciunt enimhominem dignum summo bono. Similiter in alia divisione rerum alia substantia aliaaccidens, substantiales proprietates dicunt: substantia non quia substent accidentibus, sedquia faciunt res subsistere, que accidentibus substant. Item, fructus sunt per se appetendi,quia nos alliciunt sua dulcedine. Et in hoc etiam propter Deum appetuntur. Item, Deo tantumfruimur materialiter; virtutibus effective, quia faciunt nos Deo frui et delectari in Deo; etdilectione formaliter. Unde non sequitur: Deo solo fruendum est, ergo non virtute.Respondeo: Deo fruimur materialiter et virtute non ita; vel, si ita, vera est conclusio. Etexpone quod hic dicit non propter se, id est: non propter aliquod extrinsecum commodum,sed propter intrinsecum quod in eis est. Deus enim in diffinitione virtutis ponitur»: IOANNES
DE RUPELLA, Super epistulas Pauli, Gal 5, 22-23, in BAV, Pal.Lat. 94, f. 215ra.68 «Item, dicit alia Glossa: Fructus Spiritus Sancti, id est: gratia rationis illuminate. Ergo
caritas et alii fructus procedunt ex libero arbitrio, quod falsum est, quia sicut dicitAugustinus: Virtus est quam Deus operatur in nos sine nobis. Respondeo: Caritas dicitur hicfructus rationis ea ratione qua fructus arboris dicitur fructus meus, ut habentis scilicet non utfacientis; Spiritus Sancti auctore origine vero est fructus caritatis tanquam arboris proprie,ex qua procedit. Item, dicit alia Glossa: Caput virtutum premisit, | id est caritatem. Ergocaritas caput est. Ergo prima. Contra. Prima petit campum dubia etc. Item, fides generatspem, spes caritatem etc. Et I Ad Timotheum I, <5>: Finis precepti caritas est etc. Item, sicutmotus ad motum et habitus ad habitum, sic credere prius est quam diligere, quia secundumAugustinum: Non visa diligere possumus, incognita nequaquam. Ergo habitus prior habituet fides prior caritate. Respondeo: Fides prior est caritate natura, magisterio et regimine,humilitas conservatione. Unde Augustinus: Qui ceteras virtutes sine humilitate congregat,quasi cinerem et ventum portat. Patientia nutritione caritas prior informatione secundum eosqui dicunt quod caritas alias informat. Secundum alios caritas prior est generatione etaugmentatione et motione ad opera. Et quod sequitur: ex qua nascuntur universa bonasupple: opera. Vel, secundum alios, qui dicunt, quod ipsa informat alias, expone: Id est exqua universa sunt bona. Quecumque enim bona sunt, ex illa bona sunt. Vel dicuntur omniabona nasci ex caritate, quia ex ipsa est meritum principalius aliis. Item, dicit alia Glossa: Sinequa cetere virtutes non reputantur virtutes. Et est argumentum pro illis, qui dicunt caritatemvirtutes informare. Secundum alios responde: cetere sequentes virtutes vel virtutum opera,quia movet ad opera. Et ex hoc sequitur quod virtus est vel potest esse que non reputabiturvirtus, quod verum est secundum illos, qui dicunt quod naturalia fiunt gratuita. Secundumalios dicitur quod loco huiusmodi appellationis cetere virtutes debent poni cetere nominavirtutum. Sed in alia significatione, quia modestia, patientia et politice virtutes, que sinecaritate habentur, non sunt theologice nec a theologo reputantur virtutes. Sed melius est, utreferantur ad usus, vel opera virtutum, que sine caritate non dicuntur virtutes, id est operavirtutum. Omnes enim virtutes a Deo sunt et virtus ex virtute non est»: Super epistulas Pauli,Gal 5, 22-23, in BAV, Pal.Lat. 94, f. 215ra-215rb.
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 464
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 465
Abbandoniamo ora il commento Super Epistulas Pauli, per esplorare ilcommento al vangelo di Matteo; ma prima di passare al capitolo 13, in cuisi parla dei frutti nella loro dimensione escatologica, ci soffermiamo breve-mente sul capitolo 5 dove, definendo le beatitudini, il Nostro fa qualche ri-ferimento comparativo alla natura dei frutti spirituali.
In questo passo del commento al vangelo di Matteo, infatti, usando laterminologia plotiniana diffusa da Macrobio e conosciuta già a Guglielmod’Auxerre69, classifica i frutti – insieme alle virtù teologali e ai doni delloSpirito Santo – come virtù purificative, mentre le beatitudini evangelichevengono descritte come virtù dell’animo ormai purificato. Egli ritiene, infatti, che la grazia sacramentale serva a sanare l’anima dal morbo dellacolpa; le virtù teologali ad abilitare le potenze dell’anima ad agire bene; i doni ad aiutare le potenze nell’agire, togliendo le difficoltà; mentre i frut-ti permettono il godimento (delectatio) dopo l’azione, poiché eliminano lafatica e il fastidio legati ad essa. Inoltre – secondo il Rupellense – i fruttinon si riferiscono immediatamente alla felicità eterna, così come si riferi-scono ad essa le beatitudini, che vengono definite come atti e perfezioni del-l’animo purificato70.
Come abbiamo accennato, nello stesso commento al vangelo di Matteoil maestro francescano applica anche il termine fructus all’escatologia, e quisi fa sentire la sua natura compilatrice71. Egli infatti presenta diversi modiin cui si può esporre il frutto del centuplo, moltiplicato per sessanta e pertrenta. La prima interpretazione si pone in linea con Alessandro di Hales, at-tribuendo il frutto del centuplo ai vergini, quello moltiplicato per sessantaalle vedove e quello moltiplicato per trenta agli sposi. Giovanni però nonapprofondisce l’argomento, non definisce la natura del frutto, non lo mettein comparazione ad altri tipi di premio nella patria celeste72.
69 Cf. Summa Aurea, III, tr. 30-36, 585-698.70 Cf. IOANNES DE RUPELLA, Super Matthaeum, cap. 5, (Pamplona, Biblioteca Capitular,
ms. 37, f. 11rb), edito da A. HOROWSKI, Doni dello Spirito Santo nella teologia di Alessan-dro di Hales, «Naturaleza y gracia» 55 (2008) 513, nota 75.
71 Come hanno notato alcuni studiosi, è propenso a inserire nei suoi commenti interi pas-si delle opere altrui e anche di riutilizzare le proprie opere scritte in precedenza; cf. E. LIO,Alcune “Postillae” sui vangeli nei rapporti con Alessandro di Hales, Giovanni de LaRochelle e la “Summa fratris Alexandri”, «Antonianum» 30 (1955) 290; B. SMALLEY, I van-geli nelle scuole medievali (secoli XII-XIII), Padova 2001, 182-201.
72 «Et dabant – Hic subditur fructus. Centesimum – In virginibus, Genesis XXVI, <12>:Seminavit Ysaac in terra illa et invenit in ipso anno centuplum. Aliud sexagesimum – Inviduis. Et ideo dicitur I Timothei V, <9-10>: Vidua eligatur non minus sexaginta annorumin operibus bonis testimonium habens. Et aliud trigesimum – In coniugatis. Et de hoc potestaccipi XII, <11> Ad Hebreos: Omnis disciplina in presenti non gaudii est, set meroris, sed
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 465
ALEKSANDER HOROWSKI
Presentando la seconda interpretazione del triplice frutto, il Rupellenserichiama l’autorità di Beda il Venerabile: il frutto moltiplicato per trentacorrisponderebbe alla fede nella Trinità; quello moltiplicato per sessanta, al-la perfezione delle buone opere. Manca però in questo caso la spiegazionedel frutto del centuplo73.
La terza interpretazione del triplice frutto identifica il frutto del centuplocon il frutto della sapienza, appartenente ai perfetti; il frutto moltiplicato persessantacon il fruttodellagiustizia, appartenenteaiprogrediti; il fruttomolti-plicato per trenta con il frutto della penitenza, appartenente ai principianti.
Infine, la quarta interpretazione attribuisce i tre frutti rispettivamente aimartiri, ai predicatori e ai vergini74.
3. Odo Rigaldi
Odo Rigaldi († 1275)75, seguendo l’abitudine introdotta da Alessandro,
466
postea fructum pacatissimum exercitatis reddet iustitie. Similiter III, <18> Iacobi: Fructusiustitie in pace seminatur facientibus pacem. De hoc triplici fructu Ioannis XV, <8>: In hocclarificatus est Pater meus, ut fructum plurimum afferatis et efficiamini mei discipuli. Eccefructus eius. Pater meus agricola est. Omnem palmitem in me non ferentem fructum tolleteum et omnem, qui fert fructum, purgabit eum, ut fructum plus afferat. Ecce sexagesimus ettrigesimus. De trigesimo, vero sequitur ibidem: Sicut palmes non potest fructum ferre asemetipsum, nisi manserit in vite, sic nec vos, nisi in me manseritis; qui manet in me et egoin eum, hic fert fructum multum. Ecce quod trigesimus est multus, sexagesimus maior etamplior, centesimus plurimus»: IOANNES DE RUPELLA, Super Matthaeum, cap. 13, in Pam -plona, Biblioteca Capitular, ms. 37, f. 35rb.
73 «Secundum Bedam trigesimus fructus est in fide sancte Trinitatis; sexagesimus eoquod in senario numero universitas facta est perfectionem bone operationis. Gregorius: Quiperfectionem designat, consummationem sanctitatis»: ivi, f. 35rb.
74 «Et facit quidem etc. – Hic signat premium sive fructum triplicem. Et potest exponiut supra vel sic: Est fructus sapientie et fructus iustitie et fructus penitentie. Primus estperfectorum, secundus proficientium, tertius incipientium. Primus potest dici centesimus,secundus sexagesimus, tertius trigesimus. De primo dicitur III, <13-14> Proverbiorum:Beatus homo, qui invenit sapientiam et qui affluit prudentia; melior est adquisitio eiusnegotiamine argenti et auri puri et purissimi fructus eius. De secundo III, <18> Iacobi:Fructus iustitie in pace seminatur facientibus pacem. De tertio Luce III, <8>: Facite dignosfructus penitentie. Vel primus [ms.: primum!] est martirum, III, <15> Sapientie: Bonorumlaborum gloriosus est fructus; Ecclesiastici XXXIX, <17>: Quasi rose plantate super rivulosaquarum fructificat. Secundus predicatorum, II Ad Timotheum II, <6>: Laborantemagricolam oportet primum de fructibus percipere. Tertius virginum, XXIIII, <23>Ecclesiastici: Quasi vitis fructificavi, flores mei fructus honoris et honestatis»: ivi, f. 36va.
75 Per informazioni bio-bibliografiche su Odo si veda L. SILEO, Teoria della scienza teo-logica. Quaestio de scientia theologiae di Odo Rigaldi e altri testi inediti (1230-1250), Roma 1984, in particolare 15-19; ID., I primi maestri francescani di Parigi e di Oxford, inD’ONOFRIO (a cura), Storia della teologia, II, 663-670 (bibliografia: 692-693).
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 466
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 467
parla dei frutti spirituali nel Commento alle Sentenze, all’interno della di-stinzione 34 del III libro. Il testo di questa distinzione fu pubblicato nel1929 dal benedettino belga O. Lottin76. Ai frutti viene dedicato il terzoquesito della distinzione 34. Secondo Rigaldi, i frutti sono un nutrimento(pastus) oppure dei godimenti (delectationes) che o seguono o accompa-gnano le opere delle virtù e i doni dello Spirito Santo. Perciò i frutti non siidentificano con le virtù, ma consistono piuttosto nel godimento che accom-pagna le opere delle virtù77.
Odo, quindi, sembra respingere la posizione di Giovanni de La Rochel-le, che identificava i frutti con delle virtù purificative, e segue piuttosto lalinea di Alessandro di Hales. D’altra parte, però, Rigaldi sembra non con-siderare più i frutti come una disposizione permanente (habitus) che abili-ta le potenze dell’anima allo svolgimento di un certo tipo di atti. Nel suocommento, infatti, egli si limita ai tre gradi di perfezione dell’atto (incepti-vi, perfectivi, perfecti), ai quali corrispondono le virtù, i doni e le beatitudi-ni78. I frutti, in compenso, si pongono su un altro livello, come qualcosa chesegue o accompagna gli atti e non come una loro disposizione. L’idea delnutrimento (pastus) sembra poi essere un’eco del ristoro (refectio) introdot-to dal Rupellense.
Ci soffermiamo anche sul commento di un discepolo anonimo di Odo,in cui possiamo trovare in modo più evidente la distinzione tra le disposi-zioni permanenti (habitus) che abbracciano soltanto le virtù, i doni e le bea-titudini, e i frutti e i sensi spirituali. Questo anonimo baccelliere francesca-no restringe quindi il numero degli abiti a tre, ma – in compenso – introdu-ce una nuova categoria: i sensi spirituali, che si abbinano ai frutti. I fruttivengono definiti come ristoro spirituale, mentre i sensi come la percezionedi questo ristoro. L’anonimo, quindi, nega ai frutti e ai sensi spirituali laqualifica di habitus, ma afferma che essi esprimono il perfetto stato ed usodei tre abiti sopramenzionati. Egli, infatti, cerca di dare più chiarezza e pre-cisione ai tre gradi di atti che stanno alla base dei tre tipi di habitus. Notia-mo ancora che la terminologia usata è stata ereditata in parte da Alessandro(gli atti primi, medi e ultimi o perfetti) e in parte da Giovanni de La Rochel-le (purificatio, expeditio, perfectio delle potenze e degli atti, nonché la
76 ODO RIGALDI, In III Sent, d. 34, edito da O. LOTTIN, Les dons du Saint-Esprit chez lesthéologiens depuis P. Lombard jusqu’à s. Thomas d’Aquin, «Recherches de Théologie An-cienne et Médiévale» 1 (1929) 82-92.
77 Cf. In III Sent, d. 34, 90-91.78 Cf. In III Sent, d. 34, 89.
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 467
ALEKSANDER HOROWSKI
refectio nel godimento legato ai frutti)79. Tale distinzione, con un linguag-gio molto simile, ritornerà nel Commento alle Sentenze di san Bonaventu-ra e nel Breviloquium80.
CONCLUSIONE
In questa parte della nostra ricerca sul concetto di fructus abbiamo per-lustrato i testi di cinque teologi della prima metà del ’200: due professori se-colari e tre maestri francescani di san Bonaventura. Dai loro scritti risultache il termine fructus veniva interpretato in due campi teologici, ossia nel-l’ambito dell’escatologia, a partire dall’esposizione allegorica della parabo-la del seminatore (Mt 13), e nell’ambito del discorso sul corredo delle di-sposizioni gratuite (habitus), prendendo spunto dal capitolo quinto dellaLettera ai Galati.
Questi due filoni interpretativi, abbastanza indipendenti, trovano una sistematizzazione coerente soprattutto nella teologia di Alessandro di Hales,con i termini di fructus in futuro per gloriam e fructus in praesenti per gratiam.
Nella dottrina dell’Halense avviene anche – per usare l’espressione della studiosa tedesca Elisabeth Gössmann81 – l’ontologizzazione del
468
79 «Respondeo ad primum quod, cum omnes aliquam assignent differentiam inter uir-tutes et dona, potissimus tamen modus sumitur per comparationem ad actus proprios. Suntenim quidam actus primi, quidam medii, quidam ultimi siue perfecti, sicut possumus uiderein actu cognitionis; quia prius est credere, secundo intelligere, tertio in mundo corde uidere;et secundum istam triplicem differentiam actus in nobis tres differentie habituum gratuito-rum, scilicet uirtutum, donorum et beatitudinum, ita quod uirtutes sunt ad actus primos, si-cut fides ad credere, dona ad actus secundos, ut donum intellectus ad intelligere, beatitudinesad actus ultimos, ut munditia cordis ad uidere; et quoniam in primis actibus potentie purif-icantur, in secundis expediuntur, in tertiis perficiuntur, hic est quod habitus uirtutum sunt adagendum recte, habitus donorum ad agendum expedite, habitus beatitudinum ad agendumperfecte. Postquam autem isti habitus sunt in anima, est consequenter quidam status quieta-tionis in ea et delectationis. In hac autem delectatione duo concurrunt, scilicet quedam spi-ritualis refectio et ipsius refectionis perceptio. Ideo ad ista tria genera habituum addunturfructus et spirituales sensus, qui non dicunt habitus, sed habituum precedentium exprimuntperfectum statum et usum»: DISCIPULUS ANONYMUS ODONIS RIGALDI, In III Sententiarum(Paris, BnF, ms. Lat. 3424), edito da O. LOTTIN, Les dons du Saint-Esprit du XIIe siècle à l’époque de saint Thomas d’Aquin, in ID., Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles,III: Problèmes de morale, Louvain – Gembloux 1949, 396-397.
80 Cf. BONAVENTURA, In III Sent, d. 34, pars 1, art. 1, q. 1; III, 737-338; Breviloquium,pars 5, cap. 6; V, 258-260.
81 L’espressione viene usata nella monografia di E. GÖSSMANN, Metaphysik und Heils-
Horowski:Layout 1 04/12/2009 12:10 Pagina 468
IL CONCETTO DI «FRUCTUS» 469
concetto di frutti spirituali, ai quali si attribuisce il carattere di una disposi-zione permanente (habitus) al pari delle virtù, dei doni e delle beatitudini. Tale interpretazione, fondata sull’analisi dei gradi di perfezione nello svol-gimento degli atti da parte delle potenze dell’anima, si trova in nuce già nel-la Summa de bono di Filippo il Cancelliere e viene poi ereditata e gradual-mente trasformata nei successivi maestri francescani, per giungere fino a san Bonaventura.
Le parole chiave per definire il significato dei frutti spirituali sono delec-tatio, refectio e pastus. Lungo il nostro percorso abbiamo assistito ad unaprogressiva evoluzione della classificazione “ontologica” dei frutti, cheman mano vengono distinti dagli abiti gratuiti, per descrivere non più unadisposizione o abilitazione al godimento spirituale, bensì un oggetto del godimento o un nutrimento spirituale (refectio, pastus). che diventa unaprova o un segno del perfetto stato e uso degli abiti gratuiti.
Sommario – L’Autore esamina il concetto di frutto spirituale nei maestri pariginiprebonaventuriani, in particolare francescani. Il termine fructus viene impiegato indue campi: nell’escatologia, ove ha come fondamento scritturistico un’interpreta-zione allegorica della parabola del seminatore, e nella dottrina sulla grazia, ove è ancorato a Gal 5,22-23. I due filoni interpretativi, trovano una sintesi nell’inse-gnamento di Alessandro di Hales (con i termini di fructus in futuro per gloriame fructus in praesenti per gratiam), che li considera come disposizioni permanen-ti (habitus) che abilitano l’anima al godimento spirituale. Successivamente si assi-ste all’evoluzione del concetto, che tende a significare piuttosto l’oggetto del godi-mento oppure il nutrimento spirituale.
Summary – The author examines the concept of spiritual fruit in the writings of themasters of theology (especially Franciscan) at the University of Paris before the time of St. Bonaventure. The term fruit had come to be used in two areas: first, ineschatology where its scriptural basis was an allegorical interpretation of the para-ble of the sower; and secondly, in the doctrine of grace based on Gal 5,22-23. Thetwo thoughts were synthesized in the teaching of Alexander of Hales who used theterms fructus in futuro per gloriam and fructus in presenti per gratiam, which heconsidered to be lasting dispositions (habitus) that render the soul fit for spiritualdelight. In time the meaning evolved to refer more to the object of delight or spi-ritual nourishment.
geschichte. Eine theologische Untersuchung der Summa Halensis (Alexander von Hales),München 1964.
Horowski:Layout 1 15/12/2009 08:32 Pagina 469