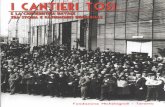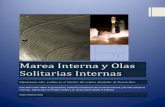MAESTRI E CANTIERI NELLA SICILIA INTERNA TRA XV E XVI SECOLO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of MAESTRI E CANTIERI NELLA SICILIA INTERNA TRA XV E XVI SECOLO
Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nelMediterraneoRivista semestrale di Storia dell’ArchitetturaN. 19/2014
ISSN: 1827-3416ISBN: 978-88-98546-25-1
Tribunale di Palermo. Autorizzazione n. 21 del 20luglio 2005
Edizioni Caracol - Palermo
Direttore responsabile:Marco Rosario Nobile
Consiglio direttivo:Marco Rosario Nobile (Università degli Studi diPalermo-Direttore responsabile)Paola Barbera (Università degli Studi di Catania)Maria Sofia Di Fede (Università degli Studi di Palermo)Emanuela Garofalo (Università degli Studi di Palermo)Stefano Piazza (Università degli Studi di Palermo)Fulvia Scaduto (Università degli Studi di Palermo)Maurizio Vesco (Università degli Studi di Palermo)
Comitato scientifico:Beatriz Blasco Esquivias (Universidad Complutense deMadrid)Monique Chatenet (Centre André Chastel, Paris)Claudia Conforti (Università Roma Tor Vergata)Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid)Alina Payne (Harvard University, Cambridge – MA)
Comitato editoriale:Begoña Alonso Ruiz (Universidad de Cantabria),Isabella Rachele Balestreri (Politecnico di Milano), DirkDe Meyer (Ghent University), Joan Domenge IMesquida (Universitat de Barcelona), Alexandre Gady(Université de Paris IV-Sorbonne), Adriano GhisettiGiavarina (Università Chieti Pescara), MercedesGómez-Ferrer (Universitat de Valencia), Javier IbañezFernández (Universidad de Zaragoza), ElisabettaMolteni (Università Ca’ Foscari Venezia), Erik H. Neil(Academy Art Museum, Easton, Maryland), WalterRossa (Universidade de Coimbra), Sandrine Victor(Université d'Albi), Arturo Zaragozá Catalán(Generalitat Valenciana, Real Academia de Bellas ArtesSan Carlos de Valencia)
Capo redattore:Domenica Sutera
Redazione:Giuseppe Antista, Antonella Armetta, Maria MercedesBares, Mirco Cannella, Sabina Montana, FedericaScibilia
Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nelMediterraneo è una rivista internazionale aventel’obiettivo di diffondere studi e notizie riguardanti lastoria dell’architettura in Sicilia e nel bacino delMediterraneo. Fondata nel 2005, Lexicon. Storie earchitettura in Sicilia e nel Mediterraneo ha unacadenza semestrale.
Le proposte devono essere inviate al direttore della rivi-sta, presso il Dipartimento di Architettura, Viale delleScienze Edificio 8, 90128 Palermo o in alternativa ai se-guenti indirizzi di posta elettronica:[email protected] e [email protected] scritti pervenuti saranno valutati dal consiglio diret-tivo e dal comitato editoriale che, di volta in volta, sot-toporranno i testi ai referees, secondo il criterio del blindpeer review.La rivista adotta un modello di condotta e un codice eticoispirati a obiettivi di correttezza e professionalità, che tro-vano riferimento in quanto stabilito dal Commitee onPubblication Ethics (COPE). Il codice etico e di condottadella rivista è consultabile su http://www.edizionicara-col.it/codice-etico.htlm.
I sommari dei numeri precedenti sono consultabili suhttp://www.edizionicaracol.it/lexicon.htm
Amministrazione:Caracol s.n.c., Piazza Don Luigi Sturzo, 14 – Palermo
© 2014: by Edizioni CaracolStampa: Tipografia Priulla - PalermoPer abbonamenti rivolgersi alla casa editrice Caracol aiseguenti recapiti:e-mail: [email protected]. 091-340011
The research leading to these results hasreceived funding from the European ResearchCouncil under the European Union’s SeventhFramework Programme (FP7/2007-2013)/ERC grant agreement n. 295960 - COSMED
In copertina: a sinistra, C. Scarpa, studio della sezionedelle sale di Antonello, di Colantuono e dei preantonelliani,particolare (Archivio Calandra, Palermo); a destra, La saladi Antonello da Messina (Collezione Pugliatti, Messina).
SOMMARIO
5 Marco Rosario NobileEditoriale
7 José María Guerrero VegaBóvedas centralizadas en la arquitectura árabe-normanda de Sicilia: notas sobre construcción y control formal en los elementos de transición en piedra
21 Marco Rosario NobileMaestri e cantieri nella Sicilia interna tra XV e XVI secolo: le chiese Madri di Pietraperzia e di Assoro
29 Annalisa DameriLa notable campaña del año 1639 del marchese di Leganés. Disegni a Madrid e a Stoccolma
41 Oronzo BrunettiLa città borghese: Martina Franca e Giuseppe Semeraro
55 Matteo IannelloAntonello da Messina e la pittura del ‘400 in Sicilia nell’allestimento di Carlo Scarpa e Roberto Calandra
DOCUMENTI
66 Mercedes Gómez-FerrerUn plano del Castello a mare de Palermo de fines del siglo XVI
73 Maria Sofia Di FedeIl viceré Garçia de Toledo e i cantieri reali. Un loggiato “alla genovese” per Palermo
78 Federico Maria GiammussoI Barrai, picapedrers cagliaritani della seconda metà del Cinquecento. Stato degli studi e nuove ipotesi
83 Federica ScibiliaIl progetto per il cortile del palazzo dell’Università a Catania: una testimonianza documentaria prima del terremoto del 1693
21
Lexicon - n. 19/2014
In un atto del settembre 1524, redatto nella città diAssoro, il maestro Giovan Pietro de Fulcro (oFulchro) si impegnava con donna Antonella Barresiper costruire nella chiesa Madre del centro diPietraperzia (feudo del consorte Matteo Barresi) trearchi, e precisamente l’arco maggiore del Crocifisso ei due collaterali2. Si trattava quasi certamente di defi-nire il setto della prima campata (quella prospicientela navata e immediatamente a ridosso del coro). Lachiesa Madre di Pietraperzia è stata demolita a fineSettecento, ma le absidi poligonali della costruzionesussistono ancora e i dati in nostro possesso consen-tono di elaborare una attendibile ricostruzione3.Come nella consuetudine isolana del tempo, si tratta-va di una chiesa basilicale, con un transetto (occupa-to al centro dal coro) non eccedente e con una nava-ta centrale poco più alta delle laterali. Non sappiamodi che genere fossero i sostegni, ma si possono imma-ginare pilastri poligonali o cilindrici.Il contratto in questione appare interessante da varipunti di vista. Innanzitutto offre notizie su un mae-stro che doveva essere particolarmente apprezzato efidato e su una assortita squadra familiare (nel con-tratto sono richiamati il genero Martino, il figlio
Francesco e i fratelli Cola e Girolamo), certamentecoinvolta in altri lavori nella stessa Assoro. Per spie-gare l’incarico di Pietraperzia si possono con qualchesicurezza ipotizzare precedenti impegni nella chiesaMadre, dedicata a San Leone, ad Assoro, che dovevaessere stata tracciata alla fine degli anni Ottanta delQuattrocento4. Quando poi nel 1533 il nuovo signoredella città Giovanni Valguarnera richiese di rinnova-re il proprio palazzo, aggiungendo un portico sucolonne disegnato dal pittore Angelo Lo Chirco, ilmaestro Silvestro de Cortisio di Troina venne incari-cato «di dirupari etiam quillo arco havia facto ettagliato lo quondam mastro Johan Petro»5.Quest’ultimo è quasi certamente da identificare conde Fulcro. Si tratta di un indizio sufficiente per sup-porre lavori svolti una generazione prima e con ungusto radicalmente diverso da quello promosso dalgiovane barone, reduce da un soggiorno a Messinadove aveva rivestito la carica di strategoto6 e doveera entrato in contatto con un vivace ambiente arti-stico. Il ruolo assunto da Angelo Lo Chircho7 e lenuove commissioni affidate a maestri con una for-mazione culturale differente indicano come adAssoro negli anni Trenta del Cinquecento ci sia stata
MAESTRI E CANTIERI NELLA SICILIA INTERNA TRA XV E XVI SECOLO: LE CHIESEMADRI DI PIETRAPERZIA E DI ASSORO1
Marco Rosario NobileProfessore ordinario, Università degli Studi di [email protected]
AbstractMaster Builders and Yards of the Interior of Sicily Between the 15th and 16th Century: the Mother church ofPietraperzia and that of AssoroThe essay focuses on two yards of the interior of Sicily between the end of the fifteenth century and the first half of the six-teenth century: the mother church of Pietraperzia and that of Assoro. New documentary investigations allowed to set out themaster builders involved in the construction process and to deduce some construction methods in use for churches basilica.These data, together with the direct observation of the buildings have allowed to hypothesize, in both cases, the original con-figuration of the churches.The hypotheses were supported by a comparison with contemporary building, similar to typological characteristics, and are-reading of the archival documents referring to them, revealing a series of plots that bind sites, master builders and aris-tocratic patrons.
KeywordsMaster builders, aristocratic patrons, Sicily 15th and 16th century, history of construction, mother church of Pietraperzia and Assoro.
una vera e propria mutazione di orizzonti8.Basterebbero qui ricordare i casi delle nuove cappel-le realizzate per completamenti della chiesa Madredella città a cavallo di queste date. Nel 1519 unasquadra di maestri napoletani (Michele Bongiorno,Disiato Guagliardo, Sansonetto Capharo) si impegnaa completare una cappella con coperture a crociera[fig. 1] iniziata dal maestro Pietro de Vitale9. Nel 1543la nuova cappella del Crocifisso venne invece affida-ta a un maestro che evidentemente padroneggiava illinguaggio del Classicismo: Domenico di Firenze10.Un ulteriore motivo di interesse del documento perla chiesa di Pietraperzia è legato alla possibilità didedurne alcune modalità di prassi costruttiva dellechiese basilicali siciliane. Il contratto di de Fulcro sipone a seguito della costruzione delle absidi e dellemura perimetrali e la posizione dei due sostegniintermedi determina l’ampiezza dell’arco maggioree delle arcate minori11. Si trattava cioè di realizzareun diaframma composto da tre arcate e forse anche idue archi perpendicolari di collegamento con la tri-buna [fig. 2]. In alcuni casi questo sistema di connes-sioni tra sostegni poteva essere proseguito lungo ilcorpo della navata, realizzando sequenze ternarie diarchi trasversali e collegamenti longitudinali, unen-do cioè un setto all’altro. Da quello che si può osser-vare in altre fabbriche isolane ancora esistenti, sideterminava una gabbia muraria adatta alla even-tuale successiva costruzione di crociere reali, mentrela realizzazione contemporanea delle arcate era inbuona misura funzionale anche a equilibrare le spin-te su sostegni spesso molto esili. Un documento relativo alla chiesa Madre diCaltabellotta può chiarire le modalità contrattuali concui si prescriveva questa procedura. In un atto del 6febbraio 1530 gli architectores maltesi GiulianoAttardo e Giuliano Mecca (veri dominatori delmondo della costruzione nella cittadina) si impegna-vano a «construere arcum unum cum suis arkectis delapidibus incisis qualitatis et bolitatis alius arci con-structi alias per dictum magistrum JualianumActarducum suis arkectis intus eandem ecclesiam»12.L’arcum unum indicato nel documento è uno di quellisulla navata centrale, con il termine arkectis si defini-scono gli archi minori laterali del diaframma e quellidelle due ali che separano le navate. Significativoappare che a Caltabellotta solo alcuni comparti deltelaio di setti determinati dalla struttura murariasiano attualmente coperti con crociere [fig. 3].
22
Fig. 1. Assoro. Chiesa Madre, volta a cinque chiavi.
Fig. 2. Pietraperzia. Chiesa Madre, ipotesi ricostruttiva (elabora-zione grafica Federico Giammusso).
23
Lexicon - n. 19/2014
Anche in questo caso la documentazione sembrarestituire tutta la delicatezza del momento in cui sicostruivano le arcate e la necessità di affidarsi a mae-stri competenti per il controllo sulla tenuta dellastruttura e la buona esecuzione dell’insieme. Adispetto di chi ripone fiducia incondizionata nelladocumentazione notarile, i limiti storiografici sonoevidenti: i contratti sono altrettanti brevi flash isolatidi vicende in movimento e non sempre la sequenzaappare lineare e gli attori coinvolti perfettamenteiscrivibili in un percorso. Probabilmente solo il con-fronto tra una serie documentaria omogenea puòchiarire alcuni passaggi. Tuttavia le specifiche con-tingenze dovevano influenzare molto il processocostruttivo. Così il pagamento effettuato nel 1560 almaestro Hyeronimus Vicchiuzzo per avere costruito(non sappiamo quanti anni prima) «septemarcus,uno pilastro e dui vinestri» nella chiesa di Sant’Olivaad Alcamo sembra indicare la costruzione di un’inte-ra ala della chiesa che era stata cominciata nel 1533dal maestro genovese Bernardino Lisaxi (o Lisasce)13.Nel novembre 1570 il maestro Giovanni Lo Presti diVizzini si impegnava per la chiesa Madre diChiaramonte a «manufacere, edificare et magistrali-ter complere tres arcos […] ex quinque archis ad pre-sens in dicta ecclesia existentibus» oltre che comple-tare un ulteriore arco già iniziato14. Si può immagina-re che problemi di natura finanziaria, e forse persinol’indisponibilità dell’intero lotto destinato alla fab-brica, dovevano consigliare procedure più articolate.Contratti di questo tipo comportano comunque unaoggettiva difficoltà a comprendere lo stadio in cui sitrovava il cantiere.Rari sono quindi i casi dove la successione degliavvenimenti segue un percorso limpido e perfetta-mente intellegibile. Si può esaminare, per esempio, ilcaso della chiesa Madre di Carini15. Sappiamo chenegli anni Trenta del XVI secolo si stavano costruen-do delle cappelle, una di esse doveva contenere ilsepolcro (monumentum marmoreum) dei La Grua(1535). Nel 1539 il maestro Mariano de Artali siimpegnava a costruire la cappella del Crocifisso. Sitratta evidentemente della fase relativa alla realizza-zione del perimetro murario, e la dimensione deisetti delle cappelle era già funzionale al tipo dicopertura prevista. Nel novembre 1550 (o 1551) siraccoglieva materiale da costruzione (attratto), com-preso «li peczi degli archi» che comunque risultano«jam incepti»16. Nel 1552 il maestro Giovanni de
Amore si obbligò con i marammieri (fabbricieri)della chiesa madre di mettere in opera «quatuorarcos cum archettu»17, mentre allo stesso tempo siindicavano gli esperti che avrebbero dovuto valuta-re la buona esecuzione dell’opera: Jordano de Callari(Cagliari) e Marco Sidoto18.La sequenza che offre la storia documentabile sullachiesa Madre di Carini finisce però per aprire altriquesiti. Suddividere le fasi di costruzione del peri-metro e delle cappelle, di acquisizione del materialeda costruzione e della sua posa in opera comportanecessariamente una regia dei fabbricieri (marammie-ri) a partire da un progetto condiviso. Da questopunto di vista però le informazioni documentariesono quasi sempre reticenti, a parte un problematicodisegno documentato per la già citata chiesa diCaltabellotta19, o il modello ligneo per la chiesa diSanta Maria La Nova a Palermo del 153220, solo indocumenti degli anni Sessanta il progetto delle chie-se basilicali sembra subire una svolta21. Basare lenostre ipotesi però solo su consuetudini e su formu-le notarili che variano nel tempo è comunquerischioso; niente esclude che esistessero dei progetti,mentre che responsabilità e che tipo di controllo del-l’insieme e dei dettagli esercitassero i maestri impe-gnati nella costruzione di chiese basilicali in Sicilia èancora un problema aperto.Anche se la chiesa cinquecentesca di Carini rimase alungo senza coperture reali, Giovanni de Amore sem-bra possedere il curriculum giusto per affrontarel’impegno; in quegli anni prestava servizio per i LaGrua nel castello di Carini22, ma sappiamo che avevalavorato a fianco di Antonio Peris nei cantieri del por-
Fig. 3. Caltabellotta. Chiesa Madre.
24
tico settentrionale della cattedrale di Palermo e nellachiesa di Santa Maria La Nova della stessa città23.Se su alcune personalità le informazioni permettonoin qualche modo di delineare una traiettoria e uncurriculum, il caso del maestro chiamato a realizzarele arcate della chiesa di Pietraperzia appare ancoratroppo sfocato. Il prestigio di de Fulcro è confermatoda due contratti di apprendistato24 e la trasmissionedei saperi costruttivi (che non tutti sono in grado disostenere sia come impegno economico che comeeffettivo dominio delle competenze) costituisce il filorosso di un fenomeno che attraversa le generazioni egarantisce per quanto possibile delle continuità25. Quello che si potrebbe ipotizzare a questo punto èche tra fine XV secolo e i primi due decenni del suc-cessivo alcuni importanti cantieri dell’interno del-l’isola devono avere svolto un ruolo trainante, diven-tando anche luogo di formazione per nuove leve.Oltre alla chiesa di San Leon ad Assoro, su cui sarànecessario tornare, si potrebbero citare le fabbrichedelle chiese maggiori di Nicosia, Castrogiovanni ePiazza26, tutte in costruzione nel periodo considerato.
Sappiamo, dalle ricerche di Emanuela Garofalo, chenel 1523 (l’anno precedente dell’incarico assunto dade Fulcro a Pietraperzia) il maestro JoanneCastiglianu era impegnato nella costruzione delgrande portale maggiore della chiesa Madre diEnna, oggi scomparso27.La presenza di un maestro castigliano aCastrogiovanni potrebbe costituire un primo buonindizio per spiegare determinati fenomeni, maovviamente la documentazione è troppo lacunosaper ricavarne certezze mentre alcune prove indizia-rie aprono altri scenari. Una tra queste potrebberiguardare Ioanne Bergognon. Di questo maestro,certamente di origine francese, possediamo esigueinformazioni. Nel 1491 lavora con MatteoCarnilivari nel cantiere di palazzo Aiutamicristo28, inquesta occasione viene definito francigena, fabricator.Nel settembre 1499 è cives Panormi ed è coinvolto nelcompletamento di arcate («ad extollendos arcos lapi-deos jam elaboratos») nella chiesa di San Paolo aCaltabellotta29. Nello stesso documento la definizio-ne cassata (e non trascritta da Meli) di Aragonisi indi-
Fig. 4. Assoro. Chiesa Madre (foto di Antonio Caffo).
25
Lexicon - n. 19/2014
ca con buona certezza la tappa intermedia del suopercorso30. Non possediamo altre notizie: pur usu-fruendo della cittadinanza di Palermo sembra proba-bile che la sua attività si sia svolta soprattutto fuoridalla capitale dell’isola. Per il poco che sappiamo,Bergognon sembra essere giunto in Sicilia pocoprima del 1491 ma il suo profilo non rientra nellacategoria dei professionisti itineranti ma in quella diun maestro che a Palermo era venuto in contatto concommittenti aristocratici che gli offrirono alcuneopportunità di lavoro nei loro feudi.Il primo giugno 1531 ad Assoro Vincenzo de Galixiodi Nicosia, procuratore di «Jannelle (sic) deMontesano, filie quondam magistri Joannis deBurgognono et Novelle, eius uxoris» vende alla chie-sa madre di Assoro una casa terrana adiacente allachiesa stessa31. Si tratta di un indizio da perseguire.Esiste certo il pericolo di omonimie, ma la consuetu-dine di offrire una abitazione-bottega ai maestriaccanto al cantiere non costituisce un avvenimentoinfrequente32. Ne potremmo dedurre un coinvolgi-mento, almeno nella prima fase di costruzione, delfrancese nella chiesa-mausoleo dei Valguarnera?Niente lo esclude. Si ricorderà poi che uno dei proba-bili promotori della fabbrica è Jaime Valguarnera,vescovo di Mdina (tra 1495 e 1501), scomparso nel1511 e seppellito nella chiesa di famiglia.Forse alla personalità di un religioso possono ascri-versi alcune scelte generali attuate nel disegno dellafabbrica. Va subito precisato che le date di edificazio-ne sono ancora fluttuanti e i punti fermi non sononecessariamente delle prove sicure. Gnolfo indica il1486 come inizio della ricostruzione33. La data del 1490inserito in una trave difficilmente può costituire laconclusione dei lavori (il tetto segue necessariamentela posa in opera dei sostegni e delle arcate), quantoforse indicare la sottoscrizione di un legato. In linea dimassima si può pensare a una fase di attività costrut-tive che occupa l’ultimo decennio del XV secolo. Perquanto riguarda gli aspetti linguistici, la soluzionecon il transetto bipartito appare in realtà un criteriodiffuso nella pratica del tempo, ma non è detto checostituiscano un ripiego, dopo avere tentato la costru-zione di un transetto a una sola arcata. Come è noto lafabbrica attuale [fig. 4] possiede delle colonne salomo-niche, frutto di un rifacimento attuato tra fine XVII eprimo XVIII secolo. Le basi tardogotiche prefiguranotuttavia un pilastro originario differente. Il primosostegno del lato settentrionale è stato parzialmente
liberato e mostra un fusto cilindrico originario e sud-diviso in rocchi [fig. 5]. Alla prima impressione il dia-metro del sostegno risulta gracile, non commisuratoalla dimensione delle basi. All’interno del blocco isegni della scalpellatura si intensificano lungo un per-corso a spirale, come se questa parte avesse resonecessaria una intensità differente di lavorazione. Ilsospetto, a questo punto, è che i rocchi fossero arric-chiti da un cordone avvolgente. Se, con molto azzar-do, si immagina che tutti i sostegni fossero uguali, unsistema standardizzato di rocchi poteva permettereun inusitato effetto fasciato, a serpentina, probabil-mente decorato a fogliame34 [fig. 6]. Questo tipo dicolonna avvolta da una spirale di foglie è più che unacongettura: compare nelle contemporanee incisioni diPhilippe Pigouchet [fig. 7] e l’ipotesi che l’idea sia nataa partire da modelli presenti in un libro d’hore france-se non è affatto improbabile35. Potrebbe essere statoBergognon il maestro in grado di offrire una rispostadi questo tipo? Si trattava forse dello stesso arteficeche ha formato i quadri degli operatori coinvolti nelprogetto della chiesa madre di Pietraperzia?
Fig. 5. Assoro. Chiesa Madre, primo sostegno del lato settentrionale.
26
Il ricorso a procedure che sembrano comuni e con-venzionali, ma che erano sostanzialmente esplose informa esponenziale nelle chiese dell’isola solo a par-tire da una o due generazioni, costituisce una spia.Costretti come siamo a fare affidamento solo su laco-nici contratti da costruzione, finisce per sfuggirequanto plausibile, in molti casi sospettabile: le inten-se relazioni che legano cantieri diversi, committentiaristocratici, maestri itineranti e nuovi operatori. SeBergognon ha lavorato per la chiesa di Assoro, il casodi de Fulcro e forse persino la misteriosa colonia dicostruttori maltesi attivi in Sicilia e a Caltabellotta36,potrebbero trovare una spiegazione in una primafase di apprendistato con il maestro francese.
Fig. 7. Hore beatissime Marie Virginis secundum usum roma-ne ecclesie, Paris 1504 (Palermo, Biblioteca Cantrale della RegioneSiciliana, rari 336).
Fig. 6. Assoro. Chiesa Madre, ipotesi ricostruttiva (elaborazionegrafica Federico Giammusso).
1 Ho cominciato ad affrontare alcuni tra questi argomenti nel volume Chiese colonnari in Sicilia (XVI secolo), Palermo 2009. Le tesi esposte in quellaoccasione sono per me ancora valide, la ricerca continua però a illuminare episodi e aspetti non secondari che possono arricchire il tema. Desideroringraziare i dottori Sabina Montana per i suggerimenti e Maurizio Vesco per l’interpretazione e corretta trascrizione dei documenti. Con entrambiho avuto proficui scambi di vedute. 2 «Lu arcu grandi di lu crucifixu et li dui archi di banda dicti arcus magni». Archivio di stato Enna (ASEn), Notai Defunti, not. F. Di Stefano, vol. 631,c. 229r, 20 settembre 1524. Per la Pietraperzia di Matteo Barresi si rimanda a F. SCIBILIA, Una corte feudale tra medioevo ed età moderna: i Barresi diPietraperzia, tesi di dottorato in “Storia dell’Architettura e Conservazione dei Beni Architettonici”-XX ciclo, tutor Prof. Arch. M.R. Nobile, cotutor Prof.Arch. A. Ghisetti Gavarina, Università degli Studi di Palermo, 2009.3 Si vedano le testimonianze raccolte e pubblicate in G. CULMONE, Alla scoperta delle radici. Viaggio attraverso l’archivio della parrocchia Santa MariaMaggiore di Pietraperzia, Caltanissetta 2010, pp. 152-153 e pp. 233-236.4 La datazione segnata in una trave della copertura (1490) può risultare indicativa: G. GNOLFO, Basilica San Leone Assoro, II ed. a cura di G. Nigrelli,Assoro 2009. Si vedano anche gli articoli di Paolo Russo e Raffaello Di Mauro, contenuti in «Kalós, arte in Sicilia», luglio-settembre 2012, pp. 4-17.Non mi sembrano condivisibili (ma si tratta di un problema che coinvolge tante chiese siciliane: da Caltabellotta a Santa Maria Maggiore a Randazzo)le presunteorigini normanne. Si tratta quasi sempre di invenzioni otto o novecentesche, che si appoggiano su dati documentari fragili (l’esistenza
27
Lexicon - n. 19/2014
delle istituzioni non comporta la presenza delle chiese così come le vediamo), mentre i dati documentari certi e la conformazione delle strutturedenunciano una appartenenza a fasi molto successive.5 ASEn, Notai Defunti, not. F. Di Stefano, vol. 555, c. 441r, 24 maggio 1533.6 V. AMICO, Lexicon topographicum siculum..., Palermo-Catania 1757-60, 3 voll. ed consultata Dizionario topografico della Sicilia. Tradotto e annotato daGioacchino Di Marzo, Palermo 1855, 2 voll., I, p. 113.7 Un primo incarico offerto al pittore è quello per l’impegnativa campagna di pittura dei soffitti del palazzo dei Valguarnera («depingere tectum salemagne domus ipsius spectabilis nec non tecta camerarum»). ASEn, Notai Defunti, not. F. Di Stefano, vol. 632, c. 152r, 6 ottobre 1530. Lo stesso giornoil barone di Assoro aveva incaricato il maestro Pino di Gagliano del rifacimento dei tetti della sua dimora (ivi, f. 151v).8 Ricordiamo per esempio la presenza ad Assoro di un maestro di grande reputazione come Pietro Oddo, impegnato in questa occasione in opere diidraulica. Ivi, c. 314r, 6 febbraio 1532.9 Ivi, vol. 631, c. 11v, 19 agosto 1519. Si tratta forse delle due cappelle con crociere dell’ala sinistra del transetto (una a sei costoloni e una a cinquechiavi), mentre una delle clausole del contratto indica: «dicti magistri teneantur perficere unam aliam crucem ultra alias cruces accordatas in primocontractu cum magistro Petro pro ut cruces intelligantur et vulgari nomine vocit antes crucharici...».10 Ivi, vol. 616, c. 449v, 12 ottobre1543. L’opera sarebbe stata sottoposta a perizia ai Gian Domenico Gagini e a Raffaele di Firenze. Ivi, not. G. Raimondi,vol. 613, c. 30r, 26 novembre 1545 (ringrazio Paolo Russo per la segnalazione). Raffaele da Firenze è certamente Raffaele Russo. Si ricorderà che qual-che anno dopo Russo e Gagini si ritroveranno a eseguire alcuni piloni della chiesa madre di Enna (E. GAROFALO, La rinascita cinquecentesca del duomodi Enna, Palermo 2007).11 Per la conformazione geometrica da dare alle arcate doveva esistere una certa libertà di azione, si ricordino comunque le indicazioni prescritte nelcontratto di Gabriele da Como (marzo 1498) : «archi di terzupuntu, cum la alticza, chi rispundirà la raxuni di li culonni». G. DI MARZO, I Gagini e lascultura in Sicilia nei secoli XV e XVI, II, Palermo 1884, pp. 3-4, doc. III. In genere il sostegno era quindi il parametro base per tracciare le forme dellearcate. Una simile procedura si può ritrovare nella fabbrica della chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Palermo, allorché nell’ottobre 1538 AntonioScalone venne incaricato di «assectari li chinco archi chi venino supradicticolonni, li tri archi chi infruntano a li maragmi di dicta ecclesia et li dui chiinfruntano a li pelastri di la tribona grandi» F. MELI,Matteo Carnilivari e l’architettura del Quattro e Cinquecento in Palermo, Roma 1958, doc.149.12 Archivio di Stato di Agrigento (ASAg), Notai Defunti, sez. Sciacca, not. V. Pastamolla, vol. aa. 1529-30, cc. 234v-235r, 6 febbraio 1530.13 V. REGINA, Alcamo. Storia, arte e tradizione, Palermo 1980, pp. 83, 85. La natura del documento (un pagamento a consuntivo) si trova in F.M.MIRABELLA, Alcamo Sacra, Alcamo 1956, p. 90.14 Archivio di Stato di Ragusa (ASRg), sez. Modica, Notai Defunti, not. S. Amellis, n. corda 16, vol. 2, 1570-71, c.113v, 18 novembre 1570. Il documen-to è stato rintracciato e trascritto dal dott. Maurizio Vesco nell’ambito del progetto COSMED.15 I documenti sono segnalati in G. FILINGERI, Carini nel Cinquecento: Storia, arte, cultura e il caso della baronessa, Montelepre 2008, pp. 233-235.16 Ivi, p. 234. Il fornitore dei materiali è il maestro Francesco De Cristina.17 Archivio di Stato di Palermo (ASPa), Notai Defunti, st. V, not. V. Lo Vecchio, c. 435v, 26 luglio 1552 (segnalato in G. FILINGERI, Carini nel Cinquecento…, cit.).18 I due periti prescrissero che il maestro era tenuto a «facere li bardelli chi mancano supra unoarco», ivi, c. 436v, 26 luglio 1552. Il termine appare nelcantiere di Santa Maria di Portosalvo a Palermo, allorché Antonio Scalone «devi assectari li bardelli supra li tre archetti chi vennosupradicticolonni.Item devi assectari li crucharizi di intaglio, chi venino supra li chinco archetti a lu titolo di dicta ecclesia». F. MELI,Matteo Carnilivari…, cit., doc 149.In un documento successivo Scalone si impegna a «fari li archi et cumbigliari secundum suoi archi di lu titolo» (ivi, doc. 150). Con cautela si potreb-be sostenere che i bardelli vadano interpretati come le imposte delle volte. In realtà i documenti non offrono molte prove sulla predisposizione con-testuale di imposte (mensole, tas de charge…), funzionali alla costruzione delle crociere. Sembra che nella maggioranza delle chiese basilicali sicilianedella prima metà del XVI secolo la costruzione dei dammusi (volte reali) fosse una opzione da prendere in considerazione solo in un secondo tempo.Una operazione a rischio e in alcuni casi fallimentare come dimostra la richiesta del vicario del vescovo di Catania di recuperare le «onze 20 qualihappimagistro Bernardino di lima per voleri fari lamia in lu tetto di ditta ecclesia et da poi non si fici per lo piriculo chi haviria cascato ditta eccle-sia» (26 giugno 1576). E. GAROFALO, La rinascita cinquecentesca…, cit. alla nota 8, p. 97.19 «Magister Julianus Actardu architeptor coram nobis sponte promisit et solleniter convenit seque obligavit et obligat venerabili presbitero Antoniode Pilaya, archipresbitero terre Calatabillotte, venerebili presbitero Petro de Graciano vicario et procuratori majoris ecclesie dicte terre et nobilibusAntonio de Mercatanti, Marco de Cusumano et Jacobo Jurano (?) juratis anni presentis dicte terre presentibus et stipulantibus nomine dictemajorisecclesie reparare et edificare dictam maiorem ecclesiam juxta designum sibi exibendum et consignandum per venerabilem presbiterum CathaldumTriscalihinc et per totum mensem septembris anni VI.e indicionis proxime futuris alias». ASAg, Notai Defunti, sez. Sciacca, not. V. Pastamolla, vol.aa. 1531-33, cc. 57v-58r, 28 settembre 1531. Si noti che questo contratto è successivo a quello dove Giuliano Attardo si impegna a realizzare gli archidella navata.20 F. MELI, Matteo Carnilivari…, cit., doc. 172. Ho segnalato il ruolo di Peris in questo progetto in M.R. NOBILE, Chiese colonnari in Sicilia…, cit., pp. 25-29.21 Questo è il caso della chiesa madre di Bisacquino, per la quale il maestro di Monreale Blasio Nicolosi nel 1565 si obbliga alla fornitura dei materia-li e alla costruzione «iuxta formam cuiusdam modelli per ipsum magistrum Blasium facti»; si veda: A.G. MARCHESE, La chiesa madre di Bisacquino.Artisti, maestranze e committenti dal Cinquecento al Settecento, Palermo 2008, doc. 1, p. 131. All’avvio della costruzione della chiesa madre di Caltanissetta(1 aprile 1566), il fabricator di Palermo Nicola Fachenti si impegna ad avviare la fabbrica«juxta la forma dilo modello» che gli viene fornito dai giura-
ti, e a realizzare una chiesa «tutta voltata a lamia» (cioè con crociere, a questa data probabilmente nude), G. GIUGNO, Caltanissetta dei Moncada, il pro-getto di città moderna, Caltanissetta 2012, doc 14, p. 176.22 G. FILINGERI, Carini nel Cinquecento…, cit., p. 104, nota 285. Il maestro è documentato nel cantiere nel 1546.23 M. VESCO, Cantieri e maestri a Palermo tra tardogotico e rinascimento: nuove acquisizioni documentarie, in «Lexicon. Storie e architettura in Sicilia», 5/6,2007-08, pp. 47-64, alla p. 57. Nel 1543 viene compensato per «il dammuso di lo tocco», cioè delle tre crociere del portico di Santa Maria La Nova aPalermo (F. MELI, Matteo Carnilivari…, cit., doc. 172). Per la stessa opera risulta coinvolto nel 1545 Antonio Natale, ma il trasferimento definitivo aCarini di Amore può essere stato determinato dall’abbandono del progetto di Peris e dall’arrivo nel cantiere di Santa Maria la Nova dell’architettoGiuseppe Spadafora.24 Martino Caimarano della terra di Nicosia si obbliga a maestro Giovan Pietro de Fulcro (Fulchro) «magistro di maramma» per servirgli da famiglioper tre anni imparando l’arte «di murari e tagliari»; Salvatore de Galeramo, al momento abitante nella terra di Assoro, si obbliga a maestro GiovanPietro de Fulcro (Fulchro) «magistro di maramma» per servirlo in cantiere per tre anni imparando l’arte. ASEn, Notai Defunti, not. F. Di Stefano, vol.631, cc. 50r e 259r, 18 gennaio 1523 e 5 febbraio 1525.25 Il fenomeno dell’apprendistato nella Sicilia tra XV e XVI secolo meriterebbe di essere indagato in tutti i suoi risvolti. Da questo punto di vista unprimato sembra possedere il maestro Joanne Manuella di Noto, con il quale tra 1520 e 1530 si stipulano quattro accordi di apprendistato (SantoroSortino, Francesco Deodato, Francesco Barba, Giovanni Robbino) e un contratto di prestazione alle sue dipendenze (Agostino La Ferla). F. BALSAMO,Giovanni Manuella. Protagonista del rinascimento netino tra fine Quattrocento e inizi Cinquecento, «Atti e memorie I.S.V.N.A.», serie II, 11-12 (2007-2008),pp. 43-70. Alcuni tra gli allievi di Manuella avranno un buon successo professionale. 26 La chiesa Madre di Piazza viene iniziata nel 1496, nel 1513 la tribuna era completata e nel 1517 si avviava la fabbrica del campanile. Si veda: D.SUTERA, La chiesa madre di Piazza Armerina. Dalla riforma cinquecentesca al progetto di Orazio Torriani, Caltanissetta 2010, p. 25.27 E. GAROFALO, La “rinascita” cinquecentesca del duomo di Enna, tesi di dottorato in “Storia dell’Architettura e Conservazione dei Beni Architettonici”-XIV ciclo, tutor Prof. Arch. M.R. Nobile, cotutor Prof. Arch. C. Conforti, Università degli Studi di Palermo, 2 voll., 2004, Allegati, II, p. 12. Nello stes-so cantiere si ricorda la presenza di un maestro orologiaio hispanus, Antoninus Robianus, compensato per le sue prestazioni nel 1536 (ivi, p. 50).28 F. ROTOLO, Matteo Carnilivari. Revisione e documenti, Palermo 1985, p. 163. Documento del primo marzo 1491.29 F. MELI, Matteo Carnilivari…, cit., doc. 52. 30 Il medesimo percorso si può ipotizzare per un’altra personalità come Jaiumu lu Francisi che nel 1487 è tra i membri della corporazione dei fabrica-tores di Palermo, si veda per ultimo E. GAROFALO, Le arti del costruire. Corporazioni edili, mestieri e regole nel Mediterraneo aragonese (XV-XVI secolo),Palermo 2010, pp.241-243. Potrebbe trattarsi dello stesso maestro Jaume le Frances presente a Girona negli anni Sessanta del XV secolo. P. FREIXAS I
CAMPS, L’art gòtic a Girona, Girona 1983, p. 347.31 ASEn, Notai Defunti, not. F. Di Stefano, vol. 632, c. 230v.32 Si vedano i casi segnalati da Emanuela Garofalo (E. GAROFALO, La “rinascita” cinquecentesca…, cit., p. 54).33 G. GNOLFO, Basilica…, cit., alla nota 4.34 Si tratterebbe comunque di una soluzione radicalmente diversa dai sostegni a spirale in uso in molteplici fabbriche europee coeve. Si vedano gliesempi rammentati in A. ZARAGOZÁ, M. GÓMEZ-FERRER, Pere Compte arquitecto, Valencia 2007, p. 99.35 Pigouchet è attivo a partire dal 1488 ca. Un raro libro d’hore di Pigouchet (Hore beatissime Maria Virginis, 1504) è conservato alla Biblioteca Regionaledi Palermo e il suo possibile uso come modello è stato segnalato in F. SCADUTO, Il progetto: fonti e modelli, in Matteo Carnilivari, Pere Compte, 1506-2006.Due maestri del gotico nel Mediterraneo, a cura di M.R. Nobile, Palermo 2006, pp. 170-179. Un recente lavoro ha mostrato come un Libro d’hore, appar-tenente a un architetto sia interpretabile anche come repertorio personale di forme: L. CIAVALDINI RIVIÈRE, Aux premères heures du monastère de Brou.Un architecte, une reine, un livre, Paris 2014.36 Ricordiamo inoltre che nel 1533 Giovanni Valguarnera avrebbe sposato Giovanna De Luna e Peralta, figlia del conte di Caltabellotta: F. SAN
MARTINO DE SPUCCHES, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia, Palermo 1924-41, 10 voll., I, pp. 168-169.
28