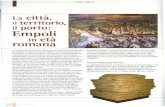Il luogo e il volto. Note a margine della crisi del monumento dopo il 1945
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia...
Transcript of La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia...
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA – DISLL
La molteplice direzionetemporale
nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica
dei secoli futuri
CORSO DI SOCIOLOGIA DELLA LETTERATURAtenuto dal ch.mo prof. CESARE DE MICHELIS
Alessandra Munari
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
(matricola 1057459, corso magistrale di Filologia moderna)
a.a. 2012/13, II semestre
1
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
Sommario
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano:fra Il Varmo e la Storia............. Filosofica dei secoli futuri.................................................................2
Bibliografia e sitografia.......................................13
2
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
La molteplice direzione temporale nelle Confessionid’un italiano:
fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri
Se ci figuriamo la Storia umana, e più specificamente nazionale,con la metafora geometrica di una retta, l’arco temporale lungo cuisi snodano le Confessioni d’un italiano si delinea allora come un segmentoorientato, cioè una porzione di tale retta delimitata da due punti(misurabile, quindi) e dotata di una direzione secondo cuipercorrerla, indicata dalla punta della freccia: la lunghezza delsegmento nieviano si quantifica allora negli ottantatré anniintercorsi tra i due estremi della vita del protagonista, Carlino.Straordinariamente, il segmento delle Confessioni è doppiamenteorientato, in entrambi i versi, contemporaneamente incontro alpassato e al futuro, così come è doppio il presente entro cui simuove Carlino, narrato e narrante, quest’ultimo tra l’altrocoincidente con lo stesso presente dell’autore.
Una prima dichiarazione d’intenti sulla dinamica temporale nelleConfessioni d’un italiano si annuncia già dal titolo, insieme rematico(“confessioni”) e tematico (“d’un italiano”). L’esposizione sottoforma di “confessione” non implica soltanto la narrazione in prima
3
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
persona, uso caro alla tradizione del romanzo, specie a quellapatriottico-risorgimentale sin dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis,rispondente alle esigenze di verosimiglianza e di identificazione collettore, tratti essenziali per il fine pedagogico-progettuale deltesto nieviano. Il termine rinvia a diversi ambiti, innanzituttoquello letterario, facendo risuonare l’archetipo agostiniano e ilprecedente rousseauiano, nel recupero nieviano rispettivamenteristretti da quel “d’un italiano” ad una dimensione di fede politicainvece che ultraterrena e nazionale piuttosto che universale. Sullascia di Agostino, la parola rimanda anche al lessico religioso, percui confessio anticamente indicava sia il riconoscimento dei peccaticompiuti nel passato, sia la testimonianza di fede resa nel presente(confiteor), sia la lode a Dio per la salvezza promessa per il futuro(si rileggano le prime righe, programmatiche, delle Confessiones). PerNievo questo processo di revisione del passato personale diventamateriale per uno studio “induttivo”, simile a quellodell’illuminista francese (“intendo mostrare ai miei simili un uomoin tutta la verità della sua natura; e quest’uomo sarò io”1), macircoscritto alla dimensione politica nazionale in Nievo: “come ilcader d'una goccia rappresenta la direzione della pioggia. Cosìl'esposizione de' casi miei sarà quasi un esemplare di quelleinnumerevoli sorti individuali che dallo sfasciarsi dei vecchiordinamenti politici al raffazzonarsi dei presenti composero la gransorte nazionale italiana”2. Anche nella terminologia giuridica, certonota a Nievo, la confessione si configura come un tipo speciale ditestimonianza, da cui si distingue in senso stretto per il fatto chela prima è fornita non da un terzo, ma da una persona direttamentecoinvolta nella causa. Collante dei tre tempi, d’altronde, ci svelaAgostino, è la soggettività della persona, che solo con un atto diintrospezione nella profondità dell’animo, nella lontananza delproprio passato, può comprendere l’altezza e l’imminenza del progettodi salvezza universale, perché solo la riscoperta delle radici puòfar riemergere la propria identità nel presente e affiorareun’ispirazione per il futuro: identità cristiana nell’autorepatristico, nazionale in Nievo.
Si transita così alla seconda metà del titolo del romanzo, dovela nazionalità italiana si afferma chiara nella nuditàdell’aggettivo, che da attributo si sostantiva e mette in primo pianoun momento storico ben preciso, il Risorgimento: capovolgendo la1 ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, Confessioni, consultato al sito (vd. bibliografia finale): <http://147.163.40.2/doc/401/Rousseau_._Confessioni.docx>2 NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni di un italiano, Roma, Carlo Colombo, 1943, p.3.D’ora in poi per brevità citeremo il romanzo più celebre di Nievo con Confessioninel testo e con NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni, op.cit. in nota.
4
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
famosa affermazione di D’Azeglio (“fatta l’Italia, bisogna fare gliitaliani”), Nievo sottintende che gli italiani esistono già, eredi diuna tradizione nazionale culturale, letteraria, storica,antropologica, precedente alla creazione dello stato, cui aspiranoappellandosi al diritto di autodeterminazione dei popoli. La svoltarisorgimentale che porterà dagli italiani all’Italia è ancora infieri, ma Nievo la considera evidente e inevitabile, date lepremesse: il Risorgimento non è lo scoppio improvviso di una nuovaideologia politica, ma la maturazione di un lungo processofecondativo che si è nutrito per secoli delle idee dei più grandipensatori e letterati italiani, in una catena di cui Nievo-Carlinorappresenta un ultimo anello proprio nell’atto di stendere in “noveanni”3 le Confessioni, con l’idea di spronare gli animi alla rivoluzione,ad una rivoluzione “ragionevole”, mettendo a frutto la lezione delfallimento nel Quarantotto. In questo senso, la parola diventasostituto, equivalente dell’azione: “dove tuona un fatto, siatenecerti, ha lampeggiato un'idea”4, e la parola è il vestito di un’ideaperché questa possa mostrarsi in pubblico e incitare all’azione;Carlino allora, nel presente sia narrato che narrante, si metteattivamente in gioco, parte in causa davvero, da giovane lottando eda ottantenne scrivendo, così come Nievo lottò e scrisse il romanzo,con l’intento di pubblicarlo subito, come opera militante (senzariuscirci). Nella visione di Nievo, lucida ma ancora ottimistaall’altezza delle Confessioni, il presente è perno intorno cui ruota loscambio tra passato e futuro, il momento in cui l’Italia da sognodiventa attuazione di un progetto razionale, conseguenza inevitabiledi una lunga serie di presupposti: ecco dunque che la “misteriosaProvvidenza” del celeberrimo incipit, invocata non a caso con leparole del padre della letteratura italiana (“la provedenza, chegoverna il mondo / con quel consiglio nel quale ogne aspetto / creatoè vinto pria che vada al fondo”, Par. XI, vv. 28-30) assume la valenzalaica di Ragione, di finalismo della Storia, purché adiuvatadall’azione consapevole degli uomini.
Io nacqui veneziano ai 18 ottobre del 1775, giornodell'evangelista san Luca; e morrò per la grazia di Dioitaliano quando lo vorrà quella Provvidenza che governamisteriosamente il mondo.Ecco la morale della mia vita. E siccome questa morale non fuiio ma i tempi che l'hanno fatta, così mi venne in mente chedescrivere ingenuamente quest'azione dei tempi sopra la vitad'un uomo potesse recare qualche utilità a coloro, che da altri
3 Otto mesi circa per Nievo, dal dicembre 1857 all’agosto 1858.4 Cap. VI, NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni, op.cit., vol. I, p. 307.
5
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
tempi son destinati a sentire le conseguenze meno imperfette diquei primi influssi attuati. 5
Queste prime righe riassumono letteralmente per capita l’interoromanzo, ripercorrente la vita del protagonista, e anzi si proiettanoaddirittura oltre la fine della narrazione, sino alla morte diCarlino (che è ancora vivo, almeno finché scrive). Da un lato,quell’“io nacqui”, davvero un passato remoto, affondante nell’ultimoe più frenetico quarto del XVIII secolo, segnato fatalmente dallaRivoluzione Francese e dal baleno napoleonico; dall’altro, un serenoe icastico “morrò” a prospettare nell’imminente seppur inconoscibilefuturo la fine ineluttabile che tocca alla sua, a ogni storiad’umanità, un dies incertus an certus quando, ma pur sempre termine sicuro enon un “se”, non un’incerta condizione, giuridicamente parlando. Laprogressione temporale si accompagna ad una progressione geografica,da Venezia all’Italia, che costituisce uno dei capisaldidell’ideologia nieviana. Si inverte a chiasmo lo schema usato perl’inizio e la fine della propria esistenza personale: Carlino pone lamorte di Venezia (nel cui seno egli viene alla luce) comeiniziaticamente necessaria, e anzi fecondatrice, grazie al suoinestimabile bagaglio storico-culturale, per la nascita dell’Italia(che Carlino spera di vedere presto compiuta, nell’imminenza dellasua morte); la fine della vita individuale coincide con il fine diuna tradizione di pensiero secolare. Un romanzo a tesi, la cuinarrazione resta sì sospesa su un finale aperto, ma presagisce unaconclusione univoca della storia.
Precisa invece è, poiché trascorsa e parte dell’identità fornitadal passato, la data di nascita di Carlino, il 18 ottobre 1775: undettaglio spesso sorvolato, ma che si illumina di una luceparticolare, è il giorno, di cui Nievo sottolinea la ricorrenza delsanto, Luca l’“evangelista”, autore cioè del “libro dell’Evo Moderno,ma insieme il compendio della sapienza antica”6 (dal Pescatore di anime).San Luca —il cui santuario principale si trova proprio nella chiesadi Santa Giustina a Padova, città d’origine di Nievo stesso—, è tra isinottici il più attento nei confronti della verosimiglianza storicae della bellezza estetica, “letteraria”, di ciò che scrive, oltreche l’unico a riportare le vicende del passato privato, dell’infanziadi Cristo, con l’intento di fornire testimonianza del ruolomessianico del “Salvatore” ereditato dal passato “universale”,dall’Antico Testamento, proiettandolo nel futuro della Passione,visto come atto di redenzione dell’intera umanità (mentre Matteo, per
5Cap. I, NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni, op.cit., vol. I, p. 1.6 DE MICHELIS, CESARE, “Io nacqui veneziano…e morrò per grazia di Dio italiano”. Ritratto di IppolitoNievo, Torino, Nino Aragno, 2012, pp. 46-47.
6
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
esempio, guarda all’indietro, cercando di conformare la novellacristiana al paradigma delle Sacre Scritture); il suo simbolo, iltoro, è ripreso dal sacrificio offerto dal primo personaggio acomparire nel suo vangelo, Zaccaria, padre di Giovanni, il profetache prepara la strada alla svolta storica: passato e futuro, quindi,intrecciati in vista della salvezza nel presente, nell’“oggi”, parolacui San Luca è molto affezionato7.
***
Fin qui le Confessioni, mille e più pagine, freneticamente stese (ericopiate) in pochi mesi. Oltre a queste Nievo, nonostante la morteprecoce, fu autore di una folta e variegata messe di opere,strettamente legate tra loro da filoni tematici e impostazionistilistiche similari, spesso basate su medesime esperienzebiografiche o riflessioni (di natura politica, soprattutto, vero asseconduttore della letteratura nieviana): l’ironia; la tendenza allamediazione, l’”arte della moderazione” intesa come “scienza dellafelicità” (si pensi al buon senso nel trattare la questione socialedella miseria rurale); il manzoniano artificio dello scartafaccio,rielaborato in maniera originale, per Il barone di Nicastro e la Storiafilosofica dei secoli futuri; la passione amorosa nell’epistolario con MatildeFerrari e nell’allegorico Antiafrodisiaco per l’amor platonico;l’allontanamento di argomenti scottanti attraverso la retrospezionestorica, in Angelo di bontà (sottotitolato Storia del secolo passato) e nelleConfessioni; la problematica sociale della povertà contadina,rappresentata nella narrativa lunga de Il Conte Pecorajo e breve de Il Varmoe del Novelliere campagnuolo, prima, illustrata nel saggio La rivoluzionenazionale, poi; il ruolo del clero delle campagne nella rivoluzione,consigliato nel saggio La rivoluzione nazionale e raccontato nell’appenaincominciato Il pescatore di anime; il fallimento quarantottesco,mascheratamente spiegato in Angelo di bontà e solo accennato, con unaspecie di preterizione, nelle Confessioni; l’importanza del lascito diVenezia all’Italia, nelle Confessioni e nel saggio Venezia e la libertà d’Italia…
Due testi citati sopra possono, in particolare, fornire un metrodi paragone per una più approfondita analisi della dinamica temporalenelle Confessioni: la novella “paesana”8 Il Varmo, stesa durante ilsoggiorno del 1855-56 in Friuli, uscita a puntate dal marzo al maggio1856 sull'Annotatore Friulano, e il romanzo breve Storia filosofica dei secolifuturi, scritto nel “limbo”9 tra l’armistizio di Villafranca e la7 Cfr. Angelus del 27 gennaio 2013, pronunciato da Benedetto XVI.8 Dal sottotitolo della stessa.9 NIEVO, IPPOLITO, Storia filosofica dei secoli futuri (e altri scritti umoristici del 1860), a cura diEmilio Russo, Roma, Salerno Editrice (Faville, 24), 2003, p. 7(dall’introduzione di E. Russo).
7
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
partenza da Quarto, apparsa nel gennaio 1860 sul periodico L’Uomo diPietra. Anche stavolta ci affidiamo agli incipit per avere una primaidea del senso di ciascuna opera (aggiungendo il corollario delladedica10 iniziale per Il Varmo):
“A FRANCESCO VERZEGNASSI - Le immagini apprese all'anima in un'ora di pace edi bontà, moltiplicate dal sentimento, popolano di vaghi fantasmi il sacrario delcuore. Questo racconto pertanto inspirato dalle memorie d'una passeggiataassieme godutaci, fra noi due diversissimi d'opera e di studi resti, pegnod'amicizia e di morale concordia.Ogni disposizione di natura, per quanto semplice osgraziata, spira tuttavolta per chi la contempli con bentemprato animo una sua singolar poesia dalla quale ci sirivelano bellezze tanto più delicate e pellegrine quantomeno aperte e comprese” (Il Varmo)11.
“La scienza delle analogie ha donato alla terra l'America edal cielo i pianeti di Leverrier. […] Io ho osservato che igiardinieri, procurando alle piante una vicenda artificialee prematura di stagioni, ottengono delle fioritureanticipate […] Su per su gli uomini somigliano alle piante,e le piante agli uomini. Tutti siamo parenti nell'attocreativo universale e nella materia del lavoro. Perché nonsi potranno ottenere anche nel processo del pensiero umanodelle fioriture anticipate?” (Storia filosofica dei secoli futuri)12.
Emergono chiare le linee guida su cui impostare l’analisi: per IlVarmo, natura, regressione nella memoria e nell’interiorità,musicalità poetica, sequenzialità pittorica più che narrativa; nellaStoria filosofica, scienza, proiezione nel futuro, “pensiero umano”, intono generico, e un progresso storico –più tecnologico che morale13—che impone aridamente la sua linearità a quello narrativo. Tra i due,in tutti i sensi, si pongono le Confessioni (1857-58), con quell’“io”,
D’ora in poi per brevità l’opera verrà citata nel testo con Storia filosofica e conNIEVO, IPPOLITO, Storia filosofica, op.cit. in nota. 10 Trascritta in corsivo per distinguerla dall’incipit vero e proprio dellanovella.11 NIEVO, IPPOLITO, Il Varmo, a cura di Iginio De Luca, Padova, Ape (La Garangola),1945, pp. 1-3 (d’ora in poi citato in nota con NIEVO, IPPOLITO, Il Varmo, op.cit.).12 NIEVO, IPPOLITO, Storia filosofica, op.cit., p. 45.13 Nievo nutriva tanta fiducia nella possibilità di progresso morale quantadiffidenza in quello scientifico. Con le parole di Lucilio, medico:“— Oh non credete neppur nella scienza! Ma in cosa credete dunque?— Credo nel futuro della scienza , se almeno qualche cometa o il raffreddamentodella corteccia terrestre non verrà a guastare l'opera dei secoli. Credoall'entusiasmo delle anime che irrompendo quandocchesia nella vita socialeanticiperanno di qualche millennio il trionfo della scienza, come il matematicocalcolatore è prevenuto nelle sue scoperte dalle audaci ipotesi del poeta!”(cap. XX, NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni, op.cit., vol. II, p. 459).
8
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
l’uomo Carlino calato nel presente, a connettere nel suo narrarepassato e futuro, storia privata e pubblica, esplorati lungo tutto ilromanzo con la più vasta gamma di toni, già evidente nel contrastotra le enfatiche prime righe, l’umorismo di appena qualche paginadopo14 e, al terzo capitolo, l’atmosfera idillica aleggiante suiluoghi di Fratta, descritti con abbondanza di vezzeggiativi,diminutivi e procedimenti di rimpicciolimento a indicare, come nelVarmo, la loro natura di “paesaggio del cuore”, per ricorrere ad unafamosa etichetta di Vittore Branca, da lui riferita però al Varmo.
Questa novella è percorsa infatti da una lenta musicalità liricain virtù proprio dell’ambientazione, rusticale, volutamenteestraniata dalla realtà: la campagna, già secondo l’impostazione“antistorica” del genere decisa dal Carcano, si configura come “luogodella memoria, terreno di resistenza all’ideologia del progresso e diperenne infanzia e rinascita dell’animo”; le tematica paesistica è infunzione di “condizione imposta dall’anima per dipanare i motiviremoti della fanciullezza”. È irrorata però in Nievo da un nuovoimpulso attivistico, realistico e insieme affettivo, un istintovitale sgorgato dallo stadio primitivo della vita umana, siabiologica che evolutiva, l’infanzia e lo stato di natura15. Un’energiaprimordiale, capace di risollevare un’Italia ancora delusa dalQuarantotto (un “entusiasmo morale, sereno e allegro slancio di vitache possiamo dire “garibaldino”’, nelle parole di Iginio de Luca);energia mitigata tuttavia dal “sentimento”, volto a resuscitare“memorie” in quello spazio intimo definito “sacrario del cuore”: e,se sacro, protetto da rimandi troppo espliciti all’attualità storica(solo per un attimo sfiorata nelle idee socialiste del nonno, subitoconvertite in innocua fantasia ad occhi aperti), che resta estraneaalla percezione innocente di personaggi umili quali sono iprotagonisti, doppiamente per età e condizione sociale: vivono in “unmondo aurorale al di fuori della storia, perché la fanciullezzadiviene il momento eterno di quella storia che veramente interessa:la storia dell’individuo, i sogni e le delusioni di lui, i suoi amorie la sua disperazione, la sua felicità e la sua sofferenze” (GaetanoMariani)16. L’idillio dell’amore infantile viene rielaborato dal Varmo
14 “- Marito mio! sono una Badoera! - disse drizzandosi la Contessa. - Miconsentirete, spero, che i polli nella nostra famiglia non sono piú numerosi chenella vostra i capponi” (cap. I, NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni, op.cit., vol. I,p.17). 15 FINOTTI, FABIO, 'Il Varmo' di Ippolito Nievo in Leggiadre donne...Novella e forme del racconto brevein Italia, ed. F. Bruni, Venezia, Marsilio, 2000, p. 105, da cui sono riprese anchele citazioni da altri critici.16 PORTINARI, FOLCO, Ippolito Nievo. Stile e ideologia, Milano, Silva, 1969, pp. 86 e sgg.,dove sono riportate anche le citazioni dei vari critici inserite nel testo
9
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
alle Confessioni: al di là degli evidenti parallelismi, come le coppiedi personaggi (Carlino/lo Sgricciolo; la Pisana/la Favitta; laContessa/Polonia; Martino/Simone; Spaccafumo/ser Giorgio….) o diluoghi (cucina/focolare), ciò che viene sicuramente ripreso èl’ispirazione lirica, evocativa, di entrambe le storie d’amorecresciute all’interno di un “paesaggio del cuore” friulano.Sennonché, nelle Confessioni, il respiro della Storia impregna anchequel mondo idillico: si pensi solo alla complicata vicenda delmandato di arresto per Venchieredo, ad appena un capitolo di distanzadall’episodio più lirico del romanzo, la scoperta del mare da partedi Carlino, che fa germogliare nel cuore del protagonista lareligione della natura, innata nei cuori della Favitta e delloSgricciolo.
La poesia dell’umile, del domestico quotidiano fa scorrere l’etàprima della Favitta e dello Sgricciolo con il liquido ritmo delVarmo, un ritmo sospeso, per fluide sequenze di “quadri”, senzainterferenze dal fuori in quel microcosmo locale, “paesano”, segnatoda confini naturali, fiumiciattoli ignorati dalle grandi autoritàlontane, amati dai personaggi umili, dallo Sgricciolo soprattutto,che “per sé riserbava l'unico sollievo di sedere alla sera di ognidomenica in qualche solitario renaio del Varmo; e in que' solimomenti viveva per se stessa l'anima sua, ma più non viveva che dimemorie; ed ogni speranza la tenea levata in quel Dio, che ricompensacol paradiso la rassegnazione operosa dei cristiani”17. Pure nelleConfessioni i corsi d’acqua agitano riflessioni e ricordi nella mentedel protagonista-narratore, che però non resta imprigionato in essi,sollevando lo sguardo al di sopra del proprio passato individuale:“[la storia della mia vita] si diparte solitaria da una cuna per frapporsipoi e divagare e confondersi coll'infinita moltitudine delle umanevicende, e tornar solitaria e sol ricca di dolori e di rimembranzeverso la pace del sepolcro. Così i canali irrigatori della pingueLombardia sgorgano da qualche lago alpestre o da una fiumiera delpiano per dividersi suddividersi frastagliarsi in cento ruscelli, inmille rigagnoli e rivoletti: più in giù l'acque si raccolgono ancorain una sola corrente lenta pallida silenziosa che sbocca nel Po. […]i casi miei sarebbero ben poco importanti a raccontarsi […] se non siintralciassero nella storia di altri uomini che si trovarono mecosullo stesso sentiero”18, e la speranza riposa sì nella Provvidenza,ma “ognuno sa che la Provvidenza coi nostri pensieri coi nostrisentimenti colle nostre opere matura i propri disegni; e a volersi
sopra.17 NIEVO, IPPOLITO, Il Varmo, op.cit., p.102.18 Cap. V, NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni, op.cit., vol. I, pp. 236-237.
10
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
aspettar da lei la pappa fatta, l'era o un sogno da disperati o unalusinga proprio da donnicciuole”19.
Nel Varmo invece il narratore stesso (in prima persona, ma vocedi una figura esterna alle vicende dei due protagonisti, a favorirela tonalità fiabesca e regressiva del c’era una volta), il narratorestesso, per non stonare nella poeticità sognante diffusa, deveabbassarsi alla statura di bambino20, dimenticare la “storia di altriuomini”, la temporalità degli adulti, e tornare anche lui a lanciareciottoli sull’acqua del Varmo, far passarini, ritrovando sulle rive diquella “vaga riviera” la propria innocenza primordiale, al di là deltempo; tempo che nel Varmo si riavvolge circolarmente su se stesso,da un’infanzia all’altra, da quella dei due piccoli protagonisti aquella nel ricordo del narratore. Nella novella si assiste ad unaregressione su più livelli: livello temporale, biografico-biologico,“orizzontale”, dalla maturità (del narratore) all’infanzia (dellostesso, rammentata parlando di quella dei due piccoli protagonisti);livello psicologico, “verticale”, dal conscio al rimosso interiore21;livello sociale, dalla borghesia al popolo; livello storico, dallaciviltà industriale a quella naturale, primitiva, rurale; livellolinguistico, dall’italiano parlato (pur in Nievo spesso colorato didialettalismi, tipici appunto del suo parlato) al dialetto del farpassarini, al punto da rendere necessaria nel testo stesso una glossa22
a vantaggio dei lettori, e dai nomi propri ai soprannomi, ispiratialla fauna locale; persino, a sorpresa, livello narrativo, come siscopre negli ultimi paragrafi23, quando il finale un po’ amarognolo èaddolcito, per l’ultima volta, dall’atto del ricordo, del riandare19 Cap. II, NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni, op.cit., vol. I, p.115.20 “[…] i consiglieri per avventura non si erano mai specchiati in quelle sue[del Varmo] acquette satiriche, né vi aveano veduto sul fondo variopinto quellelunghe chiome di alica listata di verde e di nero, fluttuante a seconda dellacorrente, e quelle foglie aranciate di giunchiglia, e quei muschi tenebrosisomiglianti a velluto, onde sopra cervelli scarnati d'ogni poesia non fece presala paura di sturbar l'albergo d'una qualche fata” (cap. I, NIEVO, IPPOLITO, IlVarmo, op.cit., p.8).21 “Pure se il linguaggio è cosí aperto, non lo sono per nulla i segni di esso;anzi l'idea di quel vago spettacolo sgorga e si compone da sì secrete origini,che bisogna contemplarlo con sincera religione per esserne alcun poco chiariti;[…] la vita è tutta interna ed ombrata” (cap. V, NIEVO, IPPOLITO, Il Varmo, op.cit.,p. 43).22 “[…] far passarini; e pur troppo s'io vi dicessi, che ciò significa fare arimbalzello, o con impeto orizzontale di braccio persuadere le schegge di selceai piú bizzarri sbalzi e scivoletti sull'acqua, torrei ogni vaghezza allaschietta frase paesana” (cap. V, NIEVO, IPPOLITO, Il Varmo, op.cit., p. 47).23 “Un mese fa, io passeggiava per quelle bande con un mio amicissimo, il cuisolo difetto è di odiare il canto delle allodole; ma lo compensa poi rispetto ame, coll'essermi compagno in una passione veramente artistica pei passarini.
11
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
all’indietro, “giù per la china”. Tuttavia, la regressione non èsoltanto estraniamento dalla realtà, poiché “nel Varmo l’infanziadiviene maestra di esplorazione umana e di scrittura”: scrittura, inquanto “è proprio ‘passeggiando’ per le rive del fiume […] che alloscrittore è data la possibilità di conoscere e ricreare la vicendadella Favitta e dello Sgricciolo”, e esplorazione umana, “nelprecoce, inconscio amore dello Sgricciolo per la Favitta, cheanticipa quello del piccolo Carlino per la Pisana”24. La condottaseguita nell’infanzia è sempre emblematica di quella della vitaintera (“la fanciullezza diviene il momento eterno della […] storiadell’individuo”), poiché la imposta e la prefigura, in una specie dimise en abyme, letteralmente: a quell’altezza già agiscono tutti ifattori che regolano il comportamento di una persona, l’”indole”individuale e le “circostanze” esterne, mentre è, o dovrebbe essere,pienamente in fieri il percorso educativo volto a adattare la primaalle seconde.
Dovrebbe essere, perché Carlino e la Pisana sono abbandonati a sestessi, imparano da autodidatti25, spesso sbagliando e soffrendo:mentre la Pisana resta in balia delle sue fortissime e altalenantipassioni, per Carlino l’unico maestro di vita sarà l’ignorante,povero, ruvidamente affettuoso Martino, ma solo dopo la morte dicostui, grazie al ritrovamento casuale dei suoi appunti, permeati diun’insospettabile profondità morale centrata sull’etica del dovereavvertito nel fondo della coscienza. L’importanza dell’educazione,della “terribile responsabilità dell’esempio”26, resterà poi un chiodo
Ora mentre le scagliuole scherzanti al sommo del Varino ci aiutavano a trascinarinnanzi d'un qualche minuto questa vitaccia grulla e inconcludente, unagarzonetta ed un fanciullo, all'aspetto contadini, pensarono di unirsi al nostrospasso; e pur troppo ci convenne confessare d'aver trovati due maestri! Lacomunanza di piaceri ingenera simpatia; e la simpatia mena alla curiosità e lacuriosità alle chiacchere, onde seppimo in breve che que' due ragazzetti sichiamavano la Favitta e Sgricciolo, e che in tal modo erano stati battezzati dailoro genitori. Doveva essere d'ingegno molto bizzarro chi si piaceva d'imporresimili nomi ai propri figliuoli! e non seppimo resistere alla tentazione diconoscerli.Dal conoscerli al farci contare la loro storia, e poi allo scriverla, la stradaera tutta un pendio. Io mi lasciai andar giú per la china alla trasandata, comeque' birichini che godono di scendere rotoloni le rive erbose delle nostrecolline” (cap. X, NIEVO, IPPOLITO, Il Varmo, op.cit., pp. 107-108).24 FINOTTI FABIO, ‘Il Varmo’ di Ippolito Nievo, op. cit., p. 114.25 Vd. l’introduzione di Simone Casini a NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni d’un italiano,voll. I-II, a cura di Simone Casini, Parma, Guanda, 1999.26 “ – […] [Lucilio a Carlino e alla Pisana] Bensí la mia propria natura mi comanda dispender bene e di usare spietatamente la vita. Voglio proprio cavarne ognisucco, e far come dei vinacci i quali, poiché ne fu spremuto il vino, sitorchiano ancora per estrarne l'olio.
12
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
fisso nelle riflessioni del Carlino maturo, che appunto deciderà discrivere le sue memorie per “fecondare” le azioni dei figli(impegnati infatti come volontari) con il modello dei padri. Bastiricordare, nelle Confessioni, l’episodio del ritorno di Carlino alcastello dopo la cavalcata con lo Spaccafumo: malgrado le pressioniminacciose degli adulti, Carlino si rifiuta di rivelare l’identitàdello sconosciuto, per dovere morale27 di lealtà nell’onorare lapromessa fatta al brigante, disperandosi poi non (sol)tanto per lapunizione, quanto per il divieto di vedere la sua Pisana, la“tirannella di Fratta” (così come la Favitta è chiamata “petulantetirannella”), la quale, imprevedibile come sempre, si precipita adassisterlo e anzi a condividere sua sponte l’umiliazione del castigo,allo stesso modo in cui anni e anni dopo assisterà l’esiliato Carlino–in fuga dalla condanna a morte comminatagli per aver combattutonella battaglia di Rieti da volontario (ossia seguendo, ancora,l’insegnamento del dovere morale)—, tanto da umiliarsi al punto dachiedere l’elemosina per lui: proprio Carlino collega i due episodi,conservando lo stesso tipo di “reliquia” in seguito a entrambe leoccasioni, una ciocca di capelli dell’amata, fonte di coraggio nellavita privata da bambina e nell’impegno patriottico da adulta.
La differenza fulcrale tra le vicende de Il Varmo e delleConfessioni è l’orizzonte spazio-temporale: statico e ristretto,fiabesco, nella narrativa breve della novella, dinamico eprogressivamente ampliato, storico, nella narrativa lunga del
- E ne avrete guadagnato?- Assai! d'aver fatto fruttificare ogni mio talento e d'aver offerto un buonesempio a quelli che verranno.Io approvai del capo, ché quella teoria del buon esempio mi avea sempre frullatoentro come un ottimo negozio: e me ne fidava piú che dei libri. La Pisanasoggiunse ch'ella per verità in tutte le sue cose non aveva mai pensato allagloria ditrovar imitatori ma che si era data con tutta l'anima al sentimento che latrasportava” (cap. XX, NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni, op.cit., vol. II, p. 464).27 “Debbo tuttavia soggiungere che quella che parrà a taluni frivola e cocciutaostinazione di fanciullo, a me sembrò fin d'allora e la sembra tuttavia unabella prova di fedeltà e di gratitudine. Fu allora la prima volta che l'animomio ebbe a lottare fra piacere e dovere; né io titubai un istante ad appigliarmia quest'ultimo. Se il dovere in quel caso non era poi tanto stringente, poichéné la raccomandazione dello sconosciuto pareva fatta sul serio, né io aveapromesso nulla, né potea capire a che gli potesse giovare il mio silenzio sopraun fatto così comune com'è quello del passaggio d'un uomo a cavallo, tuttociòprova a tre tanti la rettitudine de' miei sentimenti. Fors'anco quel primosacrificio, cui mi disposi tanto volonterosamente e per sì frivolo motivo, diedealla mia indole quell'avviamento che non ho poi cessato dal seguir quasi semprein circostanze più gravi e solenni” (cap. III, NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni,op.cit., vol. I, pp. 171-172).
13
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
romanzo. La spazialità in cui giocano la loro vita Carlino e laPisana si allarga dalla cucina del castello di Fratta, immobile nelsonno feudale, ai domini dalla declinante Venezia, all’Italia, poiall’Europa e infine, con la generazione dei figli, agli altricontinenti; la dimensione su cui scommettono i personaggi non è solola loro vita privata, ma il destino nazionale: ovviamente, leConfessioni vivono della base storica, lasciandola penetrareprepotentemente nella sfera d’azione, nella quotidianità del singoloe, viceversa, mostrando come siano i singoli uomini a fare la storia,specie la storia risorgimentale.
La Favitta e lo Sgricciolo, figure umili, invece si muovonoall’interno di un orizzonte “basso”, locale, per cui la loroesperienza infantile resta chiusa in se stessa, autosufficiente,senza sollevarsi ad illuminare il futuro su un livello più alto diquello privato, al massimo paesano; si dice, sì, a parole, che ilcomportamento del buon Pierino-Sgricciolo deve servire ad esempio di“sana morale”, e veniamo a sapere che ha ubbidito al dovere civiledella leva militare; tuttavia si resta sempre su un piano indefinito,vago, da fiaba (chi ha imposto la leva?), senza incunearsi in unorizzonte nazionale come nelle Confessioni. Il finale basta che sia diqualche pagina, cucito a punti grossolani28, esplicitamente persoddisfare la curiosità dei lettori sulla sorte della storia d’amoretra i protagonisti una volta diventati adulti: sorte dolceamara,opposta a quella di Carlino e della Pisana. La Favitta e loSgricciolo in ultimo coronano il sogno di nozze, ma tardivamente,quando ormai ogni felicità è già evaporata insieme alla giovinezza,con una velata amarezza cui la voce narrante pone rimedio in liminericorrendo ancora una volta alla dolcezza idillica del ricordo, delpassato. Nelle Confessioni invece la Pisana, dopo continue sparizioni ericomparse, finalmente prende dimora fissa presso Carlino, convivendocon lui in Inghilterra, ma non da amante, tantomeno da moglie (che28 “Io mi son ito sempre innanzi, trastullandomi a veder piovere dalla pennafrasicciuole e capitoletti; come il fanciullo si spassa col soffiare da unacannuccia le bolle di sapone; ed ora all'improvvista m'accorgo che la novella èfinita. Per non far le corna al galateo degli antichi cantafavole, sarei lí líper appiccarvi la morale, e far su tutto una croce; ma in questo secolo ècresciuta una certa genia di lettori viziati, la quale crederebbesi gabbata senon vedesse morti e seppelliti o per lo meno maritati i personaggi di unracconto […] la natura, se negò agli uomini la coda, ne fornì più o menolargamente i pecori, i giumenti e le scimmie, e può ben permetterne un tantinoanche alla mia novella. Né la coda sarà inutile del tutto, poiché se fin qui fuprovato, che anche un ragazzino può fare a sua insaputa propaganda di sanamorale, dal resto sarà chiarito, come l'indole degli uomini si raddrizzi inmeglio o torni nella vecchia piaga, a seconda delle varie fortune, e del diversofreno della ragione” (cap. IX, NIEVO, IPPOLITO, Il Varmo, op.cit., pp. 92-93).
14
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
gli ha imposto di prendere!), e muore pronunciando parole da quelmomento impresse a fuoco nell’anima di Carlino, spronando lui e,attraverso lui, la generazione dei figli a combattere in nomedell’unificazione italiana; comando cui Carlino obbedirà sia con leazioni che con la scrittura delle stesse Confessioni. Questa siconclude, alle ultime pagine, nella commozione davanti ai ricordi cheriprendono vita al suo ritorno a Fratta, davvero “paesaggio delcuore”, col rianimarsi del luminoso fantasma della Pisana, cheparadossalmente, seppur memoria del passato, respira ancora nelpresente e invita alla fiducia nel futuro, in un antifoscolianoconnubio tra speranza per il destino della patria e amore(corrisposto) verso la donna: l’alfa e l’omega della sua storia,entrambe agli occhi di Carlino rinate dalla propria morte,nell’incipit e nell’explicit; entrambe sempre amate, sempre rincorse,costantemente presenti al cuore eppur sfuggenti nella realtà, in un“là” presagito ma non ancora intravisto (“quando lo vorrà quellaProvvidenza”):
O mia Pisana, tu pensi ancora, tu palpiti, tu respiri inme e d'intorno a me! […] ti parlo come a donna viva espirante nelle ore meridiane del giorno. Oh tu sei ancoracon me, tu sarai sempre con me; perché la tua morte ebbeaffatto la sembianza d'un sublime ridestarsi a vita piùalta e serena Sperammo ed amammo insieme; insieme dovremotrovarci là dove si raccolgono gli amori dell'umanitàpassata e le speranze della futura. Senza di te che sareiio mai?... Per te per te sola, o divina, il cuoredimentica ogni suo affanno, e una dolce malinconiasuscitata dalla speranza lo occupa soavemente.
Speranza nel progresso futuro, in virtù di una morale,collettiva e (o, meglio, perché) individuale, della responsabilitànel presente: finora Nievo non ha dubbi in proposito. Poi, nel luglio1859, Villafranca, con la caduta di ogni speranza.
***
La Storia filosofica dei secoli futuri avvia l’ucronia proprio a partire dauna pace “combinata tra alcuni uomini nell'anno 1859 o in quel torno”che “non contentò, a quanto sembra, neppure gli uomini che l'avevanofatta”: il romanzo breve è scritto infatti sotto l’impressione delladelusione di fronte all’armistizio, in seguito al quale laprospettiva di trasformare un veneziano in italiano diventava purafantasia. La Storia filosofica è quindi lo sfogo su carta della cocentedisillusione storico-politica, in un divertissement di causticaironia che potremmo, anacronisticamente, definire con il termine
15
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
novecentesco di fantascienza, specificamente di fantascienzasociopolitica. Il setting certo rispetta il canone del genere,scegliendo come cornice un artificio tecnologico capace di farviaggiare indietro la storia, intesa come rappresentazionestoriografica fornita dalla testimonianza scritta di VincenzoBerardi, uomo del 2222, allo scienziato-filosofo Ferdinando de’Nicolosi, attivo nel 1859 (espediente narrativo assai originale ancherispetto alla letteratura di science fiction posteriore, che sarà solitapiuttosto far viaggiare avanti e indietro i personaggi in differentiepoche, anziché viceversa). Di nuovo una tecnica regressiva, masfruttata per illustrare il futuro.
Un futuro alquanto grigio, nella visione di Nievo, scetticosulla possibilità di “magnifiche sorti e progressive” per merito discoperte da parte della scienza: il suo progresso, cantatonell’incipit, non cambia il quadro fosco dipinto nel ‘libro quinto edultimo: dal 2180 al 2222, o il periodo dell’apatia’, in cui siassiste all’“aumento graduale della noia e del suicidio”. Un futuropressoché privo di memoria, dato che tutti i libri precedenti al 2000sono stati distrutti: certo, tale dato inquietante (come non pensarea Fahrenheit 451?) è inserito per rendere verosimile la vaghezza delladescrizione “storiografica”, specie per i tempi immediatamentesuccessivi al 1859, la quale se troppo dettagliata sarebbe incorsaforse in un’immediata smentita negli anni seguenti alla pubblicazione–stessa ragione per cui Dante aveva reso fumosa la profezia delveltro—, ma non si può non rilevare il parallelismo rovesciato conl’incipit delle Confessioni: il dies incertus an certus quando stavolta è quellod’inizio (“o in quel torno”). Da qui in poi la traccia narrativa èlineare, una catena di eventi su grande scala (guerre, congressi,invenzioni rivoluzionarie, nuove religioni) di cui il narratore èstato lettore, sui pochi volumi sopravvissuti, o spettatore dalontano, senza un diretto coinvolgimento; l’approfondimentopsicologico è ridotto a zero (anche perché i personaggi sono pochi efunzionali alle vicende), e risuona soltanto l’accento di amaraironia della voce narrante. Sono “istorie de’ secoli futuri”: nonmemorie, tantomeno confessioni, ma genericamente “pensiero umano”;non progetto, non speranza, ma arida descrizione storiografica, soloun po’ ravvivata dall’umorismo nieviano.
L’arco temporale abbracciato è più che quadruplicato rispetto aquello delle Confessioni, poiché si tratta non più della vita di unindividuo all’ombra di un periodo cruciale per la propria nazione, madella storia internazionale, dove protagonisti sono le grandi figureistituzionali, i leader statali o religiosi, gli scopritori delle
16
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
innovazioni tecnologiche di svolta29 (seppur osservati in unacontroluce umoristica30), e la stessa unificazione italiana è vistasolo come una tappa verso quella europea e poi globale. L’unico eroe,Garibaldi, scompare presto dalla scena, e così gli uomini “allaCarlino Altoviti”: l’avanzamento della civiltà non è più frutto delloro impegno attivo e della loro responsabilità morale, ma del lavoromeccanico, automatizzato, di omuncoli31, “macchine umane” dotate dilibero arbitrio solo parziale, di “agire quasi liberamente in unadata sfera d'azione”. Affidata agli omuncoli la fatica del progressofuturo, rimossa la memoria del passato dopo la distruzione dei libricon la scusa che “avevano prodotto infin allora la diversità delleclassi e le più perniciose rivoluzioni”, l’umanità decade nell’ozio enella noia, nella non-attività. “Il caso, ovverosia l'attività umanaindividuale ed anormale, ha presieduto ai periodi storici dellavecchia società” –e quel caso suona un ironico riecheggiamento dellaProvvidenza nelle Confessioni—, ma “la nuova [società] riconosce il suosviluppo crescente e regolare dall'industria, ovverosia dall'attivitàumana collettiva e progrediente”, salvo poi narrare come, con lacreazione degli automi, tale attività sia stata appunto scaricatasulle spalle meccaniche dei robot. Ricordando allora l’equivalenzascrivere/fare presupposta da Carlino-Nievo –intesa nel senso che siscrive per incitare a fare, e che il fare è l’attuazione dell’idea,inesprimibile se non a parole perché venga conosciuta e quindieseguita—, bisogna aggiungere che nel 2222 non solo non si lavora, manemmeno si pensa, né legge, né studia, né scrive più: “quelli poi che[…] si davano allo studio, incorrevano facilmente in accessicerebrali e morti improvvise per apoplessia nervosa; del qual malannoi medici incolpavano la soverchia attività concentrata tutta nelcervello per due o tre generazioni”. Interessante notare come ilprimo incarico che le “macchine umane”, all’inizio, presentinodifficoltà a condurre a termine sia l’atto della scrittura:l’incapacità di scrivere “non altro che quelle due parole” è la provache gli omuncoli non sono in grado di tessere in un discorso le29 Gli unici uomini osservati, per un breve scorcio, nella loro piccolezza (pernon dire meschinità) umana sono gli inventori dei robot, cioè dei nuovi uomini,meccanici (“-Io avrò fatto l’uomo!”, esclama uno dei due scopritori). 30 A titolo d’esempio, ecco come si descrive la reazione della Chiesa alladiffusione degli automi: “le guerre, le dispute e le discussioni religiose aproposito degli omuncoli sarebbero assai lunghe a narrarsi. Basti il dire che ilpapa di Roma scomunicò nel 2180 tutti quelli che ne fabbricavano; e poi vedendoche il divieto fruttava poco, ordinò in dubbio che quelle creature fosserobattezzate, per salvarle dalla dannazione se erano in qualunque modo animate, eper toglierle alla balia di Satanasso se non erano altro che strumentidell'attività umana” (libro quarto, NIEVO, IPPOLITO, Storia filosofica, op.cit., p.73)31 Tutte le citazioni sugli omuncoli, la diffusione dell’ozio e la conclusionedelle memorie sono riprese da NIEVO, IPPOLITO, Storia filosofica, op.cit., pp. 65-75.
17
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
proprie idee, i propri pensieri; proprio l’inabilità a pensaremanifesta la non-umanità dei robot, e di conseguenza dell’interasocietà futura, riposante sulle loro prestazioni. Si affermapigramente di non voler ripetere l’errore della vecchia società, incui, afferma il narratore, “non s'era ancora imparato a vivereintieri nell'anno che correva, e quella porcheria di voler dare unaparte del retaggio del 1800 al 1700, al 1600 e più indietro ancora,confondeva le idee e guastava il buon volere dei migliori. È buonacosa la memoria; ma il buon senso è di lunga mano migliore. Quellaserve mirabilmente agli effetti poetici32. Ma in punto a politica ioconfido che gli uomini non si dipartiranno più dal secondo”. Così,con il pretesto di voler vivere –vivere in ozio— immersi nelpresente, si cancella con un colpo di spugna il passato, senzarendersi conto di come una tale scelta tagli le gambe all’avvenire.
Il primo lettore di queste memorie dal futuro, lo scienziatoFerdinando, si dichiara “avvilito” all’aver scovato nient’altro cheuna simile “cantafera”: l’ipotetico valore dell’opera èriduttivamente ascritto solo a eventuali meriti storiografici, perverificare la veridicità regressiva e insieme profetica di queste“istorie” con il riscontro degli eventi storici ivi descritti maancora a venire all’altezza del 1859. Con tono scherzoso, proprio altermine della narrazione, si formula a favore dell’autore deiricordi, Vincenzo, l’augurio di nascere senza problemi, in unindefinito “a suo tempo”; augurio accompagnato da una frase quasifuneraria (“sia pace all'anima sua; e sia aiutato a suo tempo a veniral mondo da una buona comare!”), capovolgendo ancora una volta leConfessioni, dove alla prima pagina ci si imbatteva nell’auspicio di unamorte che potesse risultare feconda in vista di una rinascita.
Sempre alla prima pagina delle Confessioni, l’atto della scritturaannoda, nell’“operosità” del presente, la memoria del passato con lesperanze per il futuro, fornendo una testimonianza dal valore certo,quasi scientifico, quanto potrebbe risultare nel campo filologico unreperto manoscritto, “una nota apposta da ignota mano contemporaneaalle rivelazioni d'un antichissimo codice”, ponendo quindi il proprioracconto a continuazione di una lunga stirpe di “copisti”, scrittori,e lettori intenta a nutrire “legittime speranze”: lettori che, adifferenza di quelli della Storia filosofica, nelle aspettative di Carlino-Nievo gli mostreranno “simpatia” –cioè, etimologicamente, la capacitàdi sopportare e lottare contro le stesse difficoltà, con lui nelpresente e come lui nel futuro—, in uno slancio di fede a
32 Come non pensare alla poeticità della regressione nel Varmo?
18
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
trecentosessanta gradi verso le generazioni passate, presenti efuture.
In tutto ciò nulla sarebbe di strano o degno da esserenarrato, se la mia vita non correva a cavalcione di questi duesecoli che resteranno un tempo assai memorabile massime nellastoria italiana. Infatti fu in questo mezzo che diedero primofrutto di fecondità reale quelle speculazioni politiche chedal milletrecento al millesettecento traspirarono dalle operedi Dante, di Macchiavello, di Filicaia, di Vico e di tantialtri […] La circostanza, altri direbbe la sventura, di avervissuto in questi anni mi ha dunque indotto nel divisamento discrivere quanto ho veduto sentito fatto e provato dalla primainfanzia al cominciare della vecchiaia[…] Né il mio sempliceracconto rispetto alla storia ha diversa importanza di quellache avrebbe una nota apposta da ignota mano contemporanea allerivelazioni d'un antichissimo codice. […] Come suggerivanol'estro e la memoria venni scrivendo queste note. Le qualiincominciate con fede pertinace alla sera d'una grandesconfitta e condotte a termine traverso una lunga espiazionein questi anni di rinata operosità, contribuirono alquanto apersuadermi del maggior nerbo e delle più legittime speranzenei presenti, collo spettacolo delle debolezze e dellemalvagità passate.Ed ora, prima di prendere a trascriverle, volli con questepoche righe di proemio definire e sanzionar meglio quelpensiero che a me già vecchio e non letterato cercò forseindarno insegnare la malagevole arte dello scrivere. Ma già lachiarezza delle idee, la semplicità dei sentimenti, e laverità della storia mi saranno scusa e più ancora supplementoalla mancanza di retorica: la simpatia de' buoni lettori miterrà vece di gloria. 33
Le Confessioni volevano combinare in una miscela nuova –che Nievosi augurava capace di far “reagire” gli animi italiani— laregressione, già usata nel Varmo, con la progressione, successivamentesperimentata nella Storia filosofica, entrambe concorrenti alla nascitadell’italiano menzionato nel titolo… senza che il giovane autoresospettasse che nel 1867 la prima edizione del romanzo avrebbesostituito a quella parola programmatica “ottuagenario”, perdendo laproiezione verso il futuro che era stata alla base della narrazionedi Carlino e condannando non il veneziano, ma l’italiano alla morte,ad una lapide il cui significato temporale avrebbe perso il valoreprogettuale a favore di uno puramente storico, una data:
Quella lapide portava un'iscrizione di cui si potevanoperdonare le eleganti bugie, perché già nessuno ci capiva
33 Cap. I, NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni, op.cit., vol. I, pp. 3-4.
19
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
nulla in paese. Peraltro un certo compare che sapeva dilettere era giunto ad interpretarla fino ad un certo punto,dove si diceva che […] era morto octuagenarius: il chesignificava agli otto di gennaio, secondo lui.34
34 Cap. XIX, NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni, op.cit., vol. II, pp. 424-425.
20
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
Bibliografia e sitografia:
LETTERATURA PRIMARIA
EDIZIONI DI RIFERIMENTO PER LE TRE OPERE DI NIEVO PRESE IN ANALISI:
NIEVO, IPPOLITO, Storia filosofica dei secoli futuri (e altri scritti umoristici del 1860),a cura di Emilio Russo, Roma, Salerno Editrice (Faville, 24),2003
NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni di un italiano, voll. I-II, Roma, CarloColombo, 1943
NIEVO, IPPOLITO, Il Varmo, a cura di Iginio De Luca, Padova, Ape (LaGarangola), 1945
ROUSSEAU, JEAN-JACQUES, Confessioni, consultato online in data 1/07/2013al sito:<http://147.163.40.2/doc/401/Rousseau_._Confessioni.docx>
AGOSTINO, Le confessioni, a cura di Dag Tessore, Roma, Newton Compton,2008
LETTERATURA SECONDARIA:
DE MICHELIS, CESARE, “Io nacqui veneziano…e morrò per grazia di Dio italiano”. Ritrattodi Ippolito Nievo, Torino, Nino Aragno, 2012
DEL TEDESCO, ENZA, Il romanzo della nazione. Da Pirandello a Nievo: cinquant’anni didisincanto, Venezia, Marsilio, 2012
BIONDI, MARINO, Il discorso letterario sulla nazione. Letteratura e storia d’Italia,Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012
FINOTTI, FABIO, 'Il Varmo' di Ippolito Nievo in Leggiadre donne...Novella e forme delracconto breve in Italia, ed. F. Bruni, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 103-120
21
La molteplice direzione temporale nelle Confessioni: tra Il Varmo e la Storia Filosofica –ALESSANDRA MUNARI
PORTINARI, FOLCO, Ippolito Nievo. Stile e ideologia, Milano, Silva, 1969
LANGELLA, GIUSEPPE, Un libro al mese: "Le confessioni d'un Italiano" di Ippolito Nievoin Nuova secondaria, XXVII, 5, 2010, pp. 66-67
CAMPA, RAFFAELE, La Storia filosofica dei secoli futuri di Ippolito Nievocome caso esemplare di letteratura dell’immaginario sociale, in Adversus,IX, 23,dicembre 2012, pp. 13-30 consultato online in data 2/07/2013 al sito: < http://www.adversus.org/indice/nro-23/articulos/IX2302.pdf >
Introduzioni da:- NIEVO, IPPOLITO, Le confessioni d’un italiano, voll. I-II, a cura di SimoneCasini, Parma, Guanda, 1999- NIEVO, IPPOLITO, Novelle campagnuole, a cura di Elio Bartolini, Milano,Mondadori, 1956- NIEVO, IPPOLITO, Il Varmo, a cura di Vittore Branca, Firenze, LeMonnier, 1945- NIEVO, IPPOLITO, Romanzi. Racconti e novelle, a cura di Folco Portinari,Milano, U. Mursia & C., 1967- opere citate nelle edizioni di riferimento sopra
22
![Page 1: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: La molteplice direzione temporale nelle Confessioni d’un italiano: fra Il Varmo e la Storia Filosofica dei secoli futuri [+ nota contro il plagio nella sezione "Info" di Academia.edu]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023011922/6317fdaebc8291e22e0e7df2/html5/thumbnails/23.jpg)