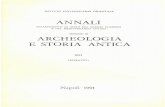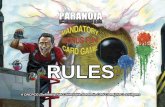Il Salmo Naasseno (Hipp. Haer. 5,10,2). Edizione, traduzione e commento a cura di G. R., Cesena 2007
Un’abduzione aberrante. Recensione e commento di Luigi Zoja, Paranoia, 2011
Transcript of Un’abduzione aberrante. Recensione e commento di Luigi Zoja, Paranoia, 2011
Un’abduzione aberrante. Recensione e commento di Luigi Zoja, Paranoia. La follia che fa la storia, Bollati Boringhieri, Torino 2011 di Claudio Tugnoli Opera monumentale questa di Luigi Zoja, forse la più impegnativa tra quelle scritte finora dallo psicoanalista junghiano. Un esempio splendido di psicostoria, difficilmente superabile. Zoja esamina la storia europea, e non solo, degli ultimi cinque secoli, dalla colonizzazione spagnola e portoghese fino ai nostri giorni, alla luce della paranoia come fenomeno individuale e collettivo. Sullo sfondo del mito la figura di Aiace rappresenta l’archetipo di tale psicopatologia, che Zoja illustra partendo dall’Aiace di Sofocle. Aiace, cresciuto in una tetra famiglia, l’uomo che nessuno ha mai abbracciato, condannato alla solitudine e al sospetto, è il prototipo della paranoia, che genera soltanto distruttività. Sulla base di una documentazione imponente e sempre di estrema pertinenza, Zoja insegue e scova nei meandri della storia europea le sacche di paranoia, mostrando come spesso sfugga all’osservatore superficiale la linea di confine che, per quanto mobile e incerta, separa la normalità dalla psicopatologia. La paranoia ha infatti sempre tutta l’apparenza estremamente persuasiva di una logica inconfutabile; il ragionamento del paranoico presenta una coerenza perfetta che lo rende inattaccabile, se non fosse per le premesse da cui il paranoico prende le mosse: si tratta sempre di premesse indimostrate e indimostrabili. L’argomentazione del paranoico si può smascherare spesso come fallace, mostrando come essa si riduca a un circolo vizioso. La paranoia è contagiosa e si alimenta per virtù propria: per autotropia. Paradossalmente l’autoalimentarsi della paranoia trae vantaggio dal ragionamento circolare: la tautologia è la figura che, nella paranoia, ha tutta l’apparenza di essere inattaccabile e persino ovvia. Ma la tautologia
e il ragionamento circolare sono la scorciatoia con cui il paranoico cerca di conservare, rafforzare ed estendere la sua visione della realtà, da cui dipendono ben precisi schemi di azione e piani di intervento nella vita reale. Nel suo rigore apparentemente invincibile, l’argomentazione tautologica permette al paranoico di autoesonerarsi dal compito di dimostrare gli assunti di partenza, quelli da cui dipendono tutte le conseguenze – assunti di partenza la cui fragilità è così tenuta meticolosamente nascosta. Sul piano strettamente formale la paranoia rappresenterebbe un esempio di applicazione del metodo abduttivo nell’interpretazione della realtà, se non fosse che il paranoico non mette mai in discussione la regola che ha adottato come chiave ermeneutica dei fenomeni empirici. La paranoia è un’abduzione aberrante.
Il termine “paranoia” rinvia etimologicamente a un oltrepassare, un andare oltre del pensiero, un varcare le soglie dell’esperienza abituale, della consuetudine. È stato introdotto come termine tecnico dalla psichiatria tedesca dell’Ottocento. La paranoia indica un movimento di pensiero che va oltre le apparenze e interpreta l’intero campo fenomenico sulla base di un unico principio. In questo senso essa rivendica una dignità epistemologica e una certa originalità creativa, tipica del modo di pensare che va oltre le apparenze e coglie il significato fondamentale della realtà, che invece sfugge al senso comune. John C. Hampsey in Paranoia and Contentment. A Personal Essay on Western Thought, University of Virginia Press, Charlottesville-London, 2004, distingue tra paranoic (pensiero divergente) e paranoidic, come stato psichico delirante. Zoja cita numerose definizioni del termine paranoia, registrando la generale convergenza verso la caratteristica ambivalenza della paranoia, che appartiene simultaneamente a due registri o sistemi: la ragione pensante e l’allucinazione delirante.
L’autore riprende la teoria di Melanie Klein, secondo la quale nel primo anno di vita la psiche dell’infante passa da una posizione schizo-paranoidea a una depressiva. Se inizialmente l’infante proietta l’aggressività verso l’esterno, verso la seconda metà dell’anno ne ritorce una parte verso di sé ponendo così le premesse interiori del futuro senso di colpa e dell’assunzione di responsabilità che accompagnano il divenire adulto. Tuttavia, osserva Zoja, le due posizioni, schizo-paranoidea e depressiva, non sono necessariamente superate, poiché si tratta di archetipi o potenziali psicologici ai quali determinate situazioni ed esperienze possono riportare nel corso della vita adulta: situazioni intollerabili
simili a quelle della prima infanzia possono riattivare nella vita adulta uno stato schizoparanoideo. Questo comporta la proiezione sugli altri della responsabilità da cui il soggetto, divenuto oltremodo aggressivo, mira a esonerarsi. L’archetipo o potenziale paranoico o mania di persecuzione che lo si voglia chiamare, può risvegliarsi e attivarsi in qualunque soggetto, in qualsiasi società, in qualsiasi momento della sua esistenza, se un determinato contesto ambientale funge da stimolo (p. 27).
Nella paranoia di una certa gravità la solitudine, causa e conseguenza dell’atteggiamento di sospetto, viene compensata nel delirio dall’immaginazione di essere oggetto di interesse da parte del mondo intero (delirio di riferimento). Inoltre il soggetto, dopo essersi percepito a lungo come di scarso valore e avere negato questa pochezza, risolve il conflitto con la fantasia opposta di grandezza, immaginando che le persone, invidiose del suo valore, si coalizzino contro di lui per oscurare i suoi meriti. Si osservi che megalomania e invidia sono atteggiamenti del soggetto paranoico, il quale tuttavia li proietta nei suoi rivali e competitori. Il paranoico si presenta come colui che possiede una chiave efficace con cui è in grado di interpretare l’intera realtà. L’idea di fondo viene assunta come una rivelazione di carattere religioso e quindi indiscutibilmente vera. Un esempio di idea delirante, presentata come una rivelazione incontestabilmente vera, è rappresentato dall’assunto contenuto nel Mein Kampf di Hitler, per cui gli incroci razziali portano sterilità e malattie. Non c’era alcuna prova all’epoca che le cose stessero così, e oggi addirittura è dimostrato il contrario: le patologie sorgono da un’insufficienza di incroci e mescolanze genetiche tra popolazioni diverse. Nel caso di Hitler, Zoja ricorda una fobia di contaminazione che affliggeva l’autore di Mein Kampf, il quale non sopportava la diversità, come dimostrerebbe la sua difficoltà nel rapportarsi al sesso femminile.
La paranoia si nutre del sospetto che qualcuno abbia intenzioni malvagie, sospetto che a sua volta induce il paranoico a pianificare la difesa con precisione ossessiva. Tra la convinzione del paranoico e le sue azioni si può osservare una rigorosa consequenzialità. Ne sono esempi comuni il figlio modello che uccide i genitori perché non soffrano nell’apprendere che lui ha sempre mentito e non si è mai laureato, oppure il dipendente completamente identificato con il suo lavoro che, nel timore di essere licenziato, uccide il suo capo e si toglie la vita, per evitare il licenziamento (p. 33). Il paranoico, a suo modo razionalista e illuminista, non si accontenta di vivere in un mondo pieno di
misteri e di eventi oscuri, vuole vederci chiaro e quindi delinea una serie di nessi e rapporti causali con l’intenzione di ottenere un quadro coerente. Man mano che la spiegazione diventa sempre più minuziosa e ossessiva, il paranoico trasforma le ipotesi in dogmi e le teorie costruite a scopo esplicativo in verità rivelate. Si assiste al dispiegarsi di una vera e propria furia esplicativa monomaniacale che esige di spiegare tutto, senza residui, anche ciò che avrebbe bisogno di verifiche. Nonostante le apparenze, il pensiero del paranoico è agli antipodi del ragionamento scientifico, che procede per ipotesi sempre suscettibili di essere riviste, modificate o abbandonate, qualora risultino prive della verifica necessaria. Il paranoico ha sempre bisogno di spiegazioni causali, non sopporta alcun evento che non sia ben collocato in un quadro di nessi indubitabili.
La paranoia non colpisce solo l’individuo, la fa da padrona anche sul piano collettivo. La paranoia è contagiosa e può portare a esiti distruttivi di proporzioni inaudite, come dimostra la pratica nazista di annientare preventivamente il nemico potenziale, con un’escalation – una vera e propria valanga che si ingrossa da sé, fenomeno che Zoja chiama autotropia. Prima del nazismo la tecnica del terrore nei confronti di popolazioni inermi era stata largamente praticata dalle potenze coloniali, nonché dagli americani nei confronti degli indiani, sterminati senza pietà se osavano avanzare qualche obiezione al saccheggio e alle devastazioni dei bianchi. Una differenza fondamentale tra delirio paranoico individuale e collettivo è che il primo è un’affezione psichica rara, di bassissima frequenza rispetto ad altre malattie psichiatriche, mentre il delirio collettivo e storico è così frequente da risultare la norma, il che spiegherebbe perché sia stato oggetto di scarsissima attenzione. Un confronto tra lo sterminio degli ebrei e quello degli armeni autorizza la considerazione che il primo «scaturì dalla coscienza collettiva dell’apparato nazista e dai suoi piani preventivi (di cui era inconscia la motivazione patologica), quello degli armeni, invece, nacque in misura maggiore dall’inconscio collettivo» (p. 45). Il XX secolo ha assistito al proliferare della paranoia collettiva, parallelamente alla crescente diffusione dei mass media, collettori e veicoli formidabili di “infezioni psichiche collettive”. I mezzi di comunicazione di massa sono un ausilio efficacissimo alla diffusione della paranoia collettiva: «Una volta affidato al potere moltiplicatore del mass medium, il fatto di essere odiati, invece di diventare occasione di autocritica, può esser offerto a dimostrazione che è giusto odiare:
ecco che l’inversione delle cause assume dimensioni continentali ed effetti apocalittici» (p. 45). Un’assurdità di massa diventa presto una verità assoluta, un credo, una fede. La paranoia collettiva è subdola e impercettibile perché nasce e vive in simbiosi con i movimenti dell’intera società, che non riesce, se non nelle figure di intellettuali indipendenti, a percepire la mostruosa infondatezza e orribile mistificazione di cui essa stessa è vittima. Come i persecutori del mito che hanno eletto una vittima caricandola di tutta la colpa possibile per i mali da cui sono afflitti e sono assolutamente incapaci di comprendere che la vittima è incolpevole ed essi stanno commettendo un crimine inaudito, così alle masse infettate dalla paranoia collettiva non è dato il dono di alzare lo sguardo sull’immonda ondata di lordura da cui tutti sono travolti e imbrattati fino a rendersi irriconoscibili. L’individuo immerso nella folla può illudersi di sfuggire alla morte trasferendola su di un nemico, sul quale proietta una volontà di distruzione che giustifica l’attacco preventivo per annientare il presunto distruttore. Naturalmente, se fosse vero che un certo nemico sta per uccidermi, potrei essere giustificato nell’adottare le misure necessarie per sfuggire al suo attacco, compresa la misura preventiva. La paranoia di massa si alimenta di questo circolo e prospera sulla base di quella che a tutti appare un’evidenza schiacciante: un attacco mortale imminente che bisogna prendere in contropiede. Se non fosse per l’assunto di partenza, il paranoico agirebbe in base a una logica ferrea. La generalizzazione della paranoia di massa trova sempre conforto nella conformistica adesione alla credenza comune. La sua normalità è il modo migliore di occultarsi. La paranoia collettiva è un fenomeno inquietante, che illustra come sia labile il confine tra ciò che è vero perché tutti credono che lo sia, e ciò che tutti credono vero perché è vero in se stesso. Il dubbio può sorgere ogni volta che una credenza, universalmente abbracciata senza discutere, scompare dal campo della coscienza critica sottraendosi automaticamente alla verifica fattuale.
**** Zoja non ha torto nel mettere in rilievo il ruolo di potenziamento e moltiplicatore della paranoia collettiva svolto in misura crescente dai mezzi di comunicazione di massa dal XX secolo in poi. La dietrologia, ovvero l’arte del sospetto e l’abitudine di ipotizzare un complotto per spiegare semplici coincidenze o casualità persino banali, è una delle forme di affermazione della paranoia, che si
diffonde insieme ai messaggi. La paranoia della notizia trova un fertile terreno nel lettore finale, avvezzo a pensar male e sempre pronto a sospettare di inganni, e tranelli di cui lui e altri sarebbero vittime. La paranoia è all’origine della calunnia e accampa, oltre a spiegazioni che i fatti possono smentire, anche un certo atteggiamento mentale che si radica e rimane nel tempo. La paranoia collettiva può essere smascherata solo dal tempo: la profondità temporale consente alla ragione di assumere il distacco necessario alla demistificazione, alla rivelazione di come effettivamente stavano le cose.
Zoja propone una graduatoria del crimine collettivo: l’aggressione collettiva locale (ad esempio i pogrom, massacri episodici di appartenenti a determinate etnie); la cacciata collettiva di una certa popolazione o etnia, che può assumere anche la forma della deportazione organizzata, come la pulizia etnica nella ex Jugoslavia: si tratta di un crimine ancora privo di uno statuto giuridico e di una precisa definizione, data la sua multiformità. Infine lo sterminio di un’etnia, chiamato genocidio da Raphael Lemkin nel 1943 e da allora entrato nella terminologia della legislazione internazionale. I passaggi del genocidio sono tipici: identificare un’etnia con una minaccia mortale per la comunità intera; delimitare e terrorizzare gli esponenti di quell’etnia eletta a nemico; toglierle prerogative e proprietà; procedere al suo annientamento. A interpretare queste escalation non bastano la storia e il diritto, si deve convocare anche la psicopatologia. Le motivazioni inconsce della paranoia collettiva non hanno alcun fondamento in un pericolo reale. Si tratta di fenomeni proiettivi, amplificati dal consenso irresponsabile e acritico offerto da un numero crescente di persone, che avvertono l’esigenza di dare una risposta, di trovare una spiegazione convincente della crisi in cui versano. Il genocidio è il tipo di crimine collettivo che può essere programmato lentamente, diffondendo un odio implacabile nei confronti di un gruppo etnico, da parte di autorità politiche e militari che tuttavia non possono mai spingersi fino al punto di annunciare apertamente l’intenzione di annientare un’intera etnia, poiché tale soluzione risulterebbe immediatamente inaccettabile e abominevole per tutti, ed è contraria anche all’impulso animale. Esempi di genocidio troviamo all’epoca della colonizzazione; i regimi comunisti di Mao, Stalin, Pol Pot hanno messo in pratica un tipo di sterminio che riguarda gli esponenti di determinate classi, per cui, ricorda Zoja, si è parlato di classicidio (p. 51).
Secondo Norman Cohn esiste una perfetta continuità tra le prime fasi di persecuzione e il genocidio vero e proprio. L’intero processo, dall’inizio fino al crimine esplicito, è governato dalla logica implacabile di un odio di persecuzione giustificato solo dalla convinzione che l’etnia perseguitata sia il male assoluto da estirpare. Se la persecuzione ha per protagonisti tutti i componenti di una nazione, il gruppo etnico preso di mira non ha più scampo; una volta che il pactum societatis si è rotto, la persecuzione non è più avvertita come perversa e ingiusta, ma ciecamente proseguita fino all’espulsione della vittima. Dall’individuazione dei segni vittimari, come direbbe René Girard, fino al linciaggio della vittima prescelta, il tutti contro uno mette in movimento la macchina dell’assassinio di cui tutti sono complici e nessuno si sente colpevole. Le categorie psichiatriche evocate da Zoja e quelle antropologiche di Girard, colgono la fatale unità del processo di persecuzione e mostrano che in molte fasi della storia (come nella prima metà del secolo scorso in Europa orientale o durante la guerra fredda, di fatto non ancora conclusa) hanno avuto il sopravvento vere e proprie esplosioni di paranoia collettiva prolungata. Nella clinica della paranoia individuale, le voci udite dal paziente rappresentano una prova del suo delirio; nel caso in cui a udire le voci sia la massa, si potrà invocare la psicopatologia, ma nessuno nutre la convinzione di trovarsi in una situazione di follia. La verità non è solo filia temporis, ma anche soprattutto vox populi. La paranoia esprime un’esigenza insopprimibile di spiegazioni, per cui la psiche si attiva per moltiplicare il numero di spiegazioni; tale tendenza si espande fino a colpire l’intera popolazione.
La moderna diffusione della paranoia è favorita anche da un altro fattore, che genera sempre nuovo sospetto tra gli esseri umani. Nel corso della storia l’uomo ha imparato a sopportare e accettare le sciagure decifrandole come espressione della volontà di Dio. I contemporanei non si accontentano della spiegazione teologica, perché gli è stato insegnato che esiste un diritto alla giustizia. Essi pretendono che per ogni evento vi sia una causa, una spiegazione razionale per ogni fenomeno, anche il più misterioso. «Dal punto di vista filosofico, avverte Zoja, l’illuminismo, lo scientismo, il positivismo (incluse le psicologie che tendono a non rispettare il mistero, come le forme di psicoanalisi freudiana più ortodossa) abituano i nuovi possessori del sapere – gli scienziati, gli intellettuali – ad assumersi la responsabilità di spiegare ogni cosa» (p. 58). La diffidenza distruttiva domina l’epoca contemporanea,
dove giornali e televisione fanno sì che il contagio paranoico progredisca senza incontrare ostacoli. Lo scopo soggettivo dell’attività dei mass media è l’informazione e, eventualmente, la condanna di certi misfatti, ma il risultato, a causa dei meccanismi mimetici di suggestione e contagio, è quello di incoraggiare la moltiplicazione degli stessi misfatti (p. 59). Il vittimismo dilaga ovunque; insieme al diritto di sapere tutto, di essere informati su tutto, di aver competenza su tutto, di poter intervenire su tutto. Lo stesso articolo 32 della nostra Costituzione dichiara che lo stato “tutela come fondamentale diritto la salute”. Zoja osserva ironicamente che Dio sembra aver preso il posto del legislatore, laddove si pretende di tutelare non il diritto alle terapie, ma alla salute. Il malato allora si sentirà vittima di un’ingiustizia solo per il fatto di essere malato, non per la mancanza di terapie; la paranoia trova così mezzi di moltiplicazione di massa, per poi agire a livello individuale, pur rimanendo paranoia collettiva. La paranoia collettiva, ormai tanto diffusa da passare per normalità, toglie visibilità anche a quella individuale. La politica e la paranoia sorgono a un parto. Un esempio di come le istituzioni democratiche segnino il sorgere anche in se stesse di pratiche paranoiche, è rappresentato dal potere di ostracismo che la democrazia ateniese concedeva al popolo, per cui bastava il sospetto che qualcuno abusasse del potere per invocare il diritto di mandarlo in esilio quale misura di prevenzione. Insomma la diffidenza, il sospetto e il sopruso preventivo sono istituzionalizzati.
**** Nella storia della colonizzazione particolarmente significativo risulta il Requerimiento, documento redatto nel 1512 da Juan López de Palacios Rubios, che doveva accompagnare l’incontro con nuove terre e nuovi popoli; documento basato sulla diffidenza, era in realtà una diffida. Oltre alle assurdità giuridiche, Zoja sottolinea la natura paranoide del documento. Il Requerimiento, come la paranoia, parte da “premesse false ma incrollabili”. La Bolla papale del 1493 aveva tracciato la linea di separazione ideale tra le terre che spettavano al Portogallo e quelle che spettavano alla Spagna. In base al sospetto, l’avversario diventa oggetto di un attacco preventivo, che non prevede di concedergli la dignità di soggetto. La fretta, la proiezione della colpa sull’avversario e l’ossessione caratterizzano il procedimento. Se gli indigeni non si sottomettono, sarà loro fatta la guerra e saranno fatti schiavi. «Che importa, si
chiede Zoja, se la donazione delle terre indigene ai re di Castiglia è contenuta in un documento scritto, quando è stata fatta all’insaputa degli indigeni? Che importa la presenza di un notaio e di testimoni per il Requerimiento, se anch’essa non è stata negoziata da entrambe le parti, ma estorta da una sola?» (p. 81). Tutti i passaggi del documento sono perfettamente logici, peccato però che derivino tutti da un’affermazione di partenza indimostrata e indimostrabile, secondo la quale Dio ha conferito al papa di Roma la giurisdizione universale sul pianeta, premessa e pretesa di cui oggi anche qualsiasi cattolico chiederebbe una prova (p. 81).
La nascita del nazionalismo presenta un altro capitolo di storia della paranoia che Zoja indaga meticolosamente. Dalle conquiste napoleoniche in poi il principio dei diritti dell’uomo viene acquisito e fatto proprio dalle nazioni europee. Contemporaneamente però si afferma anche il principio base del nazionalismo: i diritti dei popoli. Le due idee si propagano per contagio in un clima di esaltazione collettiva e di entusiasmo, ma pochi comprendono che si tratta di due idee antitetiche e cariche di un potenziale conflittuale. Infatti se il principio dei diritti dell’uomo proclama l’uguaglianza universale, quello dei diritti dei popoli al contrario sostiene che ogni popolo ha diritto di essere libero, autonomo, autogovernato perché portatore di peculiarità che lo rendono diverso dagli altri. Ebbene qual è il senso di questa diversità, se non, a ben vedere e se si guarda ai fatti, un’asserita superiorità rispetto agli altri popoli? (p. 85). La pseudospeciazione concetto ed espressione introdotti da Erickson infatti altro non è che il fenomeno per cui gli uomini di lingua, colore della pelle e aspetto diversi sono classificati come appartenenti a una specie diversa, nonostante il fatto che la specie umana sia solo una, e quindi suscettibili di essere uccisi, come si fa con gli animali. La sensazione di estraneità può essere così forte che chi ne diviene vittima corre rischi molto seri. Il nazionalismo costruisce la sua legittimazione apparentemente con il richiamo a una tradizione ingiustamente sacrificata, ma in realtà attraverso la costruzione di premesse appropriate per proiettarsi nel futuro. Zoja osserva che la lettura paranoica dei rapporti tra i popoli, basata sulla diffidenza e sull’aggressività, coincide con l’origine stessa della storia. Erodoto pone all’inizio della storia la rivalità tra fenici e greci e di altri popoli; il ratto di Elena è l’ultimo di una serie di ratti che consolidavano il sentimento dell’onore collettivo offeso (p. 88). Nazionalismo e paranoia collettiva sono così intimamente connessi che risulta impossibile parlare dell’uno senza fare riferimento
all’altra. Sotto molti aspetti è difficile negare che il nazionalismo, tolti gli entusiasmi soggettivi di individui e masse, non sia altro che paranoia collettiva. La paranoia individuale può fungere da moltiplicatore del nazionalismo e viceversa il nazionalismo da moltiplicatore della paranoia (p. 93). Una paranoia particolarmente accentuata, come nel caso di Hitler, può produrre effetti disastrosi se trapiantata nel terreno fertile di un nazionalismo già in preda a convulsioni paranoiche. Nazionalismo e razzismo hanno in comune l’aspirazione a indossare un abbigliamento culturale; entrambi avanzano la pretesa di basare le loro conclusioni su dati di fatto e non su pregiudizi e atteggiamenti emotivi.
Nella seconda metà dell’Ottocento il razzismo “scientifico” si avvale del darwinismo per dare voce alla diffidenza tipica della paranoia e giustificare gli istinti distruttivi. La nozione di sopravvivenza del più adatto veniva sfruttata da Joseph Arthur de Gobineau nel suo Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-55) per giustificare l’abbandono della dottrina giudaico-cristiana e favorire lo sviluppo dell’umanità come specie animale. Era tempo, sostenevano i razzisti che strumentalizzavano la teoria di Darwin e Spencer, che fosse abbandonata la solidarietà con i più deboli, la quale mantiene in vita individui deboli e tarati, favorendone la riproduzione, quando invece essi dovrebbero essere lasciati morire perché di ostacolo all’evoluzione e al progresso. Francis Galton, cugino di Darwin, propose addirittura un piano di “eugenetica positiva” per selezionare e rafforzare le doti intellettuali degli esseri umani. Il compito di realizzare un programma che sarebbe stato particolarmente intrusivo nella vita privata delle persone, era affidato allo stato. L’assunto di base si presentava come indiscutibile (p. 95). Un assunto falso, inverificato, era sostenuto e propagandato con il fervore dogmatico di una fede religiosa. Galton era galvanizzato dall’ansia di contaminazione che affliggerà Hitler, accompagnata da un’esigenza febbrile di separare, disgiungere, segregare, il bene dal male. Ma né Galton né Hitler furono mai sfiorati dal sospetto che incrociando tra loro i portatori di caratteri genetici positivi si determinasse un eccesso di endogamia che avrebbe rafforzato i caratteri negativi recessivi (p. 96). Si affermava così la credenza, basata su premesse false, che di lì a poco sarebbe sopravvissuta solo la razza ariana e che la selezione si sarebbe prolungata anche all’interno della razza superiore per eliminare i malriusciti, gli scarti della selezione. La persuasione che il genere umano e gli stessi individui possano trarre vantaggio dall’evitamento di incroci, era la conseguenza di dogmi indiscutibili
di base, assunti come scientifici. L’unione con persone etnicamente lontane si profilava quindi come un errore individuale e specifico, senza che potesse essere portata alcuna evidenza a sostegno di tale valutazione (anzi, esistevano già prove e contrario, non prese in considerazione, di come l’endogamia determini un indebolimento della popolazione sul piano genetico). «Questo eccesso di ansia, commenta Zoja, è rafforzato dal moltiplicarsi dei contatti con popoli lontani e dai sensi di colpa prodotti dalla loro sopraffazione (frettolosamente razionalizzata in nome del progresso come un’inevitabile selezione competitiva)» (p. 97).
**** La paranoia trionfa nei preparativi che sfociano nella Grande Guerra. E si lancia all’attacco negli ultimatum e nelle mobilitazioni preventive che accelerano lo scoppio del conflitto. Numerosi intellettuali diedero man forte lasciandosi contagiare dalla frenesia e dall’eccitazione per la grande avventura bellica − dall’entusiasmo per un evento che prometteva di risolvere in un colpo solo tutte le tensioni accumulate, i problemi non risolti, gli odi e i rancori a lungo sopiti. Tutti coloro che avevano conti in sospeso, speravano di ottenere qualche risarcimento nel marasma di una guerra che, come ogni guerra, sospende l’autorità della legge ordinaria e i diritti delle persone. La paranoia si nutre da sé e si propaga pressoché all’istante, con la forza di un contagio irresistibile. L’euforia irresponsabile che agita le menti scosse da una strana febbre si diffonde in tutti gli strati della società e contagia persino pensatori avveduti e prudenti, avversi a ogni fanatismo ideologico, come Wittgenstein e Freud (p. 145).
Nel corso della Grande Guerra i mezzi di comunicazione di massa hanno avuto un ruolo molto attivo. Zoja osserva che, se in tempo di pace ci si trova in una pianura quindi relativamente stabili, «la guerra e il suo correlato psicologico, la paranoia è invece una superficie inclinata, dove anche chi non si muove scivola» (p. 149). Nell’Europa del passato la parentela tra i regnanti europei facilitava le ricuciture tra monarchie, nel caso in cui ci fossero state offese in grado di scatenare una guerra, e si poteva concordare una versione ufficiale in cui nessuno perdeva in dignità e onore. Con la diffusione della democrazia i mezzi di informazione hanno conquistato il potere di influenzare il corso degli eventi politici e quindi anche bellici. I mezzi di comunicazione si rivolgono a lettori privi di memoria storica, prigionieri di un lasso di tempo
limitato al giorno stesso in cui leggono o ascoltano la notizia. Lettori del genere sono malleabili come plastilina, si può fare di loro ciò che si vuole, facendoli cavalcare l’onda emotiva che al momento promette di essere più remunerativa per loro stessi e per coloro che traggono vantaggio personale dal conflitto. I mass media possono linciare con l’accusa di disfattismo o codardia, coloro che si oppongono alla guerra. A un certo punto, con l’aria di voler mostrare e smascherare ogni cosa, i mezzi di comunicazione, mentre svelano i soprusi che nessuno noterebbe se mancasse l’informazione, occultano tuttavia l’interesse dei “paranoici di successo”, i quali danno a credere di avere a cuore l’onore nazionale, ma in realtà sono preoccupati dal loro successo. «I nuovi unni calano nella mente e si chiamano giornali. In un’epoca in cui lo studio dei mass media era ancora lontano quanto la luna, Karl Kraus li accuserà di approfittare del conflitto e, circolarmente, di alimentarlo, “intingendo le penne nel sangue e le spade nell’inchiostro”. Come il riunirsi di individui in una folla abbassa l’intelligenza al livello inferiore dei suoi componenti, così il moltiplicarsi della parola scritta in stampa quotidiana rattrappisce il discorso collettivo al minimo comun denominatore populista e l’orizzonte temporale a quello della sua periodicità: alla giornata» (p. 150).
Nel corso della guerra il sospetto è elevato a metodo, diventa presto cecità isterica e sfocia in esecuzioni sommarie. Cesare Battisti fu giustiziato come traditore: nel suo ruolo di parlamentare a Vienna era accusato di aver studiato le mappe militari austriache, per poi tradire passando all’Italia. La fotografia della sua esecuzione fu fatta circolare nell’Impero, per ammonire i potenziali traditori; poi arrivò anche in Italia, dove fu riprodotta a iosa per eccitare il risentimento nei confronti dell’Austria, responsabile della barbara soppressione del patriota. «Karl Kraus nota che, in quell’istantanea, il boia e molti dei presenti, si accalcano per essere fotografati insieme al cadavere (l’esecuzione è avvenuta a Trento e molti dei presenti sono probabilmente italiani)» (p. 151). La dipendenza dai mezzi di comunicazione di massa, cui oggi dobbiamo aggiungere anche il web, non è un fenomeno limitato alla situazione di effervescenza emotiva che caratterizza ogni periodo bellico, è invece una schiavitù crescente, di cui gli individui non sono consapevoli: essi per lo più nutrono l’illusione di avere il controllo della realtà mediante l’informazione che ricevono persino sul loro cellulare ovunque si trovino, mentre in realtà essi sono succubi e controllati sia nei loro pensieri sia nei loro spostamenti e movimenti. I mezzi
di comunicazione emanano ordini e disposizioni uno dopo l’altro mascherati da informazioni, veicolati da strumenti elettronici che, per via satellitare, consentono una precisa localizzazione del soggetto ovunque si trovi. Chi controlla e chi è controllato?
La follia della guerra si dispiega in tutta la sua truculenza pervasiva mediante uno stato di esaltazione paranoica che pretende di redimere le morti precedenti e i linciaggi dei traditori veri e presunti, attraverso ulteriori eccidi. Lo scopo della guerra è la vittoria, no? Non si vorrà per caso che i caduti siano morti inutilmente?! La guerra acquista così un movimento autotropico irresistibile e la sola vittoria indubbia e a portata di mano diviene il sopravvento della stessa guerra sulla pace. La guerra che si combatte è infinitamente più desiderabile della pace, finché domina la paranoia. La speranza di vincere è trasformata in certezza disperata, così da giustificare nuovi prestiti, nuovi debiti e nuovi morti, al solo scopo di sferrare l’attacco ultimo e decisivo (p. 152). La paranoia domina incontrastata nella propaganda che viene sviluppata per diffondere un’immagine denigratoria del nemico, propizia alla sua animalizzazione e all’esigenza conseguente di eliminarlo fisicamente senza scrupoli. La pseudospeciazione è all’opera con tale alacrità che diventa un luogo comune, un riflesso condizionato, un’ovvia avvertenza. Al nemico sono attribuite le peggiori atrocità e una crudeltà perversa, coerente con l’intento di disumanizzarlo definitivamente.
Zoja prende in esame la condotta di Wilson, il presidente americano che ebbe un ruolo decisivo nella condotta delle trattative e nella redazione dei trattati di pace tra gli stati belligeranti. Wilson in sostanza, secondo l’interpretazione che della sua personalità hanno fornito Keynes, Freud e Bullitt, si sarebbe identificato inconsciamente con Cristo: «Si sentiva vittima di una cospirazione contro il bene analoga a quella che si era conclusa con la crocifissione di Gesù. Il presidente americano avrebbe finito per rinunciare a una condotta maschile, esibendone con gli alleati una femminile: mancando di argomenti pratici, virili, cercava di convincerli con seduttività, concessioni, appelli alla bellezza degli ideali» (p. 172), pur sapendo già dal 1917 che gli alleati volevano imporre agli Imperi centrali condizioni di pace punitive. Le trattative si svolsero in un clima paranoico, nel quale furono impostate le relazioni decisive tra le principali potenze che avrebbero caratterizzato il XX secolo. Furono poste la basi di un nuovo conflitto: «L’utilizzo di sanzioni economiche durissime fu percepito come un’arma sleale per completare la distruzione della
Germania anche dopo l’armistizio. La sensazione di essere colpiti da una macchinazione si annidò nei vinti, e con essa una sfiducia senza precedenti, perché fuoriusciva dalla guerra stessa e riguardava direttamente il trattato di pace. Hitler avrebbe dovuto solo attingere alla rendita paranoica che con questa umiliazione si andava accumulando» (p. 175). I vincitori si comportarono con arroganza e cinico pragmatismo, rinnegando nei fatti l’impegno sancito da Wilson di riconoscere ai popoli il diritto all’autodeterminazione; del resto quasi tutti i 14 punti di Wilson furono disattesi. Le proteste della delegazione tedesca non servirono a niente. Gli emissari tedeschi fecero sapere che se la Germania avesse conosciuto le condizioni effettive che le sarebbero state imposte, non avrebbe deposto le armi né si sarebbe ritirata dai territori nemici che erano ancora sotto la sua occupazione. Ma la protesta ormai non servì a niente: la Germania si era ritirata e aveva smobilitato, mentre l’impero austro-ungarico si era già dissolto nella varie nazionalità. «A questo punto però, avverte Zoja, era divenuto impossibile il disarmo della paranoia, che dovrebbe seguire gradualmente quello degli eserciti. Al contrario, certi suoi corollari – le certezze indiscutibili, il sospetto, la tendenza al segreto, l’autoinganno, la proiezione, la falsa coerenza si erano rafforzati trasversalmente in tutta Europa» (p. 177). La pace di Versailles avvalorò all’interno della Germania l’idea e l’ossessione che una congiura aveva programmato la sconfitta e l’umiliazione della Germania. L’idea di una congiura, per quanto infondata, si basava sulle misure punitive prese nei confronti della Germania. Le misure erano effettivamente di tale durezza che venne facile ai tedeschi pensare che erano state decise dai nemici per dare alla Germania il colpo di grazia da cui non si sarebbe più risollevata. La paranoia germanica poteva quindi infiammarsi a buon diritto, proclamando che i fatti davano loro ragione.
Più in generale, ogni guerra lascia uno strascico di astio nei confronti del nemico anche dopo la firma del trattato di pace. Ma nel caso della Grande Guerra la paranoia bellica sopravvisse all’interno dei paesi vinti nella forma di un delirio di purificazione nazionalista che trovava nel razzismo il suo naturale alleato, la sua base di appoggio. Il pensiero schematico e semplificatore della paranoia riusciva a far passare come scientifiche nozioni fantastiche razza, nazione adatte però a un uso emotivo e propagandistico nella costruzione di nuove entità statuali che sostituissero la ricca molteplicità di popoli, culture e lingue che per secoli erano convissute nella compagine dell’impero. Il passaggio
che si auspicava da parte di correnti di pensiero alla moda era quello dal polinazionalismo al mononazionalismo, celebrato come transizione da uno stadio meno evoluto a uno superiore, allo stesso modo in cui si considerava il monoteismo superiore al politeismo. «Il monoteismo etnico era, per così dire, una sorta di nuovo credo laico, in nome del quale si risvegliavano le intolleranze delle antiche guerre di religione» (p. 186). Il passaggio dal nazionalismo al razzismo è breve, facilitato dall’esigenza che ha il paranoico di semplificare il proprio orizzonte mentale per autodifesa. Il processo di purificazione, per quanto assurdo, abusivo e insensato, svolge la funzione di mantenere il paranoico nella sua convinzione incrollabile di essere il bene che trionfa nella lotta contro il male. Come il peccatore compie ogni sforzo per liberarsi della sporcizia del peccato che continua a percepire dentro di sé, senza mai accontentarsi del livello di purezza raggiunto, così il razzista è animato da un impulso simile a togliere di mezzo il male che vede fuori di sé, senza che mai possa dirsi davvero ultimata la fatica purificatrice, destinata fatalmente a incontrare sempre nuove impurità razziali, nuovi residui estranei dai quali il mondo va ripulito. Il terreno era quindi pronto affinché attecchissero e si sviluppassero le farneticazioni esaltate di Adolf Hitler. Da premesse apparentemente inconfutabili, ma in realtà totalmente assurde, il futuro dittatore ricavava con logica coerenza le più nefaste conseguenze operative. Qualunque sia il modo in cui reagiscono le vittime del razzismo, la paranoia razzista troverà sempre il modo di interpretarne il comportamento in modo da confermare la tesi di partenza. Il radicalismo razzista del Mein Kampf addita come insuperabile la differenza genetica tra i popoli germanico e slavo o germanico ed ebraico. Hitler respinge quindi la soluzione del sindaco Lueger, pure antisemita, il quale vorrebbe estendere l’insegnamento del tedesco alle minoranze insieme all’obbligo di parlarlo. Per Hitler, slavi ed ebrei sono geneticamente diversi dai tedeschi, quindi se parlassero tedesco la società sarebbe minata dalla presenza di nemici occulti. Attecchisce l’ansia di contaminazione che si propaga con il razzismo, ma ecco che si assiste a un salto mortale: non solo gli ebrei, ma anche i cristiani sono una macchia da lavare via: il cristianesimo è un ramo dell’ebraismo, quindi un cristianesimo tedesco non ha alcun senso. Non si può essere tedeschi e cristiani. Ecco il punto: qui la diversità genetica non c’entra, semmai il nucleo della diversità, la base dell’incompatibilità è in una religione la stirpe dell’ebraismo che con la genetica razzista non ha nulla a che vedere. Naturalmente
questo non è l’unica macroscopica incoerenza che offusca la coerenza maniacale della paranoia razzista!
Zoja ci rammenta che secondo alcuni Hitler soffriva di pseudologia phantastica, l’attitudine mentale a inventare menzogne di ogni genere per poi convincersi della loro verità. Il complesso di onnipotenza di cui Hitler dà prove schiaccianti in numerose occasioni ha la funzione di compensare l’insicurezza tipica del paranoico. In certi suoi discorsi sostiene di aver dato ordini che rivelano una sinistra propensione a risolvere i conflitti mediante il ricorso alla forza brutale, con la fretta e l’impazienza di chi non esita a commettere e far commettere i crimini più efferati, veri e propri stermini di popolazione inerme con tanto di donne e bambini. Hitler sostiene che la forza dell’esercito tedesco consiste nella rapidità e brutalità con cui l’azione di sterminio sarà eseguita. L’intollerante impazienza del Führer concepisce la guerra come annientamento del nemico, non come strumento per modificare i rapporti di forza tra stati belligeranti. La paranoia non ama mezze misure, sfumature, compromessi di sorta: la prevenzione delle prevenzioni può solo essere radicale. Il nemico annientato non potrà più colpirci. Il paranoico fa terra bruciata intorno. Alla fine la sua profezia si autoavvera. La previsione di un complotto contro la Germania orchestrato dalle grandi potenze internazionali, se all’inizio della guerra è del tutto infondata, comincia lentamente a profilarsi come la sola opzione disponibile, nonostante le resistenze comprensibili di Stati Uniti e Unione Sovietica a stabilire un’alleanza contro il nemico comune. Il paranoico in sostanza conferisce alla situazione una struttura cognitiva che obbliga i suoi avversari a coalizzarsi contro di lui, confermando quindi il suo assunto di partenza. Come osserva Zoja, non è forse vero che in psicopatologia è lo stesso paranoico a provocare la propria rovina? La decisione del paranoico giunge spesso a conclusione di un vorticoso e sofisticato ragionamento, per quanto basato su premesse discutibili. Ne è un esempio l’argomentazione, contenuta nel documento citato da Zoja, con cui Hitler decide di eliminare la Russia, per battere gli inglesi, che devono la loro sopravvivenza alla Russia e all’America: «Se la speranza nella Russia scompare, scompare anche l’America, perché l’eliminazione della Russia potenzia enormemente il Giappone in Asia Orientale. La Russia è la spada di inglesi e americani contro il Giappone (…) La Russia è il fattore su cui gli inglesi contano di più (…) Ma se la Russia è cancellata, lo è anche l’ultima speranza degli inglesi (…) È deciso: nel corso di questo conflitto, la Russia deve esser eliminata. Nella
primavera 1941» (p. 224). La seconda guerra mondiale presenta una serie infinita di crimini contro l’umanità, come solo poteva accadere in una guerra divenuta totale, in cui gli obiettivi civili e militari sono tutt’uno e le vittime civili e militari non sono più distinguibili; il fronte è ovunque e i bersagli sono indiscriminati, come in una guerra civile sfuggita al controllo. L’impossibilità di aprirsi al dialogo con i nemici per trovare un compromesso onorevole, quando ormai le sorti della guerra volgono chiaramente al peggio per la Germania, è una caratteristica tipica della paranoia; infatti il paranoico è assolutamente incapace di autocritica e di dialogo interiore; e, avendo bisogno degli altri per attaccarli e prevenirne le supposte manovre ostili e segrete, oppure per condividere le sue ossessioni e convincerli della verità assoluta delle sue intuizioni, finirà col parlare sempre con dei fantasmi.
**** Anche l’analisi della personalità di Stalin rivela evidenti tratti paranoici. Aggressivo nei suoi approcci al prossimo, diffidente per principio nei confronti di chiunque, privo di autoironia, Stalin è simile a Hitler: anche lui considera la realtà come qualcosa che non è dato in partenza, ma che deve essere plasmata e creata, con una differenza però: «Per Hitler la costruzione mentale deve trasformarsi in realtà d’un sol colpo, per Stalin gradualmente e silenziosamente» (p. 248). A poco a poco Stalin toglie di mezzo tutti i suoi compagni di strada, puntualmente caduti in disgrazia uno dopo l’altro. Ad ogni passo Stalin rivendicava il merito e il compito di proseguire l’opera di Lenin. Hitler e Stalin sono riusciti a infettare le masse con la loro immaginazione sulla realtà e persino a diventare dei modelli agli occhi delle masse. Eppure le stragi di Stalin hanno una cifra: 54 milioni secondo Davies, per il periodo 1917-1953: sono vittime interne all’Unione Sovietica, in massima parte riconducibili alla responsabilità di Stalin. La politica di sterminio di Stalin si spiega solo in base alla sua diffidenza radicale di paranoico conclamato. Zoja ricorda che nel 1986 Ernst Nolte suscitò un’indignata reazione e una vivace polemica tra gli storici quando pose la questione se i gulag sovietici non avessero preceduto i campi di concentramento dei nazisti, e ne fossero stati il modello. L’orrore bolscevico era cominciato prima; quello nazista è stato inventato autonomamente oppure è stato introdotto sotto l’influenza di quello sovietico? Stalin non si limitò alla deportazione e allo sterminio di classe; non solo Nolte, ma anche Solženicyn
aveva già messo in chiaro che Stalin aveva preceduto Hitler anche nella deportazione e sterminio delle nazionalità, avviata nel 1937 (p. 265). Stalin poteva contare su di un intero apparato compiacente che eseguiva in modo impersonale gli ordini di eliminazione dei kulaki. Come da copione, le vittime erano preventivamente descritte come animali, per mettere da parte ogni senso di colpa fosse sorto nel corso della loro brutale eliminazione. L’animalizzazione del nemico, conseguenza della pseudospeciazione, non fu quindi una prerogativa del nazionalsocialismo (p. 270). Di qui le accuse ai contadini di nascondere i raccolti, accuse da cui non li scagionava neppure la malnutrizione di cui soffrivano; l’odio di classe e la paranoia distruttiva non conosceva limiti; di qui le insinuazioni e le calunnie, i processi spettacolo, le deportazioni e la condanna a morte. In Stalin raggiunge la vetta ogni aspetto della paranoia, come la coerenza assurda e l’inversione di consequenzialità. Stalin cerca tuttavia di stabilire un’immagine rassicurante della sua persona, nonostante mandasse a morte degli innocenti con il metodo che consisteva nell’indurli all’autoaccusa. «Gli aspetti più perversi della sua personalità erano negati, la sua ansia paranoica era alla costante ricerca di avversari in cui “punire”, per interposta persona, il criminale che era in lui» (p. 279). In buona sostanza Stalin ha creato un gigantesco rituale catartico, che svolgeva la duplice funzione sia di accrescere consenso e popolarità, sia di terapia personale. Il nemico esterno, il traditore che di volta in volta faceva “confessare” per poi toglierlo di mezzo, era la controfigura del nemico interno: voleva liberarsi dell’informatore segreto della polizia zarista che era stato in passato o della responsabilità di essere stato il “becchino” della rivoluzione. La sua “terapia processuale” si avvaleva del pubblico accusatore Andrej Vyšinskij; in tal modo «il male era espulso due volte per interposta persona» (p. 280).
Il sospetto non poteva risparmiare gli ebrei. Stalin non ha mai consentito che si parlasse dello sterminio ebraico, esercitandosi in quello che sarebbe stato il negazionismo dei neo nazisti. Per scatenare l’Armata Rossa contro i nazisti man mano che avanzava, Stalin aveva fatto disseppellire migliaia di corpi di ebrei uccisi e li aveva fatti allineare lungo la strada percorsa dalle truppe sovietiche: l’ordine era di far sapere che si trattava di cittadini sovietici barbaramente uccisi, non ebrei. La paranoia, scrive Zoja, faceva sì che Stalin guardasse con sospetto al credito guadagnato dagli ebrei nella lotta contro il nazismo, perché il primo e vero
vincitore del nazifascismo doveva essere l’Unione Sovietica. Dopo la fine della guerra e poco prima della morte di Stalin, si procedette all’eliminazione del comitato antifascista ebraico, con processi che si conclusero con la condanna a morte o a decenni di internamento dei suoi membri; intanto la nuova caccia alle streghe si diffondeva nei paesi satelliti dell’URSS, in particolare in Europa orientale (pp. 291-292).
Stalin è stato il perfetto esempio di tiranno corrispondente all’identikit aristotelico: governare facendo in modo che i suoi sottoposti non si fidassero l’uno dell’altro e non fidarsi di nessuno di essi. Una sfiducia paranoica sistematica, scrive Zoja, che si incarnava in un gigantesco apparato poliziesco e giudiziario. Il regime stabiliva che cosa fosse bene e male, creando continuamente dei capri espiatori, con una procedura che si ripeteva ogni volta: «Prima di degradarti e umiliarti, il regime ti fa recitare la tua autodegradazione e autoumiliazione. Ti fa eseguire la recita e assistere ad essa, in modo da spogliarti anche dell’ultima ombra d’identità che può avere una vittima: l’odio verso l’aggressore. Più ancora del carnefice, dovrai infatti odiare il suo più solerte collaboratore, te stesso» (p. 297). Dopo aver torturato chi era stato preso di mira, il giudice poteva chiedere che il malcapitato firmasse non solo il verbale manipolato, ma anche l’articolo 206, con cui si comunicava all’imputato che sarebbe stato di nuovo condannato, se avesse rivelato a chiunque i metodi con cui era stato indagato e interrogato (p. 297).
**** Gli Stati Uniti non andarono esenti dalla paranoia già durante la guerra. Il progetto di costruzione e utilizzo della bomba atomica obbediva a una logica paranoica. Gli scienziati impegnati nel progetto dichiararono che l’effetto dimostrativo e dissuasivo sia sul Giappone che nei confronti dell’Unione Sovietica, che prevedibilmente sarebbe stato il nemico successivo nella guerra fredda iniziata già durante quella “calda”, sarebbe stato assicurato da un lancio sperimentale in luoghi deserti o nel Pacifico, anziché su un centro abitato: in tal modo si sarebbe potuto raggiungere l’obiettivo e insieme onorare la coscienza morale dei vincitori. E invece no, si volle strafare, strabiliare, approfittare dell’occasione per testare gli effetti fisici, oltre che psicologici, della bomba. Zoja illustra la sequenza di eventi che accompagnarono il lancio dell’ordigno su Hiroshima, basandosi sul diario del dottor
Michihiko Hachiya, il quale al momento dell’esplosione si trovava a un kilometro e mezzo dall’ipocentro. La razionalizzazione trapela dalle parole con cui Truman dichiara che, “avendo trovato la bomba, l’abbiamo usata”. Commenta Zoja: «Come una rivelazione, un’illuminazione o un comandamento divino, la bomba è quasi una cosa preesistente. Non viene costruita ma scoperta, come le leggi di selezione “naturale”: è qualcosa a cui, dunque, si può ricorrere senza piena responsabilità. Non un oggetto di cui si dispone, ma una cosa che dispone di noi, quasi fosse una volontà della Provvidenza» (p. 339). Mentre gli scienziati erano ancora impegnati nella messa a punto dell’atomica, le trattative erano già in corso. La guerra dunque rischiava di finire troppo presto, senza che si potesse giustificare l’impiego della bomba atomica, come invece si voleva fare, accampando la motivazione ufficiale che quello fosse l’unico modo per convincere il nemico giapponese ad arrendersi. La bomba quindi non fu usata per porre termine a una guerra che durava già da troppo tempo, bensì perché bisognava procedere a un impiego militare dell’ordigno, che tanto era costato in ogni senso, prima che la guerra finisse.
Dopo l’11 settembre gli Stati Uniti hanno creato un sistema di sorveglianza e controllo planetario senza precedenti, basato su un documento sulla Strategia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (2001 e 2006), che ha come obiettivo quello di «dare legittimità preventiva a future azioni militari preventive: basterà supporre soggettivamente che il nemico prepari un attacco» (p. 358). Il documento citato cerca di creare i presupposti giuridici per attaccare chiunque sia investito dal sospetto, e possa “confermare” l’esistenza di un complotto occulto, che in quanto occulto non è mai dimostrabile. E tuttavia proprio questa indimostrabilità lo rende incredibilmente pericoloso e dunque giustifica il provvedimento con cui si vuole colpire chi è sospettato di collaborare al supposto piano segreto. Il ragionamento circolare tipico del paranoico si basa sul fatto che proprio l’indimostrabilità del suo assunto di base rappresenta per lui una prova della sua esistenza. L’assunto di base non è mai messo in discussione dalla paranoia, anzi l’allusione a un complotto non dimostrato rende l’assunto inattaccabile. Intanto però, come osserva Zoja, gli Stati Uniti hanno creato un presupposto senza precedenti, alterando radicalmente le norme internazionali che hanno governato il mondo dalla Pace di Westfalia in poi: «Il diritto di attaccare un altro paese in assenza di una minaccia visibile e provata è il diritto di attaccare qualunque paese in qualunque momento, sulla base della rivalità, del contrasto
di interessi, del sospetto, di motivazioni soggettive e persecutorie» (p. 360). L’attacco del Giappone a Pearl Harbour, si chiede Zoja, non ha forse seguito la stessa modalità, che la storiografia americana ha sempre considerato il prototipo dell’attacco criminale di guerra?
Non che il terrorismo islamico non sia a sua volta paranoico. Il terrorismo islamico si potrebbe sconfiggere solo uccidendo preventivamente ogni terrorista, un genocidio preventivo impossibile e inconcepibile, di qui il terrore diffuso nell’Occidente e lo sfruttamento politico di questo terrore per giustificare l’adozione di misure inaccettabili. La gravità inaudita del fenomeno terroristico si può cogliere facendo un confronto con la guerra fredda e suoi equivalenti: qui la deterrenza era rappresentata dal fatto che entrambi, USA e URSS, possedevano una tal mole di armamenti da indurre un terrore reciproco, e mettere preventivamente fuori causa l’attacco di uno dei due, al quale sarebbe seguita la risposta onnidistruttiva dell’altro. Ma il terrore della morte, comune a USA e URSS, non riguarda i terroristi, che emergono da masse ansiose di esprimere tutta la rabbia accumulata e sapientemente orchestrata dai loro maestri, e pronte a immolarsi nel martirio, senza alcuna paura della morte (p. 364). Il vantaggio del terrorismo è esattamente questa assenza di paura della morte, per cui non può essere terrorizzato né scoraggiato. Non c’è deterrenza rispetto al terrorismo; l’Occidente si trova per la prima volta dinanzi a un nemico che ha un vantaggio abissale e incolmabile. Ma avverte Zoja, «uno schieramento che risponda a un simile nemico accettando la guerra che quello ha dichiarato – e stabilendo di distruggerlo totalmente e preventivamente perché non può de-terrorizzarlo, cioè piegarlo in altro modo −, cade però a sua volta nell’infezione paranoica» (p. 365). Gli Stati Uniti, con Bush rieletto presidente, sono caduti vittime di una paranoia diffusa e impalpabile, dimostrando di essere vulnerabili alla minaccia psicologica. D’altra parte il terrorismo conta proprio sulla differenza di cultura. In Occidente le persone ci tengono a vivere, hanno paura della morte, i terroristi islamici lo sanno; vedono negli Stati Uniti il grande Satana e in Israele il piccolo Satana, pensano e si muovono come paranoici a pieno titolo, per di più paranoici che non hanno paura della morte come, in generale, tutti quelli affetti da questa affezione/infezione psichica nella sua forma più grave.
Il limite degli occidentali, ciò che rende fatale l’asimmetria del rapporto con i terroristi, è la paura della morte. E la risposta paranoica degli Stati Uniti alla minaccia terroristica è la
conseguenza della paura della morte. I terroristi però potrebbero fare un salto di qualità e ricorrere a mezzi di distruzione di massa; potrebbero agire su vasta scala provocando genocidi così estesi da far impallidire i crimini contro l’umanità del XX secolo. Potrebbero. Già questa ipotesi può prestarsi all’accusa di essere paranoica. Tuttavia, se è vero che i terroristi non hanno paura della morte, non temono neppure una risposta sterminatrice dell’Occidente ovunque fosse diretta. E questo può indurli a organizzare un attacco terroristico micidiale facendo ricorso ad armi non convenzionali. Tutto questo è estremamente realistico, soprattutto se si considera che, a differenza della guerra fredda in cui gli schieramenti condividevano la paura della morte, i paesi occidentali impegnati a fronteggiare il terrorismo hanno lo svantaggio fatale di avere di fronte un nemico che non teme nulla, tantomeno la propria morte o la fine dell’umanità. Al di là dell’estensione paranoica che anche questo nostro ragionamento può subire, l’asimmetria funesta balza agli occhi e lascia disarmati gli occidentali. Ora, quando non si sa che cosa fare, sarebbe meglio non fare nulla, per non offrire argomenti e pretesti a questo nemico davvero speciale, che le armi tradizionali non possono battere. Se non possiamo cambiare la psicologia degli occidentali, dobbiamo almeno cambiare i comportamenti, visto che una risposta paranoica alla paranoia terroristica non può che aggravare lo scontro e prolungare indefinitamente la catena degli attentati e delle vittime, con il rischio di escalation fuori controllo. Il terrorismo non può che essere alimentato da risposte di ritorsione indiscriminata. Perseguitare qualcuno perché sospettato di terrorismo significa rinunciare alla civiltà. La sfida è allora: in che modo possiamo trasformare i terroristi in alleati e amici dell’Occidente.
**** La paranoia individuale di uomini chiave, responsabili della politica internazionale, diventa paranoia collettiva. Secondo Zoja la particolare esposizione alla paranoia in epoca moderna dipende da due caratteristiche della cultura occidentale moderna: la convinzione che esista in ciascuno di noi un mondo interiore, una dimensione psicologica personale – per cui l’uomo è un microcosmo − il riconoscimento della condizione esistenziale dell’uomo, concepito come separato e solo, non parte integrante di una totalità. Le due convinzioni – l’esistenza del mondo interiore e la scissione dalla totalità in perfetta solitudine – potrebbero essere
all’origine della particolare recrudescenza della paranoia nel secolo scorso, quando il potenziale paranoico è stato attivato in una misura che non ha precedenti. La psiche moderna, resa più fragile dai due fattori citati, è più esposta all’infezione paranoica, giacché «le è particolarmente difficile viversi come “cosa separata”, in una società secolarizzata e indifferente alla metafisica» (p. 392). Infatti il paranoico non sopporta la separazione, ha un bisogno ossessivo dell’altro, e stenta a trovarlo in una società che ha allentato tutti i vincoli tra le persone, compresa la solidarietà. Il paranoico è quindi inconsapevolmente antistorico, perché al suo bisogno dell’altro di cui sospettare e da odiare, corrisponde una penuria essenziale dell’altro e la presunzione di dovere tutto ciò che si è a se stessi, di essere figli di se stessi. Il paradosso del paranoico è tutto qui: nutre l’illusione di onnipotenza autarchica e il delirio di esclusione e annientamento dell’altro, percepito come nemico mortale, ma al tempo stesso non sa di non poter fare a meno dell’altro.
Il saggio di Zoja mostra come il carattere principale del ragionamento paranoico sia la circolarità, con cui il paranoico anziché progredire nel pensiero, ritorna indietro cambiando la formulazione, ma lasciando indiscusso il presupposto. Il nazionalismo è simile alla paranoia in questo: il suo concetto è in gran parte «inafferrabile e circolare quanto un’idea paranoica» (p. 397). Il concetto di nazione non può fondarsi su di una definizione soddisfacente, e allora non rimane che la tautologia, per cui la nazione è costituita da un gruppo di individui che stabiliscono di riconoscersi come appartenenti alla stessa nazione. Anche il rapporto di fondazione tra stato e nazione è circolare: «La nazione è tanto il gruppo nazionale che vuole diventare entità giuridica, quanto lo Stato già esistente che vuol definirsi anche come nazione» (p. 397). Con il razzismo accade lo stesso. Fratello maggiore del nazionalismo, nessuno, neppure i razzisti più risoluti, saprebbero definirlo, ed è naturale che sia così dopo che la genetica ha preso posto tra le scienze biologiche. Il razzismo rappresenta uno scandalo immondo, che produce effetti catastrofici e dà esca a crimini assurdi. Può ricorrere maldestramente alla tradizione, all’identità, pretendere di avere qualche ragion d’essere in quanto scienza e riuscire a esplodere rabbiosamente in determinate occasioni, come le partite di calcio. Il nazionalismo e il razzismo, pur nella loro infondatezza e assurdità, incassano quella che secondo Zoja si può chiamare “rendita di posizione paranoica”: in una situazione di particolare crisi, in cui tutti hanno nemici personali, è facile che il contagio paranoico finisca con il convertire
la paranoia individuale in quella collettiva ai danni di uno solo (individuo o categoria).
Nel linguaggio dell’antropologia mimetica, al culmine della crisi d’indifferenziazione, si assiste al passaggio dal tutti contro tutti al tutti contro uno, in un processo la cui escalation sfocia nell’espulsione di una vittima, nella messa a morte di quello che, col senno di poi, si chiamerà capro espiatorio. I paranoici individuali o gli individui risucchiati dall’ossessione rivalitaria – corollario dell’imitazione reciproca – confluiscono nell’alta marea della paranoia collettiva, nel momento in cui appare possibile scaricare su di uno solo la raffica di odio che prima ciascuno indirizzava al proprio competitore e nemico privato. Infine, eccoci alla guerra, catastrofe in cui sfocia invariabilmente l’avventura nazionalista. Sono gli storici che hanno spiegato come sia quasi automatico il passaggio dal nazionalismo, alla guerra, alla “pulizia etnica” e al genocidio. Il piano inclinato della paranoia collettiva fa precipitare gli eventi in un’accelerazione vertiginosa dell’escalation, come dimostra la persecuzione degli armeni, la loro deportazione e il massacro che subirono; e come dimostrano molti altri genocidi successivi. La guerra è il catalizzatore e il contesto giusto per questo scivolamento sul piano inclinato. La guerra è di per sé un’esplosione di paranoia; essa si nutre infatti di aggressività, fretta e proiezione. La guerra, come la paranoia, si autoalimenta. Dimenticata la motivazione di partenza e messa da parte la soluzione di compromesso onorevole che potrebbe consentire a entrambi i contendenti di far cessare il conflitto e di conseguire gli obiettivi che in precedenza avevano indotto alla guerra, il conflitto bellico, al pari della paranoia, brucia dello stesso ossigeno prodotto dalla sua stessa combustione (p. 402). Per secoli però la proiezione paranoica all’origine della guerra è stata considerata normale e la guerra ha ricevuto l’attenzione di giuristi, filosofi, storici, persino economisti e sociologi, che l’hanno legittimata e normalizzata, arrendendosi alla presunta evidenza della sua inevitabilità meno che al principio della sua inaccettabilità.
Non si può non riconoscere la novità eccezionale del provvedimento costituzionale introdotto dalla Repubblica Federale Tedesca (ma non dalla DDR, dall’Austria, dall’Italia o dal Giappone), con il quale si stabilisce un’autocritica radicale del nazismo e di ogni politica di espansione, mettendo al bando anche il negazionismo, che Zoja definisce «una continuazione della paranoia nazionalista» (p. 405). Infine, se si deve riconoscere che, essendo l’uomo un animale gregario con la tendenza a riassumere
tutti gli io in un noi, si deve tollerare un certo grado di localismo e campanilismo, è anche vero che si deve sempre avere presente come l’insidiosa dinamica paranoica possa far scivolare facilmente dalla presunzione di diversità al pregiudizio di superiorità e al genocidio. La paranoia è intrinseca al nazionalismo e al razzismo, due –ismi da mettere al bando con la stessa determinazione. La violenza che esplode sui campi di calcio dovrebbe mettere in guardia chi ha interesse materiale a illudersi e a illudere che il fenomeno rimarrà sempre circoscritto alle partite di calcio e che solo per questo non sia preoccupante. L’errore magistrale del nazionalismo, ripetuto dalle Leghe e dai puristi di nuovo conio, consiste nel credere che la pulizia etnica sia necessaria per riportare la pace in una certa ragione, mentre la storia dimostra che la minaccia alla pace viene proprio dalla volontà di separare, dividere, isolare, purificare le presunte etnie tra loro. Un paese etnicamente puro è molto più violento e instabile di una confederazione di lingue e culture diverse, come dimostra il caso della Svizzera, che è rimasta immune da questa follia, anche se, si potrebbe osservare, la linea di demarcazione e separazione è stata fatta coincidere con i confini del territorio svizzero. Del resto, con il paranoico non si può discutere, nonostante egli faccia uso di una logica stringente. L’argomentazione del paranoico, per quanto impeccabile nel suo svolgimento, parte da premesse alle quali attribuisce il valore di verità di una rivelazione, di una fede, che è perciò indiscutibile. La paranoia è presente potenzialmente in ciascuno di noi e il paranoico conclamato non si può convincere dell’errore di partenza. La psicologia collettiva invece è sensibile all’educazione; ed è proprio sul terreno dell’educazione che oggi si può giocare la partita, creando le condizioni affinché non prevalga la paranoia potenziale. 21 dicembre 2013