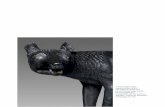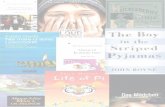recensione a J. Helmrath, Wege des Humanismus. Studien zu Praxis und Diffusion der...
Transcript of recensione a J. Helmrath, Wege des Humanismus. Studien zu Praxis und Diffusion der...
654 Cr St 36 (2014)
the moods and opinions of the populace. This was a ‘public theology’ of magnificen-ce, articulated in a practical, everyday manner – in much the same way as preachers considered the question of earning money on interest from loans. Thus, the preachers took part in and reflected back to the audience a debate which was already occurring within the city. This crucial link between preacher and public opinion is illustrated no better than by the poignant conclusion, in which Howard reminds us that it was the criticism of the ‘vanity’ of magnificence by a disciple of Antoninus, Girolamo Savona-rola, which was greatly influential in refashioning the idea once more by the end of the Quattrocento.
There are – understandably in a work of such length and concerted focus – some issues left unresolved. Most significantly, although explored to a degree by Howard, it remains largely unknown to what extent Antoninus was assisted in his endeavours by the preaching of others. One – Fra Francesco Mellino – is discussed at length, but other possibles are vaguely drawn, perhaps owing to simple lack of surviving material. But the question lingers – were sermons on magnificence by other local preachers necessa-ry in cementing its interpretation through persistent repetition, or was Antoninus able to effect the beginnings of a change in attitude within Florentine society (and politics) through his own prominence?
Despite this occasional desire for comparative material from other contemporary preachers, through Creating Magnificence, Howard has demonstrated ably the interwo-ven nature of religion and public life in Quattrocento Florence, and the potential in-fluence of the prominent preacher within a culture which was still predominantly oral. Though the primary focus always remains on a re-interpretation of the development of ideas on the virtue of magnificence, Howard also manages to address wider issues on the reception of and inspirations for preaching, in addition to closely examining the construction of cycles and specific sermons, and the adaptation of older texts for con-temporary relevance. A critical lasting secondary (but no less important) contribution of the book is to raise further questions about the possible impact and significance of local preaching in this period – an issue which has perhaps unjustly received compa-ratively far less attention among scholars than that of itinerant mendicant preaching.
Stefan VisnjevacUniversity of Roehampton
M. Decaluwe, A successful defeat. Eugene IV’s Struggle with the Council of Basel for Ultimate Authority in the Church 1431-1439, (IHBR, Bibliothèque, BHIR, Biblioteehk, LIX) Bruxelles/Brussel-Roma, Institut Historique Belge de Rome/Belgisch Historisch Instituut te Rome, 2009, pp. 398.
Gli storici, com’è noto, privilegiano lo studio delle cause vittoriose (cfr. Dieter Mer-tens, Clero secolare e cura d’anime nelle città del tardo medioevo, in Ordini religiosi e
rivista 2_2014.indb 654 12/09/14 10:40
655Recensioni
società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e XV, a cura di G. Chittolini, K. Elm, Bologna 2001, 257-329, a proposito delle Osservanze quattrocentesche), così come, in parallelo, amano illustrare le origini piuttosto che i tramonti (d’altronde alla storiogra-fia non viene richiesto, nella scelta dell’oggetto, il requisito dell’assenza di motivazioni personali; e spesso non si tratta nemmeno di motivazioni personali, ma di ricerca di linee – a posteriori però – più ricche di futuro all’interno del flusso degli eventi). Il concilio di Basilea (1431-1439) ha costituito, nel XV secolo, una causa inizialmen-te vittoriosa, ma presto storicamente perdente, di fronte alla robustezza ideologica e politico-diplomatica del papato, restaurato dopo lo scisma e agli albori della stagione rinascimentale (ma a sua volta ‘degradato’ di fronte agli Stati). Eppure, come osserva Michiel Decaluwe nell’introduzione del suo libro, tale concilio, come pure il concilia-rismo in generale, ha conosciuto una tale fioritura di studi nel XX secolo (soprattutto nell’ultimo quarantennio), da rappresentare uno dei temi più popolari per storici e teo-logi. E tanto da far ritenere un periodo di relativa attenuazione dell’interesse per questi temi l’ultimo decennio del Novecento, che pure ha visto comparire monografie come quelle di Thomas Prügl su Heinrich Kalteisen; di Zvjezdan Strika sulla personalità più influente sul conciliarismo a Siena e Basilea, Giovanni da Ragusa; di Thomas Wunsch sul conciliarismo in Polonia; di Margaret Harvey sull’Inghilterra e di studi analoghi sull’Austria e altre regioni (Decaluwe, A successful defeat, 25-29. In ordine cronologico: M.M. Harvey, England, Rome and the Papacy, 1417-1464. The study of a relationship, Manchester-New York 1993; Th. Prügl, Die Ekklesiologie Heinrich Kalteisens OP in der Auseinandersetzung mit dem Basler Konziliarismus, Paderborn et al. 1995; Id., Antonio da Cannara: De potestate pape supra concilium generale contra errores Ba-silensium. Einleitung. Kommentar und Edition ausgewählter Abschnitte, Paderborn et al. 1996; W. Baum, R. Bäumer, S. Meier-Oeser, R. Palme, Konziliarismus und Huma-nismus. Kirchliche Demokratisierungsbestrebungen im spätmittelalterlichen Österreich, Wien 1996; Th. Wünsch, Konziliarismus und Polen. Personen, Politik und Programme aus Polen zur Verfassungsfrage der Kirche in der Zeit der mittelalterlichen Reformkon-zilien, Paderborn et al. 1998; Z. Strika, Johannes von Ragusa († 1443): Kirchen- und Konzilsbegriff in der Auseinandersetzung mit den Hussiten und Eugen IV, Augsburg 2000; W. Müller, Bayern und Basel. Studien zu Herzoghaus, Kirche und Konzil (1431-1449), in «Annuarium Historiae Conciliorum», 29 [1997], 1-158, 335-500; inedito J.D. Mann, The historian and the truths. Juan de Segovia’s Explanatio de tribus veritatibus fidei, 2 voll., Univ. Chicago PhD Thesis 1993). Eppure Decaluwe non ha torto, se si considerano, da un lato, i duemila titoli elencati nelle cento pagine di bibliografia della monografia del 1987 di Johannes Helmrath sui Forschungsstand und Probleme di Basilea (J. Helmrath, Das Basler Konzil 1431-1449. Forschungsstand und Probleme, Köln 1987) e, dall’altro, la produzione degli ultimi anni e la necessità stessa di riepilo-garla con ripetute rassegne storiografiche (H. Müller, Konzilien des 15. Jahrhunderts und Zweites Vatikanisches Konzil. Historiker und Theologen als Wissenschaftler und Zeitgenossen, in Historie und Leben. Der Historiker als Wissenschaftler und Zeitgenosse. Festschrift für L. Gall, hrsg. von D. Hein et al., München 2006, 115-135; J. Helmrath, H. Müller, Einleitung, in Die Konzilien von Pisa [1409], Konstanz [1414-1418] und Basel [1431-1449]: Institution und Personen, hrsg. von H. Müller, J. Helmrath, Ostfil-dern 2007, 18-29; A. Cadili, Il concilio di Basilea nella produzione storiografica negli ultimi vent’anni, in «Cristianesimo nella Storia», 30 [2009], 635-727; H. Müller, Die
rivista 2_2014.indb 655 12/09/14 10:40
656 Cr St 36 (2014)
kirchliche Krise des Spätsmittelalters. Schisma, Konziliarismus und Konzilien, Mün-chen 2012). Decaluwe non ha torto nemmeno nel sottolineare come gli studi siano concentrati sul concilio, trascurando la controparte papale, che invece è di notevole rilievo per delineare un quadro equilibrato dell’evento. Questa attrattività della causa conciliare perdente si chiarisce considerando come la storia dell’ecclesiologia, a partire dagli anni Sessanta del Novecento (potendo valorizzare l’opera di Tierney del 1955 sugli antefatti canonistici ‘ortodossi’ del conciliarismo), rivalutasse, nell’ambito di un rinnovato interesse per forme non monarchiche di governo ecclesiastico (sono gli anni del Vaticano II), un conciliarismo (privilegiando Costanza rispetto all’‘estremismo’ ba-sileese), che aveva mantenuto una pessima fama in una chiesa a rinnovata guida papale (la raccolta di Denzinger non recepiva nessuna decisione conciliare dell’epoca). Nello stesso tempo, nel campo della storia del pensiero politico, in ambito anglosassone, si esaminava il conciliarismo quale precursore del vittorioso parlamentarismo inglese. La parte perdente nell’immediatezza, dunque, si rivela ‘vittoriosa’ sul lungo (politico) o lunghissimo termine (religioso): rispettivamente nel XVII e nel XX secolo. La vittoria amata dagli storici non è infatti necessariamente quella immediata (può esserlo), ma quella che è tale alla luce della lettura del presente, che fa volgere indietro lo sguardo (si pensi alle motivazioni del prevalere degli studi sugli eretici, storicamente sconfitti, rispetto a quelli sugli inquisitori: cfr. G.G. Merlo, Inquisitori e Inquisizione nel Medioe-vo, Bologna 2008; M. Benedetti, Inquisitori lombardi del Duecento, Roma 2008).
In ogni caso, sul piano storiografico, a profilarsi come vittoriosa e maggioritaria pare la via aperta dalla medievistica germanica (primeggiano i nomi di Erich Meuthen e dei suoi allievi), che ha individuato in Basilea un crocevia e un punto di osservazione sul XV secolo. In questo senso il titolo del libro dello studioso belga (A Successful Defeat) non rimanda a vittorie e sconfitte postume, del XVII o del XX secolo, ma (finalmente), rivestendo una pura valenza euristica, si concentra su quelle della prima metà del XV, quando Eugenio IV è costretto a rinunciare al suo tentativo di sciogliere il concilio (1431-1434), ma poi riesce a isolare i padri basileesi superstiti e il loro antipapa, non senza lanciare una fortunata ombra di eterodossia. Uno studio su Eugenio IV in quanto controparte di Basilea per tutto il suo lungo pontificato costituiva una lacuna storio-grafica, senza togliere meriti alla importante monografia del 1978 di Joachim Stieber, focalizzata sulla Germania e sulla fase finale del sinodo (J.W. Stieber, Pope Eugenius IV, the Council of Basel and the secular and ecclesiastical Authorities in the Empire. The conflict over supreme Authority and Power in the Church, Leiden 1978), e all’o-pera di sintesi in parte realizzata, in parte prefigurata da Helmrath (il Companion to the Council of Basel, coordinato dallo stesso Decaluwe, da Gerald Christianson e da Thomas M. Izbicki, in preparazione presso l’editore Brill, raccoglierà il frutto delle ri-cerche degli ultimi decenni, mantenendo una ripartizione per temi e problemi; mentre Heribert Müller ha delineato una recente sintesi dell’intero periodo ‘conciliare’: Müller, Die kirchliche Krise, cit.). Due punti sono preliminari alla ricerca. In primo luogo l’au-tore distingue tra la formulazione a Costanza di Haec sancta, ritenuta un compromesso tra diverse sensibilità (Tree ways to Read the Constance Decree Haec sancta [1415]. Francis Zabarella, Jean Gerson and the Papal View of General Councils, in The Church, the Councils and Reform. The legacy of the Fifteenth Century, ed. by G. Christianson, Th.M. Izbicki, Ch. Bellitto, Washington, DC, 2008, 122-139) e il suo utilizzo a Basilea nell’accezione invece più decisamente ‘conciliarista’ (questo lo scopo della prima parte:
rivista 2_2014.indb 656 12/09/14 10:40
657Recensioni
Previous History, 32-52). Si deve concordare, in quanto (ritengo) il decreto del 1415 (certo un compromesso, non saprei invero se concentrato sugli aspetti filologico-testuali o piuttosto sul non detto di una sua diversa o opposta valutazione) è un punto mediano e compromissorio (adattato alla situazione) di un a priori più radicale che è quello a cui poi pensano i Basileesi quando nominano Heac sancta (su questo punto mi permetto di rimandare alla mia monografia di prossima uscita Lo Spirito e il Concilio: Basilea 1432. Legittimazione pneumatologica del conciliarismo, il Mulino, Bologna 2014). In secondo luogo Decaluwe usa di proposito il termine ‘conciliarismo’ piuttosto che ‘teoria conci-liare’, al fine di comprendere non solo il thinking conciliar ma anche l’acting conciliar. Questa impostazione consente di inserire il formarsi di posizioni ecclesiologiche non solo in un confronto tra idee (come nella tradizione della Konziliengeschichte: soprat-tutto H.J. Sieben, Traktate und Theorien zum Konzil. Vom Beginn des Großen Schismas bis zum Vorabend der Reformation (1378-1521), Frankfurt a.M. 1983; Id., Die Konzil-sidee des lateinischen Mittelalters, Paderborn 1984; Id., Vom Apostelkonzil zum Ersten Vatikanum. Studien zur Geschichte der Konzilsidee, Paderborn et al. 1996; Id., Studien zur Gestalt und Überlieferung der Konzilien, Paderborn et al. 2005), ma in una realtà tridimensionale fatta di persone, eventi, incomprensioni, azioni e reazioni, ossia nella storia di ciò che accade nel concilio (e anche fuori), secondo una impostazione che si trova tanto nella medievistica tedesca a proposito di Basilea quanto in Jedin (su Trento) e in Alberigo (sul conciliarismo). La controparte del papa non è quindi un monolite. Eugenio IV non è solo l’antagonista del concilio, ma è esaminato nella sua personalità, nei suoi punti di riferimento e nei suoi atteggiamenti in quanto ciò influenzi il suo rapporto con Basilea: sia con il concilio in sé, sia con le pretese da questo avanzate, che sono due cose diverse. Due osservazioni importanti riguardano la sua prospettiva non contraria alla riforma, ma ‘curiale’, e la sua probabile sottovalutazione dell’hussitismo (al contrario di due personaggi chiave del concilio come Cesarini e Castiglione, 60-65), rispetto a un maggiore interesse per un concilio di riunione con i greci possibile solo in Italia. Il superamento della prospettiva meramente teorico-ecclesiologica emerge anche nel rilievo attribuito alle modalità di comunicazione tra Roma e il concilio, a causa della cui lentezza nascono buona parte delle incomprensioni alla base dello scontro: Eugenio IV scioglie il concilio, con le due versioni della Quoniam alto, sulla base di informazioni non più attuali; e tutte le trattative dei due anni successivi risultano sempre viziate da uno sfasamento temporale in cui si risponde sovente alla ‘penultima’ comunicazione della controparte.
Cesarini, rispondendo il 13 gennaio 1431 alla prima versione di Quoniam alto, sottolinea il disappunto dei padri, già permeati dalle teorie conciliari e diffidenti verso il papato, ma soprattutto obietta che gli hussiti non potevano essere sconfitti con le armi, ma solo con la discussione in concilio (unilaterale, ovviamente), ove i boemi erano stati invitati. Cesarini, legato in Germania, era stato testimone della sconfitta militare a Taus nell’agosto 1431 e condivideva appieno la preoccupazione dominante Oltralpe: quando la seconda versione di Quoniam alto decreta il trasferimento a causa proprio dell’invito degli eretici, il cardinale e il concilio decidono la resistenza. L’autore mostra l’avvicinamento di Cesarini al conciliarismo fondato sulla ‘riscoperta’ di Haec sancta nell’accezione più radicale, espresso nella II sessione del 15 febbraio 1432 (preceduta dall’elezione di un ‘proprio’ presidente, dopo le dimissioni dello stesso Cesarini; dopo otto mesi la riassunzione della presidenza da parte del prelato coincide con la stesura
rivista 2_2014.indb 657 12/09/14 10:40
658 Cr St 36 (2014)
delle lettera sinodale Cogitanti, articolata definizione del conciliarismo): il trauma di Taus ne costituisce forse la ragione; nelle sue lettere al papa il problema hussita è molto presente. Il punto, ben evidenziato, è comunque che la spirale di incomprensione porta alla radicalizzazione delle posizioni (cementando quelle moderate e quelle radicali) e allo spostamento della questione dal piano pratico (il mantenimento del concilio a Basilea) a quello ecclesiologico: da una parte la richiesta del riconoscimento del potere supremo in campo di fede, riforma e pace al sinodo, a cui il papa deve semplicemente sottoporsi; dall’altra, il rifiuto di tale prospettiva. Il concilio sottopone il papa a una procedura giudiziaria quale forma di pressione, mentre Eugenio IV, incapace di man-tenere un’opposizione netta, è costretto a concessioni, regolarmente rifiutate perché insufficienti. L’autore evidenzia il passaggio del papa dalla difesa delle decisioni ‘prati-che’ di breve termine, a quella delle sole questioni di principio relativa ai poteri nella chiesa: finché l’imperatore Sigismondo (protagonista della fine dello scisma a Costanza, nonché, come Cesarini, interessato alla riforma in Germania e alla questione hussita) arresta la procedura giudiziaria prima che evolva nello scisma e contribuisce alla resa di Eugenio IV alla fine del 1433.
La ‘vittoria’ estorta non è una soluzione definitiva. Già il dibattito sull’ammissione dei presidenti delegati dal papa e sull’abolizione delle annate (1434-1435) mostra come nella stessa maggioranza conciliarista vi fossero posizioni che andavano da un convinto antipapalismo (giustificato teologicamente mediante l’identità tra concilio e chiesa/cor-po mistico di Cristo, con la trasmissione al primo di tutto gli attributi della seconda, il che annullava il ruolo dei presidenti inviati dal pontefice) a forme di curialismo disposte a convivere con una divisione dei poteri nella chiesa: una sostituzione del dualismo storiograficamente tradizionale papa-concilio con più sfumate gradazioni («papalism, power-centralising conciliarism, power-sharing conciliarism»), che è una delle basi della ricerca. Gli anni successivi sono infatti un periodo di costante trattativa, ma ora soprat-tutto relativamente alla difesa delle prerogative papali, sui decreti di riforma in capite (annate), sul futuro concilio di riassorbimento dei greci, e in cui giocano vari fattori, anche esterni, dalla politica dei cardinali all’imperatore, ai singoli sovrani e principi. Tra il 1433 e il 1435 l’isolamento del papa sembra via via rompersi (tra altri fattori gioca il riposizionamento dei cardinali, esaminato da Decaluwe dopo le ricerche di Wolfgang Decker per il 1431-1434). La nuova situazione porta molti prelati ‘moderatamente’ conciliaristi a rompere drammaticamente con l’assemblea in occasione della scelta del luogo per il concilio con i greci, questione centrale che sottintendeva una scelta di cam-po (la questione darà poi il via a una concorrenza di ambascerie per attirare gli scisma-tici, infine vinta da Eugenio IV). Il 7 maggio 1437 la minoranza, ritenendosi sanior pars, non accetta la deliberazione della maggioranza e si ha una sessione tumultuosa con due decreti opposti. Lo stesso Cesarini si sfila (l’autore, come già Meuthen, non vede una sua ‘conversione’ nel 1436, ma una fedeltà a un equilibrio tra papa e concilio e alla prospet-tiva di una possibile cooperazione) e la guida del concilio passa all’unico cardinale che rimarrà fedele sino all’ultimo, Louis Aleman. Vengono quindi meno le tradizionali figu-re di spicco, che avevano svolto un ruolo di equilibrio, quali appunto Cesarini, e l’impe-ratore Sigismondo (che muore). In conseguenza di ciò, tra il 1437 e il 1439 lo scontro diviene radicale, basato su presupposti ecclesiologici inconciliabili. Da un lato si assiste a una rinascita delle teorie sul potere papale, dall’altro scompare la differenza tra power-centralising conciliarism e power-sharing conciliarism, nel senso che il secondo svanisce
rivista 2_2014.indb 658 12/09/14 10:40
659Recensioni
(Niccolò Tedeschi risponderà alla mediazione proposta da Cesarini con gli argomenti pneumatologici che Cesarini aveva usato in Cogitanti nel 1432!): in modo tanto rigido che si giunge a un nuovo processo al papa (con il contorno di documenti opportuni: le Tres veritates del 1439 dogmatizzano Haec sancta), e allo scisma (elezione di Felice V nel 1439). Arbitri dal 1437 di fatto diventano i poteri secolari, soprattutto Francia e impero (nell’ultima parte l’autore richiama infatti spesso i lavori di Stieber e Müller, con cui entra in dialogo), mentre scarsa influenza hanno quelli intermedi, come Milano e Savoia: Carlo VII sceglie una neutralità ‘attiva’ che garantisca la sua preminenza sulla chiesa francese (Prammatica Sanzione di Bourges), seguito (Instrumentum acceptationis di Mainz) dagli elettori tedeschi (ma non da Alberto II). Una cautela che continua anche dopo lo scisma, quando si rivela una forza politica superiore (anche territoriale-militare, nonostante le difficoltà) da parte del papato, mentre il concilio, senza una base politica autonoma, si deve basare sul sostegno esterno e con meno realismo si trincera dietro le sue sicurezze ecclesiologiche. La lotta per la corona di Napoli gioca un ruolo centrale, dapprima, dal 1435 con l’alleanza antipapale milanese-aragonese, ma poi col riconosci-mento papale del vittorioso Alfonso V che permette a Eugenio IV di consolidare il suo potere a Roma, non senza riflessi a Basilea. La fine del concilio si decide però Oltralpe, tramite l’accordo di Federico III con il papa nel 1447 (in quell’anno a Eugenio succede Niccolò V) e il concordato di Vienna del 1448 e tramite i negoziati con Carlo VII che (mantenendo i vantaggi acquisiti) negozia una resa onorevole per l’antipapa e i padri rimasti. La ‘vittoria’ sarebbe dunque infine quella dei poteri secolari, per le concessioni al cui prezzo Eugenio IV e Niccolò V ottengono la sconfitta del concilio e delle minacce al principio della monarchia papale. Ma l’indebolimento (non evitabile) che il papato subisce, per Decaluwe è soprattutto quello di divenire, da giudice supremo della cristia-nità, una monarchia (italiana) al pari delle altre, con cui inizia a concludere concordati (che sanzionano il controllo statale sulle chiese locali). Per di più la Francia mantiene la Prammatica con il suo riconoscimento delle pretese conciliari (non a caso, aggiungiamo, la minaccia di convocare un concilio sarà un’arma valida fino al XVI secolo). La conclu-sione è convincente, alla luce delle vicende politico-ecclesiastiche della seconda metà del XV secolo. Si potrebbe chiedersi se già dal grande scisma il papato non abbia per-duto la sua autorevolezza, e conciliarismo, hussitismo, perdita di incisività rispetto alle autorità secolari (non solo fuori d’Italia) non siano tutte conseguenze di lungo periodo.
Oltre alla dettagliata e affidabile ricostruzione, tra i meriti del volume è l’aver evi-denziato, evitando di limitarsi alle posizioni ecclesiologiche (che pure sono esaminate), il meccanismo concreto di uno scontro che include una molteplicità di aspetti e di attori (ecclesiastici, politici), ognuno con le proprie mutevoli esigenze, con i propri errori e rigidità, all’interno di un quadro credibile della situazione storica della prima metà del XV secolo, che non è solo la cornice, ma sostanza della relazione papa-concilio. Ciò consente tra l’altro di sottrarsi a uno schematismo, che deriva dal leggere l’evoluzione dello scontro alla luce della sua conclusione, come già fanno i contemporanei, sia di parte papale, sia di parte conciliare, in primis Giovanni da Segovia nella sua monumen-tale cronaca.
Alberto CadiliLeibniz-Institut für Eurpäische Geschichte - Mainz
rivista 2_2014.indb 659 12/09/14 10:40
660 Cr St 36 (2014)
Th. Woelki, Lodovico Pontano (ca. 1409-1439). Eine Juristenkarriere an Uni-versität, Fürstenhof, Kurie und Konzil, (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 38) Leiden, Brill, 2011, pp. XI-936.
«Auch für Pontano ist die Literaturlage dürftig» scriveva Johannes Helmrath nel 1987 in Das Basler Konzil 1431-1449. Forschungsstand und Probleme (Köln 1987), 242, l’opera di riferimento sul sinodo, che offriva sia un esame delle questioni princi-pali, sia una serie di indicazioni per la ricerca. Davvero è difficile trovare temi e proble-mi del XV secolo che in qualche modo non intersechino la linea quasi ventennale del multiforme fenomeno basileese. E molti di questi temi dal 1987 sono stati esplorati: se l’umanesimo è divenuto un tema privilegiato di Helmrath stesso, quella lacuna allora segnalata su Lodovico Pontano è stata più che colmata dal suo allievo, lo storico berli-nese Thomas Woelki, con una monografia monumentale di quasi mille dense pagine. Un libro di queste dimensioni rischia di divenire un’opera di consultazione (il che peraltro può essere un grande pregio e assicurare una lunghissima vita a un lavoro sto-riografico: su Basilea i due volumi di Heribert Müller, Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil 1431-1449, Paderborn et al. 1990), ma l’autore, pur offrendo i frutti di una vasta erudizione che sono di per sé utile materiale di consultazione, mantiene ferma la direzione nel produrre in primo luogo un libro da leggere nelle cinquecento pagine di biografia e nelle trecento di edizione degli scritti del giurista italiano (con ricchi apparati e appendici). Né si tratta di un mero ritorno al genere della biografia tradizionale, contrapposta al metodo prosopografico, che, nell’ambito degli studi basi-leesi ha dato il maggior frutto nella richiamata opera di Heribert Müller, bensì di una biografia che dialoga strettamente con i metodi della storia sociale, tanto da essere perfettamente (e forse meglio) adatta a figure di secondo piano, le cui carriere aprono nuove prospettive a partire proprio dalla concretezza del confronto con uno o più am-bienti (e, potremmo aggiungere, offrono, dal loro punto di vista ‘concreto-personale’ il vantaggio di intersecare diversi piani della storia generale: per cui, in questo senso, biografia e altri approcci si pongono come utilmente complementari). Un intero filone della medievistica tedesca riguarda in particolare il tema dei ‘consiglieri eruditi’ (der gelehrte Rat è espressione difficilmente traducibile), non in ultimo per il loro ruolo nella costruzione dello Stato, o comunque di personalità ecclesiastiche anche rilevanti che abbiano giocato funzioni analoghe, in cui la breve quanto rapida e densa carriera del giurista Pontano si inserisce (H. Heimpel, Die Vener von Gmünd und Straßburg. Studien und Texte zur Geschichte einer Familie sowie des gelehrten Beamtentums in der Zeit der abendländischen Kirchenspaltung und der Konzilien von Pisa, Konstanz und Basel, 3 voll., Göttingen 1982; G. Strack, Thomas Pirckheimer [1418-1473]. Ge-lehrter Rat und Frühhumanist, Husum 2010; T. Daniels, Diplomatie, politische Rede und juristische Praxis im 15. Jahrhundert. Der gelehrte Rat Johannes Hofmann von Lieser, Göttingen 2013; per gli ecclesiastici: M. Prietzel, Guillaume Fillastre der Jün-gere [1400/07-1473]: Kirchenfürst und herzoglich-burgundischer Rat, Stuttgart 2001; Ch. Kleinert, Philibert de Montjeu [ca. 1374-1439]. Ein Bischof in Zeitalter der Reform-konzilien und des Hundertjährigen Krieges, Ostfildern 2004; C. Märtl, Kardinal Jean Jouffroy [† 1473]. Leben und Werk, Sigmaringen 1996; M. Nuding, Matthäus von Kra-kau. Theologe, Politiker, Kirchenreformer in Krakau, Prag und Heidelberg zur Zeit der Großen abendländischen Schismas, Tübingen 2007; per l’Italia penso ai tre volumi di
rivista 2_2014.indb 660 12/09/14 10:40
661Recensioni
Francesco Somaini su un ecclesiastico ‘sforzesco’: Un prelato lombardo del XV secolo. Il card. Giovanni Arcimboldi vescovo di Novara, arcivescovo di Milano, 3 voll., Roma 2003, cfr. la mia rec. in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 61 [2007], 200-210).
Nei primi capitoli Woelki si sofferma nel dettaglio sugli studi bolognesi e perugini di Lodovico, fino allo straordinariamente rapido conseguimento dell’insegnamento uni-versitario a Firenze (1427); al passaggio all’università e alla curia romana come giudice rotale e poi all’università di Siena (rispettivamente nel 1431 e nel 1433); infine al trasfe-rimento alla corte di Alfonso V e al concilio di Basilea nel 1436. Pontano attraversa così tutti i principali ambiti, nota Woelki (18) – e in linea con quanto si diceva sopra sull’u-tilità di siffatte biografie – in cui un giurista colto poteva costruire la propria carriera nel XV secolo: università, corte, curia e concilio. È il caso di rilevare come l’analisi a tutto tondo di Woelki sottolinei un tratto caratteristico del protagonista, che è rilevabile in gran parte dei suoi ‘colleghi’ contemporanei, ossia l’utilizzo della propria formazione dotta per costruire una carriera con maggiore attenzione ai possibili vantaggi personali (anche a livello onorifico e di status sociale) piuttosto che a una coerenza di posizioni: posizioni di regnanti, città, università, concilio al cui servizio il dotto si pone disinvolta-mente, offrendo la propria cultura (questo sarà evidente persino a Basilea, pur essendo egli inviato con precisi compiti). Nel suo ruolo in questi ambiti Pontano produce ov-viamente testi giuridici che fanno parte della biografia di un dotto: in particolare sono però i discorsi pubblici a definire l’habitus di siffatte personalità, di cui l’autore accenna quindi di continuo, ma alla cui natura e caratteristica sono dedicati in particolare due trattazioni specifiche (VII.I, 179-204: Methodischer Excurs I: Persuasivität und Perfor-mativität von Traktatreden; VIII.I, 223-241: Methodischer Excurs II: Konziliarismus zwischen Theologie und Rechtswissenschaften), collocate fra la trattazione del soggiorno alla corte aragonese e quella del passaggio a Basilea (1436-1437). Rispetto ai contenuti dei discorsi di Pontano, a prevalere nell’esame dell’autore è il loro aspetto – nel senso più lato – tecnico-qualitativo, di modo che l’oratoria assume il rilievo di un tema esso stesso, anzi di un tema del tutto centrale con un peso specifico notevolissimo nel vo-lume. Benché sia possibile individuare diversi generi (in special modo il Traktatrede), talora i loro confini sono labili (come già aveva osservato Finke pubblicando sermoni e discorsi di Costanza nel secondo volume degli Acta concilii Constanciensis), tra strategie comunicative e contesto ‘istituzionale-cerimoniale’, prevalendo il quale a dominare è l’aspetto performativo: il che vale soprattutto per il genere ‘dimostrativo’, in occasione di ambasciate (conciliari) presso assemblee ritualizzate, come le diete imperiali. Men-tre attorno al 1440, in queste ultime occasioni, alcuni contemporanei di Pontano svi-luppano una retorica umanistica, l’oratoria politica di Lodovico rimarrebbe piuttosto accademico-scolastica, per quanto tenda ad avvicinarsi a quella classica.
I capitoli VII-XIV sono quelli che riguardano il concilio di Basilea, ossia gli ultimi anni del giovanissimo giurista, in cui quasi tutte queste orazioni si situano. Nel pieno del-lo scontro per il possesso del Regno tra Renato d’Angiò (sostenuto da Eugenio IV, in esilio a Firenze) e Alfonso V d’Aragona (dal 1435 alleato con Filippo Maria Visconti, che aveva truppe nello Stato pontificio), Pontano giunge alla corte aragonese a Gaeta, ove sono riuniti altri dotti e umanisti, tra cui Antonio Beccadelli (Panormita), Lorenzo Valla e il grande giurista Niccolò Tedeschi (Panormitanus). Alfonso, per sostenere il concilio contro Eugenio IV, vi rafforza la presenza di prelati suoi sudditi, minacciando in caso di reniten-za la privazione dei benefici (come il suo sodale milanese aveva già fatto nel 1432) e invia
rivista 2_2014.indb 661 12/09/14 10:40
662 Cr St 36 (2014)
un’ambasceria di cui sono parte giuristi di peso, come Pontano e soprattutto Tedeschi (ad affiancare frate Bernardo Serra e i legati viscontei Pizolpasso e Barbavara). Lodovico già prima della partenza aveva composto una lettera regia al papa di taglio conciliarista, che ignorava però i fondamenti teologici della pretesa superiorità sinodale. A tal proposito, sempre utile è chiedersi, come fa Woelki, cosa è ‘conciliarista’: una corrente di posizioni che hanno basi canonistiche, ma anche soprattutto teologiche, e assumono una continu-ità dal grande scisma, con Gelnhausen e Langenstein, fino a Basilea, con Ragusa e Sego-via. Ma al momento dell’arrivo di Pontano, mentre personaggi come Cesarini e Cusano si sfilavano, per l’autore ‘conciliarista’ è la posizione di chi trae le estreme conseguenze da tale corrente, e sul piano politico-ecclesiastico desidera la continuazione dell’assemblea contro Eugenio IV e via via la sua deposizione. Ciò non implica affatto una ‘conversione’ personale di Pontano. Questo ancora è un punto nodale, mi pare: chiarire negli inviati dei principi, per motivi politici (penso ai ‘milanesi’ sin dal 1432), l’effettiva ‘conversione’ al conciliarismo, le cui posizioni essi assumono nella teoria e nell’attività pratica. Certo è però che gli inviati, una volta incorporati nel concilio, collaboravano alla sua attività: oltre a far parte di una deputazione, essi potevano assumere incarichi corrispettivi a quelli rivestiti al di fuori, per cui per il protonotaio apostolico, già giudice rotale in curia, Pontano fu naturale divenire, oltre che occasionalmente membro di commissioni su sin-gole questioni, avvocato e soprattutto uditore della Rota sinodale, che giudicava le causae maiores (ad esempio le liti per il possesso di benefici maggiori), per la quale il dotto giu-rista compose consilia, relativi anche alla questione della superiorità giurisdizionale del concilio e alla liceità degli appelli a esso contro decisioni ‘romane’ (cap. IX).
Ma più che la personale convinzione di Pontano, a interessare è l’oratore. Piena-mente inserito in un contesto ‘cerimoniale’ è il lungo discorso di presentazione dell’am-basciata aragonese alla congregazione generale del 1° dicembre 1436, di natura pret-tamente giuridica: caratteristica che informa persino un precoce sermone per la festa dell’Aquinate che contiene una ‘strategica’ valorizzazione dell’autorità cardinalizia (pur rispettoso delle partizioni del sermo modernus, esso è intessuto di citazioni dal decre-tum). Ma strettamente giuridici (un coacervo di citazioni) sono soprattutto un parere orale e poi uno scritto contro la scelta di Avignone compiuta dalla maggioranza conci-liare per il concilio di ‘assorbimento’ dei greci, ma sgradita ad Alfonso V: i diritti della minoranza non sono difesi con riferimenti alla rappresentanza della chiesa universale, quanto piuttosto col diritto corporativo. Peraltro nemmeno Firenze, opzione papale e della minoranza, era gradita a Milanesi e Aragonesi, e la posizione di Pontano appariva determinata piuttosto da opportunismo e interessi di carriera. Dopo la spaccatura nella sessione del 7 maggio 1437, Alfonso V richiamò però gli ambasciatori a una più coor-dinata difesa dei propri interessi politici (cap. VIII). Pertanto, se gli inizi costituiscono per Pontano una mera continuazione della spinta carrieristica, dalla metà del 1437 ciò si unisce (con l’abbandono della minoranza ‘papalista’, a cui Alfonso è ostile) a un av-vicinamento alle tematiche ecclesiologiche conciliari della maggioranza, però accostate alla consueta base rigidamente giuridica: il capitolo X è dedicato al “conciliarista” (le virgolette sono dell’autore), il che non significa che il mutamento di campo sia ideale piuttosto che ancora opportunistico-politico. Il primo indizio del cambio di campo è il discorso in risposta alla cedula del card. Cesarini contraria al monitorio contro Eugenio IV, pubblicato per intero (547-576), in cui il numero delle citazioni canonistiche e civi-listiche (quasi le sole) è ancora altissimo, e che sollecita la reformatio in capite secondo
rivista 2_2014.indb 662 12/09/14 10:40
663Recensioni
quanto già enumerato alla corte aragonese nel 1436 e non senza critiche al papa in relazione alla concreta situazione politica dell’Italia centro-meridionale. Ugualmente nei successivi discorsi il conciliarismo di Pontano si riduce per Woelki alle posizioni aragonesi, sorrette dalle solite auctoritates canonistiche: in quello contro la bolla di traslazione del sinodo, Pontano non ebbe però successo, proprio a causa di questo stile. Il quale non mutò in un discorso del 28 dicembre (poi sistematizzato per iscritto, ed. 578-635), successivo a quelli di Tedeschi e Cesarini, a differenza dei quali non tratta la questione della migliore via da percorrere per la cristianità, ma resta sul piano giuridico del processo e della deposizione del papa, pur raccogliendo buona parte dell’armamen-tario pro-conciliare. Ciò vale anche per la risposta (17 gennaio 1438) all’ambasciata dei principi elettori (inviata per tentare una mediazione), in cui i riferimenti biblici hanno origine da fonti canonistiche: e tuttavia lo stile, già criticato da Giovanni da Segovia, inizia a cambiare, con la scomparsa del diritto civile e la riduzione delle glosse, in favore della Scrittura, seppur mediata, come i Padri, da Graziano; a tutto favore dell’argomen-tazione. E infatti non solo il mutato giudizio di Segovia, ma anche la quantità di discorsi e risposte ufficiali affidategli mostra il successo finalmente raggiunto nei primi mesi del 1438 adattandosi alla sensibilità della maggioranza mediante un sapiente bilan-ciamento degli ingredienti. Assai fortunata (come provano le numerose trascrizioni) fu infatti l’orazione Dixerit forte quisquam (o Tractatus super potestate universalis ecclesie et universalium conciliorum) che si sposta dalla questione giuridica della deposizione di Eugenio IV al tema della superiorità conciliare (ed. 637-681), in cui tutti gli argomenti ‘conciliaristi’ elaborati a Basilea trovano posto: soprattutto quelli teologico-scritturali, nel tipico ‘incrocio’ con quelli canonistici, ma pure la sensibilità per quelli storici e l’associazione tra potestà sinodale e pneumatologia; Woelki rileva il contatto con l’onni-presente Ragusa, e quest’ultima presenza gli dà totalmente ragione (ciò non impedisce una ‘indipendente’ e assai vantaggiosa aderenza alle posizioni dell’imperatore sul suo diritto di convocazione di un ‘terzo’ concilio, pur senza entrare in contrasto col proprio sovrano). Prova del successo è anche l’invio nella primavera-estate del 1438 come am-basciatore ad Amedeo VIII di Savoia, poi a Colonia e infine a Filippo duca di Borgogna (favorevole al pontefice), nel contesto di un’offensiva diplomatica conciliare in tutte le direzioni. A Ripaille egli poté prodursi in lunghissime orazioni: per quanto Woelki osservi le difficoltà di valutare l’effettivo contributo della performance retorica, in que-sto caso lo ritiene influente sull’obiettivo pienamente raggiunto dalla missione. I punti politico-ecclesiastici sono sovente molto concreti, ma la presentazione delle posizioni (teologiche ed ecclesiologiche) del concilio mostra continuità tra le orazioni in concilio e quelle pronunciate durante le ambasciate, con passaggi e argomenti trasportati dalle une alle altre (Dixerit forte quisquam, in quanto più sistematica, fornisce i maggiori ma-teriali), corredate da un armamentario di strumenti retorici classici, aspetto che si rivela sempre più robusto procedendo negli anni («Rhetorisierung», 483).
Grazie alla ‘risintonizzazione’ del proprio potenziale culturale, Pontano era giunto a un ruolo rilevante in concilio; ma già alla fine del 1438 il riposizionamento di Alfonso d’Aragona si riflesse sui suoi delegati in concilio e il papa era pronto a larghe concessio-ni: la morte per peste a soli trent’anni impedì ulteriori sviluppi alla breve quanto rapi-da e movimentata carriera di Pontano, una carriera non certo contrassegnata da lealtà nei confronti dei (numerosi e regolarmente abbandonati) ‘patroni’ – osserva Woelki in conclusione –, ma costruita utilizzando disinvoltamente una rara competenza (pronta a
rivista 2_2014.indb 663 12/09/14 10:40
664 Cr St 36 (2014)
modifiche e adattamenti, anche verso la teologia) e i propri contatti. Le 936 fitte pagine sono pienamente giustificate, nonostante la breve vita del protagonista, proprio per il fatto di focalizzare la pluralità di ambiti, politici, ecclesiastici, culturali, apertisi alla fine del Medioevo, che il dotto italiano del XV secolo attraversa rapidamente, e il carattere internazionale di un siffatto percorso (e di siffatte aperture). Un percorso transnazionale, da sud a nord, che Pontano, non unico tra gli uomini colti del suo tempo, compie (in altri casi in entrambe le direzioni, o ancora verso est), approfittando di circostanze prima inattingibili.
Alberto CadiliLeibniz-Institut für Eurpäische Geschichte - Mainz
J. Helmrath, Wege des Humanismus. Studien zu Praxis und Diffusion der An-tikeleidenschaft im 15. Jahrhundert. Ausgewählte Aufsätze, Band 1, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, pp. V-449.
Si sono recensite sin qui due importanti monografie di storici della generazione di chi scrive, nati negli anni Settanta: ora si prende invece in mano il volume di uno dei mae-stri di tale generazione, che siffatte ricerche ha stimolato e necessariamente influenzato. Johannes Helmrath raccoglie, con una nuova introduzione, i saggi sulla storia dell’uma-nesimo pubblicati tra il 2000 e il 2007: non si tratta di tutti i suoi contributi in materia, perché sono esclusi corposi, precedenti articoli, ad esempio, su Gerardo Landriani (1999) o sulla comunicazione nei concili del XV secolo (1989). Entrambi questi ultimi testimo-niavano l’estensione delle ricerche dell’autore dal concilio di Basilea all’umanesimo te-desco (o meglio, tra Italia e Germania). Si è trattato di un passaggio senza frattura, poiché già il volume Das Basler Konzil del 1987 conteneva un capitolo sugli umanisti. In questo senso dei concili, a essere al centro, è la loro funzione ‘secondaria’ (non programmata), che si esplica sul piano culturale, sociale, anche politico, e non quella propria di tali assemblee (decretazione in materia ecclesiastica). E il personaggio fondamentale della diffusione tedesca dell’umanesimo italiano, Enea Silvio Piccolomini (poi papa Pio II), giunto Oltralpe proprio in occasione del concilio di Basilea, è stato ininterrottamente og-getto degli studi di Helmrath sin dagli inizi a Colonia (ove il suo maestro Erich Meuthen ha dedicato decenni a Cusano, altro dotto – non umanista in senso stretto – ‘a cavallo delle Alpi’, oltre che al XV secolo più in generale, in cui l’assemblea basileese non è tra i fatti meno importanti). Non è un caso quindi che Pio II domini il volume, e non solo con i lunghi capitoli IV e IX a lui espressamente dedicati (insieme oltre 100 pagine su 450): nell’indice dei nomi la voce Pius II è ripartita in due intere colonne di sotto voci, in modo da costituire un indice nell’indice. L’autore è uno storico e medievista. Il fenomeno quindi è sempre illuminato dalla prospettiva storica, sebbene nel primo capitolo l’autore enumeri i suoi debiti verso generazioni di studiosi che vanno dal campo della filosofia a quello della filologia, fino all’arte: protagoniste della storia sono sempre le persone
rivista 2_2014.indb 664 12/09/14 10:40
665Recensioni
(Institution und Personen era il sottotitolo del volume curato da Helmrath e Heribert Müller Die Konzilien von Pisa [1409], Konstanz [1414-1418] und Basel [1431-1449)], Ostfildern 2007), anche quando insieme esse sono ‘autori’.
Sia il primo (nuovo), sia il secondo capitolo (tradotto dall’italiano), illustrano da un punto di vista metodologico e contenutistico l’oggetto ‘umanesimo in Germania’ (l’auto-re enuncia anche una serie di tesi che intendono definirlo e sistematizzarlo). I termini chiave di questo successo espansivo sono «diffusione» (espressione presente nei titoli di tre capitoli: III-V) e «trasformazione» (dell’antico: è il tema di un programma di ricerca alla Humboldt-Universität a Berlino, Sonderforschungsbereich 644: Transformationen der Antike). A essere indagati sono dunque gli specifici processi di ‘diffusione’ – meglio del passivo ‘ricezione’ combinato coll’attivo ‘trasferimento’ – dell’umanesimo in Ger-mania (ambito tra i cui pionieri alla metà del XIX secolo si ricorda Georg Voigt con il Wiederbelebung des classischen Alterthums, ma che è anche autore di una biografia in tre tomi di Enea Silvio), su base dunque ‘regionale’ e ‘sociale’ (ossia individuando i ‘circoli personali’): le «vie dell’umanesimo». Diffusion des Humanismus è infatti già il titolo di un volume coordinato dallo stesso Helmrath (Diffusion des Humanismus. Studien zur natio-nalen Geschichtsschreibung europäischer Humanisten, hrsg. von J. Helmrath, G. Walther, Göttingen 2002), strutturato per singole aree e figure principali, e nella cui introduzione l’autore concettualizza il termine e il fenomeno (essa costituisce ora il cap. III, comple-mentare ai primi due e introduttivo del secondo blocco, mentre il saggio sul Piccolomini è ora il cap. IV, dove appunto si passa alla concreta esemplificazione). Il punto è molto pragmatico e attiene alla psicologia sociale, cui si chiede di spiegare motivazioni, interessi e funzioni tanto nella prospettiva di chi propaga, quanto di chi accoglie l’umanesimo. La diffusione è intesa quindi come fenomeno insieme di apporto (dall’Italia, ossia dal centro) e di accoglienza (in Germania, ossia alla periferia, caduta ormai ogni teoria su umanesimi ‘autoctoni’: il paradigma della triplice translatio dalla Grecia a Roma all’Italia ‘moderna’ all’Europa settentrionale è già dei contemporanei). Italiani si recano a nord, tedeschi si recano a sud per studiare (dunque alla base sono fenomeni migratori, in parti-colare ma non solo di migratio academica), ma l’interesse di chi riceve modifica e adatta l’oggetto accolto (il modello antico). L’umanesimo (fenomeno dialetticamente europeo e nazionale), ben al di là di una semplice trasmissione letteraria, è innanzitutto un sen-timento, un’empatia verso l’antico, che, insieme alla forma espressiva, muta l’attitudine degli elitari protagonisti, ad esempio nei rapporti personali, nel culto dell’amicizia che passa attraverso gli epistolari, genere riscoperto assieme ai commentarii o ai dialogi, fino a trasformare il modo di pensare e di comportarsi, con un successo completo che sarà evidente ovunque alla fine del XVI secolo. Tuttavia, in tale condivisione di un’estetica, di valori, di modelli espressivi, di comportamenti, di habitus, la Germania si caratterizze-rebbe per alcuni tratti, come la finanche eccessiva latinizzazione dei nomi quale ‘segno elitistico’; il riconoscimento dello status dei numerosi poetae laureati anche a livello politico; la creazione di sodalitates locali, e, dal XVI secolo, uno spiccato ‘nazionalismo’ inteso come antiromanitas, ma pure riscoperta (anche storiografica) del proprio peculia-re passato di affinità preromana con i greci.
Primo poeta laureatus, nel 1442 (l’azione di Petrarca in Boemia non è considerata duratura negli effetti, mentre lo è mediante la diffusione posteriore dell’opera latina), Enea Silvio trovò alla corte imperiale un ambito di dotti e nobili, che attuò una ricezione avvenuta mediante le ‘eccellenze’ piccolominee: epistolografia, culto e capacità critica
rivista 2_2014.indb 665 12/09/14 10:40
666 Cr St 36 (2014)
dello stile latino (in cui fu considerato assoluto arbiter litterarum), e calligrafia umani-stica (ma anche l’oratoria e la ricerca dei manoscritti, attività comune degli umanisti, a differenza dei quali però Enea si occupò poco di filologia, preferendo essere scrittore egli stesso). Una serie di apporti che era necessario acquisire e imitare in ordine alla suddetta appartenenza elitaria, il che poteva ovviamente avvenire anche recandosi direttamente nelle università della penisola. Le forme concrete dell’attitudine umanistica (del Piccolo-mini) e quelle dell’imitazione da parte dei seguaci tedeschi sono dunque costituite anche di tecniche, pratiche e abilità. Il luogo privilegiato dove (come altri umanisti, Bruni e Poggio) opera Piccolomini (23 anni in Germania, il suo maggior conoscitore italiano) è la cancelleria: nel suo caso quella (anti)-papale di Felice V e poi quella imperiale di Fe-derico III, ove egli procede nella carriera civile parallelamente a quella ecclesiastica non in quanto ‘perito’, ma semplicemente in quanto raffinato latinista. In Germania la corte asburgica è affiancata, come luogo di ricezione, da quella palatina di Heidelberg, da città (centro-meridionali, con le loro università – ma tardivamente –, tipografie, corti), come Augusta, Norimberga, Strasburgo e Basilea, mentre nei monasteri si tratta solo di singole figure. Oggetto della ‘diffusione’ non è la corte come tale, ma sono persone e gruppi lì attivi o in rapporto con essa (come detto, l’epistolografia, raccolta e imitata, è un genere coltivato dal Senese e funzionale sia a tali contatti – 192 dal 1431 al 1455 – sia a diffon-dere modelli di eleganza, pur senza giungere a costituire una sodalitas ‘istituzionalizza-ta’): per cui quella che Helmrath delinea è una prosopografia, attenta a non prendere per umanista ognuno che avesse compiuto studi in Italia. Enea, in modo ambivalente, si rappresenta rispetto a costoro e all’intera Germania (ed è rappresentato) come apostolo delle buone lettere e civilizzatore della barbarie, ma definendosi egli stesso «cardinale tedesco» e dedicando all’Europa centrale gran parte della propria opera storiografica, basata sulla classica curiositas e sulla propria esperienza, in cui perciò trovano spazio i nemici hussiti e il pericolo turco, e ovviamente il concilio.
Il concilio in terra tedesca (Costanza e Basilea) come luogo di diffusione dell’umane-simo riconduce all’importante punto di passaggio dall’uno all’altro tema, lungo cui scorre molta dell’opera dell’autore. I concili già di per sé sono motivo della partenza ‘fisica’ ver-so nord di umanisti italiani, ma soprattutto occasione di manifestazione dell’umanesimo, di trasferimento di ‘tecniche’ e di modi di pensare. In ispecie a Basilea si iniziarono a udire orazioni in stile umanistico e ai nomi di Enea stesso (che vi parlò pubblicamente tre volte) si affiancano quelli di Gerardo Landriani, Francesco Pizolpasso, Pietro di Noceto e altri, nonché a una figura complementare a quella del Piccolomini, il tedesco Cusano (che compie il viaggio all’inverso, elemento di quel deutscher Freundeskreis individuato da Meuthen, cui appartenevano i cardinali Cesarini, Capranica e Carvajal: E. Meuthen, Ein “deutscher” Freundeskreis an der römischen Kurie in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Von Cesarini bis zu den Piccolomini, in Synodus. Beiträge zur Konzilien- und allgemeinen Kirchengeschichte. Festschrift für W. Brandmüller, hrsg. von R. Bäumer et al., Paderborn 1997 [= AHC 27-28, 1995/96], 487-542, saggio di notevole importanza nel delineare alcuni decenni di straordinaria e irripetibile comunicazione tra la curia romana e la Germania, che merita ulteriori studi). Quasi paradigmatiche fin nella manualistica liceale sono le scoperte dei codici che i dotti prelati annunciavano enfaticamente nelle pause dei lavori, anche se la via percorsa da tali testi è quella nord-sud, ovvero solo verso l’Italia. Ciò alimentava una produzione di copie e un mercato librario notevole, pur dedicato soprattutto a testi teologici e canonistici di cui recano testimonianza le principali biblio-
rivista 2_2014.indb 666 12/09/14 10:40
667Recensioni
teche europee (ricordo l’ambito milanese, con l’Ambrosina in primis). Vi era però una produzione di ‘nuovi’ testi, soprattutto di grandi orazioni di cui è costellata la vita conci-liare a Basilea, i cui autori intendevano soprattutto manifestarsi e promuovere la propria carriera (anche con successo): il punto è se esse (assai diverse dai consueti pareri teologi-co-ecclesiologici sul modello scolastico) servirono da esempio, e dunque da elemento di diffusione. A Basilea umanisti come Landriani, Traversari, Enea Silvio furono oratori di spicco, mescolando sino nelle prediche Cicerone con Girolamo, e il nuovo modo espres-sivo raggiunse le stesse diete imperiali coeve (mentre al concilio fiorentino la filologia [patristica] poté esplicarsi a servizio – subordinato – della trattativa con i Greci). I concili ‘tedeschi’ per Helmrath fungono pertanto da anticipazione (ma comunque emersione), ancora non recepita in loco, di un umanesimo che avrebbe coinvolto solo un poco più tardi le élites culturali tedesche; e la stessa teologia ebbe dalla ricezione dell’antico solo una lenta influenza fino al XVI secolo (ma per i principali trattatisti pro- o anticonciliari il problema rimane aperto): un fenomeno affidato alla storia sociale e alla Geistgeschichte.
Sebbene esaminata sotto il mezzo (o forse, ‘genere’) letterario dell’invettiva, proprio della cerchia elitaria umanistica, e funzionale al mantenimento di quest’ultima, anche la Invectiva in Felicem antipapam (1447) di Poggio Bracciolini conduce a Basilea. Per Poggio, che tale mezzo espressivo aveva già coltivato, ma che in questo caso adatta a un’esigenza politica, essendo egli al servizio papale, si tratta peraltro dell’approdo di anni di retorica anticonciliare e anti-‘feliciana’, da cui trae motivi, topoi ed espressioni, tutta interna, appunto, a una stretta cerchia, piuttosto che parte di una vera battaglia ecclesio-logica. Ai “generi” umanistici e ai loro protagonisti sono dedicati altri capitoli: a partire dalla retorica, sistematizzata da Cicerone e Quintiliano, e inscindibile dall’umanesimo che si rifà a tale modello umano classico del vir bonus dicendi peritus. Un retroterra che non è solo recepito tecnicamente, ma anche ‘usato’ in funzione del presente (in esso si uniscono actio, applicatio, servitius): sia per una prestigiosa autopromozione (come testimoniano le raccolte di orazioni), sia per scopi pratici, ossia celebrativi, persuasivi, cerimoniali (una Rhetorisierung della politica). Tra gli esempi è citata l’orazione contro i turchi pronunciata da Enea Silvio alla dieta imperiale di Ratisbona del 1454, che adatta alla situazione presente, trasformandolo, il modello ciceroniano del richiamo alla guerra contro i pirati, peraltro è difficile dire con quanto successo presso il pubblico dei principi tedeschi. L’impegno antiturco di Enea Silvio troverà un seguito all’epoca del suo papato, senza risultati, come tutti gli altri progetti simili, nella consapevolezza stessa di Pio II del non spero quod opto. Tale impegno è giocato tra letteratura e politica (non priva di rea-lismo, ma non attuabile nella situazione europea), unite dal medium dell’oratoria (pro-nunciata o meno che essa sia stata, ma comunque riportata da Enea stesso nei suoi Com-mentarii). Un’oratoria iniziata a Basilea nel contesto dell’unione con i greci, proseguita ad esempio nel discorso pronunciato nel 1452 all’incoronazione romana di Federico III e intensificata dopo la caduta di Costantinopoli (nelle diete imperiali come rappresentante del sovrano ma anche in altre occasioni), fino a quella fortunatissima pronunciata da lui stesso (ora Pio II) al congresso di Mantova nel 1459, i cui motivi, ‘antichi’ e cristiani (e anche la rappresentazione del nemico: ferocia e depravazione, estraneità, anche etnogra-fica, alla civiltà, pericolosità), tracimano nelle bolle, nei versi, nell’opera cosmografica e nei Commentarii. Altro genere di questa trasformazione dell’antico è la (geo)storiogra-fia, ‘laicizzata’ e ‘antichizzata’, demitizzante e insieme mitizzante (nella sua creazione di ‘origini’ e nessi legittimanti), atta, nel suo strutturarsi su base ‘nazionale’, a mostrare
rivista 2_2014.indb 667 12/09/14 10:40
668 Cr St 36 (2014)
la regionalizzazione dell’umanesimo europeo, anzi la sua funzionalità alla creazione di identità locali. Il nome di Konrad Celtis ricorre, mentre una serie di confronti riguardo al mito delle origini preromane e un dettagliato quadro per aree, anche relativamente alla ricerca e alle questioni connesse, sono offerti nei capitoli VII-VIII.
All’argomento del volume è tutt’altro che estraneo un aspetto che è tra l’estetica e la politica: l’attrazione rinascimentale per il modello dei ritratti degli antichi imperatori trasmesso attraverso le monete, oggetto peraltro di appassionata collezione (in questo caso la numismatica si eleva dal ruolo di ‘scienza ausiliaria’ per divenire oggetto di storia della ricezione dell’antichità). La predilezione per l’antiquaria induce i dotti a trattare l’argomento e gli storiografi umanisti a riproporre nelle loro opere raccolte di queste immagini realistiche (reali) di imperatori, fino a produrre precocemente veri trattati di numismatica. Tale interesse conduce insieme, oltre che alla creazione di una medaglistica rinascimentale (Pisanello), a riprodurre questi modelli nelle arti, non solo nei cicli di ‘uomini illustri’ dell’antichità e del presente (tema storico-letterario e insieme figurativo), ma nella stessa ritrattistica e come motivo decorativo sia nella pittura sia nella scultura. L’ultimo saggio (corredato di immagini in bianco e nero) che tratta il tema consente in tal modo di ampliare (unendo campi solitamente separati) e illustrare (in senso proprio) a tutto tondo la diffusione/trasformazione umanistica dell’antico, inscindibilmente lettera-ria, etica, estetica, sempre elitaria in quanto interna a un gruppo selettivo che si riconosce facendo propri tutti questi aspetti. I quali via via però conquistano la cultura europea (e la formazione dotta) dal XVI-XVII secolo sino a tempi recenti o recentissimi.
Alberto CadiliLeibniz-Institut für Eurpäische Geschichte - Mainz
L’Ordine dei Chierici Regolari Minori (Caracciolini): religione e cultura in età po-stridentina, Atti del Convegno (Chieti, 11-12 aprile 2008), a cura di I. Fosi, G. Pizzorusso, (Studi Medievali e Moderni, 27) Napoli, Loffredo, 2010, pp. 362.
Il volume pubblica le relazioni presentate nel corso del convegno tenutosi a Chieti tra l’11 e il 12 aprile 2008, insieme ad altri saggi non discussi in quella sede ma che i curatori, Irene Fosi e Giovanni Pizzorusso, hanno reputato utili per arricchire il panorama degli studi sull’Ordine dei Chierici Regolari Minori. L’ordine fu fondato nel 1588 ed ebbe come primo luogo di espansione Napoli per poi diffondersi in contesti urbani importanti e universitari in Italia e fuori penisola. Si caratterizzò per una vocazione insegnante e per l’a-dorazione perpetua del Santissimo sacramento, ma anche per un impegno nell’apostolato e nello studio delle lingue orientali. Il volume non costituisce una storia completa dell’ordine ma una prima messa a punto di specifiche ricerche, in un’ottica prevalentemente romana, anche grazie alla ricchezza del materiale documentario che, per effetto dello spostamento da sedi diverse della Casa dei Caracciolini e delle soppressioni postunitarie, si è frantumato in numerose sedi.
rivista 2_2014.indb 668 12/09/14 10:40