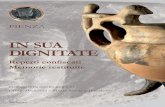Messaggi in bottiglia: tradurre memoria, memorie della traduzione
Transcript of Messaggi in bottiglia: tradurre memoria, memorie della traduzione
Rosa Maria Bollettieri Bosinelli, Ira Torresi (Università di Bologna)
Messaggi in bottiglia: tradurre memoria, memorie della traduzione
Translation is entirely mysterious. [...]What is the other text, the original? I
have no answer. I suppose it is thesource, the deep sea where ideas swim, and
one catches them in nets of words andswings them shining into the boat … wherein this metaphor they die and get canned
and eaten in sandwiches. (Le Guin 1983: 112)
Introduzione
Nel suo tentativo di dare una definizione al “mistero”della traduzione, Ursula K. Le Guin evoca un mondo liquido,la cui instabilità reca echi Baumaniani (Bauman 2000). Sesi analizza più a fondo la metafora estesa del nostro exergo, tuttavia, si percepisce anche in maniera distinta lavitalità e creatività dell’atto di pescare idee da un mareche ne pullula, usando “reti di parole” (scritte inoriginale, ma anche tradotte), per poi lavorare tali idee e“inscatolarle” per renderle edibili, digeribili, magarispalmate in “panini”, come dice Le Guin. In questa metaforail tradurre può essere visto come l’atto di tessere reti diparole (net-words, con Ruggieri 2007: 8) con cui (ri)pescarenon solo idee ma anche, come vedremo, ricordi, normesociali e traduttive, lingue perdute ed eventi storici checosì ritornano alla luce dagli abissi.
Seguendo l’esempio di Le Guin, in questo saggio anchenoi utilizzeremo alcune metafore come strumenti euristici,per esplorare il ruolo della traduzione nel tessere reti diparole e nel tramandare testi. È infatti risaputo che lemetafore svolgono un importante ruolo cognitivo tanto nelpensiero scientifico quanto in quello quotidiano (si vedanotra gli altri Black 1962 e Lakoff&Johnson 1980). Laletteratura sulla teoria e sulla prassi della traduzione,
1
in particolare, abbonda di metafore di ogni tipo, a partireda quelle politicamente scorrette dei primi studitraduttologici (come la contrapposizione tra traduzionebrutta e fedele da una parte, e bella e traditricedall’altra) fino a quelle elencate da Reynolds:
Through the centuries, translation has […] infused,transfused, refined; and mirrored, and copied, and opened thewindow. It has been thought of as preserving fire, orsuffering from disease, or bringing the dead to life. […]Many of the everyday words for describing translation have anobvious metaphorical charge: ‘faithful’, ‘free’, ‘close’; asdo many of the jargon terms of TS: ‘domesticate’, ‘dynamic’,‘formal’. (Reynolds 2011: 39)
Se poi restringiamo il campo alla traduzioneletteraria, non si può fare a meno di citare Steiner, chenel lontano 1975 nel suo After Babel scriveva:
There are no ‘theories of literature.’ There is no ‘theory ofcriticism.’ There are no theories of translation.’ What we dohave are reasoned descriptions of processes. […] Ourinstruments of perception (narrations of felt experience) arenot theories in any scientific – which means falsifiable –sense, but what I call working metaphors. (Steiner 1992: xvi,enfasi nostra) Ovviamente, occorre ricordare che le metafore sono
sempre inserite in domini cognitivi che dipendono dallacultura di riferimento; questo implica che quelle cheutilizzeremo qui sono imprescindibilmente legate allanostra cultura occidentale di appartenenza, e potrebberonon avere molto valore in altri contesti culturali.
1. La potenza generativa della traduzione
La prima metafora che desideriamo proporre qui è emersaspontaneamente da una sessione di brainstorming che dovevaservire a mettere a fuoco i motivi per cui la traduzionepotesse promuovere la memoria di un testo. Fin dall’inizioci fu chiaro che tali motivi erano espressi in forma diparti di una metafora estesa che rimandavano tutte,inaspettatamente, a una sorta di rapporto genitore-figlio
2
tra l'atto traduttivo e il testo stesso. Evidentemente,secondo noi autrici, era la traduzione a generare il testo eassumere il ruolo di sua genitrice, e non il contrario comeci si sarebbe potuti aspettare. E fornendo l’amniosmetaforico di cui il testo si nutre per venire alla luce,la traduzione crea anche la possibilità stessa che taletesto possa essere tramandato, diventando memoria.
Il primo elemento di tale metafora genitoriale è che èsolitamente grazie alla traduzione se un testo può entrarein un nuovo mondo, o come direbbe Even-Zohar (1990), unnuovo polisistema letterario. In questo polisistema diarrivo lo stesso testo, se non fosse tradotto, sarebbe deltutto assente o avrebbe una rilevanza solo marginale,perché sarebbe conosciuto solo da persone che conoscono lalingua in cui è scritto e che possono quindi entrarvi incontatto senza la mediazione di agenti istituzionali.
Poi, una volta che il testo tradotto inizia a condurreun’esistenza separata in ciascuno dei rispettivipolisistemi di arrivo, può accadere che una o più versionitradotte si guadagnino un posto più centrale, nel propriopolisistema di riferimento rispetto a quello occupatodall’originale nel polisistema di partenza. In questi casi,la traduzione può assicurare la sopravvivenza del testoanche in quei casi in cui il polisistema di partenza è unambiente ostile all’opera, come accadde per esempioall’Ulisse di James Joyce (1922), le cui prime traduzionitedesca e francese (rispettivamente Joyce 1927, tradotto daGoyert, e 1929 tradotto da Morel et al.) incontrarono unenorme successo, e furono usate come 'basi' per molte altretraduzioni in lingue europee, negli stessi anni in cuil’opera originale veniva censurata (e quindi sospesa dallacircolazione) negli USA, nel Regno Unito e in Irlanda(Lernout 2004: 12).
In terzo luogo, va da sé che una volta che il testotradotto entra in un nuovo polisistema inizia di fatto unavita indipendente, e scrive la propria storia. Seguendoancora la terminologia di Even-Zohar (1990), diventa unrepertorio attivo nel polisistema di arrivo, generando nuoveinterconnessioni che non sono disponibili per il testooriginale, ma diventano possibili solo dopo la traduzione.Questo fatto fisiologico e naturale diventa evidente solo
3
quando una deviazione dalla lettera dell’originale (una diquelle che dei traduttologi più normativi di noi nonesiterebbero a chiamare “errori”) iniziano a esserecitazioni ricorrenti e rimangono nella lingua e culturamaggioritaria anche dopo che l’“errore" da cui derivano èstato pubblicamente denunciato come tale.
Le traduzioni bibliche offrono molti interessantiesempi di tale processo, come nel caso eclatante di Mosé,descritto nell’Antico Testamento come “radioso” (karan) mache, complice l’assenza delle vocali dall’ebraico scritto(krn), nell’interpretazione di Girolamo divenne keren,“cornuto” (Esodo 34.29 della Vulgata): “ignorabat quodcornuta esset facies sua”. Il che spiega perchéMichelangelo diligentemente coronasse di due marmoree cornala fronte del profeta nella famosa statua di San Pietro inVincoli a Roma (Fig. 1). La lettura michelangiolesca dellaBibbia in latino offre inoltre un esempio molto tangibile emateriale, letteralmente scolpito nella pietra, di come unatraduzione possa prendere una strada almeno in parteindipendente dall’originale e generare nuove opere non solonel polisistema letterario di arrivo ma anche, grazie allatraduzione intersemiotica, in altre forme di arte.
Figura 1.
4
Un altro esempio del potenziale generativo dellatraduzione è il gioco, stavolta intenzionale, inventato daEugenio Montale con la sua Poesia travestita (1999). Montaleintendeva verificare cosa sarebbe accaduto ad una suapoesia che venisse tradotta in varie lingue non, comenormalmente accade, procedendo sempre dallo stessooriginale verso differenti lingue d’arrivo, ma in sequenza.Per realizzare il suo gioco, Montale mascherò la sua poesia“Nuove Stanze” da opera originariamente scritta in arabo(ovviamente si trattava della prima traduzione) che vennepoi tradotta in francese; la traduzione francese vennespacciata per originale di una terza traduzione in polacco;e così via dal polacco in russo, dal russo in ceco, dalceco in bulgaro, dal bulgaro in olandese, dall’olandese intedesco, dal tedesco in spagnolo e infine dallo spagnolo ilcerchio si chiudeva con la ritraduzione in italiano.Ciascun traduttore ignorava che Montale fosse il veroautore dell’originale e che il testo su cui stava lavorandofosse una traduzione. Ovviamente questo esperimento di“telefono senza fili” scritto risultò in un testo italianomolto lontano rispetto all'originale, che cionondimeno nonsolo era perfettamente funzionale, ma aveva anche fattoemergere potenziali significati reconditi, già presenti innuce ma inespressi nell’originale. Anche tali significatipotenziali sono "figli" generati dal processo traduttivo,che il testo originale non sarebbe stato in grado digenerare se non fosse stato sottoposto a un esperimentotanto estremo e provocatorio.
C’è infine un ultimo aspetto della metafora dellatraduzione come genitrice. Una volta che il testo tradottoinizia la sua vita autonoma, accetta il ciclo della vita intutte le sue componenti, compresa la morte. Ma in unpolisistema, proprio come in natura, la materia che muoresolitamente fertilizza nuova vita. Così avviene per esempioche opere scritte in una lingua morta vengano rivitalizzateda traduttori/autori che riscrivono gli originali imponendosu di essi il proprio stile e la propria poetica, di fattocannibalizzandoli. Talvolta, per far sì che un testo possaessere ricordato e possa vivere ancora, occorre primaucciderlo. Basti menzionare solo Seamus Heaney e la sua
5
traduzione di Virgilio (2001a) e Dante (1979 e 1993)1, oquella della saga di Beowulf (2000). Oppure Raymond Quenau(1967) tradotto in italiano da Italo Calvino.
Ciò che abbiamo discusso finora, come si sarà intuito,mette in crisi l’idea stessa di un originale. La nostrametafora della generazione ha al suo centro la traduzionecome genitrice di nuova vita che va ad arricchire ilpolisistema di arrivo e contemporaneamente instilla nuovalinfa al testo di partenza, comunemente chiamato originale,dandogli una nuova rilevanza all’interno del polisistema dacui partiva. In questo senso si può affermare che latraduzione, assicurando la presenza del testo in varipolisistemi, ponga le basi affinché di esso si serbimemoria nei polisistemi letterari e culturalicorrispondenti a tutte le aree linguistiche in cui è o èstato in circolazione. In questa prospettiva, ladistinzione tra un “originale” e le sue “traduzioni” vistecome suoi derivati perde di significato, poiché tutte leversioni del testo, compreso l’originale rivitalizzatoall’interno del proprio polisistema di riferimento, sonofiglie del medesimo processo traduttivo e da esso traggonovita e vitalità (Fig. 2).
1 Oltre ad aver tradotto la IX Ecloga di Virgilio e alcuni dei canti dell’Inferno dantesco, Seamus Heaney è anche noto per aver introdotto nella propria produzione poetica alcuni stilemi dei due scrittori classici, per esempio – rispettivamente – nella Bann Valley Eclogue e nella Glanmore Eclogue (Heaney 2001b e 2001c), e nel componimento “Station Island” (Heaney 1984).
6
Figura 2.
In questa prospettiva l’originale o meglio, il testoscritto in lingua 1, benché sia innegabilmente il punto dipartenza del processo traduttivo, non occupa il postocentrale o gerarchicamente preponderante: una volta che latraduzione ha prodotto altre versioni in altre lingue,diventa solo una delle molte incarnazioni del testo, unadelle tappe del suo viaggio nei vari polisistemi letterari,linguistici e culturali.
2. Messaggi in bottiglia
Questa riflessione ci porta alla seconda metafora cheproponiamo come mezzo di reinterpretazione del processotraduttivo. Proviamo a visualizzare il testo che viaggiaattraverso i vari polisistemi come un messaggio in unabottiglia. I produttori del testo (non solo l'autore e itraduttori, ma anche, come abbiamo appena visto, ilprocesso traduttivo stesso) lo lanciano nel mare magnumdella ricezione. La sensazione che immediatamente siassocia a questa immagine è quella di pericolo: infatti,non appena lasciata la riva, il testo viene sballottato
7
dalle onde della fortuna editoriale, e corre il rischio diraggiungere lidi diversi da quelli che prevedeva chi l’haaffidato ai flutti. C’è poi la paura concreta che il testovenga del tutto fagocitato dall’oceano ampiamenteimperscrutabile delle politiche editoriali e dei capriccidei lettori, e vada perso.
Ma allo stesso tempo, la metafora del messaggio inbottiglia ci porta a riflettere su ciò che circonda,fisicamente, il testo e lo accompagna nel suo difficileviaggio. Se paragoniamo il testo stesso alle parole scrittesul pezzo di carta racchiuso nella bottiglia, allorarisulterà evidente che la bottiglia, che è composta datante altre parti, diventa contenitore di messaggi ericordi multipli. Quanto la carta sia ingiallita, quanto ilvetro sia rovinato e reso opaco dal tempo e dalleintemperie, le concrezioni e le conchiglie che siaccumulano sulla sua superficie, la forma, il colore e ilmateriale del tappo che la chiude, addirittura l’ariaintrappolata al suo interno, diventano tutti veicoli diinformazioni e significati meno evidenti, ma pur semprepresenti. Sono tutti elementi che preservano il messaggio-testo, e al tempo stesso dicono molto sulla storia del suoviaggio: da dove viene, per cosa è passato, quando etalvolta anche perché è stato messo per mare.
Ad esempio, come ci ricorda Tymoczko (1999: 55-56), letraduzioni recano su di sé le tracce delle norme traduttiveche vigevano nel periodo storico in cui sono staterealizzate. Nel suo libro Translation in a Postcolonial Context,l’autrice descrive la storia delle traduzioni inglesi delleepopee gaeliche, sottolineando come le primissime versionifossero funzionali a una retorica dell’identità irlandeseche fosse compatibile con l’immagine romantica solitamenteassociata all’eroe forte e coraggioso, al punto diespungere i brani in cui il protagonista veniva messo inridicolo o presentato in una luce meno che cavalleresca.Evidentemente i primi traduttori non potevano prescinderedalle strategie retoriche proprie dei discorsi colonialibritannici secondo i quali il popolo irlandese era troppopoco serio per essere capace di autodeterminazione, e,volendo dimostrare il contrario, restituendo le radicidelle tradizioni irlandesi alla fruizione contemporanea,
8
operarono un’autocensura silenziosa e adottarono uno stilepiù “dignitoso” (Tymoczko 1999: 163-221). Ne consegue cheoggi tali traduzioni possono essere comprese e apprezzateappieno solo se guardate alla luce delle norme culturali etraduttive che vigevano al tempo della loro realizzazione:
The translator’s choice of translation strategy – like allpractices – is conditioned by the historical moment and theideological framework within which the translation isproduced, as well as the position of the translator withinthe cultural system. (Tymoczko 1999: 178-179)
Riportando le idee di Tymoczko alla nostra metafora delmessaggio in bottiglia, tali norme possono essereconcettualizzate come l’aria intrappolata all’interno delvetro, la cui composizione chimica e molecolare, secorrettamente analizzata, può dare informazioni preziosesul tempo e luogo in cui la bottiglia è stata tappata emessa in viaggio. È ciò che fa la stessa Tymoczko quandoanalizza le prime traduzioni delle saghe gaelicheirlandesi: illustrando il contesto di produzione dei testitradotti, svela le norme che formavano il microclima al cuiinterno, e solo lì, tali prodotti continuano ad avere unsenso. Se si ignora questo microclima, stappando troppo infretta la bottiglia e facendone uscire l'aria, il pezzo dicarta rischia di soccombere al tempo e ridursi in polvereal contatto con un’atmosfera del tutto diversa.
La metafora del messaggio in bottiglia può anche essereutile per comprendere come la traduzione possarivitalizzare testi che sono come scivolati via dallamemoria collettiva, talvolta per lungo tempo. Un esempioestremo di questa eventualità è quello della traduzione“archeologica”: interi polisistemi letterari e culturaliveicolati da lingue perdute possono essere restituitiall’umanità grazie a traduzioni in altre lingue ugualmentemorte, ma più accessibili agli studiosi.
È ben nota la vicenda di Champollion e della Stele diRosetta che consentì la prima decodifica della scritturageroglifica egizia. Forse meno conosciuta è invece lastoria dell’iscrizione di Behistun (Fig. 3), rinvenuta inIran nel XVIII secolo e decifrata a metà del secolosuccessivo. L'iscrizione narrava la biografia
9
dell'imperatore persiano Dario il Grande in tre diversescritture cuneiformi: persiano antico (il primo a esseredecodificato), elamitico e accadico babilonese. È grazie atale iscrizione trilingue che oggi abbiamo accesso a testipreziosi come quelli della saga di Gilgamesh, l’epopea delre di Uruk scritta in accadico babilonese circa 4.000 annifa, che reca tra l’altro varie somiglianze con l’AnticoTestamento.
Figura 3. (Fonte: Wikipedia)
Tradotto per la prima volta in inglese negli anni ’70del XIX secolo, fu ritradotto varie volte e oggicostituisce una fonte molto produttiva di repertori inpolisistemi di tutto il mondo. A novembre 2013, una ricercasu Google del nome “Gilgamesh” restituiva innumerevolipagine che si riferivano a testi di vari generi e media cheriportavano il nome del re di Uruk nel titolo o come unodei personaggi: da fumetti e romanzi graficifantascientifici argentini e statunitensi a videogame eserie animate giapponesi. Fa riflettere la quantità evarietà di testi moderni e contemporanei che non avrebberomai potuto vedere la luce se a Dario il Grande non fossevenuto in mente di far tradurre la propria biografia inaccadico babilonese oltre che in elamitico e in persianoantico, o se l’iscrizione di Behistun fosse rimasta sepolta
1
dalla sabbia, come un messaggio in bottiglia che navigasseancora tra le onde della memoria perduta.
Ma c’è un altro modo in cui la traduzione può fareattraversare ai testi le correnti talvolta avverse dellamemoria, che si ha quando eventi passati che rischiano dirimanere oscurati o dimenticati vengono invece riportati insuperficie da provvide traduzioni. In termini semioticianche gli eventi storici contano come testo e possono quindiessere trasportati dal processo traduttivo in polisistemidistanti non solo geograficamente e linguisticamente, maanche cronologicamente. È un caso che si verifica adesempio nel racconto “Dear You” dell’autrice irlandeseEvelyn Conlon (2013), un racconto in chiave narrativa dellavita e delle azioni di Violet Gibson, l’irlandese che sparòa Mussolini il 7 aprile 1926. Mussolini fu tanto umiliatodal fatto che l’attentatrice (mancata per poco) fosse unadonna che fece in modo di tenere sotto silenzio mediaticola vicenda, facendo internare Gibson in manicomio a vita.Conlon immagina che Violet Gibson trovi infine la forza direclamare la propria voce per raccontare la sua storia inprima persona, affidandola a un messaggio in una bottigliacosì che il mondo, a lei per sempre perduto, nondimenticasse ciò che era accaduto. Il che è invece quelloche è davvero successo nella realtà, dove non c’è statoalcun messaggio in bottiglia e dell’atto di Violet Gibsonnon rimane pressoché traccia nei libri di storia adottatinelle scuole italiane. Ed è proprio per colmare questovuoto che Conlon ha scelto una casa editrice italiana comesede di pubblicazione del suo inedito, abbinato in testo afronte con la traduzione italiana. Così Violet Gibsonrientra nella memoria, cultura e storiografia italianeattraverso una traduzione letteraria. E poiché è statoproprio il racconto di Conlon ad ispirare la nostrametafora della traduzione come messaggio in bottiglia, nonsarà del tutto inappropriato chiudere questa riflessionecon le parole che l’autrice mette nella penna di VioletGibson:
I could have said more, perhaps explained more, […] but Ihope that it suffices to bring your attention to me […],
1
despite the fact that the only way I can speak to you isthrough this perhaps unreliable bottle. (Conlon 2013: 66)
Conclusione
Facendo ricorso a metafore della traduzione abbiamocercato di dimostrare come l’idea stessa di “originale”possa essere messa in crisi se accettiamo l’idea che latraduzione generi e rigeneri testi. Si è quindisostenuto che la traduzione possa essere vista comegenitrice di nuova vita che va ad arricchire ilpolisistema di arrivo e contemporaneamente instillanuova linfa al testo di partenza. La traduzione comeportatrice di memoria è poi stata discussa attraversola metafora del messaggio nella bottiglia, messaggioche riporta alla luce eventi che possono essere statidimenticati e in questo senso, il racconto di EvelynConlon sull’attenttato a Mussolini da parte di VioletteGibson, ci è sembrato un esempio convincente.
Bibliografia
Bauman, Zygmunt. 2000. Liquid Modernity (Cambridge: Polity)
Black, Max. 1962. Models and Metaphors (Ithaca: Cornell UP)
Conlon, Evelyn. 2013. ‘Dear you’ / ‘Caro, Cara’, trad. di Ira Torresi, Tratti, 93: 42-67.
Even-Zohar, Itamar. 1990. Polysystem Studies. Numero monografico di Poetics Today, 11 (1)
Heaney, Seamus. 1979. ‘Ugolino’, in Field Work (Londra: Faber and Faber), 61-64
Heaney, Seamus. 1984. ‘Station Island’, in Station Island (Londra: Faber and Faber), 61-94
1
Heaney, Seamus. 1993. Cantos I-III, in Dante's Inferno: Translations by Twenty Contemporary Poets, a cura di Daniel Halpern(New York: Ecco), 3-15
Heaney, Seamus. 2000. Beowulf: A New Verse Translation (New York: Farrar, Straus and Giroux)
Heaney, Seamus. 2001a. ‘Vergil: Eclogue IX’, in Electric Light (New York: Farrar, Straus and Giroux), 38-41
Heaney, Seamus. 2001b. ‘Bann Valley Eclogue’, in Electric Light (New York: Farrar, Straus and Giroux), 12-13
Heaney, Seamus. 2001c. ‘Glanmore Eclogue’, in Electric Light (New York: Farrar, Straus and Giroux), 42-44
Joyce, James (1922) Ulysses (Parigi: Shakespeare and Company)
Joyce, James (1927) Ulysses von James Joyce: vom Verfasser geprüfte deutsche Ausgabe von George Goyert. 3 vols (Basilea: Rhein-Verlag)
Joyce, James (1929) Ulysse, traduction intégrale d’Auguste Morel, revue par Valery Larbaud, Stuart Gilbert et l’Auteur (Parigi: Gallimard)
Lakoff, George e Mark Johnson. 1980. Metaphors We Live By (Chicago e Londra: University of Chicago Press)
Le Guin, Ursula K. 1983. ‘Reciprocity of Prose and Poetry’, in Dancing at the Edge of the World. Thoughts on words, women, places (1989). New York: Grove Press, 104-114.
Lernout, Geert. 2004. ‘Introduction’, in The Reception of James Joyce in Europe. Vol. I: Germany, Northern and East Central Europe, a cura di Geert Lernout e Wim Van Mierlo (Londra: Continuum),3-13
Montale, Eugenio. 1999. Poesia travestita, a cura di Maria Corti e Maria Antonietta Terzoli (Novara: Interlinea)
Queneau, Raymond. 1967. I fiori blu. Trad. di Italo Calvino(Torino: Einaudi) [Edizione francese 1965, Les Fleurs Bleues (Parigi: Gallimard)]
Reynolds, Matthew. 2011. The Poetry of Translation: from Chaucer and Petrarch to Homer and Logue (Oxford: OUP)
Ruggieri, Franca. 2007. ‘Foreword’, in Joyce and/in Translation, a cura di Rosa Maria Bollettieri Bosinelli e IraTorresi (Roma: Bulzoni), 7-8
Steiner, George. 1992 (1a ed. 1975). After Babel: Aspects of Language and Translation (Oxford: OUP)
1
















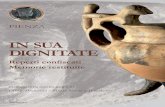






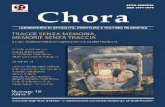

!['Pie Memorie' [An Unknown Motet by Noel Bauldeweyn]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334bb0b6c27eedec605dd06/pie-memorie-an-unknown-motet-by-noel-bauldeweyn.jpg)
![La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63188333d93a162f9c0e92a8/la-traduzione-italiana-dellufficio-liturgico-ortodosso-slavonico-soc-162-2012.jpg)