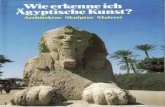La traduzione di "yĕdîdĕyāh" (2Sam 12,25) in alcune versioni antiche
Conti e Racine: la traduzione dell'Athalie
Transcript of Conti e Racine: la traduzione dell'Athalie
1 A. Conti, Dissertazione sull’Atalia, in Id., Versioni poetiche, a c. di G. Gronda, Bari, Laterza, 1966, p. 118. Come è noto, in gioventù M.me de Caylus e le demoiselles del collegio di Saint-Cyr avevano recitato dinanzi a Luigi XIV le tragedie sacre di Racine. Sui rapporti del drammaturgo francese con M.me de Caylus cfr. i Souvenirs di quest’ultima, usciti nel 1770 con la falsa data di Amsterdam (Ginevra) e una prefazione anonima attribuita a Voltaire. Nella traduzione italiana a c. di O. Merola Algranati (Palermo, Sellerio, 1988) si vedano in particolare le pp. 111-115.
2 La figura e l’opera di M.me de Caylus vengono ricordate anche nella Lettera a Monsignor Cerati sul Globo di Venere, che contiene l’apoteosi della nobildonna. Cfr. Prose e poesie del signor abate Antonio Conti patrizio veneto. Tomo primo, In Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1739, pp. VII-VIII.
3 Ibid., p. 118.
Silvia Contarini
CONTI E RACINE: LA TRADUZIONE DELL’ATHALIE
Per esplicita dichiarazione del traduttore, la versione dell’Athalie di Antonio Conti risalirebbe «all’autunno del 1720», quando l’abate padovano, «godendo l’ozio della campagna» francese con la contessa di Caylus, aveva potuto profit-tare della frequentazione assidua dell’ultima allieva di Racine per studiarne dal vivo la declamazione «passionata e maestosa» e «l’arte di ben modulare la voce ed accompagnarla col gesto opportuno»1. La scelta stessa della tragedia viene ricondotta al sodalizio con Madame de Caylus2, la quale, così ricorda il Conti nella Dissertazione sull’Atalia del Racine che introduce il testo pubblicato nel 1739 nel primo tomo delle Prose e poesie, «mi disse più volte che il Racine preferiva questa tragedia a tutte le altre che compose; ed in fatti ne avea molta ragio-ne perché non fu mai rappresentata nella minorità di Luigi XV o nel palagio delle Tuilerie o sul Teatro Francese che non traesse abbondanti lacrime dagli occhi degli spettatori e non li costringesse a confessare che il Racine con un sacerdote e con un fanciullo avea saputo meglio sorprendere ed intenerire gli animi che co’ trasporti di Fedra, con le tenerezze d’Andromaca e con la morte di Britannico»3.
Stampata nel 1691 dopo l’esperimento dell’Esther, la seconda delle due tra-gedie bibliche di Racine inserisce la riscrittura del soggetto religioso nel qua-dro formale del dramma classico, contaminando il tema del sacro nell’ottica di Port-Royal con i topoi della tradizione antica, fra cui quello centrale del sogno premonitore estraneo al circuito biblico, che come è stato osservato «introdu-ce delle ambiguità che lavorano segretamente a sfaldare il genere stesso della
SILVIA CONTARINI12
4 B. Papasogli, Il sogno premonitore nella tragedia sacra, in Il tragico e il sacro dal Cinquecento a Racine. Atti del convegno internazionale di Torino e Vercelli (14-16 ottobre 1999), a c. di D. Cecchetti e D. Dalla Valle, Firenze, Olschki, 2001, p. 236.
5 Cfr. J. Starobinski, Racine et la poétique du regard, in Id., L’oeil vivant. Corneille, Racine, La Bruyère, Rousseau, Stendhal, Paris, Gallimard, 1999², p. 91.
6 Cfr. Ch. Mauron, L’inconscient dans l’oeuvre et la vie de J. Racine, Genève, Slatkine, 1986 (rist. anastatica ed.1957), p. 317.
7 Cfr. J. Starobinski, Racine et la poétique du regard, cit., p. 80.8 G. Gravina, Della tragedia libro uno, in id., Scritti critici e teorici, a c. di A. Quondam, Bari, Laterza,
1973, p. 520. Ma su questo punto, centrale nelle teorie tragiche dell’epoca, cfr. B. alfonzetti, Il corpo di Cesare. Percorsi di una catastrofe nella tragedia del Settecento, Modena, Mucchi, 1989.
9 P. Bénichou, Morali del Gran siècle. Cultura e società nel Seicento francese, tr. it. Bologna, Il Mulino, 1990, p. 135.
10 Cfr. M. Bauduin, Athalie ou la gloire de la théomachie, in Il tragico e il sacro, cit., pp. 251-267.
tragedia sacra»4. All’incontro del teatro greco con il pensiero giansenista ha accennato del resto anche Starobinski, mostrando come la poetica dello sguar-do in Racine appaia sempre segnata dalla coscienza della colpa e della fragilità umana5.
Attingendo agli scarni passi del II libro dei Re e del II libro delle Cronache, il drammaturgo francese costruisce una storia di passioni che si consuma tutta dentro lo spazio chiuso del tempio di Gerusalemme, dove avviene il confron-to simbolico tra il notturno interiore di Athalie e la luce della fede che ispira le parole e le azioni del suo antagonista, il sacerdote Joad. Nella prospettiva duplice della scena, segnata nel profondo dall’ambiguità degli affetti, la di-mensione protettiva dell’altare sacro intorno a cui ruota il dramma si muta nel luogo primario dell’ostilità, della minaccia, del terrore inconscio. Come ha osservato a suo tempo Charles Mauron, il tempio si lega infatti, nel delirio onirico di Athalie, all’immagine archetipica della «mère infernale» incarnata dal personaggio di Jézabel, che rappresenta l’impulso di una tragica coazione a ripetere6. Se la realtà materiale del mondo è bandita dal teatro raciniano, sosti-tuita dalla coppia antinomica giorno-notte che ne svela le radici psichiche7, gli avvenimenti veri e propri, segnati dalla brutalità e dalla violenza, si consumano fuori della scena, in perfetta sintonia con quello che sarà il monito del Gravina riguardo alla rappresentazione delle «cose atroci», che «debbono per relazione agli orecchi, non per la vista agli occhi venire»8. Al centro della tragedia rimane insomma quella che Paul Bénichou ha definito la «nuova psicologia dell’istin-to»9, ovvero la graduale e ossessiva manifestazione di una passione oscura che narra la discesa nell’abisso del sé.
Insieme al naturalismo di Racine, che doveva costituire per il Conti studioso di Cartesio un elemento decisivo, non bisogna trascurare l’allegoria politica celata nel testo. L’Athalie è anzitutto una teomachia10: la lotta implacabile tra il
CONTI E RACINE: LA TRADUZIONE DELL’ATHALIE 13
11 Su questo punto rimando ancora alle pagine di P. Bénichou, Morali del Gran siècle, cit., pp. 113 sgg.
12 Il Discorso Istorico e Politico intorno allo Stato della Francia dal 1700 sino al 1730 è stato pubblica-to da R. Rabboni, «Filologia e critica», XXIX, 2, 2004, pp. 244-300. Il passo in questione si trova a p. 266.
13 A. Conti, Lettera a Sua Eminenza il Signor Cardinale Bentivoglio d’Aragona, in Il Cesare, tragedia del sig.ab. A. Conti nobile veneto, con alcune cose concernenti l’opere medesime, Faenza, Gioseffantonio Archi, 1726, p. 31.
14 Ibid., p. 32.15 Così G. Gravina, Della tragedia, cit., p. 528. Sulla «riforma dell’ethos» propugnata dal Gra-
vina cfr. P. Luciani, Le passioni e gli affetti. Studi sul teatro tragico del Settecento, Pisa, Pacini, 1999, pp. 23 sgg.
16 A. Conti, Dissertazione sull’Atalia, cit., pp. 117-118.17 Ibid., p. 118.
Dio degli Ebrei e il Baal dei Fenici, tra il potere del Sacerdote e quello del Re, che nella simbologia trasparente di Port-Royal adombra il conflitto tra Luigi XIV e il partito giansenista, con la negazione radicale dei valori terreni e di ogni autorità umana11, cui accenna di sfuggita il Discorso intorno allo stato della Francia 12. Non stupirebbe dunque se proprio questo elemento avesse contri-buito ad attirare l’interesse del Conti, allievo del Gravina e indirettamente di quella scuola napoletana che, tra Caloprese, Doria e Vico, aveva meditato a lungo sul nesso tra politica e morale. Ma soprattutto, come prova l’annotazione iniziale riferita a Madame de Caylus, l’archetipo raciniano era significativo, agli occhi del traduttore, perché mostrava che «senza amore, e senza confidenti, si possono istruire gli spettatori e farli piangere»13, delineando un modello di tra-gedia intesa come «scuola di morale»14, fondata sul contrasto psicologico delle passioni e sul rifiuto della «falsità del carattere romansesco»15. Proprio Racine, nota il Conti sulla traccia del Gravina, era stato «eccellente» nel moltiplicare le azioni «aumentando gli oggetti delle passioni», al punto che se «i poeti francesi l’avessero imitato (…) sul teatro loro non si sarebbe trasportato il romanzo», ossia «tanti nodi avviluppati che fanno d’ogni atto un’intiera tragedia, tante agnizioni di cui l’una distrugge vicendevolmente l’effetto dell’altra, tanti carat-teri o troppo metafisici o troppo verbali»16. E ricorrendo alle similitudini della scienza e della pittura, che illuminano il senso profondo di una teoria della tra-gedia che pone al centro il sistema complesso degli affetti nella loro evidenza fisica e concreta, precisa:
Chiamo caratteri verbali quelli ove non per ragion dell’azione ma delle parole s’espone il costume. Io soglio paragonare i primi caratteri alle immagini ombratili o agli spettri delle lanterne magiche in cui non mai si trova la vivacità dei colori e la verità delle sembianze che hanno le altre pitture. Rassomiglio i caratteri verbali alle rozze fi-gure de’ primi pittori che si distinguevano in virtù del cartello che loro usciva di bocca17
SILVIA CONTARINI14
Prima di indagare a fondo, attraverso le pagine acutissime del saggio critico che precede la traduzione e la completa, le ragioni per cui l’abate padovano scelse di dedicare le sue energie a un’opera che ancora qualche anno più tardi, da un altro punto di vista, un sostenitore acceso di Corneille come il Baretti avrebbe definito la migliore tragedia di Racine insieme all’Esther, è opportuno ritornare brevemente sulla genesi della traduzione, poiché a ben guardare la data finora indiscussa del 172018 non sembra trovare altri riscontri al di fuori della voce dell’autore. Anzi, secondo quanto riportato dal Toaldo sulla scorta di Jacques Hardion nelle Notizie intorno la vita e gli studi del sig. abate Conti, la prima stesura della traduzione si collocherebbe verosimilmente fra il ’24 e il ’26, l’anno in cui si chiude il secondo soggiorno francese e il termine post quem a cui riconduce il manoscritto della Nazionale di Parigi. Comunque stiano le cose, e tanto più se si accetta la versione alternativa del biografo, il lavoro più volte interrotto e ripreso sul testo raciniano non viene solo a sovrapporsi alla scrittura del Cesare, la tragedia cominciata durante il soggiorno londinese pres-so il duca di Buckingham e stampata solo nel ’26 a Faenza per iniziativa del cardinale Cornelio Bentivoglio19, ma incontra anche la redazione del Druso con l’importante discorso introduttivo che riprende e consolida le tesi della Dissertazione sull’Atalia.
La testimonianza dell’Hardion gode di qualche credito, poiché proprio a quest’ultimo si era rivolto il conte di Caylus dopo la morte della madre per abbozzare un «essai sur la vie dell’ab. Conti» che avrebbe dovuto precedere l’edizione delle lettere20. Ascoltiamo dunque le parole con cui ricostruisce la storia della traduzione, richiamando a distanza di tempo quella frequentazione assidua dei testi antichi che per il Conti, come poi per l’Alfieri, rappresentava-no insieme una scuola di stile e un modello psicologico di sicuro effetto per sondare l’abisso immutato delle passioni:
Io mi ricordo […] di due viaggi a Fontainebleau, dove era venuto col fu Sig. Duca di Villeroy; mi pare nel 1724 e 1725. Come io non aveva il tempo libero per andarlo a trovare, egli veniva da me ogni giorno il dopo pranzo, e noi passavamo ordinariamente
18 La accoglie senza riserve G. Gronda, probabilmente sulla scorta del Fubini (cfr. Racine et la critique italienne, in Id., Dal Muratori al Baretti. Studi sulla critica e sulla cultura del Settecento, Bari, Laterza, 1968³, p. 377).
19 Sul Cesare e in generale sull’esordio drammatico del Conti cfr. R. Rabboni, Sul verso tragico di Antonio Conti, in Metrica e poesia, a c. di A. Daniele, Padova, Esedra, 2004, pp. 145-172.
20 Cfr. R. Rabboni, Le lettere di Antonio Conti a Madame de Caylus (e un problema di filologia d’autore), «Lettere italiane», LIX, 1, 2007, pp. 88-104 (90), a cui rinvio anche per le osservazioni puntuali sull’edizione della corrispondenza tra l’abate padovano e M.me de Caylus portata a termine con esiti assai discutibili da S. Mamy (A. Conti, Lettere da Venezia a Madame la comtesse de Caylus (1727-1729). Con l’aggiunta di un Discorso sullo Stato della Francia, Firenze, Olschki, 2003).
CONTI E RACINE: LA TRADUZIONE DELL’ATHALIE 15
due o tre ore a legger de’ preziosi pezzi di autori Greci, Poeti, ed altri, dei quali allora non intendeva a fondo la lingua, ma credeva poterne meglio penetrare le bellezze col mezzo della conversazione, che colla semplice lettura delle traduzioni Latine. Legem-mo alcune Tragedie di Euripide, tra l’altre l’Ifigenia in Aulide, e l’Ippolito. Questa lettura crebbe in lui l’ammirazione che aveva da gran tempo per Racine, rilevando l’arte, con la quale questo gran Poeta s’avea appropriato quel che avea trovato bello in quell’originale. In oltre, come avea l’orecchia assai dilicata, riconobbe fino a qual pun-to avesse il Racine preso l’espressioni, il portamento, e l’armonia dei versi d’Euripide, e d’Omero; cosa che gli avea fatto trovare nella nostra lingua un genere di stile e di versificazione, che era sua propria, e che servirà di modello fin che si conserverà il vero gusto della Poesia Francese. […].
M’aveva egli comunicato innanzi di partire la sua traduzione dell’Attalia, sopra la quale m’aveva chiesto qualche spiegazione, sopra tutto riguardo ad alcuni versi de’qua-li volea conoscere l’energia, poiché era egli estremamente modesto, e diffidavasi sem-pre di se stesso. Così non risparmiava le ricerche, e si sottometteva senza pena agli avvisi degli amici, benché meno illuminati di lui per molti riguardi21.
Curiosamente, la ricostruzione per altri versi puntuale non menziona la Dis-sertazione sull’Atalia, abbozzata secondo il Conti insieme alla versione di Racine e sottoposta immediatamente al giudizio dei letterati francesi, tra cui l’Hardion stesso22. Alla mancata coincidenza delle fonti si aggiunge il fatto che sul testo introduttivo, da lui considerato il primo vero saggio critico sul drammaturgo francese, l’autore ritorna più volte nello scambio epistolare avviato con Mada-me de Caylus dopo il rientro in Italia, ma sempre come se dovesse annunciare qualcosa di nuovo e di inedito, di cui l’amica e confidente non sembra essere a conoscenza, tanto che informandola sullo stato del lavoro le promette di non stampare nulla senza il suo parere.
Nella lettera del 28 luglio 1727, per esempio, si legge:
Comme j’ai fait une longue dissertation sur l’Atalie, j’ajouterai à ce volume [je ne laisserai point d’ajouter] la traduction que j’ay fait de cette pièce, et j’entreray dans l’examen des tragédies de Corneille et de Racine. Vous m’avez promis la dissertation de M. Fontenelle [mais je ne la vois pas. Cependant] mais vous ne me l’envoyez pas. Vous voyez que j’en ai grand besoin. Je vous prie de croire que je [n’emprimeray rien là des-sus] ne ferai rien imprimer sur cette matière sans l’exposer [auparavant] à votre critique23.
Già nella lettera del 13 marzo, tuttavia, nella quale comunicava a Madame
21 Prose e poesie del signor abate Antonio Conti patrizio veneto. Tomo secondo e postumo, cui precedono le Notizie spettanti alla sua vita, e ai suoi studi, Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1756.
22 Cfr. A. Conti, Dissertazione sull’Atalia, cit., p. 119.23 A. Conti, Lettere da Venezia, cit., p. 156.
SILVIA CONTARINI16
de Caylus la necessità di procurare una seconda edizione emendata del Cesare e di aggiungervi «le Drusus et la traduction de l’Atalie avec vos remarques», l’aba-te allude in modo generico a un’analisi del teatro francese da inserire nel libro, per la quale richiedeva alla sua interlocutrice «la pièce que M. Fontenelle a lue à l’Académie contre M. Racine en faveur de Corneille», promettendo «d’en faire un bon usage»24. Pochi mesi più tardi, nella missiva del 9 ottobre 1727, l’auto-re chiarisce che l’obiettivo primario è proprio la disamina critica dell’Athalie, nodo centrale della riflessione sulla tragedia che si sviluppa in parallelo nelle prefazioni del Cesare e del Druso.
Rassicurando la Caylus sull’avvenuta spedizione del Cesare, il Conti aggiunge infatti subito dopo:
J’en veux faire une autre édition qui sera beaucoup plus correcte que la première. J’y joindrai le Drusus que je viens d’achever et dont j’ay fait la lecture à plusieurs per-sonnes qui m’ont conseillé avec empressement de l’emprimer. Je pense d’ajouter à ces deux tragédies la traduction de l’Atalie avec la dissertation qui en explique le plan et le caractères. Je voudrois bien lire le Discours de M.de Fontenelle pour toucher légère-ment la différence de deux poètes, soit par rapport à l’expression, soit par rapport au plan de la tragédie. M. le Comte de Plélo m’avoit fait espérer cette dissertation; mais apparemment il ne l’aura pas pu avoir. S’il ne veut pas m’envoyer la dissertation qu’il m’envoye au moins un extrait, ou les idées générales25.
La richiesta insistente riguardo al testo di Fontenelle non doveva però esse-re stata accolta dai corrispondenti francesi, dal momento che nella lettera del primo gennaio 1728 il Conti annuncia quasi rassegnato: «Mon Drusus est [en-fin] achevé avec sa préface. Je le feray imprimer avec le César et la traduction de l’Atalie que j’ay [dans l’esprit] envie de vous dédier. [Je voudrois savoir ce que M. Fontenelle a fait sur Corneille et Racine pour en grossir ma préface»26.
Se alla fine proprio quella dedica rimasta implicita può avere suggerito, nel-la stampa del ’39, l’indicazione temporale del 1720 che lega indissolubilmente l’origine del testo al soggiorno presso Madame de Caylus in una sorta di omag-gio postumo, non è dato sapere con sicurezza. Certo è che i frammenti epistola-ri successivi documentano il lavoro compiuto sulla Dissertazione27: un testo in fie-ri che con tutta probabilità all’epoca del soggiorno francese non aveva ancora una sua fisionomia precisa, tanto che nella lettera del 1728 il Conti lo descrive
24 Ibid., pp. 132-33.25 Ibid., p. 170.26 Ibid., p. 174.27 Si veda per tutte la lettera del 23 gennaio 1728 sulla teoria della gradatio tragica, sviluppata
in maniera più ampia nella Dissertazione sull’Atalia.
CONTI E RACINE: LA TRADUZIONE DELL’ATHALIE 17
alla sua corrispondente come se non le fosse già noto, e che comunque, se com-posto prima del rientro in Italia, doveva poi aver conosciuto aggiunte cospicue rispetto all’abbozzo primitivo. Non è però la sospirata Vie de Corneille, con il più rilevante Parallèle de Corneille et de Racine, a lasciare tracce nel saggio: anche se fosse riuscito a consultarli, difficilmente il Conti poteva condividere con Fonte-nelle le ragioni del primato indiscusso di Corneille e soprattutto l’incompren-sione sostanziale nei confronti del «sublime simple, naturel et precis» di Raci-ne, elogiato in un passo eloquente della Lettre à Madame la Présidente Ferrant28. Ciò che emerge dal carteggio con la Caylus è invece il contributo significativo di Domenico Lazzarini, autore di una puntigliosa Osservazione sopra la Merope del Maffei e di una disamina critica della notissima traduzione di Lucrezio a opera del Marchetti, a cui si deve anche la tragedia Ulisse il Giovane ricordata dal Martello nella lettera preposta all’edizione del Cesare e più tardi oggetto di una ristampa collettiva insieme con la Merope e lo stesso Cesare29.
Nelle pagine finali della Dissertazione il nome di Lazzarini ricorre solo di sfuggita, quando il Conti ripercorre brevemente la storia italiana dell’Athalie:
Nell’anno 1725 il signor marchese Fontenelle ed il signor abate Vandelli, che era seco a Parigi, trassero una copia della tragedia e della dissertazione e la portarono a Modena ed a Bologna; ed essendo io ritornato in Italia nel 1726 feci col mezzo del Nobil Uomo abate Carminati veder l’una e l’altra all’abate Lazzarini e al signor Ala-leona che mi mandò alcune picciole note su le parole italiane dei primi due atti della traduzione30.
Di tutt’altra natura, e assai più consistente, è però la citazione che compare nella corrispondenza con la Caylus. In una lettera del luglio 1727 dove si parla ancora del Druso, ormai quasi compiuto, l’autore rivela infatti:
L’abbé Lazarini m’a lu à Padoue quelques morceaux de sa Poétique. Je suis [bien] très content de l’analyse qu’il a fait de l’Iliade, de l’Odyssée, de l’Enéide. Il y a un mo-ment si juste entre les partie de ces fables qu’on voit [bien] clairement qu’elles n’ont pas été composées au hazard, mais il n’est pas faute d’en apercevoir les liaisons à moins de connoître les éléments de la fable, le fond et le circonstances des passions humaines.
28 «Je ne comparerois pas vos poètes avec la même hardiesse que j’ai comparé les nôtres. Je dirois simplement en gros, que dans le Cinna, dans le Pompée, dans le Polieucte je ne trouve pas ce sublime simple, naturel, et precis, que je trouve dans l’Atalie, dans la Phedre, dans l’Iphi-genie, dans le Mitridate» (A. Conti, Lettre à M.me la Présidente Ferrant, in Id., Prose e poesie, cit., II, p. XCIX).
29 Nuovo teatro italiano contenente l’Ulisse il Giovane dell’abbate Lazzarini, la Merope del signor mar-chese Maffei, il Cesare del n.h. abbate Conti..., Venezia, G. Bettinelli e P. Bassaglia, 1743.
30 A. Conti, Dissertazione sull’Atalia, cit., p. 119.
SILVIA CONTARINI18
Lazarini distingue dans chaque fable l’action de la matière. L’action de l’Iliade par exemple, est la colère d’Achille. La matière est le siège de Troyes qui détermine la colère d’Achille. Tout ce qui est dans l’Iliade se rapporte à cette colère, c’est-à-dire au mépris qui la cause, à la vengeance qu’il en tire, et au plaisir qui suit la vengeance. Tous les grands événements de l’Iliade dépendent de ces trois choses-là, qui se modifient et augmentent la passion qui en est modifiée. Quel artifice [ne s’est pas servi Homère] Homère n’a-t-il pas employé pour faire que la colère d’Achille contre Agamemnon soit vaincue par celle qu’il conçoit contre Hector. Agamemnon lui enlève une esclave; Hec-tor [luy] tue son ami. Tout ce que Cicéron a dit dans son livre de l’amitié n’est qu’une ébauche de l’amitié d’Achille et de Patrocle. Leurs âges et leurs inclinations sont con-formes. Ils ont été élevés ensemble par des pères qui s’aimoient tendrement. Ils sont nés sous la même constellation et doivent mourir la même année. Il n’ y a donc rien de plus naturel que la vengeance d’Achille et sa cruauté est pleinement justifiée par rap-port à son amitié. Comme la vengeance qu’il tire d’Agamemnon est également justifiée par rapport à son honneur. Il avoit été méprisé par le général à la vue de toute l’armée. Comment le prince Eugène eut-il traité ceux qui l’eussent méprisé en pareille occasion? Faut-il donc s’étonner si Achille [est inflexible] ne se rend ni aux prières [et] ni aux [dons] présens d’Agamemnon? Il n’ y a qu’un plus grand degré de colère qui soit capable de lui faire oublier [de se venger d’Agamemnon] la vengeance qu’il veut tirer d’Agamemnon. Ce prince n’oublie rien de son côté pour [réparer l’honneur d’] faire réparation à Achille. Les jeux en sont une bonne preuve, et Homère ne les pouvoit [pas] placer ailleurs, car il faut qu’Achille soit autant honoré d’Agamemnon, qu’il avoit été offensé, et que les funérailles de Patrocle soient une espèce de triomphe. Je vous communique des pensées [nouvelles] que vous ne trouverez [pas] dans Mons. De la Motte, ni dans M. Terrasson, ni dans Mons. Boivin31.
Il frammento del Lazzarini, derivato con tutta probabilità dalle pagine anda-te perdute sopra L’Arte poetica, e dunque prezioso per più di una ragione, ritor-na nelle pagine iniziali del saggio critico su Racine dove il Conti istituisce una similitudine tra l’Iliade e l’Athalie che ha lo scopo non solo di illuminare, ma di elevare un’azione tragica dove prevale lo studio al naturale («en physicien», avrebbe detto Cartesio) dei caratteri e delle passioni nella loro evidenza fisica e psicologica. In maniera ancora più trasparente, nella Prefazione al Druso – ap-poggiandosi anche all’autorità del gesuita Pierre Brumoy che vede nell’Iliade di Omero il modello di ogni tragedia32 – l’autore distingue tra l’assedio di Troia, materia dell’Iliade, e l’ira di Achille che ne costituisce l’azione, e trasferisce poi il ragionamento alla letteratura moderna, sostenendo per esempio che nella
31 A. Conti, Lettere da Venezia, cit., p. 153.32 Cfr. P. Brumoy, Le théatre des Grecs, Paris, chez Rollin Père, Jean-Baptiste Coignard Fils, Rol-
lin Fils, 1730, 3 voll., I, p. XXXVII. Ma su Omero modello dell’«espressione del naturale» si veda anche Gravina, Della ragion poetica, cit., pp. 203-204.
CONTI E RACINE: LA TRADUZIONE DELL’ATHALIE 19
«Gerusalemme Liberata la materia è l’assedio di Gerusalemme, l’azione deriva dalla pietà di Goffredo»33. E aggiunge significativamente:
Io composi le mie tragedie con questo metodo: nel Giunio Bruto la materia è la congiura contro de’ Consoli, e la scoperta che se ne fa; l’azione tragica vien dalla subor-dinazione al zelo infaticabile di Bruto. Nel Marco Bruto la materia è la congiura contro di Cesare, l’azione vien pure dalla subordinazione al magnanimo zelo di Marco nel restituir alla Repubblica la primiera libertà. Nel Cesare la materia è la stessa congiura contro di lui, l’azione è la stessa materia subordinata all’ambizione di Cesare, che tenta di cangiar la Repubblica in Monarchia. Non ben seppi accennar ciò nella Prefazione, perché avendo composto questa Tragedia in Francia, non molto aveva io esaminata questa distinzione, che poi molto accrebbi ed illustrai nel Trattato della Tragedia, e con essa composi un altro Cesare34.
In altre parole, la lettura in parallelo della corrispondenza con la Caylus e il discorso introduttivo al Druso sembrano confermare per via indiretta che durante il periodo francese la Dissertazione poteva essere davvero solo un abboz-zo, dal momento che la similitudine con l’Iliade da cui prende l’avvio l’analisi strutturale dell’Athalie, con la distinzione tra la materia e l’azione della favola, giungerà solo più tardi a irrobustire l’impianto teorico di quel testo e della ri-flessione stessa sulla tragedia, di cui il saggio su Racine costituisce senza dubbio una tessera fondamentale. Non per nulla, in due scritti successivi come la Dis-sertazione intorno alla Tebaide di Stazio35 e soprattutto la Prefazione al Marco Bruto, la distinzione declinata in maniera così convincente dal Lazzarini si presta a definire l’essenza del dramma in termini quasi newtoniani, con la forza degli affetti assimilata all’energia del cosmo36:
Le prime cose che io considero in una Tragedia sono la materia e l’azione; la mate-ria vien costituita dalle parti della favola o dell’istoria tragica considerate in sé stesse, o senza dipendenza e connessione tra loro. L’azion tragica è costituita da queste medesi-me parti considerate relativamente all’artifizio del Poeta, che tra loro le connette e le subordina ad una passione, ad una virtù, o ad un vizio37.
Se ora, tenendo ferme queste considerazioni, ritorniamo alla Dissertazione
33 Druso. Tragedia del Signor Abate Antonio Conti, patrizio veneto. In Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1748, pp. 22-23.
34 Ibid., pp. 23-24.35 Cfr. Dissertazione intorno alla Tebaide di Stazio, in Opuscoli filologici dell’abate Antonio Conti pado-
vano, Venezia, nella Tipografia Alvisopoli, 1832, p. 146. 36 Su questo punto rimando alle considerazioni di N. Badaloni in Antonio Conti. Un abate
libero pensatore tra Newton e Voltaire, Milano, Feltrinelli, 1968, in particolare pp. 59-101. 37 A. Conti, Prefazione a Marco Bruto, Venezia, Pasquali, 1744, pp. 20-21.
SILVIA CONTARINI20
sull’Atalia, dove lo sguardo del critico è tutto rivolto a indagare lo specifico del testo raciniano e le sue leggi interne, si vedrà subito come in un insieme eteroge-neo, dominato dall’energia dei contrasti, l’unità dell’azione dipenda dal perso-naggio di Joad, il cui «sdegno sacro» è paragonabile a quello di Achille a seguito della morte di Patroclo. Il parallelo, che riecheggia una volta di più le parole del Lazzarini, serve al Conti soprattutto per mettere in luce l’analisi cartesiana delle passioni che consente la rilettura moderna della norma aristotelica:
Chi conduce dal principio sino al fine l’azione è Ioadde, ed al zelo di lui, che è una spezie di sdegno sacro, deve ascriversi l’azione dell’Atalia, in quella guisa che l’azione dell’Iliade s’ascrive allo sdegno d’Achille. L’uno e l’altro sdegno è del pari inesorabile ed ha per oggetto la vendetta, ma l’impulso o il motivo della vendetta d’Achille è prima l’ambizione e poscia una tenerezza che si cangia in furore, all’incontro il motivo o l’im-pulso della vendetta di Ioadde è l’onor della religione tradita colla morte de’principi, a’ quali s’aveva il trono usurpato. Non s’accheta Achille fin che non uccide Ettorre, che gli avea ucciso l’amico, e non s’accheta Joadde fino a che non sia morta Atalia la quale vivendo potea turbare il Regno restituito al legittimo erede. Uno dunque essendo l’im-pulso; uno il fine o l’oggetto dell’azione di Joadde, l’azione è una, ed è una di uno, se Joadde è il solo che la prepara, la comincia, la proseguisce e termina38.
Proseguendo nella disamina articolata degli affetti che coinvolgono tanto l’autore del dramma quanto lo spettatore, secondo le norme della ricezione già individuate da Dubos, il Conti osserva ancora che le due passioni dominanti della compassione e del terrore, quelle che Brumoy aveva definito con Locke «les pivots de l’âme»39, e su cui medita a lungo la Prefazione del Druso, cadono sul terzo personaggio della triangolazione raciniana, vale a dire il fanciullo e fu-turo re Joas. È un’anomalia solo apparente, che si giustifica ricorrendo al prin-cipio dell’«unità di interesse», secondo il quale «quanto si fa o nel preparare o nel cominciare o nel proseguire o nel terminare l’azione deve interessar l’ani-mo dello spettatore per un solo e non per molti, poiché altrimenti, aumentan-do gli oggetti della compassione e del terrore, queste passioni s’impediscono, si distraggono scambievolmente e quindi si minorano e quasi s’annullano»40. Oltre tutto la scelta di indirizzare i sentimenti più istintivi e immediati dello spettatore verso un unico personaggio che non è quello principale esiste già nel mondo classico, come argomenta subito dopo il Conti:
Io so che ad alcuni interpreti d’Aristotele non aggradirà che la compassione non
38 A. Conti, Dissertazione sull’Atalia, cit., p. 105.39 P. Brumoy, Le théatre des Grecs, cit., I, pp. L-LI.40 A. Conti, Dissertazione sull’Atalia, cit., p. 107.
CONTI E RACINE: LA TRADUZIONE DELL’ATHALIE 21
cada sul Protagonista della Tragedia o sia sul sommo Sacerdote che dal principio al fine conduce tutta l’azione. Io li prego di riflettere che nell’Iliade d’Omero modello delle Tragedie l’azione cade su lo sdegno d’Achille, e la compassione, e il terrore cadono su i Greci e Troiani, e particolarmente su Patroclo ed Ettorre uccisi. Con la medesima arte è condotta l’Elettra. Oreste per vendicar la morte di Agamennone suo padre si propone di castigar colla morte gli uccisori, cioè Clitennestra ed Egisto. Oreste […] medita, e prepara, ed eseguisce l’azione, e perciò è il Protagonista, o l’attor principale della Tragedia, e pur la compassione e ’l terrore cade su Elettra, che come la persona più tragica denomina la Tragedia41.
Ciò che emerge dal ragionamento del Conti attraverso il rapporto con i modelli antichi, o piuttosto in virtù del pathos contenuto in figure che rappre-sentano gli archetipi del sentire umano, è ancora una volta il richiamo alla «naturalezza» delle passioni, ovvero a quel concetto più volte ribadito di verosi-miglianza psicologica che ritorna nella Dissertazione intorno alla Tebaide di Stazio, là dove si osserva che il poeta, «mirabile nel muovere il terrore e l’orrore come la compassione» fa cadere quest’ultima «tutta sulle femmine, oggetto natural-mente compassionevole per la debolezza del sesso»42.
Ma la centralità degli affetti si ritrova anche nelle considerazioni sull’unità di luogo costituita dal tempio, dove non solo la protagonista viene attirata, pre-da di un’inquietudine indefinita e perciò più terribile, generata dall’incontro con i fantasmi dell’inconscio, ma «tutti gli altri attori sono costretti d’entrare […] dalla necessità dell’azione»43. E qui sembra proprio che il Conti abbia compreso a pieno, molto prima di Alfieri, la prospettiva verticale del teatro raciniano che mette al centro del dramma un luogo di alto valore simbolico, e si sia anzi preoccupato di imitarlo nel Cesare, come mostra il fatto che la trage-dia si svolge tutta tra l’atrio del palazzo del dittatore e «il Tempio che il Senato eresse alla clemenza di Giulio Cesare», e «niuno de’personaggi entra od esce […] se non tratto dalla necessità dell’azione»44.
Dopo quanto si è detto non stupisce se la disamina critica di Racine e lo zelo appassionato con cui il Conti si dedicò alla traduzione dell’Athalie (giudicata ancora nella prefazione del Cesare «la miglior tragedia che nel secolo di Luigi XIV siasi composta»45) diviene il punto di partenza di quella teoria della grada-zione che il drammaturgo va delineando sulla traccia del Gravina, secondo il quale l’animo dello spettatore deve «concepire a poco a poco la passione», per-
41 Ibid.42 A. Conti, Dissertazione intorno alla Tebaide di Stazio, cit., p. 155. 43 A. Conti, Dissertazione sull’Atalia, cit., p. 108.44 A. Conti, Lettera a Sua Eminenza il Cardinale Bentivoglio, cit., pp. 18-19.45 Ibid., p. 31.
SILVIA CONTARINI22
ché altrimenti, «nello scioglimento del nodo e nella scoperta dell’ultimo even-to affatto inaspettato», egli si ritrova «occupato da improvisa notizia, che non muove l’animo, ma piuttosto l’opprime ed abbaglia», proprio come «avviene all’occhio, quando da lunghe tenebre in un tratto a gran luce è trasportato»46.
L’osservazione del Gravina si legava in origine alla polemica contro la me-raviglia come effetto dell’artificio e del romanzesco ripresa nella Dissertazione sull’Atalia con nuovo vigore, proprio perché da quelle pagine si poteva dedurre l’arte di «graduare» l’azione investigando «la natura e la forza delle passioni»47. Come aveva chiarito lo stesso Conti fin dal 1719 nella Lettre à Madame la Prési-dente Ferrant, «le grand art des arrangements consiste à proposer l’intrigue sans faire trop d’hypothèses, à les resoudre par des combinaisons les moins forcées, et à passer d’une aventure à l’autre par des degrez et des nuances impercepti-bles, augmentant toujours la passion et la tenant toujours en suspens; c’est ainsi que Sophocle a conduit son Œdipe, le Tasse sa Jerusalem, et Racine sa Phèdre, et sa Athalie»48.
Diversamente dal Gravina, interessato come Dubos a riproporre una teoria del verisimile e della finzione teatrale che si traduce in una versione moderna della catarsi, per il Conti la necessità di osservare una sorta di gradatio patetica nella rappresentazione degli affetti dipende da considerazioni di natura filo-sofica e psicologica più profonde derivate dalla lettura di Wolff, l’inventore di quei «sillogismi taciti» che simboleggiano la progressione graduale della cono-scenza dalle prime impressioni oscure alla luce della ragione49. Un percorso, delineato già in parte nel trattato filosofico Dell’anima umana, nel quale gli af-fetti e le loro implicazioni mantengono un ruolo rilevante accanto alle mani-festazioni razionali, tanto che il discorso sulla tragedia può essere inteso come una sorta di appendice di una più vasta teoria della conoscenza in cui i fantasmi poetici di Racine finiscono per confermare le intuizioni sulle operazioni della coscienza, e Wolff viene per forza a integrare le idee di Cartesio e di Locke. Se infatti, nota il Conti proprio nella Dissertazione sull’Atalia, «la nostra anima non cerca che di ragionare e di passionarsi», ma «ella non ragiona con piacere quando chiaramente non se le somministra l’antecedente onde elle senza fatica ricavar ne possa la conseguenza», né «con piacer si passiona quando tra loro le passioni si confondono, e scambievolmente diminuiscono», ne deriva che nella costruzione della tragedia bisogna «preparare all’anima i ragionamenti e le pas-
46 G. Gravina, Della tragedia, cit., p. 322.47 A. Conti, Dissertazione sull’Atalia, cit., p. 111.48 A. Conti, Lettre à M.me la Présidente Ferrant, cit., p. XC. 49 Su questo punto mi sia consentito rimandare al mio intervento «I sillogismi taciti». Conti tra
Hutcheson e Wolff, di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno Antonio Conti. Uno scienziato nella République des Lettres (Padova, 27 febbraio - 1 marzo 2007).
CONTI E RACINE: LA TRADUZIONE DELL’ATHALIE 23
sioni perché ella da se stessa incamini, sviluppi, e sciolga l’azione rappresentata, e sopra vi distribuisca i gradi della passione corrispondente a moti impressi»50.
Nella raffinata partitura psicologica dell’Athalie, che rappresenta un osserva-torio privilegiato non solo per il teatro, l’arte di «graduare l’azione» viene per così dire completata dal movimento e dal «contrasto» interno ai personaggi, determinati «dai diversi impulsi delle passioni che gli agitano e dai diversi fini che si propongono in conseguenza di quest’impulsi»: un contrasto che «comin-cia, cresce, s’invigorisce, indi scema e si compie», dando forma ai cinque atti della tragedia, del tutto simili nel loro andamento mosso alle «cinque dita della mano che vanno crescendo sin a un certo punto e poscia diminuendo»51. Den-tro questa partitura complessa e sapientemente orchestrata, l’attenzione del Conti si appunta sul terzo atto, che consiste in un momento di attesa emotiva in vista della catastrofe, «una specie d’equilibrio nel quale i consigli, le elezio-ni e gli eventi in guisa si controbilanciano che l’uditore sospeso e agitato non prevede qual de’partiti contrarî sia per prevalere»52. Nel terzo atto dell’Athalie, dunque, «la perturbazione è così accresciuta dalle dimande di Matano e da’ ti-mori di Iosabetta che la sospensione è nel colmo, ma la fiducia che Ioadde mo-strava d’avere in Dio e i segni evidenti dell’assistenza promessa, espressa nella profezia, controbilanciano in guisa il pericolo, che l’azione resta in equilibrio e perciò l’uditore è nel più alto grado di sospensione»53. Ma anche il Cesare, già più volte chiamato in causa, sembra risentire di questo schema, se è vero che nel terzo atto «accrescono i sospetti, che hanno i Congiurati di essere scoperti, e la perturbazione dell’azione è ridotta al sommo», mentre «nel quarto, ciò che tende a perturbar l’azione è, per così dire, in equilibrio con ciò che la promuo-ve», e nel quinto «si procede per gradi all’effetto dell’azione»54.
Se applicata con coerenza, la teoria della gradazione non riguarda solamen-te la partitura drammatica degli eventi e delle passioni, ma si estende natu-ralmente al sistema composito dei personaggi disposti anch’essi secondo una gerarchia delle passioni, come chiarisce ancora la Lettre à Madame la Présidente Ferrant, che contro gli «excès» della virtù e del vizio predica la necessità di at-tribuire a ciascuno dei personaggi «un degré diffent» degli affetti, per ottenere alla fine «beaucoup de varieté dans leurs caracteres et un accord admirable dans le tout ensemble»55. Ancora più chiaramente si esprimeva la Risposta al Martello che accompagna la princeps del Cesare, chiamando in causa l’analogia
50 A. Conti, Dissertazione sull’Atalia, cit., pp. 109-110.51 Ibid., p, 110.52 Ibid.53 Ibid., p, 112.54 A. Conti, Lettera a Sua Eminenza il Cardinale Bentivoglio, cit., pp. 16-17.55 A. Conti, Lettre à M.me la Présidente Ferrant, cit., p. XCI.
SILVIA CONTARINI24
con la pittura cara a Dubos:
In ogni quadro vi è una figura principale, che si colloca e colorisce in maniera che in essa, come nel centro del quadro, terminano gli sguardi degli spettatori. Nella trage-dia parimente vi è un carattere, che si mostra e colorisce più degli altri; e questo dà il nome alla tragedia. Tutti gli altri caratteri da questo dipendono; e l’artificio del poeta è di riferirveli, sebbene vi sono opposti […]. Su le dipendenze da’ caratteri si fonda la loro gradazione. La gradazione de’ colori dipende dall’intelligenza delle loro com-missure, e de’ passaggi della luce, e dell’ombre; e la gradazione de’ caratteri dipende dall’intelligenza de’ gradi delle passioni, delle virtù, de’ vizi, de’ temperamenti56.
Il modello concreto di un principio teorico che, sulla scia delle Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, rimarrà valido almeno fino a quando l’Al-fieri non deciderà di eliminare le «sfumature» dei personaggi minori per con-centrarsi tutto sulle «diverse tinte» che si trovano «per semplice forza di na-tura in ciascuno dei personaggi presi in se stessi, stante la diversità dei gradi di passione»57, si trova ancora una volta in Racine. Qui infatti il contrasto tra i due «caratteri dominanti» di Athalie e Joad appare costante e immutabile («perpetuo»), mentre i caratteri dei due personaggi «satelliti», Abner e Ma-than, «digraduano a meraviglia», anche se la scelleratezza esplicita di Mathan può risultare poco credibile a chi ha già in mente l’esempio shakespeariano di Jago, e concorda con il Gravina sulla necessità di dipingere le passioni evitando «l’estremo punto della virtù» come «l’eccesso del vizio»58. L’argomentazione del critico va riportata per intero, se non altro perché torna utile per quello studio minuzioso dei caratteri che è la Prefazione al Druso, dove i «principali li-neamenti» dell’animo di Tiberio non vengono dichiarati, ma devono trasparire dalle parole «oscure, ed ambigue» e dai sentimenti «incerti ed impenetrabili»:
La tessitura del carattere di Abnero è da preferirsi a quella di Matano. Abnero parla poco, ma le azioni sue più che le sue parole discuoprono qual sia la sua fedeltà, la sua religione e la sua sincerità; all’incontro parla molto Matano, ma ne’ suoi discorsi più apparisce l’artifizio del poeta che la imitazione del carattere imitato. Mi pare ancora che Matano si manifesti troppo malvagio al suo confidente, ciò che non è molto verisi-mile, vedendosi per lo più che i maggiori scellerati nascondono sotto onorati pretesti le loro malvagità e le abbelliscono quando ne parlano a’ loro confidenti. L’esposizione della malvagità di Matano non è pur degna di molta lode, poiché il poeta per farla en-
56 A. Conti, Risposta al Signore Jacopo Martelli, in Id., Il Cesare, cit., p. 72.57 V. Alfieri, Invenzione, in Id., Parere sulla tragedie e altre prose critiche, a c. di M. Pagliai, Asti,
Casa d Alfieri, 1978, p. 147.58 G. Gravina, Della ragion poetica, cit., p. 206. Ma sul medesimo punto si era espresso il Conti
nella Lettre à M.me la Présidente Ferrant, cit., p. XCI.
CONTI E RACINE: LA TRADUZIONE DELL’ATHALIE 25
trare nella tragedia è stato obbligato d’introdurvi un confidente che nulla opera e di cui tutto l’uffizio è semplicemente d’udire in quella occasione ciò che da molto tempo dovea sapere, se era amico così intrinseco di Matano come si suppone. Ben è vero che il poeta ha posto tutto lo studio nell’ornare questo episodio, che egli ha introdotto sia per riempire la scena lasciata vuota dalle preghiere di Iosabetta, sia per porre in maggior contrasto l’idee e gli affetti di Matano con quelli del Sommo Sacerdote, ma quando questi parla lo fa per la necessità dell’azione, laddove Matano non parla al suo confidente che per l’artifizio del poeta59.
Naturalezza e «artifizio» sono due termini ricorrenti anche nella scelta del metro, che vede il traduttore schierato con il Gravina e il Maffei nella difesa dell’endecasillabo tragico «non rimato», distinto dall’epico per «il modo delle spezzature e il giro de’periodi»60 proprio dello stile sublime, come teorizzava da subito la Lettre à Madame Ferrant 61. Infatti, più di quanto avviene nell’alessan-drino francese, qui «la varietà delle cesure» e «l’intreccio suo co’ versi seguenti sostengono e diversificano il periodo», rendendolo «tanto più atto al dialogo quanto più che il verso, potendosi rompere in qualsivoglia sillaba, introduce nel dir legato la libertà del dir sciolto»62. Il rifiuto della rima, che a dire del Con-ti «fa spesso violenza all’espression dell’idea, snerva l’armonia e non conviene al dialogo»63, trova la sua giustificazione nel Gravina, secondo cui occorre limi-tarla «ai soli cori delle nostre tragedie» perché «il coro parla con riflessione e medita» e «più figuratamente cantando, usa il suo artificio, in modo che i greci tragici diedero al coro lingua tragica ed artificiosa»64. Sempre in virtù di quel criterio di verosimiglianza psicologica che ha tanta parte nella riflessione sulla tragedia del primo Settecento, la rima andrà poi eliminata del tutto nelle scene «ove i personaggi parlano all’improviso e sono agitati dalle passioni, le quali ogni riflessione lor tolgono», poiché in questo caso «la diversa natura degli affetti» che dà forma al patetico va resa attraverso la «diversità del numero»65.
La questione dibattuta del metro introduce il lettore nel tessuto vivo della traduzione, con il problema delle scelte stilistiche e lessicali. Nella chiusa del saggio critico su Racine, il Conti riassume i criteri seguiti nella sua opera di adattamento del testo francese riecheggiando, con una sorta di abile mimeti-
59 A. Conti, Dissertazione sull’Atalia, cit., pp. 114-115. 60 Ibid., p. 119.61 Cfr. A. Conti, Lettre à Madame la Présidente Ferrant, cit., pp. LXXXVI. Ma sulla questione
dell’endecasillabo tragico fra Gravina, Martelli e Maffei, si rinvia all’analisi esaustiva di R. Rab-boni, Sul verso tragico di Antonio Conti, cit., in particolare pp. 162-172.
62 A. Conti, Dissertazione sull’Atalia, cit., p. 119. 63 Ibid.64 G. Gravina, Della tragedia, cit., p. 551.65 Ibid., pp. 551-552.
SILVIA CONTARINI26
smo, le parole dell’Huet nelle pagine introduttive all’Iliade del Salvini, appar-sa a Firenze nel 1723: «Io sono stato religioso nell’esporre i concetti, fedele nel rappresentare l’espressioni delle parole, e il giro delle figure nell’origi-nale, diligente e sollecito nel prendere l’aria e il carattere dell’Autore»66. A uno sguardo più ravvicinato, però, appare subito evidente che la fedeltà al testo raciniano riguarda soprattutto la rappresentazione degli affetti, dove lo sforzo sincero di riprodurre il movimento delle passioni nel progredire dell’azione tragica fa sì che la pagina del Conti tenda a modellarsi compiuta-mente sull’originale. Viceversa, sul piano concreto delle scelte espressive, la versione italiana dell’Athalie sembra dar ragione al Martello che aveva riven-dicato, nelle traduzioni delle «tragedie franzesi», la necessità di non rende-re «fedelmente parola per parola, frase per frase, ma al più sentimento per sentimento, di maniera che trasportate con la forza prestata loro da questa lingua, compariscano in quello stesso splendore nel quale su’ loro originali si veggono»67. E non importa poi che il Conti non segua fino in fondo il Mar-tello quando, nella brillante apologia della lingua italiana e delle sue forme «capaci di qualsivoglia più grave ed affettuosa espressione», suggerisce con di-sinvoltura l’aggiunta di «sentimenti e scene anche intere» per meglio giovare «all’azione, all’affetto, al costume»68. Rimane il fatto che i luoghi in cui il tra-duttore si discosta dall’originale andranno esaminati con cura, perché nelle operazioni del testo si celano spesso indicazioni poetiche e stilistiche precise che illuminano il percorso parallelo dell’autore tragico, e si riverberano sulla sua concezione del teatro.
Rispetto al ritmo dell’alessandrino francese, specchio di quella razionalità su cui si sarebbe soffermato più tardi Diderot, l’endecasillabo del Conti si misu-ra con le inversioni e l’uso costante degli enjambements che mirano a trasferire nella pratica le convinzioni espresse nella Risposta al Martello, secondo le quali «la passione parla con voci interrotte, e nelle sentenze tacite od espresse non si bada alle loro legature»69. Un rapido confronto di alcuni versi tratti dalla prima scena dell’atto primo è sufficiente a chiarire il procedimento:
66 Ibid., p. 119. Nella Prefazione all’Iliade d’Omero tradotta dall’originale greco in versi sciolti (Fi-renze, Gio. Gaetano Tartini e Santi Franchi, 1723), la citazione tradotta dell’Huet suona così: «tre cose ricerca nell’ottimo traduttore: nell’esprimere i concetti, religione; nel rappresentare l’espressione delle parole, fedeltà; nel pigliare l’aria e ’l carattere dello scrittore, diligenza e sollecitudine» (p. II).
67 P.J. Martello, Del verso tragico (1709), in Id., Scritti critici e teorici, a c. di H.S. Noce, Roma-Bari, Laterza, 1963, p. 152.
68 Ibid.69 A. Conti, Risposta al Signore Jacopo Martelli, cit., p. 68.
CONTI E RACINE: LA TRADUZIONE DELL’ATHALIE 27
ABNER ABNERODès longtems elle haït cette fermeté rare Lungo tempo è, Signor, ch’ella detestaQui rehausse en Joad l’éclat de la tiare. Quella rara costanza onde tu accresciDès longtems votre amour pour la Religion A la Tiara il lustro; è lungo tempo Est traité de revolte et de sedition. Che di sedizion tratta il tuo zelo. (...) (...)Mathan d’ailleurs, Mathan, ce Prestre sacrilege Matan v’aggiungi il Sacerdote iniquo, Plus méchant qu’Athalie, à toute heure l’assiege; De’ nostri Altari disertore infame, Mathan de nos autels infame deserteur, D’ogni virtù persecutore ardente, Et de toute vertu zelé persecuteur. Che peggior d’Atalia l’assedia ognora.(...) (…)Enfin depuis deux jours la superbe Athalie, Che più? Due giorni son che la superbaDans un sombre chagrin paroist ensevelie. Atalia par sepolta in gran tristezza.Je l’observoit hier, et je voyois ses yeux Mente jeri io vi posi e la vedeaLancer sur le Lieu saint des regards furieux, Lanciar sul Santo luogo orridi sguardi,Comme si dans le fond de ce vaste édifice Come se in fondo a l’edifizio vastoDieu cachoit un Vengeur armé pour son Avesse Iddio segretamente ascoso supplice. Vendicator per castigarla armato.
IOAD JOADDEPrès de ce champ fatal Jézabel immolée, Presso al campo fatal sacrificataSous les pieds des chevaux cette Reine foulée; Jezabele, da l’ugne de’cavalliDans son sang inhumain les chiens desalterez, Pesta; sbranato lo schifoso corpoEt de son corps hydeux les membres déchirez E del sangue inuman sazj i mastini 70.
In casi come questi la spezzatura del verso, il chiasmo e l’impiego delle fi-gure di ordine creano effetti quasi alfieriani, anche se in generale il Conti ri-corre con parsimonia all’iperbato, privilegiato più tardi all’autore della Mirra sulla scorta dello pseudo-Demetrio, e in ogni caso l’uso dell’inversione appare sempre temperato dalla necessità di «fuggire le durezze e l’oscurità»71. Tut-tavia, poiché l’Alfieri è stato evocato, vale forse la pena di segnalare che la presenza della metafora biblica della pianta compare, prima che nella scena notissima del Saul, nella riscrittura del Conti, dove «l’arbre seché jusques dans ses racines» del francese diviene «la pianta inaridita, e svelta da le radici». Più che per filiazione diretta, la coincidenza si spiega con l’archetipo del libro sa-cro che unisce due autori di fatto distanti: ma nello stesso tempo non si può fare a meno di osservare che a volte lo spirito del traduttore penetra a fondo nell’originale fino a colmarne le valenze nascoste, come mostra anche, in un
70 Si cita rispettivamente da J. Racine, Athalie, Paris, chez Denys Thierry, 1691, e da A. Conti, Atalia, ora in Id., Versioni poetiche, cit.
71 Cfr. A. Conti, Dissertazione sull’Atalia, cit., p. 119 e Prefazione al Cesare, cit., p.28.
SILVIA CONTARINI28
altro luogo, il ricorso ripetuto all’anafora, frequente in Racine come parte del linguaggio biblico, che però il Conti estende e amplifica con accenti che prefi-gurano quasi il Manzoni:
JOAD JOADDEEt comptez-vous pour rien Dieu qui combat Né badi al Dio che pugnerà per noi? pour nous? A quel Dio che de l’orfano proteggeDieu, qui de l’orphelin protege l’innocence, L’innocenza? A quel Dio che manifestaEt fait dans la faiblesse éclater sa puissance Ne le nostre fiacchezze il suo potere?
Talvolta la ricerca dell’effetto patetico da parte del Conti giunge a modifi-care i tempi verbali optando per un presente che mette quasi sotto gli occhi dello spettatore lo spettacolo vivo degli avvenimenti narrati, come nel caso del racconto turbato di Josabet nella scena seconda del primo atto, che muove dalla visione dell’«implacabile Atalia col pugnale a la mano» («Parmi anco di veder la sbigottita Nudrice / opporsi a’ manigoldi indarno, / E debil tener lui cascante in seno. / Insanguinato tra le braccia il prendo, / E co’ miei pianti il viso suo bagnando, / A poco a poco lo ravvivo»). Lo sforzo di restituire tutte le sfuma-ture emotive del testo spiega anche il ricorso all’aggettivazione che amplifica il dettato raciniano, come mostrano i versi seguenti tratti sempre dal primo atto:
IOSABET JOSABETTAMême de mon amour craignant la violence, Anzi temendo che co’ miei singhiozziAutant que je le puis, j’évite sa presence, La violenza de’ commossi affettiDe peur qu’en le voyant, quelque trouble Altrui non disvelasse il gran secreto, indiscret Schivai quanto potei l’amato pegnoNe fasse avec mes pleurs échaper mon secret.
Il procedimento riguarda in particolare lo spazio mediato della narrazione, dove, in osservanza del dettato graviniano che vieta la rappresentazione diretta, si concentrano gli eventi di maggiore consistenza emotiva, in una sorta di cli-max patetica che produce risultati inattesi. Nel racconto della prima comparsa di Athalie all’inizio del secondo atto, per esempio, non si può fare a meno di notare, pensando a quanto avverrà poi con l’Alfieri, che la «cieca notte» senza fine in cui il personaggio si trova immerso rende assai meglio dell’originale la solitudine inconscia di quelle tenebre interiori di cui farà esperienza più tardi, sulla falsariga di Racine, l’Innominato manzoniano:
ATHALIE ATALIAJe jouissois en paix du fruit de ma sagesse. Godea di mia prudenza il frutto in pace,Mais un trouble importun vient depuis Ma importuno timor da qualche giorno quelques jours
CONTI E RACINE: LA TRADUZIONE DELL’ATHALIE 29
De mes prosperitez interrompre le cours. Di mie prosperitadi arresta il corso.Un songe (Me devrois-je inquieter d’un songe?) Un sogno (e debbe molestarmi un sogno!) Entretient dans mon coeur un chagrin qui le Cura che mi divora in cor mi nutre, ronge.Je l’évite par tout, par tout il me poursuit. Per tutto il fuggo, e per tutto ei mi segue.C’estoit pendant l’horreur d’une profonde nuit Entro l’orror di cieca notte io vidi.
Anche se non frequentissimi, i procedimenti amplificatori messi in atto dal traduttore sono significativi soprattutto per la loro funzione di svelamento: consentono infatti di sciogliere l’allusività dell’assunto raciniano, mettendo in luce elementi del tessuto narrativo che funzionano come vere e proprie pro-lessi. Così, nella scena seconda del secondo atto, il traduttore trasforma il testo originale sostituendo l’asserzione («certo le apparve») al dubitativo («j’igno-re»), ponendo l’accento sulla «spada folgorante» che nella mente del lettore prefigura il «ferro» con cui nel finale della tragedia viene punito «l’orgoglio» dell’empia regina, messa a tacere per sempre:
ZACHARIE ZACCARIALa Reine alors sur luy jettant un oeil farouche Ver lui vibrando la Reina un guardoPour blasphémer sans doute ouvroit déja la Feroce, apria per bestemmiar la bocca; bouche.S’ignore si de Dieu l’ange se dévoilant, Ma l’Angelo di Dio certo le apparveEst venu luy montrer un glaive étincelant. Con folgorante spada e l’ammutì.
In maniera analoga, nella scena centrale del sogno di Athalie, il traduttore tra-sforma l’originale «desordre» in «orror», anticipando il contenuto della visione:
ATHALIE ATALIADans ce desordre à mes yeux se présente Tra tanto orror s’offre a miei sguardi Un jeune Enfant couvert d’une robbe Fanciul di veste candida coperto, éclatante.Tels qu’on voit des Hébreux les Prestres E qual veggiamo i Sacerdoti Ebrei revestus. Portar nel Tempio. Rinfrancarmi io sentoSa veuë a ranimé mes esprits abattus. A la sua vista gli smarriti spirti.Mais lors que revenant de mon trouble Ma mentre in me tornata il dolce guar- funeste, do,J’admirois sa douceur, son air noble et E l’aria miro nobile, e modesta, modeste, J’ai senti tout à coup un homicide acier, Ferro micidial sento repenteQue le traistre en mon sein a plongé tout Che il traditor tutto m’immerge in seno. entier.
Diverse sono le considerazioni sul lessico. Anzitutto la versione italiana tende
SILVIA CONTARINI30
ad evitare la ripresa ostentata del nome proprio, di derivazione biblica72, tipica di Racine, ricorrendo se mai alla perifrasi. Occorre tuttavia osservare che l’uso indiscriminato dei procedimenti legati alla variatio ha tra le sue conseguenze di attenuare quella «semantica dello stupore» che nell’originale affida a una serie di termini disposti a climax, e solo apparentemente sinonimici (effroi, trouble, crainte, peur, horreur, terreur), la visione abbagliante del sacro in cui «l’émotion coupe la parole»73. Così, per esempio, la traduzione di «sombre chagrin» con il più debole e generico «gran tristezza», o la resa discutibile di sostantivi di alto valore semantico come «trouble» o «effroi», tradotti con «smania» e «timore», «paura» e «spavento», indipendentemente dai gradi del pathos, sembra indica-re una sostanziale incomprensione del reseau lessicale collegato con il sublime biblico recuperato poi dall’Alfieri.
Da un altro punto di vista, probabilmente, i notturni di Racine, domina-ti dall’energia sotterranea dell’inconscio, lasciano una traccia nella scrittura tragica del Conti. Il quarto atto del Cesare, quel quarto atto che nella partitura della tragedia prelude alla catastrofe, si apre con un’immagine che mette in gioco il simbolico di Athalie: il sogno di Calpurnia derivato, tramite il Julius Caesar di Shakespeare, da Svetonio. Rispetto al rapido accenno delle fonti, in cui l’evento ha la forma esteriore del presagio, il testo del Conti indugia sul-la rievocazione visiva, intensamente patetica, del «sogno infausto», collegando una serie di tessere testuali che includono il recupero inatteso del quinto canto dantesco proprio in apertura di dialogo:
Farò come colui che piagne, e dice. La notte trionfal veder mi parve, In cui salisti il Campidoglio al lume, Che portar gli Elefanti in auree faci E mentre ch’io non lungi all’alto cocchio, Ov’eri assiso vagheggiava lieta L’ordine del trionfo, e i volti ignoti, I predati tesori, e delle tante Soggiogate città la sculta imago, All’improvviso s’ammorzar le faci, E ai rai di dubbia luna un campo vidi Di cadaveri sparso: o immensa strage!
72 Cfr. in particolare G. Spillebout, Le vocabulaire biblique dans les tragédies sacrées de Racine, Genève, Droz, 1968, pp. 176 sgg. Ma sull’argomento si vedano anche i rilievi di Ch. Bernet, Le vocabulaire des tragédies de Jean Racine. Analyse statistique, Genève-Paris, Slatkine-Champion, 1983, pp. 193-227.
73 P.A. Tordjman, La stupeur: une cathégorie minimale du sacré dans l’Athalie de Racine, in Il tragico e il sacro, cit., p. 277.
CONTI E RACINE: LA TRADUZIONE DELL’ATHALIE 31
Il cocchio tuo nuota nel sangue, infrange I tronchi busti colle rote e i capi De Senatori antichi [...]74.
Più della suggestione dovuta alle analogie tematiche, qui conta il ricordo del «bizarre assemblage» del sogno di morte di Athalie declinato nella gram-matica simbolica e frammentata dell’inconscio, dove «all’improvviso» la «robe éclatante» della visione iniziale si muta nell’«homicide acier» allo stesso modo in cui, nel Cesare, il disordine delle passioni si impone sull’«ordine del trionfo»: nella vertigine della visione onirica «i tronchi busti» prendono il posto della «sculta imago», e «le auree faci» della «notte trionfal» vengono cancellate dai «rai di dubbia luna» che illuminano il campo devastato di Filippi. In una sor-ta di intensa rivisitazione del patetico, la visione immediatamente successiva della morte dell’eroe rimanda alla notte di sangue che costituisce l’antefatto dell’Athalie, e il ricordo dei corpi dei «trucidati prenci», con la vista terribile di Joas «creduto morto», torna ad agire nel tessuto del dramma attraverso il medium della traduzione:
ATALIA IL CESAREIosabetta CalpurniaParmi ancor di veder la sbigottita Tra le braccia ti prendo, e grido, e piango,Nutrice opporsi a’ manigoldi indarno, E col mio velo , e con le chiome asciugoE debil tener lui cascante in seno. Le tue ferite. Tu mi guardi, e taci,Insanguinato tra le braccia il prendo, E a poco a poco chiudi i lumi, e chiniE co’ miei pianti il viso suo bagnando, Il capo sul mio senoA poco a poco lo ravvivo. [...] Ahimé! Ti veggo ahimé! Ti veggo ancora Insanguinato e morto.
Non solo attraverso l’analisi dello stile tragico e lo studio cartesiano degli af-fetti, dunque, ma forse proprio nella logica ambigua e speculare del sogno l’autore riesce alla fine a cogliere la cifra interiore del teatro di Racine, dove la serie progressiva dei «taciti sillogismi» scopre all’improvviso il «geroglifico delle passioni»75.
74 A. Conti, Il Cesare, cit., pp. 156-57.75 Cfr. A. Conti, Trattato dell’anima umana, in Id., Scritti filosofici, a c. di N. Badaloni, Napoli,
Casa Editrice Fulvio Rossi, 1972, p. 106.

























![La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63188333d93a162f9c0e92a8/la-traduzione-italiana-dellufficio-liturgico-ortodosso-slavonico-soc-162-2012.jpg)