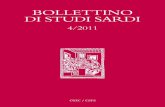Toska-Angoisse-Πόνος βαθύς. A proposito di una traduzione di Alèxandros Papadiamantis
La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]
Transcript of La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]
ACCADEMIA ANGELICA-COSTANTINIANADI LETTERE ARTI E SCIENZE
Studisull’Oriente Cristiano
Estratto
16 2 Roma 2012
La traduzione italiana dell’ufficio liturgico ortodosso slavonico
Valerio Polidori
71
LATRADUZIONE ITALIANADELL’UFFICIOLITURGICO SLAVONICO
V P
Introduzione
Sebbene la Chiesa Ortodossa russa, a cagione delle vicissitudini storiche chene determinarono una diffusione vasta ma geograficamente disomogenea1, vantiuna consistente tradizione di versioni vernacolari nelle sue ufficiature liturgiche,è proprio in Italia dove si registrano le maggiori difficoltà nel far venire alla luceun testo ufficiale approvato per l’uso ecclesiastico e che goda di un vasto consensopresso il clero ed i fedeli2.
Non è un mistero che le ragioni di queste difficoltà risiedano eminentemen-te nella delicata questione del proselitismo (vero o presunto che sia) nei rapporticon la Santa Sede. In altre parole, pur di non dare l’idea di condurre attività diproselitismo in Italia, la Chiesa russa di fatto tende a rinunciare all’uso della lin-gua locale, con la naturale conseguenza, tuttavia, di escludere dalla comprensionedella liturgia le seconde generazioni dei propri fedeli e ridurre conseguentementela partecipazione liturgica a un fatto squisitamente etnico.
1Aparte il territorio della storicaRus’, il rito russo è praticato amacchia di leopardo in Europa sianei paesi nell’orbita culturale del fu impero sovietico, sia in quelli della diaspora dopo la rivoluzionedel 1917. Fuori dal vecchio continente il rito russo è celebrato (anche in inglese) soprattutto negliStati Uniti, in Canada e in Australia. Cf. D, H.-D. Le Chiese Ortodosse. Nascita, storia ediffusione delle Chiese Ortodosse nel mondo. Genova: ECIG, 2003, pp. 69-93. Sulla questione dellelingue liturgiche si veda pure M, E. La Chiesa Ortodossa. Storia, disciplina, culto. Bologna:ESD, 1996, pp. 115-119.
2Ad oggi gli unici testi che abbiano una qualche circolazione sono: A, M. B. Antholo-ghion di tutto l’anno. Voll. 1-4. Roma: Lipa, 2000, un’antologia innografica condotta dai testi greci,e L, A.Compendio Liturgico Ortodosso. Rimini: Il Cerchio, 1990, traduzione italiana dei prin-cipali uffici liturgici condotta in maniera amatoriale e prevedibilmente costellata di errori di ognigenere. Altre versioni, come quella curata da Timotheos Moschopulos e Piero Scazzoso [Milano :Istituto di StudiTeologiciOrtodossi S.Gregorio Palamas, 1969] sono pressoché introvabili. Per unapanoramica sulla cultura ortodossa e l’attività di traduzione in Italia nella seconda metà del secoloscorso si veda pure C, A. Il cristianesimo orientale e noi: la cultura ortodossa in Italia dopoil 1945. Già e non ancora 452. Milano: Jaca Book, 2008
1
LA TRADUZIONE ITALIANA DELL’UFFICIOLITURGICO SLAVONICO
72
A complicare questo quadro di base c’è da un lato la mancanza di una in-telligencija ortodossa italiana che possa in qualche modo orientare le scelte dellaDiocesi, dall’altra una certa anarchia in cui versa il territorio canonico3, troppovasto per un solo vescovo che risiede a centinaia di chilometri di distanza4.
Nonostante tali premesse, alla fine del 2007 l’allora Diocesi del Chersonesodel Patriarcato di Mosca ha preso atto del problema della lingua liturgica5 e il 20giugno 2009 ha finalmente costituito in maniera formale una commissione inter-nazionale6 per la traduzione in italiano dei testi liturgici con la finalità di portarealle stampe in tempi brevi almeno la Liturgia di san Giovanni Crisostomo e quel-la di san Basilio Magno, che rappresentano i testi più frequentemente utilizzatinell’ufficio divino.
Il problemametodologico
Il testo finale prodotto dallaCommissione per la prima volta in Italia affrontail problemametodologicodella traduzionedi un testo liturgicoortodosso.uestopone al traduttore, com’ è noto7, problemi del tutto particolari, che nella fattispe-
3Sebbene in tempi recenti l’Italia sia stata scorporata dalla diocesi del Chersoneso (che compren-de attualmente Francia, Spagna, Portogallo e Svizzera), ed eretta ad Amministrazione, essa è stataaffidata pro tempore al medesimo vescovo, sicché l’azione episcopale nella penisola è estremamentelenta e così rimarrà sino alla nomina di un vescovo titolare per l’Italia.
4La sede dell’attuale vescovo Nestor, come già del predecessore Innokentij è a Parigi.5P, V. “Nuove sfide in Occidente per la Chiesa Ortodossa Russa”. In: L’Osservatore
Romano (8.11.2007), p. 6.6uesta era formata dall’Igumeno Andrew Wade (co-presidente), linguista e liturgista, che ha
redatto la prima versione italiana dal textus receptus slavonico; lo scrivente che ne ha curato la revi-sione italiana chiarendo altresì i punti oscuri a partire dal postulato originale greco; l’ArchimandritaAmbrogio Makàr che ha operato un’ulteriore revisione, l’arciprete Antonio Lotti (co-presidentedella commissione) e il prof. Giovanni Guaita dell’Università linguistica di Stato di Mosca. Il testofinale è stato infine sottoposto a un giudizio esterno da parte dei proff. Stefano Parenti ed ElenaVelkovska.
7Per i problemi filologici tipici del testo liturgico si veda, ad es. N, A. “Alcuni criterimetodologici per lo studio dei testi liturgici”. In: Medioeo greco 0 (2000), pp. 143–179. In Italia,dopo il Concilio Vaticano II, si è dovuto attendere quasi 40 anni affinché emergesse un testo dilinee-guida per la traduzione dei testi liturgici, rappresentato dall’istruzione Liturgiam authenti-cam, la quinta istruzione che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramentiha promulgato, il 28 marzo 2001, per la retta applicazione della Costituzione Sacrosanctum Con-cilium. Sebbene, infine, nel panorama scientifico nazionale esista un certo dibattito sul metodo ditraduzionedei testi liturgici, ad es.T,R. “TranslatingLiturgically”. In:Logos39 (1998), pp. 155–184; V, G. “Tradurre un testo liturgico per l’oggi”. In: Rivista Liturgica 2 (2005), pp. 148–171; B,M. “IlMartirologio Romano: criteri per la traduzione”. In:Rivista Liturgica 1 (2005),pp. 111–128, l’unico lavoro che interessi il testo della Liturgia di Crisostomo è a mia conoscenzaP, S. “Riforma liturgica in Italia: la traduzione della Liturgia di s. Giovanni Crisostomo”. In:A Oriente e Occidente di Costantinopoli. Temi e problemi liturgici di ieri e di oggi. Libreria Editrice
2
73
cie delle liturgie slave si arricchiscono di ulteriori elementi. La prima difficoltà ènaturalmente legata al testo liturgico, che nonpuò essere inteso comeunprodottoletterario qualsiasi, né come tale destinato alla lettura individuale,ma orientato aduna precisa azione pratica cultuale, entro la quale esso va compreso e contestualiz-zato8; d’altro canto, a causa dell’utilizzo ininterrotto nell’uso della Chiesa il valoredell’integrità filologica del testo ha perso completamente di significato, mentrepassi evidentemente corrotti del textus receptus si sono caricati nei secoli di signi-ficati nuovi, talora estranei al sensus auctoris9. Ancora, la recensione slavonica è asua volta una versione da un non identificato testo greco10, ma per gli stessi moti-vi si deve resistere alla tentazione di emendare il primo traduttore anche quandoquesti manifestamente sia caduto in errore, attenendosi strettamente al testo rice-vuto11.
La seconda difficoltà riguarda la tensione permanente tra l’aderenza stret-ta al textus receptus da un lato, e l’esigenza di scorrevolezza e comprensibilità perun pubblico italofono dall’altra. La costruzione dello slavonico, assai più vicina aquella del greco piuttosto che all’italiano12, la sua tendenza a iniziare i periodi conle congiunzioni, a giustapporre paratatticamente i participi, non agevolano certoil lavoro del traduttore. È dunque fondamentale stabilire un criterio traduttivoche ponga al primo posto l’aderenza al testo originale, introducendo tuttavia nel-la traduzione servile che ne risulta piccoli aggiustamenti ritmici nell’ordine delleparole, trasponendo inmodi finiti i verbi espressi al participio, sostituendo o sop-primendo le particelle coordinative ridondanti.
Vaticana, 2010, pp. 271–303.8G, L.Conferma le parole della nostra fede. Il linguaggio della celebrazione. Roma:C.L.V.-
Edizioni Liturgiche, 1997, pp. 68-69.9Problema del tutto analogo è nella versione dei testi biblici, P, V. “Il Textus Receptus
nella tradizione slava. Attualità e problemi”. In: Bibbia e Oriente 244 (2010), pp. 107–115.10La questione sulle fonti del testo crisostomiano slavo è lontana dall’essere chiusa. uale che
sia la forma dell’Urtext greco, la versione slavonica subì nei secoli un lungo processo redazionale delquale siamo solo parzialmente informati (le recensioni più note sono quelle delMetropolitaKipriandel XIV secolo e quella di Nikon del XVII secolo). Lo studio principale sul tema rimane ancora ilclassico P, A. “Histoire de la rédaction slave de la Liturgie de St Jean Chrysostome”. In:ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΑ : Studi e riserche intorno a S.GiovanniCrisostomo a cura del comitato per il XV ◦
centenario della sua morte. Roma, 1908, pp. 859–928.11Il testo di riferimento utilizzati dalla Commissione è lo служебник, Roma: 1956, ristampa del-
l’edizione di Kiev del 1900; Mosca, ediz. Patriarcato di Mosca: 1977; Mosca, ediz. Sretenskij Mo-nast.: 1999;Mosca, ediz. Patriarcato diMosca: 2004.Un richiamo alla tensione tra l’attenzione allefonti e il rispetto del textus receptus è presente anche in Lit. Auth. 23.
12L’antico slavo ecclesiastico è una lingua artificiale la cui sintassi è calcata fortemente sul greco,L,H.G.OldChurh Slaonic grammar.Berlin -NewYork:DeGruyter, 20017, 15-16; 156,166-167 e passim.
3
74
Altri punti di interesse riguardano, ad esempio, la scelta lessicale, come la pre-ferenza di un registro linguistico ”alto” (sempre nei limiti della comprensibilità aun uditorio di normali fedeli italofoni) a scapito di lessemi - specialmente verbi- generici e di utilizzo quotidiano (ad es. ”fare”, ”andare”, ”dire” )13: così nel Sal118,73 è preferibile «Le tue mani mi hanno plasmato» a «mi hanno fatto», ecosì via. Analogamente è preferibile evitare l’utilizzo di lessemi italiani che abbia-no significati alternativi e che possano ingenerare confusione: caso emblematicoè nell’espressione «le loro mani sono piene di corruzione» (il cui termine nonindica la putrefazione ma piuttosto l’atto di corrompere con doni o denaro persovvertire la giustizia) risolvibile in «mani piene di sovversione»; lo stesso prin-cipio può essere applicato anche a costo di creare dei neologismi: così per ”pro-scomidia” invece di ”protesi” e ”ripidio” in luogo di ”flabello”14.
Cura non minore va profusa nell’evitare espressioni desuete o di difficile in-telligibilità per il popolo, ricorrendo talora all’equivalenza dinamica15: ad es., inve-ce di «archistratega degli incorporei» può essere preferibile «condottiero supre-mo delle schiere incorporee», ovvero invece del più grammaticalmente corretto”Deìpara”, o ”Genitrice di Dio”, si può optare per la semplificazione – comune-mente accettata anche in tutti testi patristici italiani – ”Madre di Dio”16.
Per la compresenza di diversi princìpi, in alcuni casi può non essere agevoleo addirittura possibile approdare ad una soluzione che li soddisfi tutti: emblema-tico il caso della dossologia «Poiché tuo è il dominio, e tuo è il regno e la potenzae la gloria, del Padre e del Figlio e del Santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli deisecoli», in cui è impossibile stabilire una concordanza diversa da quella ad sensum(come del resto nel testo originale) senza perdere totalmente il ritmo della frase.Medesimo problema nella formula «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,l’amore di Dio Padre e la comunione del Santo Spirito sia con tutti voi» il ver-
13All’uso di un linguaggio facilmente comprensibile ma che preservi la dignità, bellezza e preci-sione dottrinale del testo originale richiamanoLit. Auth. 25; , Instr.Varietates legitimae, n. 53: AAS87 (1995) 308.
14”Flabello” è il nome tradizionalmente attribuito all’analogo strumento egizio, ben diverso dalventaglio liturgico bizantino che aveva la finalità pratica di tenere lontano gli insetti dal calice, T,R.AHistory of the Liturgy of St. John Chrysostom. Vol.II:eGreat Entrance. Orientalia ChristianaAnalecta 200. Pontificio Istituto Orientale, 2004 (1975), 208-9, nota 104.
15Che il ricorso sistematico all’equivalenza formale sia ritenuto ormai insensato oltre che tecnica-mente impossibile è un dato ormai acquisito nella scienza della traduzione, cf G, E.Teoriedella traduzione. Torino: UTET, 1998, 109 e passim.
16A titolo meramente esemplificativo si possono citare illustri manuali che riferiscono della con-troversia nestoriana sul termineΘεοτόκος rendendolo ”Madre di Dio”: S, P. Il camminodi Cristo nell’Impero romano. Bari: Laterza, 2004, p. 285; P, A. Introduzione al cristiane-simo antico. San Donato Milanese: Biblioteca Universale Laterza, 20047, p. 219; O,G. Storia dell’impero bizantino. Torino: Einaudi, 1993, p. 51.
4
75
bo al singolare concordato ad sensum, in qualche modo richiesto da motivazioniteologico-liturgiche per sottolineare l’unità nella Trinità, è manifestamente scor-retto dal punto di vista filologico. In qualche caso è possibile sacrificare la perfettapunteggiatura a favore del ritmo dell’azione liturgica (che impone le pause in re-lazione alle abitudini di canto), come nel caso dell’altra formula conclusiva «Perlamagnanimità del Figlio tuo unigenito con il quale sei benedetto, insieme al san-tissimo, buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli».
Un caso che illustra la difficoltà di una reductio ad unum di questi princì-pi è la scelta di non tradurre ”Ade” con ”inferi” come sarebbe stato logico, per lasua occorrenza in moltissimi testi che richiedono assolutamente il singolare (ades. «Ade, dov’è la tua vittoria?»); in questo caso, tuttavia, si può passare ad unagrafia minuscola per sottolineare la nuova semantica ebrea e cristiana rispetto aquella tradizionale pagana.
Come si può vedere anche solo da questi brevi esempi, è possibile ottenereuna versione equilibrata e coerente nel suo insieme senza fare violenza al testoricevuto, ovvero, nella peggiore delle ipotesi, limitandosi a piccoli interventi deltutto marginali.
I criteri traduttivi
A valle di queste considerazioni, la Commissione ha prodotto delle linee-guida per stabilire una gerarchia tra i princìpi che hanno guidato l’opera di tradu-zione affinché, nei casi in cui due o più criteri confliggessero fra loro, fosse pos-sibile risolvere il problema sacrificando quello meno importante, almeno comeprincipio generale17. Si sono così individuati un criterio-guida di base, sei criterimaggiori e cinque criteri minori, riassunti nello schema seguente:
• Ermeneutica: Ancor prima di accingersi al lavoro vero e proprio di tradu-zione, occorre afferrare il cd. sensus auctoris, cioè le intenzioni del testo nellasua recensione originale; quindi l’evoluzione di questo senso nell’evoluzio-ne storica del testo e nelle sue antiche versioni e, infine, la sua percezioneattuale, a valle di secoli di stratificazioni testuali e, inevitabilmente, di cor-ruzioni. uesto risulta tanto più necessario perché se si astrae il testo dallapluristratificazione che ce lo ha consegnato, si opera a priori una scelta in-terpretativa che ipso facto ne annulla ogni possibile altra. La ancora non per-fetta conoscenza della storia della tradizione della Vorlage slavonica rispet-to al suo antitipo greco costituisce inoltre un ulteriore motivo di pruden-
17Un salutare rimando alla realtà secondo cui non è sufficiente fissare e seguire criteri solidi mache occorra altresì superare l’ostacolo dell’ideologizzazione che spesso ruota intorno ai testi liturgiciè presente in T, “Translating Liturgically”, cit.
5
76
za che suggerisce, nel dubbio, di attenersi il più possibile a quanto il testodice, senza proporre interpretazioni, integrazioni od omissioni. A questoprincipio-guida, da considerarsi la chiave di volta della traduzione di ognitesto liturgico antico, si debbono idealmente uniformare tutti gli altri criteritraduttivi.
• A - Aderenza testuale: L’aderenza alla sintassi originale e l’applicazione perquanto possibile dell’equivalenza formale sono necessità tipiche della tra-duzione di un testo liturgico, ciò anche quando il testo di partenza appaiaoscuro18. uesto è tanto più necessario quanto si vuole evitare di livellare ilsenso del testo alla sua percezione attuale. Pertanto, ogni rimaneggiamentoreso necessario da esigenze eufoniche o di intelligibilità, deve tener contodell’assetto testuale primitivo e rispettarlo quanto più possibile.
– A1 -Ordine della costruzione. Sebbene sia il greco che lo slavonico pre-sentino spesso il periodo in una forma difficilmente riproducibile initaliano, in alcuni casi è possibile mantenere almeno l’ordine originaledelle parole, quando questo non contrasti con gli altri criterimaggiori.uando ciò è possibile, è altamente auspicabile farlo.
• B - Intelligibilità: Scopo del testo è la partecipazione alla preghiera da par-te di un’assemblea, donde sono da evitare forme desuete e arcaizzanti, cosìcome costruzioni con periodi eccessivamente lunghi o con esagerato usodella subordinazione. Per lo stile eucologico del periodo medio-bizantino,è ovvio che tale criterio entri facilmente in conflitto con quello dell’aderen-za testuale, per cui si dovrà usare una grande cautela nel risolvere i problemicaso per caso.
– B1 - Spettro semantico. È opportuno evitare parole o calchi lingui-stici che in italiano presentino una semantica completamente diver-sa da quella originale e che possa dar luogo a confusione nell’uditore,ad es. ”mondanità”, che nell’uso liturgico è intesa come ”cose terrene”ma che può essere percepita come ”eventi mondani”, o il calco ”prote-si”, cioè i riti preparatori della liturgia (”proscomidia” nell’uso russo),che ha tutt’altro significato in contesto extra-liturgico19. Ciò vale an-che per alcune locuzioni, ad es. quella che letteralmente suonerebbe
18Che la traduzione non debba diventare ”un luogo di innovazione creativa” è ben illustrato daLit. Auth. 20.22; cf. la Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, 21 giugno 1967:Notitiae3 (1967) 296; Card. Segr. di Stato, Lettera al Pro-Prefetto della Congregazione per il Culto Divinoe la Disciplina dei Sacramenti, 1 Febbraio 1997.
19Un richiamo a evitare l’ambiguità nella scelta lessicale è anche in Lit. Auth. 32
6
77
”le ignoranze del popolo” (gr. τὰ ἀγνοήματα τοῦ λαοῦ)20 che si puòrendere invece ”gli errori del popolo inconsapevole”, facendo ricorsoall’equivalenza dinamica.
– B2 - Uso dei neologismi. Come principio generale, dovrebbero essereevitati, quando ciò è possibile21. Eccezione a questo principio è sen-z’altro il vocabolario tecnico (ad es. relativo all’arredo liturgico, i pa-ramenti, etc.), che va spesso forgiato ex noo in quanto in larga parteinesistente nell’italiano moderno.
– B3 -Registro espressio. È da preferire uno stile e un lessico ”alto”, o checomunque tenga conto della natura poetica di buona parte dei testiliturgici, operando però sempre nei limiti imposti dal criterio generaleB ed evitando di scadere in barocchismi o esagerati lirismi22.
• C - Eufonia. Ogni testo liturgico, compreso quello delle preghiere silen-ziose, dovrebbe essere comunque adatto alla lettura ad alta voce e, possibil-mente, al canto23. Allitterazioni, iati, o fenomeni fonetici cacofonici sonoperciò da evitare per quanto possibile.
– C1 - ”d” eufonico. Sebbene utilizzato con una certa disinvoltura nellapratica, dovrebbe sussistere unicamente per separare vocali uguali iniato.
20L’espressione ricorre nel formulario Crisostomiano, ad esempio, sia nella prima preghiera deifedeli che nella preghiera dell’oblazione, dopo la deposizione dei divini doni sulla santa mensa.
21Il medesimo principio declinato in maniera simile è in Lit. Auth. 21; cf. Instr., Varietates legiti-mae, n. 53:AAS87 (1995) 308.Tale Istruzione ammette che talora simantengano anche espressionidesuete per mantenere un certo senso di alterità nel registro liturgico, Lit. Auth. 27 e per sottoli-nearne la sua dimensione atemporale, Lit. Auth. 19; Const. Sacrosanctum Concilium, n. 33; Const.Dogm.Dei Verbum, n. 8; cf.Missale Romanum, editio typica tertia: Institutio Generalis, n. 2.
22Che siano da evitare anche tendenze traduttive psicologizzanti è ben espresso da Lit. Auth. 54.23Indipendentemente dai possibili sviluppi nella disciplina del culto riguardo alle preghiere pro-
nunciate sommessamente (μυστικῶς), occorre ricordare la Novella #137 del 26 marzo 565 di Giu-stiniano che punisce i sacerdoti che dicono le preghiere segretamente: Corpus Juris Civilis (Ed.Mommsen), III, pp. 695-699, 1896; cf. B, F. E. Liturgies, Eastern and Western, beingthe texts original or translated of the principal liturgies of the church. Vol. 1: Eastern liturgies. Ox-ford:ClarendonPress, 1896, 533: 19-23. Sulmedesimo tema, si vedano inoltreT,R. “uestionson the Eastern Churches 2: Were Liturgical Prayers Once Recited Aloud?” In: ECJ 8.2 (2001),pp. 107–113; T, R. “Was the eucharistic anaphora recited secretly or aloud? e ancient tradi-tion and what became of it”. In:Worship traditions in Armenia and the neighboring Christian East.A cura di R. R. Irvine. AVANT 3. Crestwood, NY: St Vladimirs Seminary Press, 2006, pp. 15–57; W, G. “Praying the anaphora: aloud or in silence?” In: St Vladimir’s eologi-cal uarterly 512-3 (2007), pp. 179–202 e W, G. Der Ursprung der Chrysostomusliturgie.Liturgiewissenschaliche uellen und Forschungen 59. Münster Westfalen: Aschendorff, 1973,pp. 31-32.
7
78
• D - Ritmo. Una congrua parte di questi testi liturgici si deve prestare alcanto sugli otto toni, con la conseguente divisione in stichi e lembi24. Latraduzione, ove possibile e non in contrasto con gli altri criteri, dovrà tenereconto anche di questo aspetto pratico25.
• E - Punteggiatura. Dove possibile è opportuno rispettare quella del textusreceptus. Tuttavia, in considerazione della instabilità e tardività di questa, èpossibile adottare quella in uso nella lingua corrente, a meno che ciò nonconfligga con i criteri C/D relativamente all’uso negli uffici cantati.
• F - Coerenza interna. Ogni scelta traduttiva deve essere applicata con coe-renza. Ciò vale tanto per le equivalenze formali (evitando per quanto pos-sibile di tradurre la stessa parola in modi differenti), quanto per le sempliciabitudini grafiche (ad es. l’uso delle maiuscole) o sintattiche.
• M1 - Uso delle Maiuscole. Nel corretto italiano (indipendentemente dagliusi tipografici in ambito liturgico) l’uso delle maiuscole deve essere limitatoai nomi propri e a pochi altri utilizzi (nei casi in cui serve per distinguere unnome generico da una situazione particolare, ad es. la Legge, l’Alleanza).
• M2 -Antiche versioni. Di fronte a scelte equivalenti è da preferire quella chepresenta una tradizione d’uso consolidata in una antica versione parallela.Un caso emblematico è la scelta di rispondere alle intenzioni diaconali con”Ascolta, Signore” (Παράσχου, Κύριε nel receptus greco), in luogo di ”con-cedi” (eccessivamente duro per un uditore italofono) o ”da’” (eccessivamen-te vernacolare)26. Una soluzione simile è già percorsa dalla antica versionearaba del formulario crisostomiano.27
24Gli stichi (στίχοι) sono versetti di un salmo o di altri testi biblici. Con ”lembo” invece si intendel’unità nella quale si suddivide il testo di una stichira per il canto sugli otto toni.
25Lit. Auth. 60 richiama questo aspetto sui testi che devono essere cantati.26Entrambe le soluzioni scartate, peraltro, sembrano richiedere un oggetto diretto nelle im-
mediate vicinanze, necessità che mal si concilia con il fatto che questo sia alternativamente ma-schile singolare (angelo di pace), femminile singolare (fine cristiana della nostra vita), maschi-le plurale (il perdono e la remissione) rendendo impraticabile l’ipotesi di far cantare al coro”concedi-lo/concedi-la/concedi-li” a seconda dei casi.
27Il verbo arabo istajib esprime il senso di ’esaudire una richiesta’, donde l’equivalenza semanticacon l’invito ad ascoltare una preghiera, affinché la si abbia esaudita, cf. B, C. “Notions généra-les sur les versions arabes de la Liturgie de S. Jean Chrysostome suivies d’une ancienne version iné-dite”. In: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΑ : Studi e riserche intorno a S. Giovanni Crisostomo a cura del comitatoper il XV ◦ centenario della sua morte. 1908, pp. 405–471.
8
79
• M3 - Ausili di lettura. visto l’uso pubblico di questi testi, sarà necessarioin alcuni casi inserire degli ausili di lettura, quali accenti tonici (si pensi ailettori non italofoni). Per le pause si vedano i criteri D/E.
• M4 - Uso dei participi. È preferibile usare una resa coerente all’interno diuna stessa frase che utilizza una paratassi di participi donde si deve sceglieretra porre tutti i verbi in modi infiniti oppure tutti in modi finiti.
• M5 - Uso corrente in Italia. Diversi testi ortodossi, o almeno molte unitàliturgiche28, sono in uso anche nel rito cattolico, orientale e non, sicché ilpopolo è già avvezzo ad alcune espressioni 29 che è bene utilizzare qualoranon entrino in conflitto con altri principi traduttivi.
Sommario
Seppur con molto ritardo rispetto ad altre aree dell’Occidente, anche in Italiail Patriarcato di Mosca ha iniziato ad affrontare la questione della traduzione ver-nacolare dei suoi testi liturgici. L’articolo espone sinteticamente i criteri traduttivipredisposti dalla Commissione per la traduzione delle Liturgie di Giovanni Criso-stomo e Basilio. Tale riflessione è il primo tentativo di sintesi filologica espresso inItalia in ambito ortodosso e, sperabilmente, aprirà le porte a nuovi approfondimenti.
28Sul concetto di unità liturgica si veda T, R. “e Structural Analysis of the Liturgical Units:An Essay in Methodology”. In:Worship 52 (1978), pp. 314–329.
29Dopo l’introduzione della lingua verancolare, la lingua italiana ha progressivamente costituitoun lessico tecnico liturgico comprensibile ai fedeli. Per una bibliografia sul tema si veda V,G. Elementi di bibliografia linguistico-liturgica con particolare riferimento ai problemi di traduzioneliturgica. Verona: L.E.S., 1977.
9
![Page 1: La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012101/63188333d93a162f9c0e92a8/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012101/63188333d93a162f9c0e92a8/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012101/63188333d93a162f9c0e92a8/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012101/63188333d93a162f9c0e92a8/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012101/63188333d93a162f9c0e92a8/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012101/63188333d93a162f9c0e92a8/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012101/63188333d93a162f9c0e92a8/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012101/63188333d93a162f9c0e92a8/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012101/63188333d93a162f9c0e92a8/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: La traduzione italiana dell'ufficio liturgico ortodosso slavonico [SOC 16.2 (2012)]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012101/63188333d93a162f9c0e92a8/html5/thumbnails/10.jpg)

![[Traduzione di] Georges Bataille, La vittoria militare e la bancarotta della morale che maledice, in Symbolica e theorica. Contributi, a cura di Paolo Gregoretti, Trieste, E.U.T.,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63419e3216b404e89c032a14/traduzione-di-georges-bataille-la-vittoria-militare-e-la-bancarotta-della-morale.jpg)