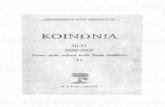(with C. Ricci), « Tradurre il divino : le dediche dei militari traci nella Roma imperiale », in...
Transcript of (with C. Ricci), « Tradurre il divino : le dediche dei militari traci nella Roma imperiale », in...
Bruno Mondadori
RiscrittureLa traduzione nelle arti e nelle lettere
a cura di Gilberto Marconi
Estratto
Tutti i diritti riservati© 2013, Pearson Italia, Milano-Torino
Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzioni grafiche, cartografiche e fotografi-che appartenenti alla proprietà di terzi, inseriti in quest’opera, l’editore è a disposizionedegli aventi diritto non potuti reperire nonché per eventuali non volute omissioni e/o erro-ri di attribuzione nei riferimenti.
È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno didattico, con qualsiasi mezzo, nonautorizzata.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di cia-scun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5,della legge 22 aprile 1941 n. 633.Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commercialeo comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di spe-cifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, e-mail [email protected] e sito web www.aidro.org
Realizzazione editoriale: Gottardo Marcoli
www.brunomondadori.com
Il volume, curato da Gilberto Marconi per l’Associazione culturale Peitho, è statopubblicato con il contributo di: Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali edella Formazione dell’Università degli Studi del Molise, Fondazione Cassa diRisparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana,Rotary Club Jesi, Korg Italia Strumenti musicali, Trillini s.r.l. Centro AssistenzaAutorizzato Toyota, STEP Informatica, Concessionaria Automobili Marco Liera.
ISBN: 9788861598691
20
Tradurre il divino: le dediche dei militari tracinella Roma imperiale
Dan Dana e Cecilia Ricci*
Il modo migliore e più consono per rispondere alla sollecitazione dell’a-mico Gilberto mi era sembrato quello di avviare una riflessione sulla scrit-tura epigrafica, come traduzione scritta della pratica commemorativa. Laconoscenza di Dan Dana e del suo lavoro ha poi dirottato la mia attenzio-ne verso un’altra direzione e un interesse di antica data. Il tema è diven-tato quello della presenza dei Traci nella guarnigione urbana e delle formeassunte dalla loro pietà religiosa.Le attestazioni dei Traci al di fuori della loro terra d’origine sono state
più volte oggetto d’indagine:1 all’interno di questo gruppo etnicamenteconnotato, è stata spesso sottolineata la percentuale considerevole rappre-sentata dai soldati; meno indagati restano invece le forme d’integrazionenel tessuto urbano e nella società di Roma; e il pantheon divino che le lorodediche ci lasciano conoscere. La base d’indagine a disposizione è costi-tuita, quasi esclusivamente, da testimonianze epigrafiche e archeologiche:fonti parziali dunque e numericamente non consistenti.Ci è sembrato allora che la documentazione sulla presenza dei Traci, e in
particolare della componente militare, la più cospicua e significativa, nellacapitale dell’impero, meritasse di essere più attentamente considerata, conun duplice obiettivo: a) dare evidenza, come sinora poco ci pare sia statofatto, al modo specifico trace di “dare un nome” alle divinità, inserendocidunque in un dibattito particolarmente attuale presso la comunità scienti-fica;2 b) considerare in sé la forma scelta o imposta (impossibile appurar-lo) da alcuni soldati della capitale, in un’epoca cronologicamente circo-scritta, di manifestare oltre al proprio atteggiamento religioso anche un’ap-partenenza (al proprio ethnos, al corpo militare o a entrambi).Il modo di nominare gli dèi epicori a Roma da parte dei soldati di ori-
gine trace è un’opera di “traduzione” sotto molteplici punti di vista. Sievidenziano più sequenze di mediazione delle informazioni, che rimanda-no a livelli differenti di significato:Un primo livello è quello linguistico-formulare: nelle dediche di Roma
i Traci usano in prevalenza il latino e adottano gli stessi schemi formulari
21
Tradurre il divino
dei colleghi urbani, mentre, nella regione di provenienza la maggior partedelle dediche è in lingua greca, per una tradizione ellenofona d’anticadata;3 solo una parte minoritaria è in latino, così come avviene in Mesiainferiore e nel territorio della città di Philippi, in Macedonia. Sempre inTracia, le denominazioni divine sono in prevalenza greche e latine, ma gliepiteti sono spesso indigeni e, nella maggior parte dei casi, toponimici; inuna percentuale meno significativa di casi si tratta di epiclesi con valorefunzionale. Incontriamo così appellativi generici, che qualificano lepotenze divine: oltre al frequentissimo Deus/Theos, anche Dominus/Kyrios; o ancora Sanctus/Hagios, e, su un registro più marziale, Invictus.La maggior parte di questi appellativi determina in particolare Heros e/oil Cavaliere Trace e Apollo, i quali, insieme con la coppia divina Giove eGiunone, sono i più popolari nella documentazione epigrafica e iconogra-fica di cui abbiamo conoscenza nello spazio trace.Un secondo livello è quello archeologico-iconografico: le forme monu-
mentali e le immagini cui i militari traci a Roma ricorrono per rappresen-tare il divino invitano a trovare paralleli nello spazio trace,4 ponendo ilproblema del trasferimento dei motivi e dei codici iconografici. Noi nonpossiamo conoscere il ruolo esatto svolto dai committenti di questi monu-menti; tuttavia, la presenza di immagini divine in un contesto votivo efunerario è chiara traccia dell’attività di artigiani che avevano una buonaconoscenza dei modelli iconografici balcanici, cari e familiari a una clien-tela fedele, quale quella dei cavalieri della guardia imperiale o dei preto-riani traci.Un terzo livello è quello teologico, il più delicato da decrittare: lo sfor-
zo che i moderni devono compiere è quello di capire il modo in cui i Tracitrasponevano linguisticamente le caratteristiche dei propri dei accostan-doli “sincretisticamente” a quelli greco-romani; o piuttosto, quando ilcorrispettivo non era rintracciato, limitandosi a traslitterarne i nomi. Laquestione, di non facile soluzione, è ulteriormente complicata dal fattoche noi possediamo assai poche informazioni sulla lingua trace, conosciu-ta essenzialmente attraverso gli antroponimi e i toponimi; anche il referen-te divino trace resta per noi spesso inaccessibile e noi ignoriamo il nomeoriginario di molte divinità.5 Un punto infine su cui non abbiamo manca-to d’interrogarci, senza ancora riuscire a dare una risposta, riguarda lepratiche cultuali indigene: noi sappiamo che l’obbligo di prestare cultoalle divinità protettrici del territorio era l’unico esistente per ogni comu-nità etnica o politica istallata nel territorio romano. Noi non sappiamo selo stesso vincolo era caratteristico dei Traci prima del contatto con Romao se piuttosto tale atteggiamento prese forma solo in una fase successivacon la potenza imperiale.
22
Riscritture
Premesso ciò e che tanti interrogativi, come è evidente, sono destinati arimanere aperti, a causa della nostra carenza di testimonianze, il percorsosi articolerà in tre momenti:
1) la presentazione cursoria della documentazione relativa ai Traci sol-dati dell’Urbe. Quest’operazione è essenziale per dare un profilo ai mili-tari, nell’epoca e nella temperie culturale in cui la loro pietà religiosa siè manifestata;2) l’illustrazione del ricco dossier delle divinità tracie, venerate a Romadai pretoriani. Piuttosto che predisporre un repertorio – lavoro giàcompiuto da altri studiosi6 – ci è sembrato più interessante in questocaso interrogarci sulle modalità che hanno prodotto questa documenta-zione;3) nella terza e ultima parte di questo lavoro, proveremo infine a inda-gare un livello generalmente trascurato, quello dell’atteggiamento deglistudiosi moderni, che a lungo hanno nutrito, nei confronti dei Traci,pregiudizi analoghi a quelli degli antichi.
Il tema in oggetto, quello delle divinità indigene dei soldati dell’esercitoromano,7 è difficile e delicato perché si confronta da una parte con ilcarattere ineguale e fortuito della documentazione, dall’altra con il parzia-le interesse da parte degli storici moderni. Per fare un esempio che a noipare calzante, un’indagine recente ha avuto in oggetto il valoredell’Hercules Magusanus per la costruzione di una “identità batava”:8 lascelta della divinità, per questo gruppo di Germani, è connessa con la per-cezione della loro “barbaricità” da parte dei Romani. Il culto collettivodel loro Ercole da parte dei soldati diviene, come bene suggerisce TomDerks, un efficace strumento per mantenere dei legami di solidarietà,senza nulla togliere alla propria lealtà verso Roma.9
Se si eccettua lo spazio trace, e il caso particolare di Roma che qui siandrà ad analizzare, solo un’altra provincia ha fornito un dossier epigrafi-co e iconografico altrettanto considerevole in relazione alle pratiche cul-tuali dei militari traci: si tratta di una provincia latinofona, la Pannoniainferiore, dove, a Intercisa, la presenza dell’ala I Thracum veterana sagitta-ria ha restituito dediche in latino e in greco con epiteti che rinviano allospazio trace.10 Il tentativo che qui ci si propone, in definitiva, è quello dicalarsi, per quanto è possibile, nella realtà di tali pratiche, mantenendouna rispettosa distanza, per non alterare, con la comune tendenza a dareun valore generale a testimonianze parziali, le poche tracce residue diun’antica devozione.
23
Tradurre il divino
1. I militari traci di Roma
La componente trace della popolazione militare di Roma è stata indivi-duata e studiata in alcuni lavori, in parte già ricordati (vd. nota 2). L’unicaforma di documentazione, quella epigrafica, restituisce più di duecentotestimonianze, tra latercoli11 e diplomi di congedo,12 dediche sacre, iscri-zioni sepolcrali, rinvenuti a Roma, nei suoi dintorni o nelle diverse loca-lità dove questi soldati, una volta terminato il servizio, decidevano di sta-bilirsi. Questa documentazione, assai diversa per schemi, destinazione ericchezza di dettagli, se opportunamente interrogata, non è avara d’infor-mazioni.L’epoca in cui la presenza trace nella capitale fu percentualmente signi-
ficativa corrisponde al secolo a cavallo tra la metà del II e la metà del IIId.C. In questa fase, troviamo traci in netta prevalenza tra i pretoriani, tragli equites singulares Augusti (le guardie del corpo a cavallo dell’impera-tore), e tra i soldati della legio II Parthica, accampati ad Albano, alle portedella città.13
Le indicazioni del corpo in cui i soldati prestavano servizio e della fun-zione ricoperta permettono di conoscere le forme del reclutamento, il tipodi carriera, i servizi svolti fuori città. Il luogo di provenienza degli epitaf-fi e dei diplomi, quando noto, ci dà notizie sulla destinazione all’indoma-ni del congedo o sulle aree di sepoltura.Indizio particolarmente eloquente ci è sembrato il modo in cui i Traci,
assimilandosi all’uso militare romano, indicano la propria origine.Emergono, per il maggior numero di attestazioni, alcune città: Philip-popolis, Serdica, Hadrianopolis, Traianopolis14 e anche se più modestamen-te, Anchialus, Pautalia e Beroea. Oltre però all’indicazione della città, cheaiuta il pubblico romano a orientarsi in un territorio certamente pococonosciuto, i Traci, a differenza degli altri soldati provinciali, specificanoil vicus, il pagus, la regio di provenienza. Si forniscono in tal modo puntidi riferimento più precisi ai soldati corregionali, segnalando al contempol’attaccamento al proprio territorio d’origine e alla sua specificità ammi-nistrativa. Quest’attenzione al dettaglio diventa così un espediente perreagire al proprio essere déraciné e al modello “uniformante”, in relazio-ne alla gestione territoriale, tipico della metropoli e della realtà imperialein cui operavano. Gli spazi familiari del distretto e del villaggio, rispettoalla grande città e al modello standardizzato del municipio, contribuivanoa tener vivo il senso di appartenenza a un mondo ancora prevalentemen-te rurale e a dimensione d’uomo.
24
Riscritture
2. La religione dei Traci di Roma
La religione dei Traci è esclusivamente attestata a Roma dalle dediche deisoldati. Questi soldati non sono del tutto isolati, manifestano solidarietàlocali e familiari, oltre a nuove amicizie nel contesto militare. Nei loro epi-taffi compaiono anche donne, soprattutto mogli, originarie in qualchecaso dei medesimi territori.15 Come cittadini romani, come militari al ser-vizio dell’imperatore, ma soprattutto come membri dei due corpi d’éliteche proteggevano l’Augusto, essi ricreano il proprio spazio familiare, incui l’aspetto cultuale gioca un ruolo di peculiare importanza.Le dediche dei soldati traci, individuali o collettive, separati per provin-
ce di provenienza o insieme a soldati di diversa origine, si dividono in duecategorie: quelle rivolte alle divinità del pantheon greco-romano e quellerivolte agli dei patri.Oltre alle dediche di piazza Manfredo Fanti, che rappresentano un
unicum dal punto di vista della concentrazione topografica e cronologi-ca e delle divinità che ricordano (e di cui si parlerà più avanti), altre dedi-che di soldati traci provengono dall’accampamento più antico (castravetera) degli equites singulares Augusti, che aveva sede presso l’attuale viaTasso. Una delle più antiche è rivolta a Giove Ottimo Massimo,Giunone, Minerva, Marte, Ercole, Silvano, alle dee Campestri et ceterisdis deabusque, oltre che al Genio dell’imperatore Adriano, da parte deicavalieri cives Thraces. L’indicazione del nome dell’imperatore è indizioevidente che, nel corpo delle guardie scelte, i Traci entrarono sin dallaprima metà del II secolo, dunque prima che nelle coorti pretorie. Grossomodo nella stessa epoca, nel 139 d.C., è sempre un gruppo di equites sin-gulares Augusti (ancora una volta cives Thraces) che fa dono di una sta-tua marmorea a Giove Ottimo Massimo e al Genio dell’imperatore (que-sta volta Antonino Pio).16
A questi documenti in cui i soldati dichiarano esplicitamente la propriaorigine va accostata una serie di dediche e di epitaffi con la raffigurazionedel Cavaliere Trace:17 in questo caso la cautela è d’obbligo, perché inassenza di un’indicazione di provenienza, l’immagine del “CavaliereTrace” è solo un indizio, non sempre probante: sappiamo infatti tale ico-nografia conobbe un discreto successo in tutta l’area balcanica e in areecircostanti.
Un nucleo di alcune decine di testimonianze (tra iscrizioni e/o rilievi voti-vi) è stato rinvenuto negli anni Settanta dell’Ottocento sull’Esquilino, nel-l’attuale piazza Manfredo Fanti; è quel che resta di monumenti originaria-mente collocati presso i castra praetoria e successivamente prelevati a
25
Tradurre il divino
scopo di reimpiego, in età post-constantiniana.18 La maggior parte di talidediche – e in particolare quelle rivolte a Heros – è posta nel III secolo dapretoriani,19 provenienti dalle regioni balcanico-danubiane. Non tutti idedicanti sono traci: altri si dicono mesici, galli (Belgica) e pannoni.Quando l’origine dei soldati non è chiaramente indicata, è possibile desu-merla grazie agli indizi onomastici,20 agli epiteti o ai nomi stessi delle divi-nità; o ancora grazie all’iconografia specifica.21 In non pochi casi si devericorrere alla combinazione di più indizi per poterla stabilire. Il dossier dipiazza Fanti consente di rilevare, si è anticipato, due principali livelli ditraduzione.Un primo livello riguarda il nome della divinità. Con una sola eccezio-
ne (Iambadoulïs, associato a Zeus Zberthourdos), si tratta di nomi latini:Apollo, Giove, Giunone, Esculapio (e la variante greca Asclepio). Que-st’assimilazione è verosimilmente determinata da una similitudine funzio-nale, sulla quale torneremo a proposito dell’Apollo trace.Un secondo livello è quello degli appellativi delle divinità, selezionati
per esprimere le loro potenze sotto l’aspetto sovrano.22 Così, una seriecoerente di dediche presenta Heros come Deus Sanctus Heros, che divie-ne una formula ricorrente; Apollo come Deus Dominus;23 Esculapio comeNumen Sancti Dei; Giunone come Dea Sancta oppure Sancta. Presentiamoa seguire le singole divinità attestate e le loro possibili corrispondenze inTracia.La divinità più popolare del dossier è certamente Apollo, spesso raffi-
gurato con i tratti del “Cavaliere Trace”24 e definito attraverso diversi epi-teti toponimici.25 Il primo di essi è Raimullus (?) Auluzelus:26 il ricorreredi un epiteto simile in una dedica latina da Iatrus, nella Mesia inferiore, ciautorizza a individuare dopo il nome di Apollo ben due epiteti e a inte-grarne un altro, prima di esso (e.g. Invicto /Domino o il generico Deo).Gli altri epiteti del dio sono modellati sui nomi di centri o regioni:
Vergulesis con riferimento al centro trace di Bergule (la futuraArcadiopolis), sulla trafficata arteria che univa le città di Serdica,Philippopolis, Hadrianopolis e Byzantium;27 Cicanos, con riferimento al-l’antica regione tracia di dove provenivano i leggendari Cicones;28 Tetes-syras, forse un etnico che designa gli abitanti di *Tetessyra, nella regionedi Marcianopolis, nella Mesia inferiore.29
Il dio Esculapio è venerato con due epiteti che rinviano alla localitàtrace di *Zimidra: una prima volta, nel 239 d.C., come AsclepiusZimidrenus, da parte di cives Philippopolitanorum (sic), che, accanto alnome della propria città, indicano il vicus di appartenenza; una secondavolta come Numen Sancti Dei Aescul[apii], da parte degli abitanti diSindrina reg(io) Philippopolitana. La dedica è del 241 d.C. e l’iniziativa
26
Riscritture
appartiene a un pretoriano/sacerdos, Aurelius Mucianus, che agisce perconto dei cives et commilitones.30 In entrambi i casi riconosciamo la divi-nità venerata presso il santuario di Batkun, nel territorio di Philippopolis:da questa località un ricco dossier epigrafico offre varianti grafiche dellostesso epiteto (Zymyzdrïnos e Zylmyzdr(i)ïnos sono le più frequenti). Ildio è raffigurato come Asclepio, o come il Cavaliere Trace.31 Come nellospazio trace un santuario attira i fedeli di tutta la regione, così a Roma ipretoriani originari di quel territorio sembrano associarsi per rendereomaggio a una divinità regionale.Il cosiddetto “Cavaliere Trace” è considerato generalmente un dio poli-
funzionale dello spazio provinciale, che conosce una molteplicità di asso-ciazioni con le divinità greco-romane, in particolare con Apollo, Asclepioe Giove. Come recentemente suggerito da Nora Dimitrova, esso rappre-senta un modello iconografico greco, rielaborato per rappresentare figu-re divine o eroiche maschili del mondo trace.32 Isolato in dediche indivi-duali, il dio è sempre Deus Sanctus Heros e il ricorso alle sole iniziali –D(eus) S(anctus) H(eros)33 – è segno della sua frequenza nello spazio cul-tuale.34 Nell’età di Gordiano, con i tratti del cavaliere trace, Heros è raffi-gurato con Ercole, Mercurio, Marte e la Vittoria, e venerato da pretoria-ni della Mesia Inferiore, regione Dime(n)si.35 Con appellativo toponimicoSanctus (H)eros Briganitius il dio è venerato dai cives Vsdicenses,36 dal vicodi Agatapara.Diversi epiteti caratterizzano il dio supremo Giove. Oltre ai tradiziona-
li Sanctus e Optimus Maximus, cui nel caso della dedica di un pretorianodella Mesia si aggiungono Capitolinus Sanctus,37 troviamo IuppiterOptimus Maximus [.].NCCIET[.] nella dedica del sacerdos Aurelius Bitus,il quale, nel 266 d.C., scioglie un voto, per conto dei cives traci della regio-ne di Serdica e della circoscrizione Potelense, per la salvezza del collegiomilitare Martis et Herculis. L’ultimo epiteto, impenetrabile per MarcelDurry,38 può certamente essere letto come [S]anc(to) et [---].Il pretoriano Aurïlios Dionysios fa una dedica, in greco, a Theos
Zberthourdos e Iambadoulïs epiphanestatoi (“i più illustri”),39 accompa-gnata da un suggestivo rilievo: Giove nudo, con scettro e folgore, compa-re insieme a un giovane imberbe nudo, a cavallo. Zbelsurdos, con diversegrafie, è ben conosciuto come epiclesi (funzionale?) di Giove, in numero-se iscrizioni greche e latine provenienti da aree diverse della Tracia.40 Ildio Iambadoulïs è viceversa sconosciuto altrove:41 il suo è un nome com-posto e la seconda parte si rintraccia, nella Macedonia orientale, in un teo-nimo (theos Asdoulïs) oltre che nell’antroponimo trace Doulïs, anch’essoricorrente nell’area.42
Due dediche riguardano Giunone: una, con rilievo, è rivolta Dehe (sic)
27
Tradurre il divino
sanctae Iunoni ex reg(ione) Marcianopolitani; l’altra, eretta nel 265 d.C. daValerius Iovinus, della prima coorte pretoria, presenta alla fine un epitetotoponimico di difficile lettura (Sa<nc>(tae) Iunoni ARISEA?).43
Infine, la divinità d’origine frigia Sabazio è assai popolare nei Balcani edè venerata a Roma come Deus Sanctus Iupiter Sabazius44 accompagnata dalrilievo del Cavaliere Trace, che, ancora una volta, permette di misurarel’importanza dei codici iconografici tradizionali.Il dossier di piazza Manfredo Fanti ci appare come il relitto del naufra-
gio delle decine di dediche erette anno dopo anno dai pretoriani o daglialtri militari balcanici. Ciò che in particolare colpisce è la varietà di figu-re divine, di appellativi e, appunto, di traduzioni, che testimoniano lagrande varietà cultuale dei traci militari nell’Urbe. L’attaccamento cultua-le alla patria d’origine che si cristallizza intorno alle figure del pantheontrace, così come alle divinità tradizionali con epiteti “territoriali”, sembraorganizzarsi secondo le solidarietà regionali che, nell’ambito militare,restano molto forti.La scelta della lingua non è oscura: il latino era la lingua di Roma e l’am-
bito militare in particolare lo imponeva. Non mancano tuttavia testi scrit-ti in greco, d’uso prevalente in Tracia, che pongono il problema dellarecezione da parte della componente ellenofona nella città.Questi militari si mettono di preferenza sotto la protezione dei dii patrii
/ theoi patrioi – dove gli dèi ancestrali sono i protettori del territorio, perun’identità religiosa sentita indissolubile rispetto a quella etnica. In nonpochi casi tuttavia, i soldati traci invocano, con un atto di lealismo, la stes-sa protezione per la casa imperiale. Naturalmente noi ignoriamo i dettaglidi questi contesti cultuali, così come i dettagli della comunicazione coldivino (qual era, ad esempio, la lingua delle preghiere?), della messa inscena degli atti cultuali, della posizione esatta delle dediche.45
Ci sembra però necessario, nonostante le gravi lacune dell’informazio-ne di cui disponiamo, un superamento della visione essenzialista, secondola quale le divinità tracie sarebbero state ovunque e sempre le stesse: mal-grado gli epiteti simili o similari, in Tracia e a Roma, il contesto socio-cul-turale cambia sensibilmente, le intenzioni divergono, così come diversesono le stesse personalità divine. A Roma i dedicanti sono traci, ma so-prattutto sono soldati al servizio dell’imperatore. Piuttosto che la “Traciaeterna”,46 si può rintracciare la coesistenza d’identità multiple; non si puòparlare di una “resistenza alla romanizzazione”, in una visione dicotomi-ca che oggi appare semplicistica e appesantita dal pregiudizio ideologico,ma di una coesistenza tra volontà d’integrazione ed espressione di un’i-dentità culturale diversa. Come osserva Nicole Belayche a proposito degliimmigrati orientali, la fedeltà alla patria si esprimeva con l’attaccamento
28
Riscritture
alle divinità epicorie adattandosi alla società che accoglieva.47 Quel cheavviene allora è una traduzione di livelli, di aggregazioni e circuiti (perso-nali, familiari, di corpo, a diversi livelli, regionali e provinciali), di socia-lità e di appartenenze.
3. Dalla traduzione all’interpretazione: l’ingannevole dicotomia dionisiaco/apollineo
Tramite le associazioni o le identificazioni operate a livello di nomi, imma-gini e pratiche cultuali, il dossier dei militari traci è un vero esempio d’in-terpretatio realizzata dai provinciali invece che dai romani, che attestaun’assimilazione delle particolarità provinciali nel cuore dell’impero el’integrazione riuscita dell’altro, nel caso specifico i soldati balcanici.47
Riprendiamo il punto dell’alterità, vera o presunta, dei Traci nell’immagi-nario degli studiosi moderni. L’immagine dei Traci e della loro religione sifonda principalmente sui clichés letterari degli antichi che li dipingonocome guerrieri feroci e crudeli.48 Tali modelli e i loro presupposti vannodecifrati operando, in questo caso, la traduzione di un retro-pensiero.Secondo Mateescu, le divinità tracie «sembrano aver avuto un caratterepiuttosto immateriale e ideale e, rispetto agli dei antropomorfi della civiltàgreco-romana, erano più agevolmente comprese e meglio soddisfacevanocon gli aspetti concreti del culto le necessità di una nazione così appassio-nata e voluttuosa come i Traci». Richiamando le dediche dei pretorianitraci, Durry invece esclama: «Che insulto, per un latinista che si avventu-ra tra queste pietre: ovunque barbarie e mistero!».49 Si tratta, come è evi-dente, di un’immagine superata che ben si accorda con quella letterariadei Traci che si abbandonano a ogni sorta di eccesso.Mateescu parla di una tetrade divina trace: l’Eroe trace, Apollo,
Dioniso-Sabazio, Asclepio, seguito in questo da Durry il quale però, alcu-ni anni dopo, scrive: «La triade più venerata è composta da Héros, Apolloed Esculapio: ci stupiamo dell’assenza di Dioniso-Sabazio». Per questoforse Georges Seure si sforza di individuare in Iambadoulïs un’ipostasidionisiaca di Heros.50 In realtà, come abbiamo visto, non c’è nessuna trac-cia di Dioniso: da dove viene allora, nonostante l’assenza di fonti, l’asso-ciazione di questa divinità al mondo dei Traci?L’idea diffusa della religiosità tracia a lungo è stata alterata dal precon-
cetto di una differenza radicale, carica di elementi primitivi e selvaggi, dieccentricità e di esagerazioni. Alla metà del XIX secolo, il culto di Dionisoe le manifestazioni a esso connesse (l’estasi, la possessione, le orge), al cen-tro dell’attenzione degli specialisti come antitesi dello spirito autentico
29
Tradurre il divino
della religione “classica”, era considerato originario della Tracia o del-l’Asia minore. Dioniso era difficile da classificare e, ai Greci come aimoderni, appariva a un tempo strano e straniero. I Traci stessi erano una-nimemente percepiti dagli studiosi come un popolo barbaro, preda di ritiorgiastici, secondo la seducente interpretazione di Erwin Rohde nel suocelebre Psyche (1893). Fortemente ispirato da Nietzsche e dal suo Lanascita della tragedia, con la celebre dicotomia apollineo/dionisiaco,Rohde concepiva Dioniso come un corpo estraneo rispetto alla culturagreca, proprio perché legato al mondo trace. L’ipotesi dell’origine tracedel dionisismo e il presunto carattere trace dei culti orgiastici, nonostantela ricca documentazione offerta dall’archeologia, sono perdurati nella cul-tura occidentale sino alla sorprendente rivelazione delle tavolette miceneein cui il nome di Dioniso compare per ben tre volte.51
Le ricostruzioni fittizie sono più rivelatrici dell’immaginario dei moder-ni che delle divinità cosiddette “barbare”. Come abbiamo visto, nel dos-sier di Roma – che riflette assai fedelmente le divinità principali veneratein Tracia – Dioniso è assente, mentre Apollo52 supera, se si accantona lafigura ambigua dell’Heros o del Cavaliere Trace, le attestazioni di altredivinità; così come, nelle testimonianze della Tracia, gli indigeni privile-giano Apollo piuttosto che Dioniso.L’abbandono del dionisiaco non significa adesione all’apollineo: il rico-
noscimento della posizione privilegiata di Apollo nel contesto trace nondeve comportare l’apertura di un nuovo filone di distorsioni teoriche,quali un culto della luce e del sole, secondo l’immagine moderna diApollo.53 È forse più logico immaginare una divinità le cui manifestazionierano messe dai Traci in relazione con le modalità d’azione di Apollo,secondo un procedimento d’interpretatio analogo, almeno a livello di teo-nimia, a quello attuato agli angoli dell’Impero: nelle province celto-ger-maniche (Apollo insieme con Mercurio), nello spazio illirico-pannonico edanubiano (Silvano), nelle province africane (Saturno).
Note
* Il contributo è stato pensato e articolato congiuntamente dai due autori. Lastesura delle pp. 20-24 si deve, tuttavia, a Cecilia Ricci, quella delle pp. 24-29 aDan Dana.
1 Roma e Italia: G.G. Mateescu, I Traci nelle epigrafi di Roma, in “EphemerisDacoromana”, 1, 1923, pp. 57-290 (saggio massimalista); L. Moretti, Sui Traci nelle
30
Riscritture
iscrizioni pagane e cristiane di Roma, in “Pulpudeva”, 2, 1978, pp. 36-42 (= Tra epi-grafia e storia. Scritti scelti e annotati, Quasar, Roma, 1990, pp. 205-209); C. Ricci,Balcanici e danubiani a Roma. Attestazioni epigrafiche di abitanti delle provinceRezia, Norico, Pannonia, Dacia, Dalmazia, Mesia, Macedonia, Tracia (I-III sec.), in L.Mrozewicz, K. Ilski (eds.), Prosopographica, WydawnictwoWers, Poznan 1993, pp.141-208; H. Solin, Thrakische Sklavennamen und Namen thrakischer Sklaven inRom, in Studia in honorem Georgii Mihailov, Български книжици, Sofia 1995, pp.433-447; C. Ricci, Principes et reges externi (e loro schiavi e liberti), in “Rendicontidell’Accademia dei Lincei” ser. IX, 7, 1996, pp. 561-592.
2 N. Belayche et alii, Nommer les dieux. Théonymes, épithètes, épiclèses dansl’Antiquité, Brepols, Turnhout 2005.
3 A. Rizakis, Le grec face au latin. Le paysage linguistique dans la PéninsuleBalkanique sous l’empire, in H. Solin, O. Salomies, U.-M. Liertz (eds.), ActaColloquii epigraphici latini Helsingiensis 3.-6. sept. 1991 habiti, Acta InstitutiRomani Finlandiae, Helsinki 1995, pp. 373-391; N. Sharankov, Language andSociety in Roman Thrace, in I.P. Haynes (ed.) Early Roman Thrace. New Evidencefrom Bulgaria, JRA, 92 Peleg, Road Portsmouth (Rhode Island) 2011, pp. 135-155.
4 A questo proposito, non è difficile rintracciare, nella storiografia bulgara erumena, posizioni nazionaliste, combinate con una visione essenzialista del fattoreligioso e con speculazioni etimologiche di valore discutibile. Anche la prospet-tiva della maggior parte degli studiosi occidentali è in gran parte ormai datata.Vedi, tra gli altri, R. Pettazzoni, La religione dell’antica Tracia, in “Bulletin del’Institut Archéologique Bulgare”, 16, 1950, pp. 291-299 (= L’onniscienza di Dio,Einaudi, Torino 1955, pp. 259-285); V. Georgiev, Die thrakischen Götternamen.Ein Beitrag zur Religion der alten Thraker, in “Linguistique Balkanique”, 18, 1975,pp. 5-56; V. Velkov, V. Gerassimova-Tomova, Kulte und Religionen in Thrakienund Niedermösien, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II.18.2, 1989,pp. 1317-1361; V. Georgiev, Thrakische und dakische Namenkunde, in Aufstiegund Niedergang der römischen Welt II.29, 2, 1983, pp. 1203-1210 (teonimi ed epi-teti traci). Come disse una volta G. Mihailov, Problèmes de la mythologie et de lareligion thrace, in “Pulpudeva”, 1, 1976, pp. 71-80, conviene adottare una posizio-ne critica rispetto alle fonti e alle interpretazioni: «chiunque si occupa della mito-logia trace è invischiato su un terreno estremamente sdrucciolevole».
5 D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Österreichischte Akademie derWissenschaften, Phil.-hist. Kl. Schriften der Balkankomission, Linguist. AbteilungXV., Wien 1957 (rist. 1976), repertorio che verrà presto sostituito dal-l’Onomasticon Thracicum, di prossima uscita (Dan Dana). Erodoto indica i nomidei principali dèi traci, ma in greco (anche se nel caso degli Sciti precisa anche inomi indigeni); si veda D. Dana, Comment représenter les coutumes religieuses desThraces (Hdt. V 3-8), entre Anciens et Modernes?, in C. Bonnet, A. Declercq, I.Slobodzianek (eds.), Les représentations des dieux des autres, Salvatore SciasciaEditore, Palermo 2011, pp. 221-237.
6 G.G. Mateescu, I Traci, cit., pp. 233-244 [e il resoconto di M. Durry in“Journal des Savants” 1926, p. 176]; M. Durry, Les cohortes prétoriennes,
31
Tradurre il divino
Bibliotheque des Ecoles Francaises d’Athenes et de Rome, vol. 146, Paris 1938,pp. 333-339; M. Giacchero, Heros, il dio cavaliere dei Traci e il suo culto fra i sol-dati dell’Impero, in L. Gasperini (a c. di), Scritti sul mondo antico in memoria diFulvio Grosso, Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università diMacerata vol. 9, 1981, pp. 220-222; M.G. Granino Cecere, C. Ricci, Culti indige-ni e lealismo dinastico nelle dediche dei pretoriani rinvenute presso piazza ManfredoFanti a Roma, in C. Wolff, Y. Le Bohec (eds.), L’armée romaine et la religion sousle Haut-Empire romain. Actes du quatrième Congrès de Lyon (26-28 octobre 2006),Université Lyon 3, 2009, pp. 185-201.
7 I.P. Haynes, The Romanisation of Religion in the Auxilia of the RomanImperial Army from Augustus to Septimius Severus, in “Britannia”, 24, 1993, pp.141-157; S. Price, Religious Mobility in the Roman Empire, in “Journal of RomanStudies”, 102, 2012, pp. 3-7 (culti etnici).
8 Possiamo citare una dedica a Hercules Magusanus di Roma, del 219 d.C., daparte degli equites singulares Antoniniani cives Batavi sive Thraces ex provinciaGermania Inferiore (CIL, VI 31162 = ILS 2188 = M.P. Speidel, Die Denkmäler derKaiserreiter: Equites singulares Augusti (Beihefte der Bonner Jahrbücher, 50),Rheinland Verlag, Bonn 1994, nr. 62); in questo caso i soldati provengono dallelegioni (vd. quanto detto supra, a p. 23).
9 N. Roymans, Hercules and the Construction of a Batavian Identity in theContext of the Roman Empire, in T. Derks, N. Roymans (eds.), Ethnic Constructsin Antiquity. The Role of Power and Tradition, Amsterdam University Press, 2009,pp. 219-238; T. Derks, Ethnic Identity in the Roman Frontier. The Epigraphy ofBatavi and Other Lower Rhine Tribes, ibid., p. 255.
10 Ad esempio RIU, V 1061, per Deus Dobrates (tavoletta con il CavaliereTrace). Particolarmente interessante è la dedica RIU, V 1084 di un templum daparte dei cultores di un collegium di Iuppiter Optimus Maximus Heros, a cura delpater Aurel(ius) Mes<t>rius, per la salvezza del imperatore Severo Alessandro(222-235). In greco la dedica di Beithynikos figlio di Tarsas, in onore di KyriosKendreisos (SEG XXIX 1049), con rilievo del Cavaliere Trace. Apollo Kendrisos èla divinità protettrice della capitale tracia Philippopolis.
11 Come vengono chiamate le lunghe liste di nomi di soldati congedati che dinorma accompagnavano dediche all’imperatore e al Genio di un’unità, come lacenturia o la coorte.
12 Nutrita è la lista dei militari traci attestati dai diplomi: si tratta di almeno cin-quanta documenti, che riguardano pretoriani ed equites singulares Augusti, tutticompresi tra l’età antonina e la metà del III secolo, cui vanno ora aggiunti gli ine-diti segnalati da W. Eck, Diplomata militaria für Prätorianer, vor und seit SeptimiusSeverus. Eine Bestands-Aufnahme und ein Erklärungsversuch, in “Athenaeum”,100, 2012, pp. 321-336.
13 A questi va ad aggiungersi un gruppo costituito da poco più di una decina tramarinai della flotta e veterani.
14 Oltre al la città di Marcianopolis, in Mesia inferiore.15 Si vedano, in generale, C. Ricci, Soldati e veterani nella vita cittadina dell’Italia
32
Riscritture
imperiale, Quasar, Roma 2010; A.W. Busch, Militär in Rom: militärische und para-militärische Einheiten im kaiserzeitlichen Stadtbild, Reichert Verlag, Wiesbaden2012. Tra gli eredi compaiono membri della stessa famiglia, adfines, consobrini oconvicani (ma anche mogli di pretoriani): CIL, VI 2566, 2737, 2557, 2568, 2570,2603, 2604, 2736. L’esempio più interessante è quello di Firminius Valens, mil(es)nu(meri) stator(um) pr(aetorii), di Philippopolis il cui epitaffio è posto dalla madree dalla moglie, omonime (Tataza), la seconda figlia di un Mucapor (CIL, VI 2954).
16 CIL, VI 31157 (= 31176) = M.P. Speidel, Die Denkmäler, cit., nr. 26 e CIL, VI31147 = ILS 2182 = M.P. Speidel, Die Denkmäler, cit., nr. 11.
17 CIL, VI 2805, 2806, 2807, 2391 (= 32549), 32566 (fr. a+b). Per l’iconografia,cfr. Supplementa Italica-Imagines. Supplementi fotografici ai volumi italiani delCIL, a c. di S. Panciera, Roma, I: Roma (CIL, VI) 1. Musei Capitolini, a c. di G.L.Gregori, M. Mattei, Quasar, Roma 1999; II.1: I. Roma (CIL, VI) 2. Musei Vaticani.1, a c. di I. Di Stefano Manzella, Quasar, Roma 2003.
18 Da ultimo si vedano M.G. Granino Cecere, C. Ricci, Culti indigeni, cit., pp.185-187 e 192-194.
19 A eccezione della dedica CIL, VI 3691 (= 30912) = ILS 4064, in cui l’originetrace è resa sicura dall’epiteto Thraciacius.
20 Cfr. D. Dana, L’impact de l’onomastique latine sur les onomastiques indigènesdans l’espace thrace, in M. Dondin-Payre (ed.) Les noms de personnes dansl’Empire romain. Transformations, adaptation, évolution, Ausonius Éditions,Bordeaux 2011, pp. 37-87.
21 Si veda il corpus di M.P. Speidel, Die Denkmäler, cit., con le stele funerarienrr. 258, 525, 541, 543, 544, 568, 577, 579, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598,599, 600, 601, 603, 604, 635 (e, fuori di Roma, nr. 682); i defunti sono originari diTracia, Mesia, Macedonia e Dacia.
22 Nelle iscrizioni latine della Mesia inferiore, i appellativi Deus e Sanctus sonofrequentissimi, in particolare Apollo Sanctus e Heros Sanctus/Sanctus Heros.
23 Due Traci, un padre, Aurïlios Pouris, e il figlio Aurïlios Bouris pretorianodella X coorte, fanno una una dedica in lingua greca a Theos [---] Apollÿn (IGVRI 134; lo stesso pretoriano e commemorato nell’epitafio CIL, VI 2732): nella lacu-na compresa tra l’appellativo e il nome della divinità si trovava un epiteto comeepïkoos, genikos o patrÿos, tutti attestati in Tracia, in relazione ad Apollo. Semprein relazione ad Apollo troviamo anche, su un registro più marziale, Invictus.
24 Cfr. i saggi tradizionali di Z. Goãeva, Le culte d’Apollon en Thrace, in“Pulpudeva” 1, 1976, pp. 221-225; Ead., Epitetha des Apollo in Thrakien, in“Thracia”, 4, 1977, pp. 207-223; Ead., Apollon (in Thracia), in LexiconIconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), II.1, Artemis & Winkler Verlag,Zürich-München-Düsseldorf 1984, pp. 332-334; M. Taãeva, Quelques observa-tions sur le culte d’Apollon en Thrace, in M.-M. Mactoux, E. Geny (eds.),MélangesPierre Lévêque, IV, Annales de l’Université de Besançon - Les Belles Lettres, Paris1990, pp. 397-404.
25 In due casi (CIL, VI 32571 e 36764) la variante Apolloni ricorre accanto allapiù comune Apollini, a indizio di una familiarità particolare con il greco.
33
Tradurre il divino
26 CIL, VI 32571; «seul l’Apollon RAIMVLLOVLVZOLO conserve sonsecret», secondo M. Durry, in “Journal des Savants”, cit.; D. Detschew, Diethrakischen Sprachreste, cit., pp. 388 e 348: Uluzolo[s Biti fil.?]; AE 2003, 1538(Iatrus).
27 CIL, VI 2798 (= 32570) = ILS 4057; cfr. M. Durry, Les cohortes, cit., p. 336sulla forma latinizzante Vergule(n)sis (e non Vergulenus).
28 CIL, VI 2797 = 32546. Potrebbe trattarsi di ad Statuas, toponimo collocatonella Tabula Peutingeriana 8.5 tra Bisanzio e Perinto (ad).
29 CIL, VI 36764: Donum dedit | in<v>icto Apolloni | Tetessyras (?) aMar|cianepo<l>i, Fla(vius) | Marce<ll>us v(otum) p(osuit). Tetes Syras è epitetogeografico per G.G. Mateescu, I Traci, cit., pp. 228-229 e 240.
30 CIL, VI 2799 (= 32543) = ILS 2094; CIL, VI 30685 = ILS 2095. CriticandoMateescu e Detschew, G. Mihailov, IGB, III.1, 1961, p. 118 sottolinea cheSindrina non è un epiteto di Asclepio.
31 G. Mihailov, IGB, III.1, 1961, pp. 117-118; V. Georgiev, Thrakische und daki-sche Namenkunde, cit., pp. 1208-1209, con un’etimologia molto discutibile(“Wasserschlange”), ripresa da I. Duridanov, Der Sprache der Thraker,Hieronymus, Neuried 1985, p. 70. Nelle due dediche urbane, mentre AsclepiusZimidrenus è l’esatta trasposizione dal greco, l’Aesculapius Sindrinae reg(ionis)Philippopolitanae rappresenta la variante latina, con la forma aggettivale contrattadel toponimo, *Sindra/Zindra.
32 Si vedano G.I. Kazarow, Die Denkmäler des thrakischen Reitergottes inBulgarien, Institut für Münzkunde und Archäologie der P. Pázmány-Universität,Budapest 1938; A. Cermanoviç-Kuzmanoviç et alii, Heros equitans, in: LexiconIconographicum Mythologiae Classicae, cit., VI.1, pp. 1019-1081. Il Corpus CultusEquitis Thracii rappresenta la raccolta più recente, anche se incompleta (5 tomi,tra il 1979 e il 1984). Il repertorio di Kazarow è ormai sostituito da quello di M.Oppermann, Der Thrakische Reiter des Ostbalkanraumes im Spannungsfeld vonGraecitas, Romanitas und lokalen Traditionen, Verlag Beier & Beran,Langenweißbach 2006. Sull’iconografia, si vedano i contributi di M. Giacchero,Heros, il dio cavaliere dei Traci, cit., pp. 189-223; Id., Santuari indigeni nell’impe-ro romano: i cavalieri danubiani e il cavaliere trace, in Santuari e politica nel mondoantico, a c. di M. Sordi, Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore,Milano 1983, pp. 168-195. All’approccio tradizionale e positivista di Z. Goãeva,Neos Hïrÿs (Kouros Hïrÿs), Cavalier Thrace (Heros), Heros Equitans, in A.Iakovidou (ed.) Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the 10th
International Congress of Thracology, Komotini – Alexandroupolis, 18-23 October2005, Meletïmatata, Athenai 2007, pp. 199-202, è ora da preferire lo sguardo luci-do e attento ai contesti di N. Dimitrova, Inscriptions and Iconography in theMonuments of the Thracian Rider, in “Hesperia”, 71, 2002, pp. 209-229.
33 CIL, VI 2803 (= 32578), 2804 (= 32579), 2805 (= 32580), 2806 (= 32581),2807 (= 32582), 3691 (= 30912), ICVR, I 1529 = ILCV, II 1906 = AE 2008, 187[rilettura e commento approfondito di C. Lega, ICUR, I 1529: dedica sacra di unpretoriano?, in M.L. Caldelli, G.L. Gregori, S. Orlandi (a c. di), Epigrafia 2006.
34
Riscritture
Atti della XIVe Rencontre sur l’épigraphie in onore di Silvio Panciera con altri con-tributi di colleghi, allievi e collaboratori, Quasar, Roma 2008, pp. 1185-1196, confoto a p. 1196.
34 Cfr., in Mesia inferiore, CCET, II.1 194, IV 196 e 206; e AE 1975, 749 (HeroDeus Sanctus).
35 CIL, VI 2391, 2392, 2858, 3901, 3902a (= 32549).36 Una regione che riprende il nome di un’antica strategia tracica. Si veda
M.G.G. Parissaki, Étude sur l’organisation administrative de la Thrace à l’époqueromaine. L’histoire des stratégies, in “Revue des Études Grecques”, 122, 2009, pp.337-338 e 350 nr. 93. La dedica è CIL, VI 2807 = 32582.
37 CIL, VI 2811 (= 32593 = 37184b), 2813 (= 32586), 2818 (= 32589).38 CIL, VI 2819 (= 32567); M. Durry, Les cohortes, cit., p. 337.39 IG, XIV 981 = IGR, I 58 = IGVR, I 132; foto IGVR, I, p. 116.40 La bibliografia è spesso discutibile: P. Perdrizet, Le dieu thrace Zbelthiourdos,
in “Revue des Études Anciennes”, 1, 1899, pp. 23-26; G. Seure, Les images thra-ces de Zeus Kéraunos: ZBELSOURDOS, GEBELEIZIS, ZALMOXIS, in “Revuedes Etudes Grecques”, 26, 1913, pp. 224-261; K. Vlahov, Die thrakischenGottheiten Zberthourdos, Iambadoula und Asdoula, in “Bulgarian HistoricalReview”, 8, 1980, pp. 90-96; D. Popov, Zbelsourdos, in Thrace in the Graeco-Roman World, cit., pp. 487-491. Zberthourdos è tradotto come “Blitzhalter” da N.Jokl, che segue W. Tomaschek, commentato da D. Detschew, Die thrakischenSprachreste, cit., pp. 177-178.
41 Alcuni esegeti (P. Pedrizet, F. Cumont, G. Seure, D. Detschew) hanno pensa-to a una figura divina femminile, tratti in inganno dall’ambiguità del rilievo; altria un dio: G.G. Mateescu, Iambadoules, in E. de Ruggiero (a c. di), Dizionario diantichità romane, IV, 2-3; L. Robert, in Hellenica, 10, 1955, 158.
42 IGB IV 2319, Melnik (teonimo) e LGPN IV 111 (antroponimo). Un’altra divi-nità trace menzionata in una dedica in greco perduta fu eretta da M. AureliusAlexandros, frumentarius della legio II Italica (nel Norico): in luogo di PatriÿSSALîNœ (con sigma lunato), siamo tentati di restituire Patriÿ theÿ Salïnÿ (IG,XIV 958 = IGR, I 29 = IGVR, I 135). Si tratterebbe di una divinità locale, dalmomento che ritroviamo lo stesso epiteto nella Macedonia orientale, in una seriedi dediche dal santuario del theos Salïnos (patrios theos) presso Parthicopolis, oggiSandanski (IGB, V 5901-5905, 5909).
4 CIL, VI 2808 = 32583; CIL, VI 2809 = 32565.4 CIL, VI 37187. L’antica e tenace tesi dell’origine trace (oppure traco-frigia) di
Sabazio è ormai da respingere; si veda I. Tassignon, Sabazios dans les panthéons descités d’Asie Mineure, in “Kernos”, 11, 1998, pp. 189-209. L’anatolico Sabazio,inoltre, è assimilato a Giove, piuttosto che a Dioniso.
45 M. Durry, in “Journal des Savants”, cit., menzionava Mommsen, il quale evo-cava «une sorte de Saint-Louis des Français pour les Thraces» (CIL, VI, p. 720: utnunc Francogalli in urbe degentes S. Ludovici ecclesia maxime utuntur).
46 Così la tesi ufficiale della tracologia bulgara, diffusa da Alexander Fol, chescrive: «La religion thrace est le sujet favori, je dirais même le premier sujet par
35
Tradurre il divino
son importance de la thracologie, parce qu’il est difficilement compréhensible etparce qu’il est attrayant». Cfr. in particolare il capitolo La Thrace éternelle de lacroyance en l’immortalité, in Légendes thraces, traduit par N. Stoyanov et C.Quinet, Sofia-Presse, Sofia 1977, pp. 137-150.
47 N. Belayche, Les immigrés orientaux à Rome et en Campanie: fidélité auxpatria et intégration sociale, in A. Laronde, J. Leclant (eds.), La Méditerranée d’unerive à l’autre: culture classique et cultures périphériques. Actes du 17e colloque de laVilla Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 20 & 21 octobre 2006, Boccard, Paris 2007, pp.243-260.
48 Per una messa a punto recente C. Ando, Interpretatio Romana, in “ClassicalPhilology”, 100, 2005, pp. 41-51.
49 Basti in questo caso il riferimento ai topoi su Massimino, figlio di un pastorenato in un villaggio oscuro della Tracia. Per una messa a punto, si veda J.-P.Martin, L’image de Maximin le Thrace dans Hérodien, in M.-H. Quet (ed.), La«crise» de l’Empire Romain de Marc Aurèle à Constantin, l’Université Paris-Sorbonne, Paris 2006, pp. 95-106.
50 G. G. Mateescu, I Traci, cit., p. 237 (seguito da M. Durry, Les cohortes, cit.,p. 335).
51 G. G. Mateescu, I Traci, cit., p. 241; M. Durry, Les cohortes, cit., p. 338 n. 10;G. Seure, Les images thraces de Zeus Kéraunos, cit., pp. 236-237.
52 C. Isler-Kerényi, Mitologie del moderno: “apollineo” e “dionisiaco”, in S. Settis(a c. di), I Greci, III (I Greci oltre la Grecia), Einaudi, Torino 2001, pp. 1397-1417;E. Rohde, Psiche: culto delle anime e fede nell’immortalità presso i Greci, LaterzaRoma-Bari, 2006 (Darmstadt 1991).
53 Il nome di Dioniso compare più volte sulle tavolette in lineare B di Pylos etKhania (a Creta), circa 1250 a.C., nella forma di-wo-nu-so.
54 Apollo è tuttavia venerato senza alcun epiteto, a Roma, da un cavaliere dellaguardia imperiale, M. Vlpius Bitus (CIL, VI 31166 = M.P. Speidel, Die Denkmäler,cit., nr. 35). Altre dediche da parte dei militari traci nelle province non-tracie: inGermania Inferiore, un gruppo di legionari della legio XXX Vlpia Victrix veneranel 223 d.C. deus Apollo Dysprus (insieme a Luna e Sol) (CIL, XIII 8607); nellaPannonia inferiore, una dedica greca ricorda (Apollo) Kendrisos (si veda la nota10); in Dacia Porolissensis, un veterano degli auxilia venera Apollo, senza alcunepiteto (CIL, III 787); infine, a Palmyra, un cavaliere trace si unisce al suo prefet-to d’ala in una dedica a Latona e Apollo (IGLS, XVII.1 172).
55 L’associazione del Cavaliere Trace con Apollo e la popolarità di Apollo inTracia non riguardano una divinità d’aspetto luminoso e solare, come propostonella storiografia bulgara (Z. Goãeva, Le culte solaire chez les Thraces, in“Pulpudeva”, 2, 1978, pp. 343-349), o nei contributi di M. Giacchero, citati allanota 32.