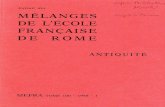L'arte musiva nelle colonie gemelle di Piacenza e Cremona
Transcript of L'arte musiva nelle colonie gemelle di Piacenza e Cremona
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali
L’ARTE MUSIVA
NELLE COLONIE GEMELLE
DI PIACENZA E CREMONA
Elaborato finale di :
Filippo BRANDOLINI
Matricola n° 707539
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa GRASSI
Anno Accademico 2008/2009
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
“L’archeologia è ricerca di fatti.
Non di verità. Se quello che vi interessa
è la verità, allora dei corsi di filosofia
sono un buon punto di partenza”
Prof. Henry Jones Jr.
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
INTRODUZIONE ........................................................................ 1
1 STORIA DELLE COLONIE GEMELLE .......................... 2
1.1 Cremona ........................................................................................................... 2
1.2 Piacenza ........................................................................................................... 8
2 CATALOGO ........................................................................ 15
2.1 Mosaici di Cremona ....................................................................................... 16
CR01 - Anguissola ................................................................................................ 16
CR02 – Anguissola, cinema Italia ......................................................................... 19
CR03 – Bella Rocca ............................................................................................... 21
CR04 – Cadolini, Domus del Labirinto ................................................................. 22
CR05 – Cadolini, Domus delle Stagioni ................................................................ 32
CR06 - Campi ........................................................................................................ 36
CR07 - Cattedrale .................................................................................................. 38
CR08 - Filodrammatici .......................................................................................... 40
CR09 - Goito .......................................................................................................... 41
CR10 – Marconi, Ninfeo........................................................................................ 42
CR11 - Plasio ......................................................................................................... 46
CR12 - Roma ......................................................................................................... 48
CR13 – Roma, 6 ..................................................................................................... 49
CR14 - Roma, 7 ..................................................................................................... 50
CR15 – Roma, 7 ..................................................................................................... 51
CR16 – Roma 7 ...................................................................................................... 52
CR17 – Roma 7 ...................................................................................................... 53
CR18 – Roma, 9 ..................................................................................................... 54
CR19 – Roma, Guarneri ........................................................................................ 56
CR20 ...................................................................................................................... 57
CR21 ...................................................................................................................... 58
CR22 ...................................................................................................................... 59
2.2 Mosaici di Piacenza ....................................................................................... 60
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
PC23 - Benedettine ................................................................................................ 60
PC24 - Camicia ...................................................................................................... 60
PC25 - Campagna .................................................................................................. 61
PC26 - Cavalletto ................................................................................................... 61
PC27 - Cavalli ........................................................................................................ 62
PC28 – Cavalli, Basamento ................................................................................... 63
PC29 – Cavalli, Gotico .......................................................................................... 63
PC30 – Cavalli, I.N.P.S. ........................................................................................ 64
PC31 – Cavalli, Monumento equestre ................................................................... 64
PC32 – Cavour, Mazzini ........................................................................................ 65
PC33 – Cavour, Romagnosi ................................................................................... 66
PC34 - Cittadella .................................................................................................... 66
PC35 – Cortile scuola G.Mazzini .......................................................................... 67
PC36 – Delle Grida ................................................................................................ 69
PC37 - Dezopis ...................................................................................................... 69
PC38 - Duomo ....................................................................................................... 70
PC39 – Giordano Bruno......................................................................................... 72
PC40 – Gregorio X ................................................................................................ 73
PC41 - Legnano ..................................................................................................... 74
PC42 - Matteotti ..................................................................................................... 74
PC43 - Mazzini ...................................................................................................... 75
PC44 – Melchiorre Gioia ....................................................................................... 75
PC45 – Palazzo Vescovile ..................................................................................... 76
PC46 - Poggiali ...................................................................................................... 77
PC47 – Risorgimento, Mazzini .............................................................................. 80
PC48 – Risorgimento, Melchiorre Gioia ............................................................... 81
PC49 - Romagnoli.................................................................................................. 82
PC50 – S. Marco .................................................................................................... 82
PC51 – S. Martino.................................................................................................. 83
PC52 – S.Stefano ................................................................................................... 83
PC53 - Sopramuro.................................................................................................. 84
PC54 - Taverna ...................................................................................................... 84
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
PC55 – XX settembre, Bertola............................................................................... 85
PC56 – XX settembre, Cappellotti......................................................................... 87
PC57 – XX settembre, Cigalla ............................................................................... 87
3 CONCLUSIONI ................................................................... 88
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE ............................. 101
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
1
INTRODUZIONE
La fondazione di Cremona e Piacenza, avvenuta alla fine del III sec. a.C., rientra in un
ampio progetto di espansione e di affermazione della presenza romana nell’ager
gallicus. Le due colonie, dette “gemelle”, vennero fondate nello stesso momento, sulle
rive opposte del Po, Cremona a nord e Piacenza a sud, a breve distanza l’una dall’altra,
in importanti punti strategici e, forse, con un medesimo impianto urbanistico. I primi
anni di vita delle due colonie furono funestati da una continua serie di eventi bellici, ad
iniziare dalla seconda guerra punica (218-202 a.C.). Nel 218 a.C., infatti, le fasi della
guerra si svolsero in Cisalpina. Annibale, dopo aver varcato le Alpi, conseguì
importanti successi proprio nei pressi delle due colonie gemelle (battaglia del Ticino,
battaglia di Clastidium, battaglia del Trebbia). All’inizio del II sec. a.C., Piacenza e
Cremona furono investite, come tutta la Cisalpina, da un’insurrezione generale dei
popoli gallici contro Roma: la rivolta si risolse con una vittoria dei Romani. Rifondate
nel 190 a.C., le due colonie conobbero un progressivo sviluppo e floridezza, grazie
soprattutto ai traffici commerciali che gravitavano su questa area sfruttando sia il
sistema stradale romano, in particolare la via Aemilia e la via Postumia, sia le vie
fluviali con due importanti porti sul Po. In epoca imperiale, tra I e II sec d.C., Piacenza
e Cremona raggiunsero l’apice dello sviluppo. La ricchezza delle due colonie romane
era rappresentata sia dalla dotazione di importanti edifici pubblici sia dalle sfarzose
dimore che ci hanno restituito splendide testimonianze artistiche quali intonaci dipinti e
mosaici pavimentali. Purtroppo la continuità di vita in entrambe le colonie, anche dopo
il crollo dell’Impero romano, impedisce di avere evidenze monumentali significative e
di condurre scavi archeologici estesi e approfonditi. Tra i reperti rinvenuti a Piacenza e
a Cremona sono molto interessanti i lacerti musivi che hanno indotto a condurre
un’analisi parallela dei mosaici delle due colonie per verificare la possibilità di
considerarle “gemelle” anche per quanto riguarda l’arte musiva.
Dopo un capitolo riservato alla storia delle due colonie, segue un catalogo in cui sono
raccolte tutti i mosaici di Cremona e Piacenza rinvenuti e pubblicati. Nel terzo capitolo
sono esposte le conclusioni a cui si è giunti dall’analisi dei reperti contenuti nel
catalogo stesso.
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
2
1 STORIA DELLE COLONIE GEMELLE
1.1 Cremona
Cremona fu dedotta nel 218 a.C., insieme alla sua gemella Piacenza e sorse come un
baluardo militare a nord del Po, su un terrazzo alluvionale, protetto dal fiume. Fu la
prima colonia fondata in Transpadana. Il fiume Po, l’Oglio, l’Adda e i corsi minori
della Cremonella e Mechioris (oggi non più visibili) furono l’elemento essenziale per la
sua futura prosperità1.
Figura 1 Ripresa satellitare di Cremona, in evidenza il probabile impianto urbano della colonia romana.
(foto satellitare da www.google.it/maps, rielaborata da F. Brandolini secondo la carta archeologica edita in PASSI
PITCHER 2003)
Fonti del V sec d.C. ricordano ancora la presenza a Cremona di un porto per servizio
pubblico. Il porto era importantissimo per le attività commerciali della colonia e qui
avvenivano transazioni con molte regioni del Mediterraneo come testimoniano i
rinvenimenti di anfore provenienti da tutto l’Impero.
1 PASSI PITCHER 2003, pp. 132-133, 143-144 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
3
Figura 2 Anfore da trasporto conservate nel Museo Archeologico Figura 3 Bollo di anfora rodia.
San Lorenzo di Cremona. (foto di F. Brandolini) (da PASSI PITCHER 2003)
L’economia di Cremona era basata principalmente sull’allevamento, scambi
commerciali e produzione di ceramica. Quest’ultima attività artigianale è stata
ampliamente testimoniata da frammenti di ceramica di tipo Aco, terra sigillata e pareti
sottili nonché dal ritrovamento di alcune fornaci nell’area della colonia2.
Figura 4 Esempi di ceramiche rinvenute a Cremona: matrice di ceramica di tipo Aco, frammenti di ceramica a pareti sottili,
frammenti di ceramica tipo terra sigillata. (da PASSI PITCHER 2003)
Nonostante la certezza della presenza di un porto, non ne sono, però, ancora state
individuate le tracce3. Le numerose vie d’acqua sfruttate dalla città esponevano la
colonia a continui rischi di esondazioni e impaludamento e fu, pertanto, sottoposta a
numerose opere di drenaggio e bonifica, testimoniate da ritrovamenti di alcuni banchi
di anfore sotto il manto stradale4. Il territorio della colonia era costellato da campagne
così rigogliose, sia per la fertilità del terreno sia per la ricchezza d'acqua, che ben presto
Cremona divenne sede della più celebre fiera agricola della Padania centrale5.
2 PASSI PITCHER 1998, p. 407 .
3 PASSI PITCHER 1998, p. 406 .
4 PASSI PITCHER 2003, pp. 131-132 .
5 http://www.cremonaarcheologica.net/?arg=1&l=i .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
4
Nello stesso anno in cui fu dedotta la colonia cremonese, la Gallia Cisalpina fu teatro di
scontro della prima fase della seconda guerra punica (218-202 a.C.) combattuta tra
Roma e Cartagine. Le truppe di Annibale, valicate le Alpi, sconfissero ripetutamente le
legioni romane proprio nei pressi delle due colonie gemelle. Pochi anni dopo
l’invasione annibalica, i Galli intensificarono la guerriglia nel territorio e, dopo la
distruzione di Piacenza, attaccarono Cremona nel 200 a.C. . La colonia riuscì a
resistere, ma subì gravi danni. Dopo aver risolto il problema con i bellicosi Galli, Roma
decise, nel 190 a.C., una rifondazione delle due colonie gemelle6. La città di Cremona
venne dotata di una cinta muraria di cui però non sappiamo nulla, forse a causa di
espoliazioni successive: si pensa, comunque, che fossero costruite in mattoni cotti come
le mura di Piacenza7. Dopo la rifondazione, la città si ampliò e l’abitato si diffuse oltre
la cinta muraria e, all’interno, la colonia contava molte ricche dimore, ampiamente
documentate dai rinvenimenti archeologici. Lo schema della città antica è oggetto di
numerose ipotesi e tuttora i limiti della colonia non sono definibili con certezza, anche
se, tuttavia, nuove testimonianze portate alla luce chiariscono in parte come poteva
essere la forma urbis di Cremona. Una delle ipotesi è quella che sostiene che l’impianto
della città possa essere derivato da quello di un accampamento militare. Un’altra ipotesi
sostenuta è, invece, che l’impianto fosse organizzato a isolati rettangolari disposti per
strigas o per scamna. Pare tuttavia più verosimile, alla luce delle scoperte
archeologiche, che l’impianto della colonia fosse organizzato a assi ortogonali con
isolati quadrati. “Senza voler forzare interessantemente una teoria, il modello risulta
uguale a quello della colonia gemella di Piacenza”8. E’, comunque, rilevante il fatto che
nelle due colonie siano stati indagati isolati quadrati delle medesime dimensioni (circa
80 m.). Il foro di Cremona non è ancora stato scoperto, ma doveva probabilmente
trovarsi all’incrocio tra cardo massimo e decumano massimo, come a Placentia. Anche
dell’edilizia pubblica della colonia conosciamo pochissimo: in piazza Marconi sono
stati trovati resti di una struttura lunga circa 21 metri, da ritenere, forse, un edificio
pubblico per attività commerciali. Il frammento di statua acroteriale, rinvenuto in
6 PASSI PITCHER 1998, p. 404 .
7 PASSI PITCHER 2003, pp. 132-133, 136 .
8 PASSI PITCHER 2003, p. 141 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
5
giacitura secondaria in via Plasio, suggerisce la maestosità e la ricchezza che dovevano
avere certi edifici di uso pubblico.
Figura 5 Statua acroteriale rivenuta in via Plasio. A sinistra : particolare del volto. A destra: statua vista nell'insieme, così
come è esposta al Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona. (foto di F. Brandolini)
Tacito dà notizia, parlando di Cremona, della presenza di un anfiteatro, di terme
pubbliche e di un tempio extraurbano, tutti edifici i cui resti non sono ancora stati
individuati9. La più frequente testimonianza archeologica di Cremona consiste in
mosaici: questi sono lo specchio concreto della ricchezza delle domus cittadine10
, oltre
a intonaci dipinti e splendide fontane, come il bellissimo ninfeo rinvenuto frammentario
durante gli scavi di piazza Marconi. La documentazione archeologica permette di
individuare, con certezza, quartieri residenziali in via Cadolini, nell’isolato tra via
Magenta e via Garibotti, nell’area di piazza Marconi11
e nella zona tra piazza Roma e
via Plasio12
. Purtroppo gli sventramenti estensivi che hanno caratterizzato gli anni ‘60
del secolo scorso e la mancanza di scavi e documentazioni accurate rendono di difficile
9 PASSI PITCHER 1998, pp. 404-406 .
10 PASSI PITCHER 2003, pp. 154-155 .
11 PASSI PITCHER 2003, p. 157 .
12 PASSI PITCHER 2003, p. 405 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
6
Figura 6 Frammenti di intonaci dipinti conservati nel Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona. (foto di F. Brandolini)
lettura la situazione dell’edilizia privata della Cremona romana. In una prima fase,
durante il I sec. a.C., le abitazioni erano costruite con fondamenta in laterizi legati con
argilla all’alzato che poteva essere in mattoni crudi o in incannucciata. Dalle poche
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
7
testimonianze rinvenute, l’elemento caratteristico delle residenze di questa fase era il
pavimento in cocciopesto. Meglio documentate sono le abitazioni di I-II sec. d.C. . La
maggior parte dei mosaici delle domus di questa fase sono forse riferibili a ricostruzioni
effettuate dopo le distruzioni vespasianee del 69 d.C. che investirono Cremona.
Figura 7 Lastra frontale bronzea di una balista della IV Legio Macedonia che prese parte alle guerre civili del 69 d.C. .
Conservata nel Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona. (foto di F. Brandolini)
I mosaici scoperti sono caratterizzati da decorazioni in tessere policrome o solo in
tessere bianche e nere, sia con motivi geometrici sia con elementi figurativi molto
ricercati. Oltre a mosaici pavimentali, di squisita fattura sono alcuni esemplari di
pavimenti in opus sectile composti da crustae di marmi policromi molto preziosi 13
.
La presenza nel corso del IV sec. d.C. di una fabbrica imperiale di scudi (fabrica
scutaria cremonensis) e di un Corpo Sarmatarum Gentilium, ci confermano una
posizione di prestigio della città anche nel periodo tardoantico14
.
Dopo le distruzioni perpetrate durante le guerre del 69 d.C. Cremona subì altre gravi
sciagure che danneggiarono profondamente la città: nel 603 d.C. venne attaccata dal re
longobardo Angilgulfo, nel 1113 le cronache riferiscono notizia di un terribile incendio
e nel 1117 la città subì un forte terremoto15
.
13
PASSI PITCHER 2003, pp. 159-173 . 14
http://www.cremonaarcheologica.net/?arg=1&l=i . 15
PASSI PITCHER 1998, p. 404 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
8
1.2 Piacenza
La colonia di Piacenza venne fondata nel 218 a.C. su un terrazzo fluviale del Po, in una
posizione strategica per il controllo di un guado, crocevia di antiche piste pedemontane
della Cisalpina. La fondazione di Piacenza e della sua gemella Cremona sancirono la
presenza romana in un territorio già costellato di empori commerciali e avamposti
militari precedenti.
Figura 8 Ripresa satellitare di Piacenza, in evidenza il probabile impianto urbano della colonia romana. (foto satellitare da
www.google.it/maps, rielaborata da F. Brandolini secondo la carta archeologica edita in MARINI CALVANI 1990a)
Fin dall’inizio la neonata colonia venne ordinata seguendo un impianto regolare di assi
ortogonali che, come rivela una serie di ritrovamenti, “non fu il risultato di successive
addizioni, ma la traduzione sul terreno di un impianto urbanistico unitario” 16
. A nord-
est della città doveva trovarsi il porto fluviale, identificato nell’odierna area di
Malcatone, vicino all’antica Fossa Augusta17
. Piacenza era inoltre uno snodo stradale
16
MARINI CALVANI 1990b , p. 774 . 17
MARINI CALVANI 1998 , p. 401 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
9
fondamentale poiché qui si incontravano due vie molto importanti: la via Aemilia
(inaugurata nel 187 a.C.) e la via Postumia (inaugurata nel 148 a.C.). Sempre da
Piacenza partiva anche una strada diretta alla colonia di Ticinum. Tratti di queste strade
penetravano anche in città. Nel caso della via Aemilia, infatti, la strada extraurbana
ricalcava il tracciato del decumano massimo della colonia. All’incrocio tra cardo
massimo e decumano massimo doveva trovarsi il foro della colonia, nell’area dove
sorsero le due chiese altomedievali di S. Martino e S. Pietro, dette appunto “in foro”18
.
Si pensa tra l’altro che la chiesa di S. Pietro ricalchi la struttura del Capitolium
municipale che, da un’iscrizione, pare esser stato ricostruito in epoca augustea19
. L’area
dell’antico foro è verosimilmente quella dell’odierna Piazza Cavalli.
Figura 9 Frammento di ceramica locale a vernice nera. (da MARINI CALVANI 1990b)
Sin dalle prime fasi successive alla deduzione della colonia, l’attività artigianale e
l’edilizia dovettero essere molto intense, come rivelano rinvenimenti, databili intorno al
II-I sec. a.C.20
di ceramica locale, decorazioni fittili e mattoni cotti. Queste produzioni
18
MARINI CALVANI 1990b , p. 776 . 19
MARINI CALVANI 1998 , p. 461 . 20
MARINI CALVANI 1990b , pp. 775 - 777 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
10
devono essere riferibili all’attività di fornaci extraurbane che alimentavano il
fabbisogno cittadino.
Figura 10 Frammenti di antefisse fittili rinvenute a Piacenza. (da MARINI CALVANI 1990b)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
11
Nel 218 a.C. alle porte di Piacenza si svolse la battaglia del Trebbia tra le legioni
romane e le truppe di Annibale. Le legioni di Scipione e Sempronio Longo, travolte dal
nemico cartaginese, ripararono proprio a Piacenza e a Cremona. Risolta vittoriosamente
la seconda guerra punica contro Cartagine (202 a.C.) Roma dovette affrontare
un’insurrezione generale dei popoli della Gallia Cisalpina. Nel 190 a.C., in seguito alla
definitiva vittoria romana sui Galli, Placentia venne rifondata e dotata di una cinta
muraria e la colonia emiliana divenne il quartiere generale delle operazioni militari
contro il popolo dei Liguri. I ritrovamenti dei resti della cinta muraria e di altri edifici
sono tra le testimonianze più antiche di una produzione di mattoni cotti, materiale da
costruzione per eccellenza dall’ ager gallicus 21
.
Verso la fine del I sec. a.C., conclusesi le lotte per la successione
imperiale tra Antonio e Ottaviano con la vittoria di quest’ultimo,
in molti centri della Cisalpina vennero effettuate espropriazioni,
rifondazioni e bonifiche per elargire lotti di terre ai veterani degli
eserciti. Indirettamente siamo informati, grazie ad un’iscrizione
funeraria rinvenuta a Casteggio, che anche Piacenza venne
rifondata in epoca augustea: sulla lapide funeraria infatti
Placentia è detta Augusta 22
. L’assegnazione di terre ai veterani
da parte di Ottaviano Augusto riversò nella Cisalpina numerose
famiglie di italici che portarono con loro, un proprio linguaggio
architettonico e figurativo leggibile nei numerosi rilievi funerari
ritrovati. Dell’architettura pubblica di Piacenza conosciamo,
purtroppo, poco o nulla, soprattutto attraverso frammenti di
edifici romani soggetti a riuso nelle epoche successive. Degli
edifici del foro non si sa nulla, mentre sotto il cortile di Monte di
Pietà vi sono tracce di fondamenta, di un’ara mutila decorata a
testa di Gorgone e di un podio, il tutto forse riferibile a un
tempio pubblico23
.
21
MARINI CALVANI 1998 , p. 399 . 22
MARINI CALVANI 1998 , p. 401 . 23
MARINI CALVANI 1990b , p. 779 .
Figura 11 Lapide funeraria
rinvenuta a Casteggio. Oggi
conservata nel cortile di
Lettere e Filosofia dell'
Università degli Studi di Pavia.
(foto di F. Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
12
Figura 12 Resti dell'ara su podio ritrovata durante gli scavi di Monte di Pietà a Piacenza. (da MARINI CALVANI 1990b)
Figura 13 Particolare a testa di Gorgone della decorazione dell'ara rinvenuta durante gli scavi di Monte di Pietà a Piacenza.
(da MARINI CALVANI 1990b)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
13
Non sono state trovate finora tracce del teatro, mentre i resti di tubature in piombo
rinvenuti in piazza Duomo sembrerebbero riferibili a terme pubbliche24
. L’anfiteatro
della città, distrutto forse durante le guerre intestine tra Otone e Vitellio nel 69 d.C.,
doveva essere collocato, come rivelano resti di fondazioni di un grande edificio di
spettacolo, tra le mura cittadine e il fiume Po.
Figura 14 Resti dell'anfiteatro rinvenuto in viale Risorgimento a Piacenza. (da MARINI CALVANI 1990b)
Numerosi lacerti di mosaici pavimentali sono da attribuire verosimilmente ad abitazioni
private e, oltre a rivelare la presenza di maestranze itineranti specializzate, questi
mosaici testimoniano l’alto livello economico raggiunto dalla colonia di Piacenza. Le
decorazioni pavimentali vanno dal tassellato disseminato di crustae marmoree alle più
o meno complesse composizioni a motivi geometrici in tessere bianche e nere. Si tratta
purtroppo di testimonianze isolate e frammentarie che poco suggeriscono dei contesti di
appartenenza. Necropoli riferibili all’abitato di Piacenza sono state individuate nell’
24
PAGLIANI 199, p. 36 n. 73 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
14
area di Malcatone e lungo il percorso della via Emilia, in prossimità di successive
chiese altomedievali piacentine25
.
Dopo la sconfitta subita dai romani nel 271 d.C. vicino a Piacenza contro Alamanni e
Iutungi, la città venne dotata di una nuova cinta muraria 26
. La colonia emiliana, infatti,
come altre città dell’Impero, dovette difendersi nel III sec. d.C. dalle incursioni dei
barbari, specialmente di stirpe gotica.
Cronisti del IV sec. d.C. parlano di Placentia come di una città ormai in rovina e nel
476 d.C. l’ assassinio del generale Oreste, padre dell’ultimo imperatore Romolo
Augustolo, avvenuto proprio a Piacenza, segna la fine del ciclo storico dell’Impero
Romano d’Occidente 27
.
Figura 15 Romolo Augustolo su un tremisse d'oro. (da www.summagallicana.it)
25
MARINI CALVANI 1990b , p. 783 . 26
MARINI CALVANI 1990b , p. 785 . 27
MARINI CALVANI 1998 , p. 403 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
15
2 CATALOGO
Avvertenze al catalogo
Nel seguente catalogo i mosaici presi in esame per questo studio sono stati ordinati con
numerazione successiva dal n. 1 al n. 57. Trattandosi di mosaici rinvenuti a Cremona o
a Piacenza, il catalogo è diviso in due sotto unità: i mosaici rinvenuti a Cremona dal n.
1 al n. 22 e i mosaici rinvenuti a Piacenza dal n. 23 al n. 57. Nel catalogo le schede
sono ordinate in ordine alfabetico topografico senza tener conto dei termini
via/piazza/località/corso/strada ma solo considerando il nome proprio come
Anguissola/Cavalli/Dezopis/XX Settembre. In ogni scheda compaiono voci (luogo di
rinvenimento, data, luogo di conservazione, stato di conservazione, materiali, misure,
descrizione, contesto, cronologia, bibliografia) alle quali si è cercato di dare risposte
ampie e dettagliate ove la bibliografia a disposizione lo permetteva. Anche il repertorio
iconografico è viziato dalla disparità di pubblicazioni disponibili, più numerose per
l’ambito cremonese e invece purtroppo abbastanza limitate per i reperti di Piacenza.
Nel testo, quando citate, le schede del catalogo sono indicate tra parentesi con le sigle
‘CR#’ o ‘PC#’, dove ‘#’ è il numero della scheda. In schede in cui vengono analizzati
complessi residenziali come intere domus, i mosaici sono distinti per ambiente con una
lettera maiuscola dell’alfabeto (es. CR04A , CR04B).
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
16
2.1 Mosaici di Cremona
CR01 - Anguissola
Luogo di rinvenimento: Via Anguissola.
Data: Il primo lacerto venne rinvenuto nell’ottobre 1962, mentre il secondo lacerto fu
scoperto nel 1991 .
Luogo di conservazione: Il primo lacerto venne strappato e depositato al Museo
Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala I, collocato sul pavimento), ora si trova nel
deposito del Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona in attesa di una nuova
collocazione. Il secondo lacerto è, invece, conservato in situ.
Stato di conservazione: Il primo lacerto venne restaurato nel 1963 da Edoardo
Bernasconi per la S.A.L., nel 1991 da Felice Bernasconi, e ancora nel 1993 venne
restaurato da Paolo Pastorello.
Materiali: Tessere di 7x7 mm, marmi policromi: nero di Varenna, bianco di Verona,
rosso tenue di Verona, rosso rubino di Stazzona (Lucca). Statumen in frammenti laterizi
posti a taglio e legati con limo argilloso; rudus di cocciopesto rosa-chiaro molto
sabbioso e friabile con frammenti di piccoli laterizi; nucleus di cocciopesto rosa-scuro
molto duro con frammenti di calce; tessere musive policrome inserite in uno strato di
calce bianca.
Misure: Lacerto scoperto nel 1962: 1,60x0,77 m.
Lacerto scoperto nel 1991: 9,70x0,82 m.
L’ambiente doveva avere una dimensione totale di almeno 11,50 x 2,60 m.
Descrizione: Si tratta di due frammenti della parte mediana di una grande sala
mosaicata, probabilmente un triclinium, con émblema a triangoli concentrici e
kantharos centrale:
- Frammento del 1962: motivo a tralcio di vite e rosette rese con tenue policromia su
sfondo nero. Di difficile interpretazione l’elemento a L che potrebbe forse suggerire
una originaria forma a T dell’ambiente.
- Frammento del 1991: mosaico molto importante per minuzia di esecuzione e
policromia. Parte mediana di una grande sala con emblema a triangoli concentrici e
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
17
kantharos centrale. Schema geometrico a quadrature con decorazione interna a cerchio
e quadrato, delimitato da campiture a stella di otto losanghe.
Contesto: Il frammento scoperto nel 1962 venne alla luce in seguito a lavori della SIP,
alla profondità di 1,85 m sotto la soglia del portone d’ingresso dello stabile n. civ. 22.
Fu un rinvenimento casuale. Venne strappato, restaurato e conservato nel Museo Civico
di Cremona Ala Ponzone. Il secondo lacerto venne scoperto in seguito a nuovi lavori
della SIP, nel medesimo luogo nel 1991. In questo caso la Soprintendenza
Archeologica decise di intervenire con scavi sistematici nella stessa area della scoperta
del 1962. La situazione stratigrafica del sottosuolo della sede stradale si presentava
particolarmente compromessa anche per la quota insolitamente alta di 1,49 m. La
differenza di quota tra i due lacerti è dovuta a smottamenti del terreno, fenomeno
evidente anche durate lo scavo iniziato nel 1991. Il secondo lacerto rinvenuto nel 1991
non poteva non essere stato notato nel 1962 visto che i cavi della SIP erano
praticamente poggianti sul mosaico.
Cronologia: II sec. d. C. (PONTIROLI 1974)
Metà del I sec d.C. (PASSI PITCHER1996)
Fine I sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: PONTIROLI 1974 , pp. 46,47 n. 2(647) – TAV. II ;
PASSI PITCHER1996, pp. 109-116 ;
PASSI PITCHER 2003, p. 165 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
18
Figura 17 CR01: Via Anguissola , alcuni dei frammenti di mosaico rinvenuti nel 1991 e ricostruzione ipotetica
dell'ambiente mosaicato. (immagine rielaborata da F. Brandolini: ricostruzione ipotetica del mosaico da PASSI PITCHER
1996; foto di alcuni dei lacerti rinvenuti da PASSI PITCHER 2003)
Figura 16 CR01: Via Anguissola , mosaico frammentario rinvenuto nel 1962. (da PONTIROLI 1974)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
19
CR02 – Anguissola, cinema Italia
Luogo del rinvenimento: Via Anguissola, area Cinema Italia.
Data: 1962
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
III, collocato sul pavimento), ora è conservato nel deposito del Museo Archeologico
San Lorenzo di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato nel 1963 da Edoardo Bernasconi,
ricomposto nel 1966 dal cav. Stefano Locati e infine spostato e restaurato nel 1971
ancora da Edoardo Bernasconi.
Materiali: Tessere bianche nere di 1,3 x 1,3 cm ca.
Misure: 3,89 x 3,98 m.
Descrizione: Tre lati del frammento di mosaico pavimentale sono fasciati da una
decorazione a merlatura composta di quattro tessere nere, al cui margine interno vi sono
due corsi di tessere nere alternate a tessere bianche. Nel quarto lato l’interruzione della
scacchiera rivela che il pavimento probabilmente continuava. Lungo i due lati marginali
adiacenti sono distribuite tacche regolari di 4 x 12,5 cm di cui solo due originali.
All’estremità del lato marginale privo di tacche vi è una soglia di 17 x 87 cm decorata a
mosaico con motivo a treccia. I quadrati della scacchiera misurano 26 x 26 cm e sono
bianchi e neri alternati. Nei quadrati bianchi vi sono quadrati neri posti a punta.
Contesto: /
Cronologia: I-II sec. d.C.
Bibliografia: PONTIROLI 1974, pp. 62-63 n. 17 (632) TAV XXI .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
20
Figura 19 CR02: Particolare della decorazione del mosaico rinvenuto in via Anguissola. (da PASSI PITCHER 2003)
Figura 18 CR02: Mosaico rinvenuto in Via Anguissola. (da PONTIROLI 1974)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
21
CR03 – Bella Rocca
Luogo del rinvenimento: Via Bella Rocca – Via Belcavezzo.
Data: 1961
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
VIII, posto verticalmente alla parete Sud), ora è conservato nel deposito del Museo
Archeologico San Lorenzo di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato da Edoardo Bernasconi nel 1963.
Materiali: Tessere di 7-8 mm per lato in marmo nero di Varenna e bianco di Verona.
Misure: 0,60 x 1,15 m max.
Descrizione: Si tratta di un mosaico pavimentale molto frammentario con decorazione
a tessere disposte diagonalmente. Un duplice corso di tessere bianche e nere affiancate
separa i due campi della decorazione.
Contesto: /
Cronologia: I-II sec. d.C. (PONTIROLI 1974)
seconda metà I sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: PONTIROLI 1974, p. 70 n. 23 (626) TAV XXV ;
PASSI PITCHER 2003 , pp. 161-162 .
Figura 20 CR03: mosaico rinvenuto in via Bellarocca. (da PONTIROLI 1974)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
22
CR04 – Cadolini, Domus del Labirinto
Luogo di rinvenimento: Via Cadolini angolo NE con Via Anguissola, nell’area ex
S.t.i.p.e.l. (Società Telefonica Interregionale Piemontese Lombarda).
Data: scavi del 1926, 1952 ,1971 .
Luogo di conservazione: Fino al maggio 2009 i mosaici erano conservati presso il
Museo Civico Ala Ponzone di Cremona Sala I pavimento; ora al Museo Archeologico
San Lorenzo, Cremona ( A,B,C,D,E ).
Stato di conservazione: Strappati dalla loro sede naturale e ricomposti al Museo
Civico Ala Ponzone, vennero poi restaurati nel 1963 da Felice e Edoardo Bernasconi.
In un primo momento furono ricomposti e immersi in supporti di cemento armato.
Dopo anni di restauri vennero staccati dal supporto in cemento armato e collocati in un
supporto in argilla e malta leggera.
Figura 21 CR04: i mosaici pavimentali della domus del Labirinto esposti nel Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona.
(foto di F. Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
23
Contesto: La domus è stata scavata a più riprese anche se parzialmente tra gli anni ‘20
e ‘70 del secolo scorso. Si sono potuti comunque individuare cinque ambienti e una
zona all’aperto. Gli ambienti interni erano decorati a mosaico. Un lungo corridoio
portava a un piccolo atrio con decorazione a labirinto. Dall’atrio si accedeva a due
stanze dopo aver varcato una piccola soglia. Una delle due stanze era bordata da una
ricca fascia a mosaico con quadretti contenenti motivi floreali diversi. L’intera domus
venne probabilmente distrutta da un incendio durante le guerre civili del 69 d.C. :
durante gli scavi, infatti, sopra alla domus fu rinvenuto uno strato molto consistente di
materiale bruciato.
A- Corridoio in opus tessellatum
Misure: Un frammento misura 5,10 m di lunghezza, l’altro misura 73 x 121 cm
max.
Materiali: Tessere di 1x1 cm in marmo nero, rosso, giallo di Torri del Benaco e
Biancone d’Asiago.
Descrizione: La superficie del corridoio è contenuta, da entrambi i lati, da tre corsi
di paralleli di tessere nere. Il pavimento è costellato da crocette tipo S. Andrea, a
bracci uguali, alternate bianche, rosse e gialle tutte con una tessera nera al centro. Le
crocette sono disposte a intervalli regolari di 7,5 cm ca. su sette corsi nella parte più
larga della composizione, presso il gradino di passaggio all’atrio del Labirinto. Ai
lati del pavimento corre da una parte e dall’altra una duplice fascia formata da
quattro corsi di tesse bianche. Ciascuna fascia è larga 4,5 cm ed è inframezzata da
tre corsi di tessere nere parallele. L’impianto decorativo si chiude, nel lato verso
l’atrio del Labirinto, con una fascia di tre corsi di tessere nere seguita da tessere nere
poste diagonalmente fino al muro. Il pavimento porta traccia di un restauro antico
con tessere rettangolari e privo del motivo a crocette di S. Andrea.
Cronologia: Fine I sec d.C – inizio II sec d.C. (PONTIROLI 1974)
Fine I sec a.C. – inizio I sec. d.C. (BUGINI, FOLLI, PASSI PITCHER 2009)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
24
Figura 22 CR04A: Corridoio in opus tessellatum. (foto di F. Brandolini)
Figura 23 CR04A: Particolare della decorazione del corridoio in opus tessellatum. (foto di F.Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
25
B - Piccolo Atrio in opus tessellatum con il Labirinto:
Misure: 1,44 x 1,13 m.
Materiali: Tessere policrome di varie dimensioni.
Descrizione: Il tracciato dei muri del labirinto (reso con tessere di 10mm) è segnato
mediante una sola fila di tessere e rende la composizione leggera e luminosa. Nei
vertici della cinta muraria sono rappresentate quattro torri con feritoie ottenute con
due tessere nere. Tre cortine murarie portano ventuno merli formati ognuno da
quattro tessere sporgenti dal perimetro murario. Il quarto lato, che presenta al centro
due torri merlate ciascuna con una finestra, era rivolto verso un gradino in marmo
verdello di Verona che divideva l’atrio dal precedente corridoio in opus tessellatum.
Nell’interno della cinta muraria, in corrispondenza dell’unica
porta inizia il percorso del labirinto organizzato in quattro
settori. L’emblema inserito al centro del labirinto
rappresenta, con tessere policrome, la scena della lotta tra
Teseo e Minotauro. Il mostro mitologico è rappresentato in
ginocchio, tenuto fermo da Teseo con una mano mentre con
l’altra sta per sferrare il colpo mortale. Una piccola fascia
ondulata scura costituisce la linea di terra. Le tessere
policrome del l’emblema sono tagliate in modo anche
irregolare per servire a disegnare al meglio la scena
mitologica. Mancano elementi di fondo. Il perimetro del
labirinto è reso come una cinta urbica, un motivo decorativo
molto diffuso in Italia Settentrionale.
Cronologia: Fine I – inizio II sec d.C. (PONTIROLI 1974)
Seconda metà I sec d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Fine I sec a.C. – inizio I sec. d.C. (BUGINI, FOLLI, PASSI PITCHER 2009)
Figura 24 CR04B:
Particolare della
decorazione: lotta tra
Teseo e Minotauro.
(foto di F. Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
26
Figura 25 CR04B: Atrio Piccolo Atrio in opus tessellatum con il Labirinto. (foto di F.Brandolini)
C- Bordo a mosaico di pavimento in cocciopesto bianco con grosse tessere nere
Misure: Ambiente largo 6 m. ca. , lunghezza non ricostruibile.
Materiali: Tessere bianche e nere in marmo nero di Varenna e biancone di Asiago.
Descrizione: A quest’ambiente si accede dopo aver varcato una soglia in trachite
che separa la stanza dall’atrio del Labirinto. Il pavimento è ornato da un fregio
perimetrale composto da doppia fascia nera. Ciascuna fascia è costituita da quattro
corsi paralleli di tessere nere racchiudenti corsi di tessere bianche. Tra il fregio e il
muro si sviluppa un corso di tessere nere a losanga che segue l’andamento del
perimetro.
Cronologia: Fine I sec d.C – inizio II sec d.C. (PONTIROLI 1974)
Seconda metà I sec d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Fine I sec a.C. – inizio I sec. d.C. (BUGINI, FOLLI, PASSI PITCHER 2009)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
27
Figura 26 CR04C: Bordo a mosaico di pavimento in cocciopesto bianco con grosse tessere nere. (foto di F. Brandolini)
Figura 27 CR04C: Particolare della decorazione del bordo a mosaico del pavimento in cocciopesto bianco.
(foto di F. Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
28
D- Soglia in opus tessellatum:
Misure: 82 x 43 cm.
Materiali: Tessere bianche e nere.
Descrizione: Questa soglia rettangolare separa l’atrio del Labirinto dall’ ambiente
in opus sectile. E’ un ambiente decorato con motivi geometrici e delimitato ai lati
da due corpi marmorei. Un doppio corso di tessere bianche del motivo decorativo
forma un rettangolo, separato da sette corsi di tessere nere paralleli toccanti i merli
delle mura del labirinto. Dieci corsi paralleli di tessere nere più piccole, sono
disposti tra i limiti marmorei e i lati brevi del rettangolo racchiudente il fregio della
soglia. Nella decorazione della soglia rettangolare il centro è ornato da un motivo a
fiore a sei petali, in bianco e nero, in campo circolare di tessere bianche inscritte in
un quadrato di tessere nere. Esternamente a questo quadrato corre una doppia fila di
tessere bianche seguita da un altro corso di tessere nere. Da una parte e dall’altra di
questi quadrati concentrici sono disposti due rombi, composti da un corso di tessere
nere e da due di tessere bianche, includenti un quadrato in tessere nere con una
foglia d’edera in tessere bianche.
Figura 28 CR04D: Soglia in opus tessellatum . (foto di F. Brandolini)
I vertici opposti dei rombi toccano il punto medio del quadrato con la foglia
d’edera e quello di due rettangoli estremi tra i motivi della soglia. Questi rettangoli
comprendono un corso di tessere nere e due di tessere bianche ed un corpo
rettangolare concentrico con motivi dati da un fascio di dieci fulmini in tessere
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
29
bianche. Il restante motivo decorativo della soglia è a losanghe nere contornate da
doppio corso di tessere bianche e da uno più esterno in tessere nere. A metà dei lati
maggiori e ai vertici della composizione sono realizzati triangoli in tessere bianche
e nere. Il fiore a sei petali è lacunoso di tessere per il guasto apportato dal
chiavistello di una porta che separava l’atrio del Labirinto dalla sala in opus sectile.
Cronologia: Fine I sec d.C – inizio II sec d.C. (PONTIROLI 1974)
Inizi II sec d.C. (GHEDINI,BAGGIO,TOSO 1998)
Seconda metà I sec d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Fine I sec a.C. – inizio I sec. d.C. (BUGINI, FOLLI, PASSI PITCHER 2009)
E- Bordo a mosaico di ambiente in opus sectile:
Misure: Larghezza tra 3,20 e 3,80 m , lunghezza non ricostruibile.
Materiali:Tessere bianche, nere e policrome di 7 mm ca. per lato.
Descrizione: Dall’esterno verso l’interno la
decorazione si presenta composta da una
fascia marginale di 20 cm ca. di tessere nere
disposte in diagonale, seguita da tre corsi di
file parallele di tessere nere, poi quattro corsi
di tessere bianche e, infine, ancora due corsi
di tessere nere. Questa cornice concentrica
racchiude un lungo fregio a meandro con
quadrati includenti motivi decorativi vari:
rosette con quattro petali posti sulla
diagonale e quattro foglie lanceolate
sull’asse; fiori con petali bilobati e
lanceolati; decorazione a ottagoni a lati
inflessi con foglie d’edera sui quattro apici
angolari. Questi motivi decorativi sono tutti
ottenuti con viva policromia di marmi in giallo, verde, nero, rosa, rosso, bianco.
Verso l’interno il meandro è limitato, in successione, da due corsi di tessere nere,
tre di tessere bianche, di nuovo due di tessere nere e due di tessere bianche. Oltre
questa successione alternata di corsi di tessere bianche e nere sono disseminate per
Figura 29 CR04E: Alcuni dei motivi floreali
che decorano la cornice a mosaico.
(foto di F. Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
30
tutta l’area pavimentale crustae irregolari di brecce multicolori di marmi diversi
separati tra loro da una doppia fila di tessere bianche. Di recente queste scaglie
colorate sono state sottoposte a un’analisi petrografica per capire l’origine e il tipo
dei marmi utilizzati.
Cronologia: Fine I sec d.C – inizio II sec d.C. (PONTIROLI 1974)
Età augustea (GHEDINI,BAGGIO,TOSO 1998)
Seconda metà I sec d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Fine I sec a.C. – inizio I sec. d.C. (BUGINI, FOLLI, PASSI PITCHER 2009)
Figura 30 CR04E: Pavimento in opus sectile con bordo a mosaico. (foto di F. Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
31
Figura 31 CR04E: Particolare della decorazione del bordo a mosaico dell'ambiente in opus sectile. (foto di F. Brandolini)
Bibliografia: PONTIROLI 1974, pp. 48-52 ; TAVV. V,VI,VII,VIII,IX,X ;
GRASSIGLI 1998, pp. 267-269 ;
GHEDINI,BAGGIO,TOSO 1998, pp. 177-188 ;
PASSI PITCHER 2003 , pp. 164-165 ;
BUGINI, FOLLI, PASSI PITCHER 2009 , p. 201 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
32
CR05 – Cadolini, Domus delle Stagioni
Luogo del rinvenimento: Via Cadolini , ex casa Poli n. civ. 10.
Data: 1970
Luogo di conservazione: Fino al maggio 2009 entrambi i mosaici erano esposti al
Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala III, pavimento e parete Nord), ora si
trovano al Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona: uno (A) esposto, l’altro (B)
è conservato nel deposito del museo in attesa di una nuova collocazione.
Stato di conservazione: Strappati dalla loro sede naturale e ricomposti al Museo
Civico Ala Ponzone, vennero poi restaurati nel 1963 da Felice e Edoardo Bernasconi.
In un primo momento furono ricomposti e immersi in supporti di cemento armato.
Dopo anni di restauri vennero staccati dal supporto in cemento armato e collocati in un
supporto in argilla e malta leggera.
Contesto: I mosaici vennero rinvenuti durante i lavori di fondazione di un nuovo
edificio residenziale in corrispondenza dell’area dell’abbattuta casa Poli n. civ. 10.
A-Pavimento in opus tessellatum con le Stagioni:
Misure: 4,56 x 2,66 m.
Materiali: Tessere di 1 x 1 cm in marmi policromi: rosso di Verona, bianco di
Verona, nero di Varenna, verde delle Alpi, azzurro Bardiglio, violetto di brecce, due
tessere in pasta vitrea color lapislazzuli.
Descrizione: Si tratterebbe di un pavimento di sette file di almeno cinque grandi
ottagoni alternati da sei quadrati, tutto chiuso da una fascia perimetrale. I bordi, a
petali floreali di tessere bianche su fondo nero, sono racchiusi da corsi paralleli di
tessere bianche. I sei quadrati (54 x 54 cm), simmetricamente distribuiti, includono
emblemata. Nella restante superficie ci sono ottagoni di 27 cm di apotema, triangoli
lungo il fregio marginale e motivi a M a base chiusa ai vertici dei quadrati. Dei sei
quadrati, quattro formano gruppo a se, ciascuno con un busto femminile allegorico
di una delle quattro Stagioni. Ne rimangono superstiti solo due di questi busti
femminili. In uno si riconosce la Primavera che porta un mantello fermato sulla
spalla sinistra e sul capo una corona di fiori e di foglie. La seconda immagine è
l’Inverno come farebbe supporre il capo coperto da un leggero tessuto mentre
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
33
mostra le spalle nude. Gli altri due quadrati superstiti sono decorati da fiori
stilizzati. Gli ottagoni hanno, invece, inscritte rosette di otto petali ciascuna. Questo
mosaico potrebbe appartenere a un triclinium.
Cronologia: Metà III sec d.C. (PONTIROLI 1974)
Metà del II sec d.C. (VOLONTE’ 1998)
Età augustea (GHEDINI,BAGGIO,TOSO 1998)
Seconda metà II sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Figura 32 CR05A: Particolare del pavimento in opus tessellatum con le Stagioni nel vecchio allestimento del Museo Civico
Ala Ponzone di Cremona. (da PONTIROLI 1974)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
34
Figura 33 CR05A: Particolare del pavimento in opus tessellatum con le Stagioni nel nuovo allestimento del Museo
Archeologico San Lorenzo di Cremona. (foto di F. Brandolini)
Figura 34 CR05A: Particolari della decorazione: a sinistra l' Inverno; al centro motivi floreali stilizzati; a destra la
Primavera. (foto di F. Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
35
B- Pavimento in opus tessellatum con motivi geometrici bianchi e neri:
Stato conservazione: Frammento angolare, restaurato da Edoardo Bernasconi.
Materiali: Tessere bianche e nere di varie dimensioni in marmo nero di Varenna e
bianco di Verona.
Misure: 1,63 x 2,35 m max.
Descrizione: Frammento di mosaico pavimentale romano, decorato a motivi
geometrici. Una larga fascia marginale lacunosa composta da corsi alternati di
tessere bianche e nere (un corso di tessere bianche, cinque di tessere nere, quattro di
tessere bianche, quattro di tessere nere, quattro di tessere bianche) comprende
motivi geometrici centrali con tessere di marmo nere e bianche. L’impianto
decorativo prevede tre grandi quadrati con quadrato interno contornato da triangoli
geometricamente distribuiti. Ogni lato dei quadrati grandi è comune a quello di
rettangoli separativi con losanga nera inscritta. I lati minori dei rettangoli formano
quattro quadrati con quadratino nero concentrico.
Cronologia: Seconda metà II sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Figura 35 CR05B: Pavimento in opus tessellatum con motivi geometrici bianchi e neri. (da PONTIROLI 1974)
Bibliografia: PONTIROLI 1974, pp. 61-63 , TAV XVIII, XIX, XX, XXII ;
VOLONTE’ 1998, pp. 509 s. V11 ;
GRASSIGLI 1998, pp. 268-269 ;
PASSI PITCHER 2003 , pp. 164-165 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
36
CR06 - Campi
Luogo del rinvenimento: Corso Campi, n. civ. 26.
Data: 1920
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
I, sul pavimento), ora è conservato nel deposito del Museo Archeologico San Lorenzo
di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato da Edoardo Bernasconi nel 1963 per
S.A.L. .
Materiali: Tessere bianche, nere e policrome di 1x1 cm.
Misure: 3,30 x 3,30 m.
Descrizione: Si tratta di un mosaico pavimentale romano con decorazione geometrica,
vasi ansati (kantharoi), trecce, nodi salomonici, girali, pelte e rosette. Tutta la
decorazione, in cui prevalgono motivi curvilinei, è caratterizzata da una lieve
policromia.
Contesto: /
Cronologia: Seconda metà II sec d.C.
Bibliografia: PONTIROLI 1974 , p. 47 , n. 4(645) – TAV IV .
Figura 36 CR06: mosaico rinvenuto in Corso Campi, vecchio allestimento nel Museo Civico Ala Ponzone di Cremona.
(da PONTIROLI 1974)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
37
Figura 37 CR06: Particolare della decorazione: un kantharos. (da www.cremonaarcheologica.it)
Figura 38 CR06: Porzione centrale del mosaico. (da PASSI PITCHER 2003)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
38
CR07 - Cattedrale
Luogo di rinvenimento: Piazza del Comune, Cattedrale di S. Maria Assunta, Cappella
Sacra Spina, cortiletto del Torrazzo.
Data: 1901, 1966
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: Frammentario.
Materiali: Tessere di marmi e pietre.
Misure: /
Descrizione: La decorazione si articola in un reticolo di ottagoni e quadrati collegati da
una matassa a due nastri che li accoglie senza interruzioni. Nei quadrati vi sono fiori a
quattro petali che con quattro sepali hanno terminazioni di nero e note di grigio e di
rosa. Negli ottagoni sono presenti due motivi: girali di foglie e di edera nere, con fiori
in boccio rosa, che cingono motivi ottagonali a quattro apici fogliati; cerchi concentrici
culminanti in un nodo salomonico centrale. Impianto di grande eleganza. Il mosaico
quasi sicuramente non è pertinente a un edificio privato, ma ad una fase paleocristiana
del Duomo, come si evince da un analisi delle fondamenta e dei resti strutturali.
Contesto: Venne scoperto nel 1901 sotto il pavimento del Duomo. Solo nel 1966 la
Soprintendenza decise di avviare scavi e ricerche nell’area in seguito ai lavori di
ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento che prevedeva il passaggio di un tubo di
aria calda proprio sotto la sagrestia e la vicina Cappella Sacra Spina.
Cronologia: fine IV sec d.C.- inizio V sec. d.C. (MIRABELLA ROBERTI 1985)
fine IV sec d.C.- inizio V sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: MIRABELLA ROBERTI 1985, pp. 177 -182 ;
PASSI PITCHER 2003 , pp. 153-154 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
39
Figura 39 CR07: Mosaico paleocristiano rinvenuto nel cortiletto del Torrazzo. (da PONTIROLI 1982)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
40
CR08 - Filodrammatici
Luogo del rinvenimento: Piazza Filodrammatici.
Data: 31 dicembre 1953.
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
I, sul pavimento), ora è conservato nel deposito del Museo Archeologico San Lorenzo
di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato da Edoardo Bernasconi nel 1963 per
S.A.L. .
Materiali: Tessere bianche e nere di 1 x 1 cm.
Misure: 3,90 x 1 m.
Descrizione: Si tratta di un mosaico pavimentale decorato con fasce spezzate bipenni,
ottagoni dai lati arcuati, trecce, rosette e fiori di loto stilizzati distribuiti in semicerchi.
Contesto: Rinvenuto durante gli scavi delle fondamenta del casamento al civ. n. 7.
Cronologia: II sec. d.C.
Bibliografia: PONTIROLI 1974 , p. 52 n. 6 (643) – TAV XI .
Figura 40 CR08: Mosaico rinvenuto in Piazza Filodrammatici, vecchio allestimento del Museo Civico Ala Ponzone di
Cremona. (da PONTIROLI 1974)
Figura 41 CR08: Particolare della decorazione. (da PASSI PITCHER 2003)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
41
CR09 - Goito
Luogo del rinvenimento: Via Goito, Galleria Kennedy.
Data: 1962
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
VIII, posto verticalmente alla parete Sud), ora è conservato nel deposito del Museo
Archeologico San Lorenzo di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato da Edoardo Bernasconi nel 1962.
Materiali: Tessere di 1 x 1 cm in marmo nero di Varenna e in bianco di Verona.
Misure: 2,20 x 1,69 m max.
Descrizione: Si tratta di un mosaico pavimentale decorato con una fascia composta di
cinque corsi di tessere nere seguita da cinque corsi di tessere bianche e poi da tre corsi
di tessere nere. La fascia racchiude un campo di tessere nere disposte diagonalmente in
cui sono collocate a intervalli regolari di 15 cm tre corsi di crocette di quattro tessere
bianche includenti al centro una tessera nera. A destra di questo campo di tessere nere
si sviluppa, ad angolo, un campo di tessere bianche disposte in diagonale.
Contesto: Sotto questo pavimento in mosaico ne venne rinvenuto un altro pavimento in
graniglia.
Cronologia: I-II sec d.C. (PONTIROLI 1974)
Seconda metà I sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: PONTIROLI 1974, pp. 70-71 n. 24 (625) TAV XXV ;
PASSI PITCHER 2003 , p. 167 .
Figura 42 CR09: Mosaico pavimentale rinvenuto in Via Goito, Galleria Kennedy. (da PONTIROLI 1974)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
42
CR10 – Marconi, Ninfeo
Luogo di rinvenimento: Piazza Marconi.
Data: Rinvenuto durante la campagna di scavo iniziata nel maggio 2005 e terminata
nella primavera del 2008.
Luogo di conservazione: Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona.
Stato di conservazione: I frammenti sono applicati a un supporto metallico con
calamite che permettono un agevole spostamento per l’integrazione con possibili nuovi
frammenti mancanti.
Materiali: Le tessere, di misura compresa tra 0,3 e 1 cm, sono in blu egizio, pietra
calcare rosa, marmo bianco, pomice, pietra calcare bianca, grigia e nera. Il verde e il
rosso sono ottenuti con frammenti di vasellame in vetro che vennero ritagliati e levigati
per essere usati nella decorazione. Bordatura è resa con bastoncini in vetro bianchi e
blu. Pigmenti sono ottenuti con pellicola pittorica blu, rossa o grigio scura. Le
conchiglie utilizzate nello schema decorativo sono di diverse specie molto comuni nel
Mediterraneo, in particolare: Hexaplex trunculus, Panopea glycimeris, Cerastoderma
glaucum.
Descrizione: La superficie del ninfeo è ornata di tessere di vari materiali. Lo sfondo è
realizzato con blu egizio mentre i dettagli cromatici sono in rosa , bianco, verde, nero,
rosso, blu. Le decorazioni sono ottenute anche con conchiglie. La malta di allentamento
era colorata in grigio, rosso e bianco. La grande quantità di frammenti rinvenuti ha
permesso la ricostruzione di buona parte del ninfeo. Quasi certamente il volume della
struttura era articolato in tre nicchie: una grande al centro separata da due semicolonne
dalle più piccole nicchie laterali. La ricca decorazione è composta da motivi vegetali
(girali di foglie d’edera o vite, ghirlande di foglie, palmette, fiori di loto) e da motivi
geometrici (losanghe, cornici a meandro). La nicchia centrale doveva essere decorata a
conchiglia a valva rovesciata, mentre ghirlande vegetali ornavano le due nicchie
laterali. Sulle semicolonne, infine, si sviluppava un tralcio continuo di foglie di vite. È
interessante la commistione tecnica di vari materiali. La struttura portante poteva essere
in laterizi e argilla cruda. La struttura doveva essere a edicola, abbastanza articolata,
con grande nicchia centrale con due colonne ai lati e un timpano. Forse c’erano altre
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
43
due nicchie ai lati di quella centrale. Probabilmente il ninfeo ornava un giardino che
doveva essere in un’area a sinistra del luogo del ritrovamento dei frammenti musivi.
Contesto: I frammenti vennero rinvenuti nell’area nord-ovest dello scavo iniziato nel
2005 e conclusosi nel 2008. La maggior parte dei frammenti derivano da depositi di
distruzione che caratterizzano lo scavo. Questi depositi sono contraddistinti da una
grande quantità di materiali edilizi, tra cui mosaici, quasi tutti con vistose tracce di
combustione dovuti probabilmente alle distruzioni di Vespasiano nel 69 d.C. . Questo
ninfeo rappresenta la più antica testimonianza di mosaico parietale della Cisalpina.
Cronologia: I sec a.C. - I sec d.C. (PASSI PITCHER et alii 2007)
Fine I sec. a.C. (BOSCHETTI, PASSI PITCHER, POLETTI 2009)
Bibliografia: PASSI PITCHER et alii 2007, pp. 361-369 ;
BOSCHETTI, PASSI PITCHER, POLETTI 2009 , pp. 343 – 348 .
Figura 43 CR10:Particolare della decorazione di una delle semicolonne. (foto di F. Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
44
Figura 44 CR10: Cerastoderma glaucum , esempio di come è stata utilizzato nella decorazione del ninfeo. (immagine
elaborata da F.Brandolini: foto della conchiglia da www.naturamediterraneo.com, foto del frammento del ninfeo di F.
Brandolini)
Figura 45 CR10: Panopea glycimeris, esempio di come è stata utilizzata nella decorazione del ninfeo. (immagine elaborata
da F.Brandolini: foto della conchiglia da www.nystmania.org, foto del frammento del ninfeo di F. Brandolini)
Figura 46 CR10: Hexaplex trunculus, esempio di come è stata utilizzata nella decorazione del ninfeo. (immagine elaborata
da F.Brandolini: foto della conchiglia da www.mineralslamacla.com, foto del frammento del ninfeo di F. Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
45
Figura 47 CR10: Ninfeo a mosaico conservato nel Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona. (foto di F. Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
46
CR11 - Plasio
Luogo del rinvenimento: Via Plasio – Via Capra.
Data: 1974
Luogo di conservazione: In loco, cortile di una scuola.
Stato conservazione: Mosaico frammentario, attualmente in fase di restauro.
Materiali: Tessere bianche e nere di 1x1 cm.
Misure: 12 x 5 m max.
Descrizione: Si tratta di un mosaico a fondo nero. La parte centrale, delimitata da una
fascia bianca, è un rettangolo in cui sono inserite tessere bianche disposte a crocetta.
Fascia ornamentale nei lati della stanza: a sud, verso via Capra, la fascia è a meandro
con svastiche alternate a quadrati centrati; a nord questa fascia segue un frammento di
mosaico di 2 m2 con motivo decorativo geometrico a quadrati, contenenti a taglio un
altro quadrato o formati da una scacchiera di piccoli quadrati bianchi e neri. I
frammenti di mosaico sono da riferire probabilmente a una stanza di rappresentanza
centrale (triclinium) con stanze di riposo (cubicula) ai lati.
Contesto: Venne rinvenuto durante lo scavo per l’installazione dell’impianto di
riscaldamento nell’edificio scolastico. Il mosaico è in fase di restaurato ed è conservato
nel cortile della scuola.
Cronologia: I sec a.C. – I sec d.C. (SCARFI’1985)
I sec d.C. – II sec d. C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: SCARFI’1985 , pp. 99-107 ;
PASSI PITCHER 2003 , pp. 165 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
47
Figura 48 CR11: Mosaico rinvenuto e conservato nel cortile della scuola di Via Plasio – Via Capra. (foto di F. Brandolini)
Figura 49 CR11: Particolare della decorazione del mosaico. (foto di F. Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
48
CR12 - Roma
Luogo del rinvenimento: Piazza Roma.
Data: 1963
Luogo di conservazione: Era esposto Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala I,
sul pavimento), ora è conservato nel deposito del Museo Archeologico San Lorenzo di
Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato da Edoardo Bernasconi nel 1963 per
S.A.L. .
Materiali: Tessere di 1 x 1 cm in marmi policromi (nero di Varenna, rosso e bianco di
Verona).
Misure: 1,97 x 1,90 m.
Descrizione: La decorazione è stilizzata, con ottagoni a lati curvi, cerchi, trecce, nodi
salomonici, semicerchi, amigdali. Il fregio marginale è purtroppo incompleto, ma si
puo’ comunque notare una doppia fascia a scacchiera di tessere bianche e nere.
Contesto: Scoperto e recuperato durante lavori edilizi.
Cronologia: Seconda metà II sec. d.C. – III sec d.C. (PONTIROLI 1974)
II sec. d.C. (PASSI PITCHER, VOLONTE’ 2001)
Terzo quarto I sec. d.C. – II sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: PONTIROLI 1974 , p .47 , n. 3(646) – TAV III ;
PASSI PITCHER , VOLONTE’ 2001 , p. 390 ;
PASSI PITCHER 2003 , p. 158 .
Figura 50 CR12: Uno dei mosaci rinvenuti in Piazza Roma. (da PASSI PITCHER 2003)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
49
CR13 – Roma, 6
Luogo del rinvenimento: Piazza Roma, stabile n. civ. 6.
Data: /
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
I, posto verticalmente sulla parete Ovest), ora è conservato nel deposito del Museo
Archeologico San Lorenzo di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato da Edoardo Bernasconi.
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: 0,86 x 0,59 m.
Descrizione: Frammento di mosaico pavimentale con motivo circolare formato da
quattro fasce concentriche di cui la più esterna toccante una tangente. La terza fascia
verso l’interno, su sfondo di tessere nere, contiene una treccia di tessere bianche
bordata da un corso di tessere nere. Nel centro del motivo circolare si sviluppano
losanghe bianche bordate di tessere nere con quadrati centrali in tessere nere.
Contesto: Scoperto e recuperato durante lavori edilizi.
Cronologia: I-II sec. d.C. (PONTIROLI 1974)
Terzo quarto I sec. d.C. – II sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: PONTIROLI 1974 , p. 55 , n. 12 (637) – TAV XVI ;
PASSI PITCHER 2003 , p. 158 .
Figura 51 CR13: Mosaico rinvenuto in Piazza Roma in prossimità dello stabile al n. civ. 6. (da PONTIROLI 1974)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
50
CR14 - Roma, 7
Luogo del rinvenimento: Piazza Roma, n. civ. 7.
Data: /
Luogo di conservazione: Era esposto Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala I,
posto verticalmente sulla parete Ovest), ora è conservato nel deposito del Museo
Archeologico San Lorenzo di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato da Edoardo Bernasconi.
Materiali: Tessere in marmo nero di Varenna, rosso di Verona, bianco bresciano e
corallo.
Misure: 0,39 x 0,77 m.
Descrizione: L’impianto decorativo prevede ai lati del lacerto musivo un poligono
incompleto con fascia a treccia composta da tessere rosse, bianche, nere e corallo.
Contesto: Scoperto e recuperato durante lavori edilizi.
Cronologia: I-II sec. d.C. (PONTIROLI 1974)
Terzo quarto I sec. d.C. – II sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: PONTIROLI 1974 , p. 54 , n. 13 (636) – TAV XVI ;
PASSI PITCHER 2003 , p. 158 .
Figura 52 CR14: Mosaico rinvenuto in Piazza Roma in prossimità dello stabile al n. civ. 7. (da PASSI PITCHER 2003)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
51
CR15 – Roma, 7
Luogo del rinvenimento: Piazza Roma, n. civ. 7.
Data: /
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
I, posto verticalmente sulla parete Ovest), ora è conservato nel deposito del Museo
Archeologico San Lorenzo di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato da Edoardo Bernasconi.
Materiali: Tessere in marmo nero di Varenna e bianco bresciano.
Misure: 1,10 x 0,66 m.
Descrizione: Il frammento è decorato con un disegno geometrico a losanghe nere e
quadrati bianchi.
Contesto: Rinvenuto e recuperato durante lo scavo per le fondamenta dello stabile al
civ. n. 7.
Cronologia: I-II sec. d.C. (PONTIROLI 1974)
terzo quarto I sec. d.C. – II sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: PONTIROLI 1974 , p. 56 , n. 14 (635) – TAV XVII ;
PASSI PITCHER 2003 , p. 158 .
Figura 53 CR15: Mosaico rinvenuto in Piazza Roma in prossimità dello stabile al n. civ. 7. (da PASSI PITCHER 2003)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
52
CR16 – Roma 7
Luogo del rinvenimento: Piazza Roma, civ. n. 7.
Data: /
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
I, posto verticalmente sulla parete Ovest), ora è conservato nel deposito del Museo
Archeologico San Lorenzo di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato da Edoardo Bernasconi.
Materiali: Tessere rosse, bianche e nere.
Misure: 0,61 x 0,48 m.
Descrizione: Frammento di mosaico pavimentale decorato a ottagoni concentrici, di cui
uno a treccia, racchiudenti al centro una rosetta di otto petali di tessere bianche con
seme centrale circolare.
Contesto: Scoperto e recuperato durante lavori edilizi.
Cronologia: I-II sec. d.C. (PONTIROLI 1974)
Terzo quarto I sec. d.C. – II sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: PONTIROLI 1974 , pp. 56-57 , n. 15 (634) – TAV XVII ;
PASSI PITCHER 2003 , p. 158 .
Figura 54 CR16: Mosaico rinvenuto in Piazza Roma in prossimità dello stabile al n. civ. 7. (da PASSI PITCHER 2003)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
53
CR17 – Roma 7
Luogo del rinvenimento: Piazza Roma, ex casa ing. Piazza, civ. n. 7.
Data: 20 gennaio 1956
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
VIII, parete Nord), ora è conservato nel deposito del Museo Archeologico San Lorenzo
di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato da Edoardo Bernasconi.
Materiali: Tessere di 1 cm2 ca. in marmo nero di Varenna, bianco di Verona, giallo di
Verona, rosso di Verona.
Misure: 2,20 x 1,30 m max.
Descrizione: La decorazione comprende una fascia con seminato di tessere nere sparse
irregolarmente, seguita da una fascia di tessere bianche. Il bordo della parete più interna
è decorato con triangoli neri alternati, in contrasto con spazi bianchi triangolari. Segue
poi una fascia di tessere nere, una in tessere bianche e un listello in tessere nere che
chiudono come una grande cornice i motivi decorativi interni: trecce, ogiva
racchiudente foglia d’edera, parte di un poligono a lati arcuati con parte di elemento
decorativo interno, parte di un motivo circolare.
Contesto: Scoperto e recuperato durante lavori edilizi. Questo frammento di mosaico
pavimentale copriva i resti di un pavimento in cocciopesto.
Cronologia: Terzo quarto I sec. d.C. – II sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: PONTIROLI 1974, p. 69 n. 21 (628) TAV XXIV ;
PASSI PITCHER 2003 , p. 158 .
Figura 55 CR17: Mosaico rinvenuto in Piazza Roma in prossimità dello stabile al n. civ. 7. (da PASSI PITCHER 2003)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
54
CR18 – Roma, 9
Luogo del rinvenimento: Piazza Roma, ex Casa Conti, n. civ. 9.
Data: 1928
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
I, verticalmente alla parete Sud), ora è conservato nel deposito del Museo Archeologico
San Lorenzo di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato da Edoardo Bernasconi.
Materiali: Tessere bianche e nere di misura compresa tra 1 e 1,5 cm2 .
Misure: 4,45 x 4,60 m.
Descrizione: Mosaico pavimentale in tessere bianche e nere, decorato con una fascia
perimetrale a grandi quadri a scacchiera bianchi e neri. Il motivo centrale è costituito da
un grande quadrato di metri 3,40 x 3,40 con decorazione composita racchiusa in una
cornice di tessere bianche e nere (in successione: due file nere, cinque bianche, tre
nere). In mezzo al motivo centrale vi è un quadrato racchiudente un piano intrecciato. A
ogni vertice del quadrato sono disposti cerchi del diametro di metri 1,14 organizzati a
zone circolari concentriche con motivi decorativi vari (ruote dentate, strisce spezzate a
zig-zag) racchiudenti una rosetta a quattro petali. Negli spazi tra i cerchi vi è una
decorazione a losanghe racchiudenti motivi vegetali come ramoscelli e foglie d’edera.
Gli interspazi della composizione sono completati da triangoli. Nella metà dei lati del
quadrato-cornice, sono disposti rettangoli con motivo centrale a treccia. A ciascuno dei
quattro vertici vi è un quadrato racchiudente una foglia d’edera con gambo a gancio in
tessere bianche su campo nero.
Contesto: Scoperto e recuperato durante lavori edilizi.
Cronologia: II-III sec .d.C. (PONTIROLI 1974)
Terzo quarto I sec. d.C. – II sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: PONTIROLI 1974 , p. 54 , n. 8 (641) – TAV XIII ;
PASSI PITCHER 2003 , p. 158 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
55
Figura 56 CR18: Mosaico rinvenuto in Piazza Roma in prossimità dello stabile al n. civ. 9. (da PASSI PITCHER 2003)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
56
CR19 – Roma, Guarneri
Luogo del rinvenimento: Piazza Roma - Via Guarneri del Gesù.
Data: /
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
I, sul pavimento), ora è conservato nel deposito del Museo Archeologico San Lorenzo
di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato nel 1963 da Edoardo Bernasconi per
S.A.L. .
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: Due frammenti di pavimento: il primo misura 2,17 x 3,55 m mentre il
frammento angolare misura 1,17 x 1,28 m.
Descrizione: Si tratta di due frammenti di mosaico pavimentale con decorazione
geometrica ottenuta con filari di tessere nere binate, in diagonale, formanti reticolato a
losanghe con interni di tessere bianche. Il fregio perimetrale è decorato a meandro
attraverso l’impiego di tre corsi di tessere nere in ogni suo elemento compositivo. Il
frammento angolare presenta invece una decorazione a reticolo di losanghe con una
fascia perimetrale a meandri.
Contesto: Scoperto e recuperato durante lavori edilizi.
Cronologia: I sec. d.C. (PONTIROLI 1974)
Prima metà – terzo quarto del I sec. d.C. (PASSI PITCHER 2003)
Bibliografia: PONTIROLI 1974, p. 53 n. 7 (642)–TAV XII, p. 54 n. 9 (640) TAV XIV;
PASSI PITCHER 2003 , p. 159 .
Figura 57 CR19: Mosaico rinvenuto durante lavori edilizi nello stabile tra piazza Roma e via Guarneri del Gesù. (da
PONTIROLI 1974)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
57
CR20
Luogo del rinvenimento: Ignoto.
Data: /
Luogo di conservazione: Era esposto Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala I,
posto verticalmente sulla parete Est), ora è conservato nel deposito del Museo
Archeologico San Lorenzo di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario, restaurato da Edoardo Bernasconi.
Materiali: Tessere bianche e in marmo nero di Varenna.
Misure: 0,54 x 0,48 m max.
Descrizione: Frammento di mosaico pavimentale romano decorato da un campo di
tessere bianche disposte diagonalmente e da una fascia ottenuta con due corsi paralleli
di tessere bianche, seguiti da sei corsi paralleli di tessere nere e da altri due di tessere
bianche.
Contesto: /
Cronologia: /
Bibliografia: PONTIROLI 1974 p. 55 n. 10 (639) – TAV XIV .
Figura 58 CR 20: Mosaico in tessere bianche e nere, provenienza ignota. (da PONTIROLI 1974)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
58
CR21
Luogo del rinvenimento: Ignoto.
Data: /
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
I, posto verticalmente sulla parete Ovest), ora è conservato nel deposito del Museo
Archeologico San Lorenzo di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario.
Materiali: Tessere bianche e nere , frammenti di marmi colorati di diverse dimensioni.
Misure: 1,30 x 1,15 m.
Descrizione: Il mosaico pavimentale è decorato con un margine di tessere bianche in
diagonale, seguite da un doppio corso di tessere bianche parallele e da una fascia
marginale costituita da sette file di tessere nere, seguite a loro volta da un corso di
tessere bianche. Questa decorazione perimetrale fa da cornice a un campo di tessere
bianche e nere e scaglie di marmi colorati di diverse dimensioni.
Contesto: /
Cronologia: I-II sec d.C.
Bibliografia: PONTIROLI 1974 , p. 55 , n. 11 (648) – TAV XV .
Figura 59 CR21: Cornice a mosaico in tessere bianche e nere racchiudente campo decorato a tessere bianche, nere e
frammenti di marmi colorati. Provenienza ignota. (da PONTIROLI 1974)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
59
CR22
Luogo del rinvenimento: ignoto.
Data: /
Luogo di conservazione: Era esposto al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona (Sala
VIII, posto verticalmente sulla parete Sud), ora è conservato nel deposito del Museo
Archeologico San Lorenzo di Cremona in attesa di una nuova collocazione.
Stato conservazione: Frammentario.
Materiali: Tessere in marmo bianco, nero di Varenna e grigio d’Istria.
Misure: 33,5 x 33 cm.
Descrizione: L’impianto decorativo di questo lacerto di mosaico pavimentale prevede
triangoli isosceli rettangoli con vertice dell’angolo retto tangente il punto mediano della
base dei successivi. Questi triangoli sono realizzati con tessere bianche in campo nero e
racchiusi da una triplice fascia di tessere bianche disposte nell’insieme a formare tre lati
di un rettangolo. Ai fianchi dei lati maggiori di questo rettangolo vi sono, da una parte
tre corsi di tessere nere affiancate e dall’altra due corsi simili affiancati oltre i quali vi è
un campo di tessere nere poste diagonalmente.
Contesto: /
Cronologia: /
Bibliografia: PONTIROLI 1974, p. 71 n. 25 (624) TAV XXV .
Figura 60 CR22: Mosaico in tessere di marmo grigio, nero e bianco. Provenienza ignota. (da PASSI PITCHER 2003)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
60
2.2 Mosaici di Piacenza
PC23 - Benedettine
Luogo del rinvenimento: Via Benedettine, angolo via Melchiorre Gioia.
Data: 1947
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: distrutto.
Materiali: tessere bianche e nere.
Misure: 15,5 x 13,5 m.
Descrizione: Frammento di mosaico pavimentale a fondo bianco con motivi
geometrici a tessere nere.
Contesto: Rinvenuti durante uno scavo per vasche alla profondità di 3,50 m ca.
Cronologia: Prima età imperiale (MARINI CALVANI 1990a)
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 9 n. PC 01.01.031 ;
PAGLIANI 1991, p. 27.
PC24 - Camicia
Luogo del rinvenimento: Via Camicia.
Data: 1959
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: Distrutti.
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: /
Descrizione: Lacerto di mosaico pavimentale a decorazione geometrica bianca e nera.
Contesto: Ritrovati con uno scavo profondo 2 m ca.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 8 n. PC 01.01.024 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
61
PC25 - Campagna
Luogo del rinvenimento: Via Campagna.
Data: 1830
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: /
Descrizione: Due mosaici pavimentali.
Contesto: Ritrovati a 4,69 m di profondità, riferibili probabilmente a un insediamento
lungo la strada che portava a Ticinum.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 23 , n. PC 01.01.116 .
PC26 - Cavalletto
Luogo del rinvenimento: Via Cavalletto n. civ. 6, angolo via Garibaldi.
Data: 1829,1923
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: Distrutti.
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: Frammento del 1829 : 2,50 x 3,00 m ;
Frammento del 1923 : estensione inferiore a 1 m2 .
Descrizione: Due lacerti di mosaici pavimentali: quello scoperto nel 1829 aveva una
decorazione geometrica bianca e nera e venne rinvenuto sotto uno strato di resti di
combustione insieme a materiale fittile; quello scoperto nel 1923 era a fondo bianco
con decorazioni geometriche a tessere nere, tra cui una svastica.
Contesto: Scoperti in seguito a scavi per un pozzo nel 1829 e scavi per l’ampliamento
di una cantina nel 1923.
Cronologia: I-II sec. d.C. (MARINI CALVANI 1990a)
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , pp. 11-12 n. PC 01.01.047 ;
PAGLIANI 1991, pp. 30-31
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
62
PC27 - Cavalli
Luogo del rinvenimento: Piazza Cavalli.
Data: /
Luogo di conservazione: Musei Civici Palazzo Farnese, Piacenza.
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: /
Descrizione: Si tratta di un pavimento organizzato a reticolo di quadrati (contenenti
quadrati sulla punta) e di rettangoli (contenenti rombi) che cingono cassettoni riempiti
da quadrati concentrici a punta o a taglio.
Contesto: /
Cronologia: I sec d.C.
Bibliografia: GHEDINI,BAGGIO,TOSO 1998, pp. 177-188 .
Figura 61 PC27: Mosaico rinvenuto in piazza Cavalli. (da MARINI CALVANI 1990b)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
63
PC28 – Cavalli, Basamento
Luogo del rinvenimento: Piazza Cavalli, sotto il basamento del monumento equestre
di Alessandro Farnese.
Data: 1985
Luogo di conservazione: Musei Civici Palazzo Farnese, Piacenza.
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: 2 m2 ca.
Descrizione: Resto di un mosaico pavimentale.
Contesto: Rinvenuto durante gli scavi per la verifica delle condizioni del basamento
della statua equestre.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 12 n. PC 01.01.049.
PC29 – Cavalli, Gotico
Luogo del rinvenimento: Piazza Cavalli, Il Gotico.
Data: 1281
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: /
Descrizione: Lacerto di mosaico pavimentale con figura del Sole.
Contesto: Rinvenuto a ca. 7,50 m durante scavi per fondamenta.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 12 n. PC 01.01.049 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
64
PC30 – Cavalli, I.N.P.S.
Luogo del rinvenimento: Isolato tra Piazza Cavalli, Via Sopramuro, Piazzetta
S.Francesco ( Palazzo dell’ I.N.P.S.).
Data: 1938
Luogo di conservazione: Musei Civici Palazzo Farnese, Piacenza.
Stato di conservazione: Frammentario
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: 2,07 x 1,37 m.
Descrizione: Lacerto di mosaico pavimentale a fondo nero con decorazione geometrica
a tessere bianche.
Contesto: Rinvenuto durante scavi per fondamenta.
Cronologia: II sec. d.C. (MARINI CALVANI 1990a)
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 12 n. PC 01.01.052 ;
PAGLIANI 1991, p. 31 .
PC31 – Cavalli, Monumento equestre
Luogo del rinvenimento: Piazza Cavalli, presso il monumento equestre di Alessandro
Farnese.
Data: 1624
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: /
Descrizione: Resti di un mosaico pavimentale.
Contesto: Rinvenuto a 5,16 m ca. di profondità durante gli scavi per le fondamenta per
il basamento della statua.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 12 n. PC 01.01.050 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
65
PC32 – Cavour, Mazzini
Luogo del rinvenimento: Via Cavour, scuola G. Mazzini, angolo orientale del
fabbricato.
Data:1907, 1926
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: Distrutti.
Materiali: Grosse tessere in bianco e nero.
Misure: /
Descrizione: Mosaico pavimentale con decorazione geometrica bianca e nera.
Contesto: ritrovati alla profondità di 3 m ca. durante scavi per fondamenta delle
edificio scolastico nel 1907 e durante lavori di ampliamento del medesimo edificio nel
1926.
Cronologia: Prima età imperiale (MARINI CALVANI 1990a)
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 5 n. PC 01.01.14 ;
PAGLIANI 1991, pp. 24- 25 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
66
PC33 – Cavour, Romagnosi
Luogo del rinvenimento: Via Cavour, cortile dell’Istituto Tecnico G.D.Romagnosi.
Data: 1915 , 1954
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: Distrutti.
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: Un lacerto dei due aveva dimensioni maggiori di 1 m2 ca.
Descrizione: Due lacerti di mosaico pavimentale: uno decorato con un motivo a T
alternato in tessere bianche e nere, l’altro presenta una decorazione a motivi geometrici
neri su fondo bianco.
Contesto: Rinvenuti durante lo scavo per la centrale termica a una profondità di 2,30 –
3 m ca.
Cronologia: Età imperiale (MARINI CALVANI 1990a)
I-II sec d.C. (PAGLIANI 1991)
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 8 n. PC 01.01.025 ;
PAGLIANI 1991, pp. 26-27.
PC34 - Cittadella
Luogo del rinvenimento: Piazza Cittadella, area del Mercato Coperto.
Data: 1949
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: Distrutto.
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: /
Descrizione: Resti di un mosaico pavimentale romano in tessere bianche e nere.
Contesto: Ritrovato durante le fasi di un saggio geognostico.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 4 , n. PC 01.01.00 ;
PAGLIANI 1991, p. 16 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
67
PC35 – Cortile scuola G.Mazzini
Luogo del rinvenimento: Cortile della scuola G. Mazzini.
Data: 1984
Luogo di conservazione: Museo Archeologico Nazionale di Parma.
Stato di conservazione: Frammentari, vennero restaurati nel 1990.
Materiali: Tessere bianche, nere e policrome di differenti misure.
Misure: /
Descrizione: Mosaici pavimentali a decorazione geometrica e naturalistica stilizzata a
tessere bianche, nere e policrome. La decorazione è caratterizzata da motivi a grata
integranti elementi naturalistici stilizzati organizzati attorno a un tappeto centrale.
Questo lacerto musivo è da ritenere pertinente a un triclinium. Si sviluppano su due
differenti livelli ( a 2,30 m uno e 2,80 m l’altro). Alla quota di 2,60 m è stato rinvenuto
anche un lacerto di pavimento monocromo a grosse tessere nere. I numerosi
ritrovamenti di mosaici in questa zona attesterebbero la presenza di una vasta domus le
cui murature, delle quali non è stata rinvenuta traccia, sarebbero state distrutte già in età
tardo antica.
Contesto: Vennero rinvenuti durante lavori per la costruzione della centrale termica, in
parte anche con uno scavo stratigrafico fino alla profondità di 4 m .
Cronologia: Prima età imperiale (MARINI CALVANI 1990a)
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 6 n. PC 01.01.16 ;
MARINI CALVANI 1990b , p. 783 ;
PAGLIANI 1991 , p. 22 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
68
Figura 62 PC35: Mosaico rinvenuto nel cortile della scuola G. Mazzini. (da MARINI CALVANI 1990b)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
69
PC36 – Delle Grida
Luogo del rinvenimento: Piazzetta Delle Grida, perpendicolare al lato ovest di Palazzo
Gotico.
Data: 1917
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: /
Descrizione: Lacerto di mosaico pavimentale.
Contesto: /
Cronologia: Età imperiale (MARINI CALVANI 1990a)
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 12 n. PC 01.01.048 ;
PAGLIANI 1991, p. 30.
PC37 - Dezopis
Luogo del rinvenimento: Località Casa Dezopis (non identificata).
Data: /
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: /
Descrizione: Mosaico pavimentale con decorazione geometrica a tessere bianche e
nere.
Contesto: Ritrovato a 5 m ca. di profondità.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 26 , n. PC 01.01.148 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
70
PC38 - Duomo
Luogo del rinvenimento: Piazza Duomo.
Data: 1857
Luogo di conservazione: (forse) in situ.
Stato di conservazione: Frammentario.
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: Il frammento di mosaico più conservato misura 70 x 10 m. ca.
Descrizione: Vennero rinvenuti, a quote differenti, i resti di due mosaici pavimentali. Il
primo, meno conservato, è a fondo bianco con decorazione geometrica a tessere nere. Il
secondo frammento, più conservato, è pertinente a un mosaico pavimentale diviso in
due settori differenti. Nella zona d’ingresso c’era una decorazione composta di un
kantharos con girali, mentre nell’altro settore del pavimento c’era un emblema dilatato
a decorazione geometrica con ottagono centrale in cui doveva figurare un altro
kantharos. L’ambiente decorato da questo mosaico forse è da ritenere un triclinium.
Contesto: Questi frammenti di mosaico pavimentale vennero rinvenuti alla profondità
di 1,40 – 2,40 m durante gli scavi per le fondamenta della colonna in granito con la
statua di Maria Assunta in Cielo. Si ritiene che qui fossero ubicate le terme anche a
causa del rinvenimento di condutture in piombo.
Cronologia: II sec d.C. (MARINI CALVANI 1990a)
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 16 n. PC 01.01.072 ;
MARINI CALVANI 1990b , p. 783 ;
PAGLIANI 1991, p. 36 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
71
Figura 64 CR38: Disegno del 1827 che documenta il rinvenimento di mosaici e di strutture murarie in piazza Duomo.
(da PAGLIANI 1991)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
72
PC39 – Giordano Bruno
Luogo del rinvenimento: Via Giordano Bruno.
Data: 1924
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: /
Descrizione: Mosaico pavimentale romano.
Contesto: /
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 10 n. PC 01.01.038 ;
PAGLIANI 1991 , p. 30.
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
73
PC40 – Gregorio X
Luogo del rinvenimento: Via Gregorio X.
Data: 1981
Luogo di conservazione: Museo Archeologico Nazionale di Parma.
Stato di conservazione: Frammentario .
Materiali: Tessere bianche e nere e scaglie di marmi policromi .
Misure: /
Descrizione: Si tratta di lacerti di mosaici pavimentali bianchi e neri con inserti di
marmi policromi talvolta contornati da tessere di colore contrastante. Lo schema
decorativo comprende anche meandri intrecciati attorno a quadrati con punto centrale e
tessere marmoree bianche e nere nella fascia perimetrale. Durante il medesimo scavo
venne rinvenuto anche un altro mosaico pavimentale, costituito da decorazione
geometrica bianca e nera a meandri intrecciati.
Contesto: Lacerti pavimentali rinvenuti durante uno scavo stratigrafico iniziato nel
1981.
Cronologia: Età imperiale.
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 10 n. PC 01.01.040 .
Figura 65 PC40: Mosaico rinvenuto in via Gregorio X. (da MARINI CALVANI 1990b)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
74
PC41 - Legnano
Luogo del rinvenimento: Via Legnano.
Data: 1965
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: Frantumatosi durante le fasi di recupero.
Materiali: /
Misure: 3 m2 ca.
Descrizione: Mosaico pavimentale.
Contesto: Rinvenuto durante scavi per fondamenta.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 16 n. PC 01.01.071 .
PC42 - Matteotti
Luogo del rinvenimento: Via Matteotti, Palazzo Borsa Mercato.
Data: 1892 , 1949
Luogo di conservazione: Musei Civici di Palazzo Farnese di Piacenza.
Stato di conservazione: Frammentari.
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: /
Descrizione: Lacerti di mosaici pavimentali a decorazione geometrica bianca e nera.
Uno di questi, rinvenuto a circa 4 m di profondità, era a fondo bianco con fregi
policromi.
Contesto: Rinvenuti alla profondità di 2,50 - 5,00 m durante scavi per fondamenta.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 10 n. PC 01.01.037;
PAGLIANI 1991 , p. 29.
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
75
PC43 - Mazzini
Luogo del rinvenimento: Via Mazzini, angolo via Mentana.
Data: /
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: /
Descrizione: /
Contesto: /
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 10 n. PC 01.01.039 .
PC44 – Melchiorre Gioia
Luogo del rinvenimento: Via Melchiorre Gioia.
Data: 1890
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: /
Descrizione: /
Contesto: Mosaico pavimentale rinvenuto alla profondità di 4,69 m.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 10 n. PC 01.01.041 ;
PAGLIANI 1991, p. 30 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
76
PC45 – Palazzo Vescovile
Luogo del rinvenimento: Sotterraneo del Palazzo Vescovile.
Data: /
Luogo di conservazione: in situ.
Stato di conservazione: Frammentario.
Materiali: Tessere bianche.
Misure: /
Descrizione: Frammento di mosaico pavimentale monocromo bianco.
Contesto: Scoperto durante lavori di restauro.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 16 n. PC 01.01.077 ;
PAGLIANI 1991, p. 36 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
77
PC46 - Poggiali
Luogo del rinvenimento: Via Poggiali (isolato tra via Mazzini, via Poggiali, via Monte
di Pietà, via S.Eufemia).
Data: 1964
Luogo di conservazione: Musei Civici Palazzo Farnese.
Stato di conservazione: Frammentario.
Materiali: Tessere bianche e nere e tessere policrome. Rudus a doppio strato di ciottoli
e nucleus in cocciopesto dello spessore di 8 cm.
Misure: Larghezza di circa 6 m max., lunghezza non ricostruibile. L’ ambiente nel
complesso avrebbe dovuto misurare circa 30 m2.
Descrizione: Tutta la composizione è caratterizzata da una bicromia del reticolo e da
una policromia dei cassettoni. Si tratta di un mosaico d’accesso a una sala, segnato da
una lunga soglia con al centro un kantharos. Da
quest’ultimo prendono origine due girali d’andamento
simmetrico, nei cui sintetici sviluppi spiraliformi
trovano posto alternatamente una melagrana e una
foglia d’edera. In una delle foglie superstiti dei girali è
raffigurato un piccolo volatile. Il tappeto è organizzato
a cassettoni di tipo naturalistico e venne realizzato
secondo una trama geometrica piuttosto semplice
utilizzando per lo più combinazioni di quadrati tutti
uguali e disposti in file parallele. Gli intervalli tra
quadrati sono riempiti da altri quadrati di più piccole
dimensioni ed a fondo bianco contenenti rombi neri, al
cui centro è disegnato, con tessere bianche, un piccolo
fiore stilizzato. I pannelli quadrati, alternatamente a
fondo bianco e a fondo nero, sono decorati con una varietà di soluzioni floreali a
delicata policromia: fiori a quattro o sei o otto petali lanceolati bianchi, sovrapposti a
un fiore policromo di altrettanti petali; rosette plastiche policrome; fiori costituiti da
quattro petali lanceolati, impostati ora su petalo bilobato, ora su quello lanceolato.
Alcuni dei pannelli quadrati presentano al centro, al posto di un elemento vegetale, un
volatile rappresentato o su frasca o su linea di terra. Mediati da ambiente centro italico,
Figura 66 PC46: Motivi floreali della
decorazione. (da MARINI CALVANI
1990b)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
78
questi motivi figurativi ornitologici sono di probabile derivazione ellenistica e
prendono spunto da elementi programmatici della propaganda augustea. Alcuni uccelli
sono rivolti verso la soglia, verso chi entra nella sala. Questo mosaico pavimentale,
forse pertinente a un tablinum, doveva appartenere a una domus il cui impianto
originario potrebbe risalire al I-II sec. d.C. : subì modifiche e interventi di restauro
successivi di III-IV sec d.C. che suggeriscono una prolungata frequentazione
dell’edificio.
Contesto: Rinvenuti durante scavo per fondamenta alla profondità di circa 4,60 m.
Cronologia: Seconda metà I sec. d.C. (MARINI CALVANI 1990a)
I sec. a.C. – I sec. d.C. (GHEDINI,BAGGIO,TOSO 1998)
Bibliografia: MARINI CALVANI 1985, pp. 261-273 ;
MARINI CALVANI 1990a, p. 6 n. PC 01.01.018 ;
MARINI CALVANI 1990b, p. 783 ;
PAGLIANI 1991, pp. 25-26 ;
GRASSIGLI 1998 , pp. 126-127;
GHEDINI,BAGGIO,TOSO 1998, pp. 177-188 .
Figura 67 PC45: Particolare della soglia. (da MARINI CALVANI 1990b)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
79
Figura 68 PC46: Pavimento a mosaico rinvenuto in via Poggiali. (da MARINI CALVANI 1990b)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
80
PC47 – Risorgimento, Mazzini
Luogo del rinvenimento: Viale Risorgimento, scuola G.Mazzini.
Data: 1958
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: Distrutto.
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: /
Descrizione: Mosaico pavimentale romano a fondo bianco con motivi di triangoli a
tessere nere. Doveva probabilmente estendersi sotto il piano stradale che divide il
cortile della scuola dall’area di Palazzo Farnese.
Contesto: Ritrovato a tre metri di profondità durante lavori di scavo delle fondamenta
per la palestra della scuola G.Mazzini.
Cronologia: Prima età imperiale (MARINI CALVANI 1990a)
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 5 n. PC 01.01.15 ;
PAGLIANI 1991, p. 16 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
81
PC48 – Risorgimento, Melchiorre Gioia
Luogo del rinvenimento: Viale Risorgimento, Liceo Classico Melchiorre Gioia.
Data: 1913 , 1935
Luogo di conservazione: Musei Civici di Palazzo Farnese di Piacenza.
Stato di conservazione: /
Materiali: Tessere policrome di marmo e tessere bianche e nere.
Misure: Frammento a decorazione geometrica bianca e nera, 1,00 x 1,50 m
Frammento a decorazione geometrica policroma, 0,72 x 1,13 m
Descrizione: Entrambi i lacerti di mosaici pavimentali sono decorati con motivi
geometrici. Lo spazio della decorazione è stato scandito con una soluzione a cassettoni
affiancati a formare una soglia.
Contesto: Rinvenuti con uno scavo di ca. 2-3 m di profondità.
Cronologia: Prima età imperiale.
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 6 n. PC 01.01.17 .
Figura 69 PC48: Mosaico rinvenuto in viale Risorgimento. (da MARINI CALVANI 1990b)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
82
PC49 - Romagnoli
Luogo del rinvenimento: Isolato tra via Romagnoli, corso Cavour, via XX settembre,
via S. Francesco.
Data: 1959
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: /
Descrizione: Resti di mosaici pavimentali.
Contesto: /
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 11 n. PC 01.01.045 .
PC50 – S. Marco
Luogo del rinvenimento: Via S. Marco, angola Cittadella, ex Albergo S. Marco.
Data: 1935
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: Dispersi.
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: /
Descrizione: Resti di mosaico pavimentale a fondo bianco con riquadratura perimetrale
a tessere nere.
Contesto: Rinvenuto a tre metri di profondità dal piano stradale.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 8 n. PC 01.01.029 ;
PAGLIANI 1991, p. 27.
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
83
PC51 – S. Martino
Luogo del rinvenimento: Area vicina alla chiesa di S. Martino in Foro, casa del
comm. Ippolito Landi.
Data: 1614
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: /
Descrizione: Mosaico pavimentale romano.
Contesto: Rinvenuto insieme a un’ara e a un bronzetto raffigurante Mercurio.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 9 n. PC 01.01.033 ;
PAGLIANI 1991 , p. 29.
PC52 – S.Stefano
Luogo del rinvenimento: Via Scalabrini, presso la Chiesa S. Stefano.
Data: 1830
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: /
Descrizione: Lacerti di due mosaici pavimentali.
Contesto: Rinvenuti alla profondità di 5,63 m .
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 20 , n. PC 01.01.099 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
84
PC53 - Sopramuro
Luogo del rinvenimento: Via Sopramuro, Casa Tinelli, nei pressi della Chiesa di
S. Francesco.
Data: 1892
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: /
Descrizione: Frammento di mosaico pavimentale a tessere bianche e nere.
Contesto: Rinvenuto insieme a una scultura di marmo, una mano e un piede di una
statua di bronzo e monete imperiali.
Cronologia: Età imperiale
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 15 n. PC 01.01.066 .
PC54 - Taverna
Luogo del rinvenimento: Via Taverna, fabbricato scolastico di rione G. Mazzini.
Data: 1926
Luogo di conservazione: Museo Archeologico Nazionale di Parma.
Stato di conservazione: /
Materiali: Tessere bianche e nere, marmo rosso di Verona.
Misure: Il mosaico pavimentale a fondo bianco misura una larghezza massima di 4 m
ca., mentre quello a fondo nero misura una larghezza massima di 0,07 m.
Descrizione: Si tratta di mosaici pavimentali collegati da una fascia marmorea in rosso
di Verona. Il pavimento era posto su un vespaio di laterizi. La decorazione è costituita
da un mosaico a fondo bianco con fascia perimetrale nera.
Contesto: Lacerti di mosaici pavimentali scoperti durante lavori di ampliamento
dell’edificio scolastico.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 17 n. PC 01.01.085 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
85
PC55 – XX settembre, Bertola
Luogo di rinvenimento : Via XX settembre, Casa Bertola.
Data: 1861
Luogo di conservazione: Museo Civico Palazzo Farnese, Piacenza.
Stato di conservazione: /
Materiali: Tessere bianche, nere e policrome.
Misure: Emblema circolare del diametro di 1,30 m.
Descrizione: Tre fasce circolari di triangoli bianchi e neri alternati e capovolti
preludono a uno spazio circolare interno concepito come un emblema. Questo è
occupato nella parte più esterna da una larga fascia a fondo nero sulla quale è
raffigurato un sistema architettonico culminante in otto mensole sporgenti. Su ognuna
delle mensole è rappresentato un cigno bianco nell’atto di prendere il volo. Al centro è
rappresentata, su fondo bianco, la lira di Apollo con lieve policromia.
Contesto: Venne rinvenuto alla profondità di circa quattro metri.
Cronologia: I sec a.C. (MARINI CALVANI 1985)
I sec d.C. (MARINI CALVANI 1990a)
II sec d.C. (MARINI CALVANI 1992)
Epoca augustea (GHEDINI,BAGGIO,TOSO 1998)
Epoca augustea (GRASSIGLI 1998)
Bibliografia: MARINI CALVANI 1985, pp. 261-273 ;
MARINI CALVANI 1990a , p. 15 n. PC 01.01.068 ;
PAGLIANI 1991, p. 33 ;
MARINI CALVANI 1992 ;
GHEDINI,BAGGIO,TOSO 1998, pp. 177-188 ;
BAGGIO,LACHIN,TOSO 1998, pp. 351-352 ;
GRASSIGLI 1998, p. 134 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
86
Figura 70 PC55: Mosaico rinvenuto in via XX settembre. (da MARINI CALVANI 1990b)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
87
PC56 – XX settembre, Cappellotti
Luogo del rinvenimento: Via XX Settembre, Casa Cappellotti.
Data: /
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: Tessere bianche e nere.
Misure: /
Descrizione: Frammento di mosaico pavimentale a decorazione bianca e nera.
Contesto: /
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 15 n. PC 01.01.070 ;
PAGLIANI 1991, p. 33 .
PC57 – XX settembre, Cigalla
Luogo del rinvenimento: Via XX Settembre, Casa Cigalla.
Data: 1890
Luogo di conservazione: /
Stato di conservazione: /
Materiali: /
Misure: /
Descrizione: Frammento di mosaico pavimentale.
Contesto: Rinvenuto alla profondità di 3,28 m.
Cronologia: /
Bibliografia: MARINI CALVANI 1990a , p. 15 n. PC 01.01.069 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
88
3 CONCLUSIONI
I numerosi mosaici venuti alla luce nelle due colonie gemelle di Cremona e Piacenza
rappresentano solo una parte di tutta la produzione musiva attestata in Cisalpina e lungo
la via Postumia. Dall’ analisi dei sessantadue mosaici riportati nelle cinquantasette
schede del catalogo, emergono alcuni dati significativi circa l’arte musiva delle colonie
gemelle di Cremona e Piacenza. Per l’ambito cremonese sono stati presi in
considerazione ventisette mosaici divisi in ventidue schede, mentre per la città emiliana
le schede e i mosaici sono trentacinque. Bisogna, però, precisare che per tredici
mosaici piacentini abbiamo notizia della loro scoperta ma in seguito andarono distrutti
o dispersi rendendo impossibile un’accurata analisi. Tolti quindi dall’analisi questi
tredici mosaici perduti, per Piacenza i mosaici studiabili sono ventidue e per le due
colonie gemelle quelli analizzabili sono quarantanove sul totale di sessantadue
catalogati. In generale, comunque, le schede dedicate alla colonia di Piacenza sono
meno ricche di particolari rispetto a quelle dei mosaici della gemella Cremona: questo è
dovuto a una disparità di pubblicazioni disponibili, più cospicue per la colonia
cremonese che non per quella piacentina.
A Cremona i reperti musivi coprono un arco cronologico che va dall’inizio dell’età
imperiale ai primi anni del III sec. d.C. e pare esserci uno iato assoluto di rinvenimenti
per tutto il III sec. d.C. . L’ unica attestazione per il IV sec. d.C. è un mosaico
tardoantico che fu rinvenuto nella zona del Duomo (CR07) 28
. Nella colonia di
Piacenza, invece, i reperti musivi sono attestati in un periodo compreso tra la fine del I
sec. a.C. e il II sec. d.C. . E’ necessario sottolineare, però, che anche il dato cronologico
è inficiato dalla differenza di documentazione disponibile per le due colonie, visto che
per Piacenza ben ventuno mosaici su trentacinque non sono stati datati. Oltre ai tredici
mosaici perduti, infatti, per altri otto non è stata indicata una possibile cronologia, forse
perché troppo frammentari. A Cremona, invece, soltanto due mosaici non sono stati
datati, mentre per gli altri venticinque è stata proposta una cronologia.
I dati ottenuti dall’ analisi delle testimonianze d’arte musiva delle colonie gemelle sono
stati raccolti nella tabella, alla pagina seguente, divisa in colonne dedicate alla cromia,
28
PASSI PITCHER 1996, p. 108.
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
89
ai motivi decorativi ricorrenti nei frammenti musivi e alla destinazione d’uso degli
ambienti decorati dai mosaici.
Tabella 1 Dati emersi dall'analisi dei mosaici raccolti nel catalogo. (elaborazione di F. Brandolini)
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
90
Come si può notare , prima di tutto e per quanto riguarda la cromia, quasi tutti i mosaici
considerati sono realizzati con tessere bianche e nere. Pochi sono i lacerti musivi in cui
la decorazione è resa con tessere policrome e spesso queste, ove presenti, sono
utilizzate solo per alcuni elementi figurativi. Sono, pertanto, assai rare le testimonianze
di mosaici in cui prevalga l’uso uniforme di tessere policrome. Soltanto un mosaico dei
sessantadue considerati è completamente monocromo bianco (PC45). Per quanto
concerne la decorazione, la maggior parte dei lacerti musivi sono decorati con elementi
geometrici combinati tra loro come rombi, rettangoli, semicerchi, triangoli, quadrati.
Considerando, in percentuale, i dati sull’arte musiva delle colonie gemelle che
emergono dalle quarantanove schede analizzate si può dire che per il 93% si tratta di
mosaici bicromi bianchi e neri dei quali il 30 % presenta anche una lieve policromia
negli elementi decorativi. Le decorazioni utilizzate nella composizione dei mosaici
presentano, nel 89% dei casi, elementi decorativi geometrici di cui solo un terzo sono
combinati anche con elementi decorativi figurativi.
Esaminando, però, le due colonie singolarmente, i dati percentuali raccolti mutano
sensibilmente. L’incidenza di mosaici bicromi, per ogni singola colonia, non si discosta
molto dal dato emerso dall’analisi complessiva delle due colonie gemelle: a Cremona
sono il 92% ed a Piacenza il 95% . Per quanto riguarda la presenza di policromia degli
elementi decorativi nei mosaici bicromi, l’incidenza rilevata, invece, è quasi doppia a
Cremona (40%) rispetto a Piacenza (23%). Lo stesso dato emerge quando si considera
la frequenza di mosaici in cui gli elementi decorativi geometrici sono combinati anche
con elementi decorativi figurati: a Cremona questo avviene nel 42% dei casi e a
Piacenza nel 22%. Le discordanze nei dati considerati per singola colonia, sono in parte
dovute alla differenza di materiale schedato a disposizione per le due città, sia di
ordine numerico (per Piacenza ventidue schede mentre per Cremona ventisette) sia
contenutistica (più dettagliate le schede dei mosaici cremonesi rispetto a quelli
piacentini).
L’ analisi dei mosaici delle due colonie gemelle, cosi come tutti quelli della Cisalpina,
appare facilitata dal loro carattere prettamente geometrico. I mosaici figurati
consentono di ricavare molte informazioni sullo status sociale, sul livello culturale e
sulla personalità del committente, ma sono soprattutto i mosaici geometrici a fornire
utili indicazioni sullo stile e sulla provenienza degli artigiani operanti in un sito. Dall’
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
91
esame di mosaici a decorazione geometrica emergono anche importanti dati sul tipo di
scansione pavimentale adottata, sulla predilezione per determinate forme geometriche e
sugli elementi decorativi scelti per la creazione del mosaico stesso 29
.
Gli elementi figurativi più comuni e riscontrati nei mosaici piacentini e cremonesi
provengono dal mondo vegetale e animale e solo in cinque casi vengono rappresentati
oggetti, ovvero quattro kantharoi e una lira. Il kantharos è un motivo decorativo che
richiama simbolicamente Dioniso e le pratiche del simposio e, forse proprio per questo,
non è accidentale che venga rinvenuto in tre casi su quattro come decorazione di
ambienti di rappresentanza di domus private: due triclinia (CR01, PC38) e un tablinum
(PC46). La lira, invece, simbolo che allude ad Apollo30
, compare solo una volta in uno
splendido mosaico circolare (PC55) la cui forma ha fatto ipotizzare una possibile
pertinenza ad un ambiente con copertura a cupola31
la cui destinazione d’uso non è
stata ancora identificata con certezza. Le decorazioni antropomorfe sono accertate
soltanto in due casi e sono riconducibili a immagini allegoriche (CR05A) oppure a
scene mitologiche (CR04B).
Lo spazio della decorazione appare prevalentemente organizzato a cassettoni (CR01,
PC48), sia nella variante a reticolo di quadrati (PC46) sia nella variante a reticolo di
quadrati e rettangoli (CR05B, PC27). Quale che sia lo schema organizzativo adottato
nella composizione, si possono trovare combinati tra loro sia elementi decorativi
geometrici sia elementi decorativi figurativi. Solo per dieci mosaici, di cui sette
cremonesi e tre piacentini, è stato possibile riconoscere la destinazione d’uso
dell’ambiente che decoravano. Infatti, oltre ai già citati tre ambienti decorati dai
kantharoi, sono stati riconosciuti altri tre triclinia, due a Cremona (CR05A,CR11) e
uno a Piacenza (PC35), poi un corridoio, un atrio e una soglia tutti pertinenti a una
domus cremonese (CR04) ed infine, un ninfeo in piazza Marconi a Cremona (CR10).
Tale ninfeo a mosaico rappresenta un unicum in questa analisi, poiché non si tratta di
un mosaico pavimentale e tutta la ricca decorazione è caratterizzata da una uniforme e
vivace policromia, composta non solo da tessere musive ma anche da conchiglie ed
elementi in pasta vitrea. La maggior parte dei frammenti proviene da grandi depositi di
29
BAGGIO, LACHIN, TOSO 1998 p. 351. 30
GRASSISLI 1998, p. 134 . 31
GRASSISLI 1998, p. 313 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
92
distruzione contraddistinti da ingenti quantità di materiali edilizi, quasi tutti con vistose
tracce di combustione. Si tratta dei resti lasciati dalla distruzione ad opera delle truppe
vespasianee che, nel 69 d.C., per quattro giorni, misero a ferro e fuoco la città
cremonese. Questo ninfeo, datato al I sec a.C., è ritenuto il più antico esempio di
mosaico parietale in Cisalpina32
. I frammenti del ninfeo a mosaico sono stati rinvenuti
durante gli scavi in piazza Marconi iniziati nel maggio 2005. Le prime indagini
archeologiche in questa piazza risalgono al 1983 quando vennero iniziati lavori
preventivi per un’opera di riqualificazione dell’area che prevedeva, tra l’altro, la
costruzione di un parcheggio sotterraneo. Durante l’ultima campagna di scavo, tra il
2005 e la primavera del 2008, sono emersi ulteriori importanti dati sulle fasi di vita
della città, dai primi anni di fondazione sino ai nostri giorni33
.
Le differenze delle due colonie gemelle nell’arte musiva sembrano, comunque,
abbastanza esigue e, quindi, consistenti appaiono le analogie al punto che, in alcune
pubblicazioni34
, è perfino ipotizzata l’esistenza di un possibile “gusto di sito” proprio
dell’area piacentino-cremonese. In questi studi sulla via Postumia e sulle città da essa
attraversate, si è, infatti, notato come questa importante strada romana svolgesse un
evidente ruolo attivo nella circolazione di merci e di cultura, ma, per quanto riguarda
l’arte musiva, non sembra che costituisse un vettore privilegiato di diffusione35
. Nelle
aree attraversate dalla via Postumia, i mosaici rinvenuti consentono piuttosto di
ipotizzare l’esistenza di diverse aree produttive, topograficamente vicine e
caratterizzate da strette analogie: tale situazione sembra verificarsi proprio a Cremona e
a Piacenza.
Particolarmente importante è ciò che emerge dal confronto tra il mosaico pavimentale
di via Poggiali a Piacenza (PC46) con la cornice a mosaico di un pavimento della
domus del Labirinto di via Cadolini a Cremona (CR04E). Il mosaico piacentino è
collocabile in un periodo a cavallo tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. . La datazione del
reperto cremonese è stata riveduta di recente e sembra essere molto vicina a quella del
mosaico di Piacenza. Infatti si è spesso ipotizzato che il complesso di via Cadolini fosse
databile a un periodo compreso tra I e II sec. d.C., ma ultimamente si ritiene più
32
BOSCHETTI, PASSI PITCHER, POLETTI 2009 p. 344 . 33
PASSI PITCHER et alii 2007 pp. 361-362 . 34
in particolare GHEDINI, BAGGIO, TOSO 1998 e BAGGIO, LACHIN, TOSO 1998 . 35
GHEDINI, BAGGIO, TOSO 1998 p. 177 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
93
verosimile considerare una cronologia compresa tra la tarda età repubblicana e il primo
Impero. Questa nuova ipotesi di datazione è supportata sia dal fatto che il complesso
della domus del Labirinto venne rinvenuto sotto uno strato di bruciato pertinente, forse,
alle distruzioni vespasianee (69 d.C.), sia da numerose attinenze stilistiche che
emergono dal confronto con un’analoga cornice mosaicata di una domus, databile ad
età augustea, scoperta con i recenti scavi di piazza Marconi 36
. Nonostante siano state
notate molte affinità decorative tra i due reperti musivi, difficilmente può trattarsi dell’
opera della stessa bottega in quanto vi sono evidenti differenze nei due reperti musivi
per quanto riguarda l’organizzazione dello spazio e l’impaginazione dei cassettoni37
.
Figura 71 Elementi decorativi fitomorfi che si ripetono sia nella cornice a mosaico da via Cadolini (a sinistra) sia nel
pavimento mosaicato da via Poggiali (a destra). (immagine elaborata da F. Brandolini)
Le analogie sono, però, cospicue in quanto compaiono identici elementi decorativi
fitomorfi a suggerire evidentemente l’applicazione di un medesimo bagaglio tecnico
artistico da parte di un artigiano piacentino operante a Cremona38
. Anche nella cornice
a mosaico di via Cadolini compaiono, infatti, sia le rosette a quattro petali (posti sulla
diagonale) e quattro foglie lanceolate (nell’asse) sia i fiori con petali bilobati e
lanceolati.
36
BUGINI, FOLLI, PASSI PITCHER 2009 p. 201. 37
GHEDINI, BAGGIO, TOSO 1998 p. 181 . 38
BAGGIO, LACHIN, TOSO 1998 p. 351 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
94
I motivi decorativi più originali rilevati nei due reperti musivi paiono essere gli ottagoni
a lati inflessi sulle cui diagonali si impostano quattro foglie d’edera “che potremmo
ritenere creazione originale della bottega piacentina che ritorna solo a Cremona”39
.
Questo particolare motivo decorativo compare infatti sia nei cassettoni del pavimento
piacentino che nella cornice mosaicata cremonese, e non sembra sia attestato in nessun
altro mosaico della Cisalpina, a tal punto da far ipotizzare che potesse essere il motivo
firma della bottega 40
.
Mi pare interessante notare che lo stesso motivo decorativo sembra ricomparire, seppur
con qualche differenza e in una resa più incerta, circa due secoli dopo nel mosaico
tardoantico databile al IV-V sec d.C. rinvenuto in piazza Duomo a Cremona (CR07).
Il disegno di base, un ottagono a lati inflessi con foglie d’edera su quattro apici
angolari, è sostanzialmente lo stesso.
Figura 72 Il motivo decorativo dell'ottagono a lati inflessi riscontrato in tre dei mosaici analizzati.
(immagine elaborata da F. Brandolini)
Le varianti applicate nel mosaico tardoantico consistono, prima di tutto, nell’aver
ruotato il rombo inscritto nell’ottagono di 45° rispetto ai due esemplari musivi più
antichi e nella sostituzione, negli apici angolari dell’ottagono combacianti con i vertici
del rombo, del motivo circolare con due biforcazioni lineari a spirale. Le uniche
aggiunte evidenti sono una crocetta all’interno del rombo a lati inflessi, derivata forse
dal fatto che questo mosaico pare pertinente ad ambienti di una chiesa paleocristiana,
nonché trattini neri vicino alle foglie d’edera.
39
GHEDINI, BAGGIO, TOSO 1998 p. 180 . 40
GHEDINI, BAGGIO, TOSO 1998 p. 181 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
95
Analizzando lo schema decorativo dei tre lacerti musivi in questione, emerge un altro
dato rilevante: nel mosaico piacentino di via Poggiali questo particolare elemento
decorativo ottagonale compare solo in due dei ventiquattro riquadri che si sono ben
conservati fino a noi. Nel lacerto musivo cremonese di via Cadolini, invece, l’ottagono
a lati inflessi decora solo alcuni dei riquadri di una cornice mosaicata di un ricco
pavimento in opus sectile. Per quanto riguarda il mosaico paleocristiano, invece, lo
spazio della decorazione è organizzato a reticolo di quadrati e poligoni ottagonali uniti
da un motivo continuo a treccia. All’interno dei poligoni ottagonali compaiono nodi
salomonici inscritti in cerchi concentrici oppure il motivo a ottagoni a lati inflessi
incorniciato da un tralcio continuo di foglie e boccioli di fiori. Si nota, dunque, come
nel mosaico tardoantico questo motivo decorativo acquisisca quasi un ruolo da
“protagonista” nella decorazione del mosaico pavimentale, a differenza dei due mosaici
più antichi dove era utilizzato principalmente come motivo di complemento, soprattutto
nella cornice a mosaico di via Cadolini. Se la somiglianza tra questi motivi decorativi,
così distanti nel tempo, fosse confermata da studi futuri, potrebbe diventare
particolarmente stimolante verificare come e se un motivo decorativo così unico e
specifico dell’area cremonese-piacentina, possa essere sopravvissuto così a lungo e
motivare, quindi, ulteriormente l’ipotesi di una possibile cultura musiva propria delle
due colonie gemelle.
I legami fra la tradizione musiva di Piacenza e quella di Cremona si evidenziano
ulteriormente prendendo in esame e confrontando il lacerto di mosaico pavimentale di
piazza Cavalli a Piacenza (PC27) con il frammento di un mosaico pavimentale di
un’altra domus di via Cadolini a Cremona (CR05B). In questo caso, l’esemplare
piacentino è anteriore (I sec. d.C.) rispetto a quello cremonese (II sec. d.C.). Il mosaico
pavimentale piacentino e quello di via Cadolini a Cremona condividono un analogo
impianto decorativo e si differenziano solo per minimi particolari41
. Anche nel reperto
cremonese infatti, compare il reticolo a quadrati (contenenti quadrati) e a rettangoli
(contenenti rombi) racchiudente cassettoni a quadrati concentrici.
41
BAGGIO, LACHIN, TOSO 1998 p. 351.
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
96
Nel mosaico di Cremona le uniche differenze consistono nell’aggiunta di quattro
triangoli neri entro i cassettoni e la posizione di taglio anziché di punta dei quadrati
all’interno del reticolo42
.
Figura 73 I due lacerti di mosaico pavimentale da Cremona (sopra) e Piacenza (sotto) con impianto decorativo quasi
identico. (immagine elaborata F.Brandolini)
Lo stretto rapporto tra Piacenza e Cremona nell’ambito dell’arte musiva pare evidente e
l’analogia che accomuna questi due siti è ancor più chiara se si confrontano le soluzioni
adottate in queste due colonie con quelle attestate all’estremità orientale della via
Postumia, ad Aquileia. Sia a Piacenza sia a Cremona, lo schema a cassettoni è
documentato in varianti che non compaiono ad Aquileia dove è, invece, attestata più
volte la soluzione a reticolo di quadrati contenenti quadrati orizzontali anziché sulla
punta. Altra incongruenza di stile è rappresentata dall’uso dell’esagono che è uno degli
elementi prediletti nelle composizioni aquileiesi, ma quasi completamente assente nei
mosaici piacentini e cremonesi43
.
42
GHEDINI, BAGGIO, TOSO 1998 p. 181. 43
GHEDINI, BAGGIO, TOSO 1998 p. 184 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
97
Anche se non può suffragare appieno la tesi sostenuta della presenza di un gusto di sito
nelle colonie gemelle, appare significativo il rinvenimento nel vicus di Bedriacum44
di
un mosaico con Labirinto del tutto simile a quello rinvenuto a Cremona in via Cadolini
(CR04B). Le analogie tra il mosaico cremonese e quello di Bedriacum (oggi Calvatone,
CR) sono molte. In entrambi i mosaici il Labirinto è percorribile e bordato da una cinta
urbica con la porta rivolta verso l’ingresso nella stanza e tutti e due gli esemplari sono
da considerare pertinenti a sale di rappresentanza. Le differenze principali riguardano la
resa dei particolari.
Figura 74 Scena con il Minotauro nei due esemplari di mosaico con Labirinto: si nota come sia più particolareggiato il
mosaico cremonese (a sinistra) rispetto al mosaico di Bedriacum (a destra). (immagine elaborata da F. Brandolini)
Figura 75 Mosaico con Labirinto di Bedriacum. (da users.unimi.it/calvbedr/)
44
E’ stato pubblicato nel 2008 dall’Università degli Studi di Milano un dvd “Calvatone Bedriacum – I
nuovi scavi nella domus del labirinto (2001-2006)” a cura di M.T.Grassi .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
98
Nell’ esemplare di Bedriacum troviamo, infatti, nel riquadro centrale ed in fattura assai
incerta, la figura del Minotauro morente e la cinta muraria che borda il labirinto è molto
stilizzata. Il mosaico cremonese, invece, sembra realizzato da una mano più esperta
che, nel centro del labirinto, con viva policromia e minuzia di particolari, ha
rappresentato la scena con Teseo e il Minotauro e, con la stessa perizia tecnica, ha
disegnato una cinta urbica molto realistica.
In alcuni dei lacerti musivi delle due colonie gemelle è stata notata un’influenza
stilistica nelle decorazioni mediata da ambiente centroitalico. Tutto ciò non sorprende
ed è da mettere in relazione con le rifondazioni d’epoca augustea che interessarono
alcuni centri della Cisalpina e riversarono nell’area padana molte famiglie
centroitaliche, portatrici di una propria identità culturale e artistica. Tra i centri che
vennero rifondati da Augusto per assegnare terre ai suoi veterani, sappiamo con
certezza che vi era anche Piacenza. Proprio in alcuni mosaici piacentini si notano
queste influenze artistiche tipiche dell’area centroitalica. Infatti, l’insieme degli
elementi emersi dall’analisi del già citato mosaico pavimentale di via Poggiali (PC46),
fanno pensare all’opera di una bottega capace di una certa fantasia inventiva
(testimoniata dai particolari ottagoni a lati inflessi) ma sicuramente formata in ambito
urbano centro italico45
. Alcuni dei pannelli quadrati che decorano il pavimento
presentano, al centro, al posto di un elemento vegetale, un volatile rappresentato o su
frasca o su linea di terra. Mediati da ambiente centro italico, questi motivi figurativi
ornitologici sono di probabile derivazione ellenistica e prendono spunto da elementi
programmatici della propaganda augustea, con particolare riferimento all’ età d’oro
cantata dai poeti, con evocazioni di scene pastorali e idilliache. Nel trasferimento in
ambito privato di temi ufficiali si nota un processo di semplificazione per cui un
semplice volatile richiama interi paesaggi idilliaci46
. Un’analoga decorazione si trova,
sempre a Piacenza, nella splendida porzione centrale circolare del mosaico pavimentale
rinvenuto in via XX settembre (PC55). In questo lacerto musivo infatti, intorno alla lira
che abbiamo già considerato in precedenza in questo capitolo, si sviluppa una
decorazione di mensole su cui sono disposti splendidi cigni in una sorta di vorticosa
danza intorno al motivo centrale apollineo. Entrambi questi mosaici (PC46, PC55) sono
45
GRASSIGLI 1998 p. 127 . 46
GRASSIGLI 1998 pp. 126 – 127 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
99
databili tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. . Per quanto riguarda la gemella Cremona, motivi
decorativi ornitologici simili a quelli ritrovati a Piacenza sono riscontrabili in alcuni
frammenti di mosaici, databili al I sec. d.C., rinvenuti durante i recenti scavi di piazza
Marconi e conservati oggi nel Museo Archeologico San Lorenzo.
Figura 76 Motivi decorativi ornitologici. A sinistra particolare del mosaico PC46, al centro particolare del mosaico PC55, a
destra particolare di un frammento di mosaico con scena palustre rinvenuto in piazza Marconi a Cremona.
(immagine elaborata da F. Brandolini)
In conclusione, l’analisi compiuta sui mosaici di Piacenza e Cremona mette bene in
evidenza gli stretti legami nella produzione musiva delle due città, sia dal punto di vista
dell’applicazione di determinati schemi geometrici sia per gli elementi decorativi
utilizzati. I tassellati bicromi decorati con motivi geometrici sono la testimonianza più
consistente di cultura musiva delle due colonie. Non mancano tuttavia fantasiose e
ricercate composizioni di elementi geometrici combinati a elementi figurativi. Circa un
terzo dei mosaici, considerati in questo studio, sono caratterizzati anche da una
policromia in alcuni elementi decorativi e solo nel caso del ninfeo a mosaico (CR10) la
policromia interessa l’intero l’impianto decorativo. I ritrovamenti effettuati sono tutti da
ritenere pertinenti a quartieri residenziali, tranne forse il mosaico rinvenuto nei pressi
del Duomo di Cremona (CR07). Nei pochi casi in cui è stata riconosciuta la
destinazione d’uso degli ambienti decorati dai mosaici, si può notare chiaramente come
quelli più preziosi per materiali e perizia tecnica siano riferiti ad ambienti di
rappresentanza delle domus private mentre le zone di passaggio delle case erano
decorate con mosaici più semplici per materiale e decorazione. Il motivo a ottagono a
lati inflessi con foglie d’edera su quattro apici angolari, è la conferma di una fantasia
creativa delle maestranze locali che, seppur molto influenzate dai canoni artistici
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
100
circolanti nell’Impero, creano varianti locali nella realizzazione dei mosaici. Come era
già stato notato anche in studi precedenti, pare legittimo parlare di un “gusto di sito” 47
proprio dell’arte musiva delle due colonie gemelle, che si rifaceva senz’altro ai modelli
circolanti nel mondo romano, ma li modificava e li arricchiva con nuovi e originali
canoni artistici.
47
GHEDINI, BAGGIO, TOSO 1998 p. 185 ; BAGGIO, LACHIN, TOSO 1998 pp. 351-352 .
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
101
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
BAGGIO,LACHIN ,TOSO 1998 M.BAGGIO, M.T.LACHIN,
S.TOSO La produzione musiva nei
centri lungo la Via Postumia,
pp351-352, in F.GHEDINI Cultura
artistica lungo la via Postumia, in
Tesori della Postumia. Archeologia
e storia intorno a una grande strada
romana alle radici dell’ Europa,
Milano1998.
BOSCHETTI, PASSI PITCHER, POLETTI 2009 C. BOSCHETTI, L. PASSI
PITCHER, K. POLETTI Nuovi dati
dal ninfeo a mosaico di piazza
Marconi a Cremona in AISCOM
XIV Colloquio dell’Associazione
Italiana per lo Studio e la
Conservazione del Mosaico
(Spoleto, 7-9 febbraio 2008) a cura
di C. ANGELELLI , Tivoli 2009,
pp. 343-348.
BUGINI, FOLLI, PASSI PITCHER 2009 R. BUGINI, , L. FOLLI, L. PASSI
PITCHER La domus di via
Cadolini (Cremona): identificazione
dei “marmi colorati”del pavimento
a scaglie in AISCOM XIV Atti del
XIV Colloquio dell’Associazione
Italiana per lo Studio e la
Conservazione del Mosaico
(Spoleto,7-9 febbraio 2008) a cura
di C. ANGELELLI , Tivoli 2009,
pp. 201-204.
GHEDINI,BAGGIO,TOSO 1998 F.GHEDINI, M.BAGGIO, S.TOSO
Cultura musiva lungo la via
Postumia , in Optima Via.
Postumia, storia e archeologia di
una grande strada romana alle
radici dell'Europa. Cremona 13-
15/6/1996 , a cura di G.SENA
CHIESA e E.A.ARSLAN ,
Cremona, 1998, pp 177-188.
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
102
GRASSIGLI 1998 G. L. GRASSIGLI, La scena
domestica e il suo immaginario, in I
temi figurativi nei mosaici della
Cisalpina, Napoli, 1998.
MARINI CALVANI 1990a M. MARINI CALVANI
Archeologia. Schedario topografico
dei ritrovamenti archeologici nei
territori di Placentia e Veleia in
Storia di Piacenza. Vol.I Dalle
origini all’anno Mille, p.III, Milano
1990.
MARINI CALVANI 1990b M. MARINI CALVANI,
Archeologia, in Storia di Piacenza.
Vol I Dalle origini all’anno Mille,
p.II, Milano 1990.
MARINI CALVANI 1998 M. MARINI CALVANI, Le colonie
gemelle : Piacenza in Tesori della
Postumia. Archeologia e storia
intorno a una grande strada
romana alle radici dell’ Europa,
Milano1998, pp. 399-403.
MIRABELLA ROBERTI 1985 M. MIRABELLA ROBERTI,
Documenti paleocristiani in
Cremona,pp177-182, in Cremona
romana, Atti del Congresso storico
archeologico per il 2200° anno di
fondazione di Cremona (Cremona,
30-31 maggio 1982), a cura di G.
PONTIROLI, Cremona1985.
PAGLIANI 1991 M. L. PAGLIANI Piacenza: Forma
e urbanistica, Roma 1991.
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
103
PASSI PITCHER 1996 L.PASSI.Pitcher Cremona un
mosaico ritrovato in via
Anguissola, in AISCOM III Atti del
III Colloquio dell’Associazione
Italiana per lo Studio e la
Conservazione del Mosaico
(Bordighera, 6-10 Dicembre 1995),
a cura di F.GUIDOBALDI e
A.GUIGLIA GUIDOBALDI,
Bordighera 1996.
PASSI PITCHER 1998 L.PASSI PITCHER, Le colonie
gemelle: Cremona in Tesori della
Postumia. Archeologia e storia
intorno a una grande strada
romana alle radici dell’ Europa,
Milano1998 , pp. 404-411.
PASSI PITCHER 2003 L.PASSI PITCHER, Archeologia
della colonia di Cremona: la città
e il territorio, in "Storia di
Cremona. L'età antica”, a cura di
P. Tozzi, Azzano San Paolo (Bg),
2003, pp. 130- 200.
PASSI PITCHER et alii 2007 L.PASSI PITCHER, R.BUGINI,
C.BOSCHETTI, S.DI
MARTINO, M.ROTTOLI Un
ninfeo a mosaico da Cremona in
AISCOM XII Atti del XII Colloquio
dell'Associazione Italiana per lo
Studio e la Conservazione del
Mosaico (Padova-Brescia, 14-17
febbraio 2006) a cura di C.
ANGELELLI e A. PARIBENI,
Tivoli 2007.
PASSI PITCHER , VOLONTE’ 2001 L. PASSI PITCHER ,M. VOLONTE'
, L'edilizia residenziale di Cremona
romana: evoluzione delle strutture e
delle decorazioni alla luce delle
nuove scoperte, in Abitare in
Cisalpina. L'edilizia nelle città e nel
territorio in età romana, (Antichità
Altoadriatiche, 49), 2001, pp. 377-
397.
© Filippo Brandolini - Università degli Studi di Milano - 2009
104
PONTIROLI 1974 G. PONTIROLI Catalogo della
sezione archeologica del Museo
Civico “Ala Ponzone” di Cremona,
Milano 1974.
SCARFI’ 1985 B. M. SCARFI’, Testimonianze
artistiche della’antica Cremona:
mosaici e resti fittili di statua da via
Plasio,pp. 99-102, in Cremona
romana Atti del Congresso storico
archeologico per il 2200° anno di
fondazione di Cremona (Cremona,
30-31 maggio 1982), a cura di G.
PONTIROLI, Cremona1985.
VOLONTE’ 1998 M.VOLONTE’, in Tesori della
Postumia. Archeologia e storia
intorno a una grande strada
romana alle radici dell’ Europa, s.
V.11 , Milano 1998.