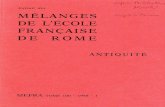The Piacenza, Bettola and Cremona Tramway Company (Limited). La sua preistoria nel dibattito dei...
Transcript of The Piacenza, Bettola and Cremona Tramway Company (Limited). La sua preistoria nel dibattito dei...
Anno CVIII - Fascicolo 2° Luglio-Dicembre 2013Sped. in A. P. - 45% - Art. 2 c. 20/b, legge 662/96 - Filiale di Piacenza ISSN 0006 - 6591
Bollettino Storico
Rassegna semestrale di storia, lettere e arte fondata da Stefano Fermi
Piacentino
Bol
lett
ino
Stor
ico
Pia
cent
ino
- An
no C
VII
I -
Fasc
icol
o 2°
-
Lugl
io-D
icem
bre
2013
BIBLIOTECA STORICA PIACENTINAnuova serie
Tip.Le.Co., Via Sisto Salotti, 37 (San Bonico), 29122 Piacenza
11. Ranieri Schìppisi, Capitoli giordaniani, 1992, 184 p.12. Giuseppe Taverna. Una giornata di studi (Piacenza, 15 maggio 1993), a cura di Gian-
marco Gaspari, 1993, 176 p.13. Giovanna Valenzano, Giuliana Guerrini, Antonella Gigli, Chiaravalle della Colomba. Il
complesso medievale, 1994, 136 p., 160 p. di illustrazioni f.t.14. Pietro da Ripalta, Chronica Placentina nella trascrizione di Iacopo Mori (ms. Pallastrelli 6),
a cura di Mario Fillìa e Claudia Binello, introduzione di Piero Castignoli, 1995, 136 p.15. Giordani letterato. Seconda giornata piacentina di studi (Piacenza, 20 maggio 1995), a cura
di Giorgio Panizza, con Bibliografia giordaniana 1974-1994 di Laura Melosi, 1996, 256 p.16. Marco Boscarelli, Istituzioni e costumi fra Piacenza e Cortemaggiore (secc. XVI-XVIII),
1996, 184 p.17. Anna Riva, La biblioteca capitolare di S. Antonino di Piacenza (secoli XII-XV), prefazio-
ne di Luciano Gargan, 1997, 328 p., 48 tavole f.t.18. Daniele Andreozzi, Piacenza 1402-1545. Ipotesi di ricerca, 1997, 206 p.19. Giacobini e pubblica opinione nel Ducato di Piacenza. Atti del Convegno, Piacenza, 27-
28 settembre 1996, a cura di Carlo Capra, 1998, 262 p.10. Fabrizio Periti, Agricoltura e istituzioni agrarie a Piacenza in età liberale. Il primo con-
sorzio agrario cooperativo (1900-1927), 1998, 216 p.11. Giordani-Leopardi 1998. Atti del Convegno nazionale di studi, Piacenza 2-4 aprile 1998,
a cura di Roberto Tissoni, 2000, 488 p.12. Marco Boscarelli, Tra i secoli XVI e XIX nei ducati di Piacenza e Parma, 2001, 174 p.13. Domenico Ponzini, Santa Giustina di Piacenza. Storia, tradizione, culto, 2001, 208 p.,
32 p. di illustrazioni f.t.14. Luigi Cassola, Il Canzoniere del codice Vaticano Capponiano 74, introduzione, testo cri-
tico e commento a cura di Giuliano Bellorini, 2002, 174 p.15. Pietro Giordani, Antonio Canova, Giovan Battista Sartori, Carteggio, edizione critica a
cura di Matteo Ceppi e Claudio Giambonini, introduzione di Irene Botta, 2004, 520 p.,85 p. di illustrazioni f.t.
17. Marco Pizzo, Un museo per la morte. Il cimitero di Piacenza, 2004, 204 p. (con 81 illu-strazioni)
18. Cose piacentine d’arte offerte a Ferdinando Arisi, a cura di Vittorio Anelli, 2005, X, 405p. (con 33 tav. a colori)
19. Bibliografia degli scritti di Ferdinando Arisi 1950-2005, a cura di Cecilia Lala, 2006, XI, 160 p.20. Stefano Fermi e il Bollettino Storico Piacentino, Giornata di studi per i cento anni del-
la rivista, Piacenza, 29 novembre 2005, a cura di Vittorio Anelli, 2006, XII, 162 p.21. Un nuovo teatro applauditissimo. Lotario Tomba architetto e il Teatro Municipale di Pia-
cenza, Atti della Giornata di studi, Piacenza, 4 dicembre 2004, a cura di Giuliana Ric-ci e Vittorio Anelli, 2007, X, 221 p.
22. Studi in onore di Alberto Spigaroli, a cura di Vittorio Anelli, 2007, X, 328 p. (con 16 tav. a col.)23. Riccardo De Rosa, Lo Stato Landi (1257-1682), 2008, XII, 275 p.24. Pietro Giordani, Panegirico ad Antonio Canova, edizione critica e commentata a cura
di Gabriele Dadati, introduzione di Fernando Mazzocca, 2008, XX, 260 p.25. Piero Castignoli, Eresia e inquisizione a Piacenza nel Cinquecento, prefazione di Adria-
no Prosperi, 2008, XVIII, 238 p.26. Erudito e polemista infaticato e infaticabile. Luciano Scarabelli tra studi umanistici e im-
pegno civile, a cura di Vittorio Anelli, 2009, XX, 412 p.27. Il Collegio Alberoni nella Piacenza tra Ancien Régime e Restaurazione, a cura di Giusep-
pe Cattanei, 2009, X, 310 p.28. Gabriele Cingolani, L’officina di Pietro Giordani, prefazione di William Spaggiari, 2009,
XXIV, 288 p.29. Medioevo piacentino e altri studi. Atti della giornata di studi in onore di Piero Castigno-
li, a cura di Anna Riva, con la bibliografia di Piero Castignoli, 2009, XII, 228 p.30. Andrea Scala, Appunti di toponomastica piacentina. Bacino del Tidone e aree limitrofe, con
un saggio di Eleonora Destefanis sul popolamento antico e medievale, 2010, X, 198 p.31. Luca Ceriotti, Storie locali. Momenti dell’iniziativa storiografica a Piacenza tra età moderna
ed epoca contemporanea, 2011, xXII, 186 p.
€ 13.00
€ 13.00
€ 26.00
€ 11.00
€ 21.00
€ 11.00
€ 21.00€ 19.00
€ 21.00
€ 19.00
€ 31.00€ 11.00
€ 19.00
€ 18.00
€ 40.00
€ 20.00
€ 25.00€ 15.00
€ 15.00
€ 20.00€ 25.00€ 22.00
€ 22.00
€ 22.00
€ 32.00
€ 25.00
€ 23.00
€ 20.00
€ 20.00
€ 20.00
Copertina N2 2013_N2 2006 25/11/13 16:17 Pagina 1
Mario Di Stefano, Quindici fiabe della tradizionepopolare piacentina raccolte da Ernesto Tammi nel 1887-1888........... 177Ugo Bruschi, All’ombra di Giulio II: il vescovo Malabaylae i capitoli di papa Della Rovere per il clero piacentino ...................... 208Giuseppe Bertini, Giulio Mazzoni (1519-1590) in una letteradi Francesco Paciotto ad Ottavio Farnese .............................................. 241Fausto Aosta, La Provincia di Piacenza dal 1860 al 1870nei verbali delle sedute consiliari ............................................................. 248Lorenzo Cantoni, The Piacenza, Bettola and CremonaTramway Company (Limited). La sua preistoria nel dibattitosui media piacentini tra 1878 e 1879..................................................... 296Umberto Fava, «Le quaranta stagioni della mia vita».Vita, opere e passione teatrale di Giancarlo Maseratie la sua Canea: una testimonianza ......................................................... 316Rassegna bibliografica ............................................................................... 327Notiziario .................................................................................................... 345
* * *Gli indici completi del Bollettino Storico Piacentino e della Biblioteca Sto-rica Piacentina sono consultabili sul sito www.bollettinostoricopiacentino.it
* * *Nei prossimi numeri: Vittorio Anelli, Per il quinto centenario della Ma-donna Sistina; Antonella Gigli, La mostra del centenario: «Un Raffaello perPiacenza. Origine e fortuna della Madonna Sistina»; David Ekserdjian, LaMadonna Sistina nell’evoluzione della Sacra Conversazione e nell’opera diRaffaello; Davide Gasparotto, La lunetta della Madonna Sistina: una pro-posta; Alessandro Malinverni, Per la vendita della Madonna Sistina: DonFilippo, Luisa Esisabetta e la Delfina di Francia; Susanna Pighi, La Ma-donna Sistina e la sua copia piacentina; Davide Parazzi, Relazione di re-stauro della copia e della lunetta della Madonna Sistina; Luca Ceriotti, Giu-seppe Costalta corrispondente di Caramuel e di Magliabechi; Angelo Ceriz-za, L’I.R. guarnigione di Piacenza nel 1848; Martino Marangon, Piacenti-ni e pavesi nella storia della protoeditoria veneta; Daniela Morsia, Tra tor-chi e trince: Giovanni Biggi (1841-1902) pioniere dell’industria meccanicapiacentina; Maria Luigia Pagliani, Una gita a Piacenza: i consigli di Giu-seppe Verdi; Anna Riva, Un falsario piacentino del secolo XVIII; Ead., Unabiblioteca privata piacentina del 1245; Piero Rizzi Bianchi, L’archivio fa-miliare Anguissola di Grazzano aggregato a quello Visconti di Modrone inMilano; Marcello Valdini, L’organizzazione psichiatrica piacentina nel secoloXIX. Appunti per una storia dei luoghi e delle persone.
INDICE DEL FASCICOLO
Euro 13.00
ASSOCIAZIONEDEGLI INDUSTRIALI
DI PIACENZA
Hanno concorso alla realizzazione dell’annata 2013del «Bollettino Storico Piacentino»:
COMUNEDI
PIACENZA
DIREZIONE E REDAZIONE: presso Archivio di Stato, Palazzo Farnese, Piazza Cit-tadella 29, 29121 Piacenza; e-mail: [email protected]: Vittorio Anelli (direttore responsabile), Carlo Emanuele Manfredi.COMITATO DI REDAZIONE: Fabrizio Achilli, Massimo Baucia, Luca Ceriotti, Anto-nella Gigli, Stefano Migliorini, Daniela Morsia, Maria Luigia Pagliani, AnnaRiva.SEGRETARIA DI REDAZIONE: Anna Riva; e-mail: [email protected] e illustrazioni, pubblicazioni da segnalare nella Rassegna bi-bliografica e comunicazioni per il Notiziario vanno inviati alla redazione,che non si considera comunque impegnata alla restituzione del materia-le anche non pubblicato.Gli autori sono responsabili della correttezza delle loro affermazioni.
EDITORE: Tip.Le.Co., Via Sisto Salotti, 37 (San Bonico), 29122 Piacenza; tel.0523380102; fax 0523380520; e-mail: [email protected]; www.tipleco.com
ABBONAMENTI PER L’ITALIA
Anno 2014: ordinari € 21,00; sostenitori € 50,00.Si accettano abbonamenti in qualunque periodo dell’anno: gli abbona-menti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l’an-no successivo. Il versamento va effettuato sul c.c. postale 10927291 inte-stato a Tip.Le.Co., Via Sisto Salotti, 37 (San Bonico), 29122 Piacenza, spe-cificando la causale.
ABBONAMENTI PER L’ESTERO
Casalini Libri, Via Benedetto da Maiano, 3, 50014 Fiesole (FI);tel. 05550181; fax 0555018201; e-mail: [email protected]; www.casalini.it.
Fascicoli non pervenuti vanno richiesti entro 30 giorni dal ricevimento delfascicolo successivo.
CAMERA DICOMMERCIOINDUSTRIA
E ARTIGIANATODI PIACENZA
FONDAZIONEDI PIACENZAE VIGEVANO
Copertina N2 2013_N2 2006 25/11/13 16:18 Pagina 2
296
THE PIACENZA, BETTOLA AND CREMONATRAMWAY COMPANY (LIMITED).
LA SUA PREISTORIA NEL DIBATTITOSUI MEDIA PIACENTINI TRA 1878 E 1879(*)
di Lorenzo Cantoni
Questo articolo presenta i primi passi del tramway Piacenza-Bettola-Cremona, da quando l’idea divenne per la prima volta pubblica a quando il progetto fu approvato dalle due amministrazioni locali competenti, il Comune e la Provin-cia, negli anni 1878-1879; tale resoconto è integrato da un’analisi dettagliata di come il progetto è stato presentato e discusso dai media locali, con attenzione ai temi trattati e agli argomenti proposti in favore del tramway.
I. Introduzione
Nella seconda metà del secolo XIX l’Italia ha assistito a una stra-ordinaria diffusione dei tramway a vapore(1), intesa a integrare il siste-ma ferroviario e a offrire alle comunità locali un mezzo di trasporto comodo e veloce. Tra le numerose città e province che svilupparono le loro linee, Piacenza inaugurò la propria esperienza tramviaria nel 1881 e la terminò nel 1967.
Questo articolo presenta un resoconto dei primi passi del tramway piacentino, da quando l’idea divenne per la prima volta pubblica, a quando il progetto fu approvato dalle due amministrazioni locali competenti: il Comune e la Provincia (anni 1878-1879); tale resoconto è integrato da un’analisi dettagliata di come il progetto è stato pre-sentato e discusso dai media locali.
Tra le ragioni di questa ricerca v’è anzitutto una carenza di studi
(*) Il testo riprende, con modifiche e integrazioni, un lavoro presentato nel 2012 dall’autore alla University of York (UK) per il conseguimento del Graduate Certificate in Transport History.
(1) Cfr. Stefano Maggi, Storia dei trasporti in Italia, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 40-48.
297
THE PIACENZA, BETTOLA AND CREMONA TRAMWAY COMPANY (LIMITED)
sul tema. Quando è stata iniziata, solo poche pubblicazioni erano disponibili in merito: un breve cenno nel volume Storia di Piacen-za. L’Ottocento(2), un volumetto fuori commercio(3), e alcune pagine illustrate incluse nella pubblicazione del bilancio 2002 della Banca di Piacenza(4). A ricerca già iniziata, un’importante pubblicazione sui tram a vapore in Piacenza, Voghera e Tortona vi ha dedicato un’intera sezione(5); essa presenta, come le precedenti pubblicazioni, il tramway in azione, ma non studia quanto avvenne nei due anni (1878-1879) nei quali il progetto fu discusso e ottenne l’approvazione delle au-torità locali. Nessuna delle ricerche disponibili, inoltre, presenta la “copertura” mediatica del progetto nel suo periodo iniziale.
Oltre alla mancanza di ricerche sul tema, anche una ragione auto-biografica si aggiunge a motivare lo studio qui presentato. Chi scrive è nato a Piacenza nel 1967, anno in cui il tramway – allora elettri-ficato e gestito da una società diversa rispetto a quella che l’aveva costruito – terminò di essere operativo. Benché il ricordo del tramway dovesse essere stato senz’altro vivace nella memoria dei piacentini (inclusi i miei famigliari e insegnanti), non ricordo che il tramway sia stato mai menzionato né a casa, né a scuola, né altrove, a indi-care una sorta d’involontaria damnatio memoriae dovuta, molto pro-babilmente, al ruolo dominante che in quegli anni stava acquisendo il trasporto su gomma. Asfalto e petrolio, bus automobili e camion avevano vinto la guerra del trasporto locale, e non vi era più spazio – né fisico né mentale – per il perdente…
L’articolo è organizzato in quattro sezioni: la prima presenta la struttura metodologica e il contesto documentale della ricerca, la se-conda studia i primi passi dell’idea/progetto di tramway tra Piacenza, Bettola e Cremona, mentre la terza analizza come questa sia stata presentata e discussa sui media locali. Un breve paragrafo al termi-ne s’incarica di proporre ulteriori ricerche, e d’indicare alcuni limiti della presente.
(2) Cfr. Carmen Artocchini, Le comunicazioni, in Storia di Piacenza, I: L’Ottocento, Piacenza, Cassa di Risparmio di Piacenza, 1980, pp. 223-234 (dei tramvai si parla alle pp. 232-233).
(3) Cfr. Giuseppe Marippi, Il Tramway a vapore in Val Nure. 1882-1982 Centenario dell’inaugurazione della linea Piacenza-Ponte dell’Olio-Bettola, Piacenza, T.E.P., 1982.
(4) Cfr. Banca di Piacenza – Relazioni e Bilancio 2002, Piacenza, Banca di Piacen-za, 2003.
(5) Cfr. Francesco Ogliari, Francesco Abate, Il tram a vapore tra l’Appennino e il Po. Piacenza, Voghera e Tortona, Milano, Arcipelago, 2011, pp. 63-106.
298
LORENZO CANTONI
II. Metodologia e contesto documentale
La ricerca è stata condotta principalmente su fonti primarie: i do-cumenti disponibili nell’Archivio di Stato di Piacenza, e le raccolte per il periodo giugno 1878-dicembre 1879 dei media piacentini attivi all’e-poca(6), due quotidiani: «Il Corriere Piacentino. Gazzetta Quotidiana della Provincia e dei Comuni» e «Il Progresso. Gazzetta di Piacenza», e due periodici: «Il Veridico. Periodico religioso, politico, letterario delle provincie di Parma e Piacenza», pubblicato settimanalmente, e «Il Piccolo. Giornale della Democrazia», pubblicato dapprima setti-manalmente e poi due volte a settimana.
Tutte le fonti sono state utili per ricostruire i primi passi del progetto del tramway, con particolare attenzione alle sue relazioni con le autorità locali che erano chiamate ad approvarlo e a cofinan-ziarlo: Comune e Provincia. Ciò è dovuto, in particolare, ai materiali disponibili in Archivio. La società che ne curò la realizzazione e ne prese la gestione iniziale era una società londinese privata, chiusa definitivamente nel 1909, quando fu rilevata da una società locale, la S.I.F.T.: Società Italiana di Ferrovie e Tramvie. Alcuni documenti della prima società – The Piacenza Bettola And Cremona Tramway Com-pany Limited – sono stati trasferiti alla società acquirente, e parte degli archivi di quest’ultima sono stati conferiti all’Archivio di Stato di Piacenza. In ogni caso, la maggior parte dei documenti disponibi-li in archivio riguardano il Comune e la Provincia, che del tramway si occuparono per dare le autorizzazioni di loro competenza, e in quanto cofinanziatori pubblici dell’impresa.
Tutti i documenti che riguardano il tramway oggetto di questo stu-dio sono conservati in quattro faldoni: due raccolgono i documenti su tutti i tramway piacentini negli anni 1878-1913, uno raccoglie i docu-menti dell’Amministrazione Provinciale in merito, e un quarto racco-glie quanto rimane dell’archivio della S.I.F.T., che a sua volta conserva alcuni documenti della società che diede vita al tramway. Di seguito i riferimenti ai quattro faldoni e le sigle con cui verranno citati:
Archivio di Stato di Piacenza, Reparto degli incarti speciali, Tram-vie a vapore, 1878-1913 (= ASPRISTV), registri 144 e 145 (già 208 e 209), d;
Archivio di Stato di Piacenza, Archivio SIFT SEA (= ASPASS);Archivio dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza, titolo IV,
classe B, sottoclasse 1, faldone 6 (= AAPP).Oltre a queste fonti, è stata studiata anche la «London Gazette»,
(6) Cfr., per una presentazione dei media piacentini dell’epoca, Corrado Sforza Fo-gliani, Il giornalismo, in Storia di Piacenza, I: L’Ottocento, pp. 507-526.
299
THE PIACENZA, BETTOLA AND CREMONA TRAMWAY COMPANY (LIMITED)
che riporta informazioni societarie rilevanti in merito alla prima so-cietà: The Piacenza Bettola And Cremona Tramway Company Limited.
I giornali sopra menzionati sono stati studiati non solo per ri-costruire i primi passi del tramway, ma anche per analizzarne la “copertura” dal momento in cui per la prima volta l’idea divenne pubblica fino a quando il progetto fu approvato – e cofinanziato – da Comune e Provincia. Sono stati studiati tutti i numeri di queste riviste, alla ricerca di ogni singola menzione del tramway in oggetto, così da poter offrire una visione completa di come il progetto è stato presentato e discusso nella stampa locale, analizzando gli argomenti a favore e quelli (invero assai pochi) contrari.
Si farà riferimento a questi giornali come segue: «Il Corriere Pia-centino. Gazzetta Quotidiana della Provincia e dei Comuni» = ICP; «Il Progresso. Gazzetta di Piacenza» = IP; «Il Piccolo. Giornale della Democrazia» = IPG(7).
III. The Piacenza Bettola and Cremona Tramway Company Limited
Anche in ragione della sua posizione geografica, nella seconda me-tà del XIX secolo Piacenza era già un centro ferroviario importante. Il 21 luglio 1859 viene aperta la linea Piacenza-Parma-Reggio-Modena-Bologna; il 19 gennaio 1860 è completato il collegamento tra Ales-sandria e Piacenza, e l’anno seguente, il 14 novembre 1861, diventa operativa anche la linea che collega Piacenza a Milano(8). Nello stesso anno 1861, il processo di unificazione politica nazionale viene com-pletato, e nel 1865 viene definita la legge per l’unificazione ammini-strativa del Regno d’Italia, il cui annesso F definisce le concessioni ferroviarie(9).
Nel 1878 viene preparata e discussa da un apposito comitato una legge intesa a definire un piano complessivo delle future ferrovie(10). Nessuno dei differenti tipi di ferrovia – definiti a seconda della prio-rità data alla costruzione, e del conseguente contributo economico a carico delle varie amministrazioni: Stato, Provincia, Comune – venne previsto nella pianificazione per Piacenza. Nonostante questa esclu-
(7) Non è stato definito alcun acronimo per Il Veridico, dal momento che non menziona mai il tramvai qui studiato. In ragione della frequenza di citazioni dei media locali, i riferimenti a questi ultimi saranno fatti direttamente nel corpo del testo e non in nota. La trascrizione dei documenti è totalmente conservativa.
(8) Cfr. Ogliari, Abate, Il tram a vapore tra l’Appennino e il Po, pp. 37-62.(9) Legge n. 2248, del 20 marzo 1865: cfr. Maggi, Storia dei trasporti in Italia, pp.
30-31.(10) Cfr. Maggi, Storia dei trasporti in Italia, p. 32.
300
LORENZO CANTONI
sione dal piano nazionale delle ferrovie, in Piacenza si cominciò a considerare l’ipotesi d’integrare le linee ferroviarie esistenti con una linea locale di tramway, da finanziare senza contributi nazionali.
Nel medesimo periodo le tramvie stavano conoscendo un notevo-le sviluppo: la prima linea extraurbana era stata aperta tra Torino e Moncalieri nel 1875, mentre la prima linea urbana, a trazione ani-male, era entrata in esercizio nella stessa Torino già nel 1872; «alla fine del 1879, dopo le prime inaugurazioni, erano in esercizio 29 linee lunghe complessivamente 515 Km: su 17 linee, dette “pirotramvie”, era già “usata la locomotiva”. L’anno dopo i chilometri erano divenuti 700, metà dei quali si trovavano in provincia di Milano»(11).
La prima comparsa del tramway nel dibattito pubblico a Piacenza è documentata da un articolo pubblicato su «Il Piccolo. Giornale della Democrazia» (IPG, 17.07.1878), che informa che lo stesso giorno la deputazione provinciale avrebbe discusso il tema di un tramway a Piacenza. L’articolo aggiunge che la proposta è stata avanzata da un giovane ingegnere piacentino, Giuseppe Manfredi(12), e che si tratte-rebbe di una linea della terza categoria di ferrovie, quelle cioè finan-ziate da capitali privati ed eventualmente con contributi comunali e provinciali. Undici giorni, e tre numeri, dopo, lo stesso giornale rife-risce che il progetto ha «fatto buonissima impressione in Piacenza; e tanto che dovunque se ne sente parlare con molto favore dal grosso capitalista al modesto borghese, e giù giù sino all’ultimo operaio» (IPG, 28.07.1878)…
Dopo questa prima, positiva, apparizione sui media locali, il te-ma del tramway rimarrà latente fino all’autunno dello stesso anno. Il 16 ottobre «Il Progresso. Gazzetta di Piacenza» (IP, 16.10.1878), e il giorno seguente «Il Corriere Piacentino. Gazzetta Quotidiana della Provincia e dei Comuni» (ICP, 17.10.1878) pubblicano una lettera di Giuseppe Manfredi indirizzata all’onorevole deputato Ernesto Pasqua-li(13) e datata 30 settembre 1878. Nella lettera, Manfredi presenta il progetto di costruire un tramway Piacenza-Bettola (da estendere fino
(11) Cfr. Maggi, Storia dei trasporti in Italia, p. 44, che cita La costruzione e l’e-sercizio delle ferrovie italiane nel 1878, in «Giornale del Genio Civile», 1880, parte non ufficiale, pp. 191-199.
(12) Giuseppe Manfredi (San Nicolò a Trebbia, 1853-Piacenza, 1912), nato da una modesta famiglia di provincia, studiò al Politecnico Federale di Zurigo (Svizzera) e in Germania. Esperto di sistemi ferroviari, fu il promotore delle linee di tramway nella provincia di Piacenza. Fu anche membro del Parlamento italiano e, nel 1900, sindaco di Piacenza. Cfr., per una presentazione biografica, la voce Manfredi, Giuseppe, in Di-zionario Biografico Piacentino (1860-1980), Piacenza, Banca di Piacenza, 2000, p. 208.
(13) Ernesto Pasquali (Piacenza, 1844-Torino, 1917), avvocato, fu eletto parlamen-tare diverse volte nell’area di Piacenza. Cfr., per una presentazione biografica, la voce Pasquali, Ernesto, in Dizionario Biografico Piacentino (1860-1980), pp. 264-265.
301
THE PIACENZA, BETTOLA AND CREMONA TRAMWAY COMPANY (LIMITED)
a Monticelli), progetto che aveva presentato al consiglio provinciale già il luglio precedente. A suo avviso, questo contribuirebbe al be-nessere dell’area, le cui condizioni economiche sono assai difficili, specialmente in ragione dell’assenza di un’adeguata infrastruttura di trasporti. La risposta di Pasquali, datata 10 ottobre 1878 e pubblica-ta sullo stesso numero de «Il Progresso» (IP, 16.10.1878), sottolinea l’importanza di un progetto simile per il commercio e per i viaggia-tori, osserva che altre città hanno già il loro tramway (Torino, Mi-lano, Cuneo e Novara), informa inoltre che il consiglio provinciale aveva già preso in considerazione di costruire un tranvai trainato da cavalli nel 1860-1861. Dichiara di essere molto felice di collaborare con Manfredi per la realizzazione di un tramway fino a Cremona, e gli offre tutti i materiali e gli elementi che aveva raccolto in tal senso. Nella stessa lettera, Pasquali avanza inoltre l’ipotesi d’istituire un comitato iniziatore dell’opera, e conclude: «Dunque coraggio ed avanti: da Bettola a Piacenza, e da Piacenza a Cremona, una stu-penda linea che darà un buon prodotto e gioverà assaissimo a tutta la nostra Provincia».
Il 21 dicembre successivo, «Il Corriere Piacentino» (ICP, 21.12.1878) informa che l’ingegner Manfredi aveva avuto un incontro con alcuni sindaci dell’area che sarebbe stata toccata dal tramway.
Molte attività devono essere state svolte nei primi mesi del 1879, sia per trovare una società disposta a finanziare il tramway, sia per convincere dell’utilità del progetto tutte le amministrazioni interessate.
Il 20 settembre 1879 il Comitato promotore scrive una lettera aperta a tutti i sindaci interessati dal progetto(14), chiedendo soste-gno per il lancio dell’iniziativa. È stato trovato un investitore inglese, che chiede solo un piccolo contributo da parte dei comuni toccati, così come – si osserva – è stato fatto anche altrove. Il 25 dello stes-so mese il consiglio comunale di Bettola vota il suo contributo per lo stabilimento della linea (IP, 26.09.1879): su un investimento previ-sto di due milioni di lire, l’azienda investitrice è disposta a coprirne 1.800.000, mentre chiede che i comuni e l’Amministrazione Provin-ciale coprano 200.000 lire, da dividersi sulla base dei loro abitanti e della loro estensione (IP, 7.10.1879; IP, 30.09.1879). Dal momento che la linea prevista è di 64 km, si tratta di un contributo di circa 3.000 lire al km: una richiesta, nota «Il Progresso» (IP, 15.10.1879), signi-ficativamente inferiore a quanto domandato dal governo nazionale
(14) Disponibile in ASPRISTV. La lettera era firmata da Ernesto Pasquali – Presi-dente, Lodovico Camia, Cesare Ghizzoni, Lodovico Pallastrelli, Alessandro Belli – Se-gretario; i comuni interessati erano, come indicato nella stessa lettera, quelli di Bettola, Ponte dell’Olio, Vigolzone, Podenzano, S. Lazzaro Alberoni, Piacenza, Mortizza, Caorso, Monticelli d’Ongina, Castelvetro Piacentino.
302
LORENZO CANTONI
come contributo chilometrico per la realizzazione di nuove ferrovie. Inoltre, l’azienda inglese chiede che il contributo pubblico venga pa-gato una volta che la linea sia stata completata, solo dopo un mese intero di funzionamento ordinario del tramway, e con la possibilità di frazionarlo in rate annuali. Di più: si prevede che almeno 600.000 lire siano pagate in salari, occupando così circa duemila lavoratori locali (IP, 16.10.1879).
A metà ottobre, «Il Corriere Piacentino» informa che già dieci comuni hanno aderito al progetto; Farini d’Olmo, che pure non sarà toccato dalla linea, ha votato un contributo, in ragione dei benefici che comunque ne ricaverà, così come espresso in una lettera del sin-daco all’ingegner Manfredi (ICP, 14.10.1879). Nel frattempo il sindaco di Piacenza aveva raccolto i contratti di concessione realizzati in altre città: Torino, Genova e Milano(15).
Il 14 ottobre il consiglio comunale di Piacenza deve discutere la proposta, ma non viene presa alcuna decisione, molto probabilmente perché nel frattempo era stata avanzata un’altra offerta(16). Il consi-glio dà dunque mandato a una piccola commissione di studiare la cosa. La commissione presenta le sue valutazioni tre giorni dopo, il 17 di ottobre, e si dichiara senza esitazioni in favore dell’offerta fat-ta dall’investitore inglese; un contributo di 32.000 lire viene quindi votato all’unanimità a favore del progetto del tramway(17). Nel giro di pochi giorni la società con sede in Inghilterra fa un primo deposito cauzionale di 8.000 lire (IP, 6.11.1879; IPG, 9.11.1879), e il 19 novem-bre anche il consiglio provinciale approva il progetto (IP, 20.11.1879; IPG, 23.11.1879). Alla fine di novembre l’ingegner Manfredi incontra tutti i sindaci coinvolti per definire nel dettaglio le quote di ciascun comune, che saranno calcolate dallo stesso ingegnere(18).
(15) Cfr. i documenti disponibili in ASPRISTV.(16) Non si sono trovati dettagli in merito a questa proposta, fatta da un tal Curci,
si tratta comunque, a detta de «Il Corriere Piacentino», di qualcosa di non veramente serio (ICP, 17.10.1879).
(17) Cfr. il resoconto della seduta nei documenti d’archivio: ASPRISTV, e sulla stam-pa: ICP, 18.10.1879; IPG, 19.10.1879.
(18) IPG, 26.11.1879 e 31.11.1879. In effetti tali contributi furono causa di problemi, e IPG, 26.11.1879 e 31.11.1879. In effetti tali contributi furono causa di problemi, e In effetti tali contributi furono causa di problemi, e anche di cause legali. Cfr., per esempio: Eccellentissima Corte di Appello di Parma, Senten-za 10-16 Settembre 1887 nella Causa della Bettola-Piacenza and Tramway Cremona Company Limited di Londra contro il Comune di Castelvetro Piacentino in punto al pagamento della quota di concorso per la formazione e l’esercizio della tramvia suddetta (Parma, Tipografia Michele Adorni, 1887), disponibile in ASPRISTV. Cfr. anche, a proposito di un’altra causa indetta per una richiesta d’indennizzo fatta dalla società in ragione di un’interruzione del servizio dovuta alla riparazione di un ponte: Consiglio Provinciale di Piacenza, Relazione intorno la proposta di transigere colla società The-Piacenza-Bettola and Cremona Company Limited la lite da questa mossa alla Provincia di Piacenza ed al Comune di Caorso in se-guito ai lavori di ristauro del ponte di Chiavenna in Caorso, 1891, disponibile in AAPP.
303
THE PIACENZA, BETTOLA AND CREMONA TRAMWAY COMPANY (LIMITED)
Il nostro racconto dei primi passi che hanno condotto alla costru-zione del tramway si conclude qui.
Nell’anno seguente, il 1880, Robert Fowler Machenzie – l’investitore inglese – istituisce una limited company per costruire e gestire la linea: The Piacenza, Bettola and Cremona Tramway Company (Limited)(19).
La società acquisisce le ulteriori autorizzazioni richieste a livel-lo nazionale, e il 16 maggio 1881 la linea Piacenza-Grazzano-Ponte dell’Olio inizia la sua operatività, l’ultimo segmento per raggiungere Bettola è completato nel 1882; in seguito si aggiungono anche il col-legamento con Cremona, e anche una linea per Rivergaro, che pure non apparteneva al progetto originario(20).
Anni dopo, e per ragioni che non sono oggetto di questa ricerca, il 19 aprile 1906 viene deciso lo scioglimento della società(21).
Il 28 dicembre 1908 la Piacenza-Bettola and Cremona Tramway Company Limited è acquistata da una nuova società, di proprietà locale: la S.I.F.T. – Società Italiana di Ferrovie e Tramvie, che acqui-sisce anche altri tramway che operano nella provincia di Piacenza(22). Il processo di acquisto sarà definitivamente perfezionato con un atto di assegnazione della prima società alla S.I.F.T., rogato dal notaio Oreste Costa di Torino e datato 27 dicembre 1909(23).
IV. Una prospettiva comunicativa
È ora il momento di accostare la vicenda appena raccontata con una prospettiva comunicativa.
(19) Cfr. la traduzione italiana del documento istitutivo e dei suoi statuti in Mini-stero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione dell’Industria e del Commercio, Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni, Roma, Tipografia Eredi Botta, 9 Agosto 1883, anno I, fascicolo XXXI, pp. 53-86.
(20) Ogliari, Abate, Il tram a vapore tra l’Appennino e il Po, pp. 70-106.(21) «The London Gazette», 24 aprile 1906, p. 2817. «The London Gazette», il 27 luglio
1906, p. 5160, scrive: «The PIACENZA BETTOLA AND CREMONA TRAMWAY COMPANY Limited. NOTICE is hereby given, in pursuance of section 142 of the Companies Act, 1862, that a General Meeting of the Members of the above named Company will be held at 72, Tooley-street, London, S.E., on the fifth day of September; 1906, at eleven o’clock in the forenoon, for the purpose of having an account laid before them, showing the manner in which the winding up has been conducted, and the property of the Company disposed of, and of hearing any explanation that may be given by the Liquidator; and also of de-termining, by Extraordinary Resolution, the manner in which the books, accounts, and documents of the Company, and of the Liquidator thereof, shall be disposed of. — Dated this 25th day of July, 1906. P. POLENGHI, Liquidator, 72, Tooley-street, London, S.E.».
(22) Cfr. Ogliari, Abate, Cfr. Ogliari, Abate, Il tram a vapore tra l’Appennino e il Po, pp. 153-198.(23) Documento raccolto in ASPRISTV.Documento raccolto in ASPRISTV.
304
LORENZO CANTONI
La storia dei trasporti è sempre stata strettamente connessa con quella della comunicazione: i veicoli trasportano beni e persone, ma anche messaggi(24). Nelle righe seguenti sono indicate alcune aree d’in-teresse, in cui la ricerca su un tramway a vapore intercetta la storia della comunicazione.
Il tramway stesso, come il treno, deve sviluppare un suo proprio codice di comunicazioni: nel 1881 viene pubblicato un libretto ad hoc con le istruzioni per i segnali(25), e una decisione del Prefetto di Piacenza, datata 5 febbraio 1884, definisce la tematica in dettaglio: l’articolo 7 riguarda il segnale del corno; l’art. 11 proibisce l’uso del fischio a vapore, riservato ai soli treni; l’art. 20 prescrive l’uso di un segnale per annunciare quando le carrozze sono al completo; l’art. 30 stabilisce la tenuta di registri conservati a cura delle stazioni e del capotreno, sui quali i clienti possono scrivere eventuali lamentele. Per non menzionare le regole che definiscono come acquisire e mantenere i documenti e le licenze di guida(26)…
L’azienda del tramway deve assicurare una corretta comunicazione con i clienti, comunicazione che include la pubblicazione degli orari e di eventuali cambiamenti di programma. In una lite con l’Ammi-nistrazione Provinciale l’azienda indica, tra le varie spese in cui è incorsa in ragione di un’interruzione di servizio non prevista, anche la pubblicazione di avvisi ad hoc(27).
Il trasporto della posta è esplicitamente menzionato come un com-pito del tramway. Tra le condizioni a cui Fowler Machenzie deve assoggettarsi per ottenere la concessione, l’articolo 32 è dedicato al servizio postale: «Il concessionario dei Tramways sarà obbligato a tra-smettere, anzi a trasportare, gratuitamente la corrispondenza postale nella misura di 40 kg per ogni treno, accompagnata da un agente del-la Amministrazione delle Poste, il cui trasporto sarà pure gratuito»(28).
(24) Per un approccio comprensivo alla tematica, cfr., per esempio, Walter Ong, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, London-New York, Routledge, 19823
(trad. it. Oralità e scrittura: le tecnologie della parola, Bologna, il Mulino, 1986); cfr. anche, con un accento sugli sviluppi recenti e sui processi di diffusione: Lorenzo Can-toni, Stefano Tardini, Internet, London-New York, Routledge, 2006, soprattutto il cap. 1.
(25) Cfr. Istruzioni pei segnali, Piacenza, Tipografia Marchesotti, 1881, disponibile in ASPRISTV.
(26) Determina del Prefetto della Provincia di Piacenza sull’esercizio delle tramvie a vapore nella Provincia di Piacenza, del 5 febbraio 1884, Piacenza, Tipi del Maino, 1884, disponibile in ASPRISTV.
(27) Consiglio Provinciale di Piacenza, Relazione intorno la proposta di transigere colla società The-Piacenza-Bettola and Cremona Company Limited cit. alla nota 18.
(28) Disciplinare del 21 agosto 1880. Corpo Reale del Genio Civile. Provincia di Pia-cenza. Circondario di Piacenza. Condizioni a cui il sig. ing. Roberto Fowler Machenzie deve obbligarsi di osservare per ottenere la concessione di stabilire ed esercitare un tramways, con trazione a vapore lungo il tratto della strada nazionale n. 20 compreso fra il bivio
305
THE PIACENZA, BETTOLA AND CREMONA TRAMWAY COMPANY (LIMITED)
Con una lettera a firma del direttore della società del tramway, ingegner Rinaldo Lusardi, datata 15 aprile 1881, il sindaco di Pia-cenza viene informato che «in evasione dell’ordinanza Prefettizia […] quest’amministrazione sta impiantando una linea telegrafica lungo la tramvia di sua proprietà. In tali lavori occorrendo collocare il fi-lo attraverso la città […] mi affretto informarne come d’obbligo la I.V.S.»(29). Così i media elettrici accompagnano già i primi passi di un tramway a vapore…
Si può notare nei documenti d’archivio anche un’interessante in-novazione tecnologica. Mentre nei primi anni i documenti sono talo-ra a stampa – come per esempio i documenti ufficiali o i formulari – oppure, più frequentemente, scritti a mano, improvvisamente, il 28 giugno 1897, la macchina da scrivere fa la sua comparsa in una lettera dell’ingegner Lusardi(30). Si deve essere trattato di un ingresso recente tra le tecnologie di una società tecnologicamente avanzata: l’archivio conserva una sua lettera dell’anno precedente (datata 12 giugno 1896) scritta completamente a mano.
Un altro tema comunicativo merita d’esser qui menzionato: la dif-ficoltà per gli italiani nello scrivere termini stranieri. In entrambe le cause sopramenzionate(31) il nome dell’azienda è riportato in modo erroneo nel titolo stesso: nella prima essa viene chiamata Bettola-Piacenza and Tramway Cremona Company Limited di Londra, scam-biando le parole Cremona e Tramway, mentre nella seconda viene chiamata The-Piacenza-Bettola and Cremona Company Limited, omet-tendo addirittura la parola Tramway. Se i termini inglesi erano così poco comuni per gli italiani del tempo, lo stesso può essere detto dei termini italiani rispetto a scrittori di lingua inglese: nel 1896 il nome della società riportato sulla London Gazette è: Piacenza Bettolla and Cremona Tramway Company Limited and Reduced(32), aggiungendo una «l» al nome di Bettola…
Oltre alle dimensioni appena menzionate, un aspetto comunicativo molto importante, che merita d’essere indagato in profondità, riguar-da il modo in cui i media del tempo hanno trattato del progetto del tramway, contribuendo così alla formazione di un’opinione pubblica in merito. Nel seguito di questo paragrafo si proporrà un’analisi del-la copertura del progetto del tramway sulla stampa piacentina tra
della strada provinciale di Ponte dell’Olio e la barriera di S. Raimondo d’ingresso alla città di Piacenza, disponibile in ASPASS.
(29) Lettera disponibile in ASPRISTV.(30) ASPRISTV.(31) Cfr. sopra, nota 18.(32) «The London Gazette», 31 gennaio 1896, p. 597.
306
LORENZO CANTONI
la metà del 1878 e la fine del 1879(33), con particolare attenzione ai contenuti presentati e agli argomenti proposti in favore della realiz-zazione della linea tramviaria (o contro di essa).
I media devono essere stati considerati assai importanti dai de-cisori del tempo, se nella lettera aperta inviata ai sindaci dei comu-ni coinvolti dal progetto del tramway il Comitato promotore scrive: «Conosciutasi la cosa in città, applaudita da tutti, incoraggiata dalla stampa cittadina»(34), considerando l’approvazione da parte della stam-pa come un importante argomento a supporto del progetto.
Conviene innanzitutto osservare che tre dei quattro giornali stu-diati hanno dedicato molta attenzione al progetto del tramway. Nel periodo considerato – da giugno 1878 a dicembre 1879 – «Il Progres-so. Gazzetta di Piacenza» ne parla venti volte, «Il Corriere Piacentino. Gazzetta Quotidiana della Provincia e dei Comuni» quindici volte, e «Il Piccolo. Giornale della Democrazia» ugualmente quindici volte, benché venisse pubblicato solo due volte alla settimana; se in taluni casi si tratta di un semplice cenno, spesso vi viene dedicato un in-tero articolo, e talora addirittura l’articolo di apertura del giornale. Un discorso a parte va fatto per «Il Veridico», giornale cattolico delle diocesi di Parma e Piacenza, che dedica uno spazio molto limitato agli avvenimenti politici e di cronaca locale, e non cita mai il pro-getto di tramway che qui ci occupa.
Tutti i temi e gli argomenti presentati possono essere suddivisi – a seconda del loro focus specifico – in otto categorie: (1) motivi economici, connessi con la promozione della ricchezza e del benes-sere; dal momento che spesso sono presentati tramite paragoni con altri luoghi, è stata creata una sezione apposita a raccogliere i (2) motivi comparativi/competitivi; (3) motivi ideologici/deterministici, che presentano l’innovazione come inevitabile, e necessariamente positi-va; (4) motivi morali: raccolgono quei temi e argomenti che sugge-riscono una sorta di superiorità morale di quanti sono in favore del progetto di tramway; questi sono in stretta relazione con le – invero assai poche – occorrenze dei punti di vista contrari al progetto: (5) argomenti contrari; (6) motivi connessi con i viaggiatori, che includo-no anche le ragioni di svago. Due ulteriori categorie raccolgono i (7) motivi connessi con l’azienda proponente, e (8) le immagini usate per presentare il tramway.
I vari temi e argomenti, naturalmente, non sono presentati in modo indipendente l’uno dall’altro, ma appaiono spesso insieme, a
(33) Cfr., per una mappa della stampa locale nel XIX secolo, Sforza Fogliani, Il giornalismo, pp. 507-526.
(34) Lettera datata 20 settembre 1879, in ASPRISTV, corsivo aggiunto.
307
THE PIACENZA, BETTOLA AND CREMONA TRAMWAY COMPANY (LIMITED)
sostenersi e giustificarsi reciprocamente. Passiamo ora in rassegna le otto categorie, presentando per ciascuna di esse alcuni esempi pa-radigmatici.
1. Motivi economici
«Il commercio, il benessere, la prosperità – in una parola: la ci-viltà – corrono e si spandono in ragione delle buone condizioni di viabilità», scrive «Il Progresso. Gazzetta di Piacenza» (IP, 30.09.1879), mentre «Il Piccolo. Giornale della Democrazia» aveva sostenuto che «La ricchezza e l’avvenire del nostro bel Paese – scrive un illustre ingegnere – risiedono almeno per 9/10 nel grande sviluppo delle linee di terz’ordine, ossia delle ferrovie d’interesse locale; – dovendosi inten-dere per tali linee quelle che saranno impiantate ed esercitate dall’i-niziativa privata, a mezzo di società private, con capitali privati, col solo concorso dei proprietari, dei capitalisti e degli industriali delle località interessate, e tutt’al più con un piccolo sussidio della Provin-cia e dei Comuni» (IPG, 17.07.1878). La popolazione è la principale fonte di lavoro, commercio, industria e ricchezza, e maggiore la po-polazione, maggiore il bisogno di mezzi di trasporto (IP, 25.10.1879).
Il commercio è frequentemente citato come un settore che trarrà beneficio dall’attivazione del tramway, e i cittadini di Piacenza sono bia-simati perché incapaci di usare il fiume Po e le linee ferroviarie come importanti strumenti d’importazione ed esportazione (ICP, 4.10.1879).
Il trasporto può ridurre le differenze economiche tra la città e le campagne circostanti; in effetti, nota «Il Corriere Piacentino», l’uni-ficazione dell’Italia sotto un’unica monarchia è stata fatta solo dalle città principali, mentre nelle campagne le persone pagano le tasse, ma non ricevono benefici corrispondenti (ICP, 9.10.1879). L’agricoltura può trarre molto vantaggio dal tramway, si sostiene in un articolo del medesimo giornale: i contadini hanno compreso che aiuta a rispar-miare tempo (e il tempo è denaro…), animali e carri non vengono danneggiati, i beni possono essere trasportati in ogni stagione, e i campi aumentano di valore (ICP, 8.10.1879).
Si osserva che una conseguenza fondamentale dell’approvazione del progetto di tramway sarà che quasi metà dei soldi investiti saran-no spesi localmente: «le guide e le macchine verranno bensì dall’este-ro, ma il resto si prenderà quì, ed almeno un milioncino resterá [sic] nella provincia, fra operai, manuali e provveditori» (IP, 8.10.1879). 600.000 lire saranno spese per impiegare circa duemila poveri lavora-tori locali, salvandoli dalla disoccupazione, e specialmente dai rigori dell’inverno (ICP, 27.09.1879; IPG, 28.09.1879, 8.10.1879, 26.11.1879; IP, 8.10.1879, 16.10.1879).
308
LORENZO CANTONI
Senza i vantaggi portati dal tramway, che aiuta ad abbandonare un contesto in cui le comunicazioni sono incomplete, insicure e trop-po costose (IP, 16.10.1879), gli abitanti «sono costretti a emigrare in massa per tutte le parti d’Europa e delle Americhe, onde procacciarsi in estranee contrade i mezzi per mantenere le loro famiglie» (ICP, 14.10.1879), scrive in una lettera all’ingegner Manfredi il sindaco di Farini d’Olmo.
Anche la pubblica amministrazione avrà benefici dal tramway, dal momento che il suo successo significherà pure più tasse (IP, 1.10.1879); per questo le istituzioni pubbliche devono contribuire alla sua realizzazione (IP, 1.10.1879): si tratta di un investimento sicuro, e anche nel caso in cui l’azienda dovesse ritirarsi, non sarà difficile trovarne un’altra che subentri nella gestione (IP, 4.10.1879). In ogni caso, i soldi pubblici sono spesso spesi per scopi molto meno impor-tanti (ICP, 23.10.1878; IP, 16.10.1879)…
«Il Corriere Piacentino» sostiene gli argomenti economici pubbli-cando statistiche straniere, tratte da un’appendice del giornale france-se «Journal des Debats» dedicata ai tramway (ICP, 19.11.1878).
I paragoni con altri contesti, sia italiani che stranieri, sono frequen-ti nei media studiati, e dovranno ora essere analizzati più da vicino.
2. Motivi comparativi/competitivi
«Il Piccolo. Giornale della Democrazia» sostiene che non vi sia centro importante senza un tramway (IPG, 8.10.1879); l’esempio di altre città – tra cui, in Italia, Torino, Milano, Cuneo – deve essere seguito (IP, 16.10.1878; ICP, 19.11.1878).
Una sorta di complesso d’inferiorità può essere notato in molte occasioni, a suggerire che gli stranieri sono più avanzati, e che i piacentini devono impegnarsi per ridurre la distanza. Per esempio, «Il Corriere Piacentino» scrive che la Francia, benché avesse avuto più problemi dell’Italia, era stata capace di ristabilirsi completamente, ma là tutti i cittadini sono patrioti, mentre in Italia «le moltitudini sono pressochè àpate, e i non molti che si preoccupano delle cose pubbliche si dividono spesso in partiti che per mancanza di nobili e grandi scopi, degenerano in sette piene d’astii personali e d’invidiòle pettegole» (ICP, 17.10.1878); i paesi stranieri – si suggerisce – so-no più avanzati tecnologicamente (ICP, 19.11.1878); la maggior parte delle tecnologie necessarie per il tramway arriveranno dall’estero (IP, 8.10.1879), e stranieri sono perlopiù (benché non tutti) gli autori ci-tati dal Pasquali come autorità nel campo (IP, 16.10.1878). I lettori sono invitati a portare l’Italia (e Piacenza) allo stesso livello delle altre nazioni europee (ICP, 14.10.1879).
309
THE PIACENZA, BETTOLA AND CREMONA TRAMWAY COMPANY (LIMITED)
«Il Corriere Piacentino» giunge a definire l’«istinto o genio di lo-comozione […] dote principale de’ popoli moderni» (ICP, 4.10.1879), un talento che deve essere ancora acquistato da Piacenza…
Questo argomento ci porta alla prossima categoria di temi, che presentano un approccio deterministico all’innovazione, vista come movimento inarrestabile di progresso.
3. Motivi ideologici/deterministici
«E noi? Noi dovremo dunque vedere languire i nostri centri prin-cipali e lasciare senza mezzi di viabilità rispondenti ai progressi at-tuali i centri minori?» (ICP, 19.11.1878) si chiede retoricamente «Il Corriere Piacentino»; in effetti il mondo «cammina come un cavallo sboccato» (ICP, 17.10.1878).
I tramway appartengono alle meraviglie del progresso (IP, 16.10.1878), «tutto in questo mondo, uomini e cose, deve obbedire alla legge fatale del progresso, nè le strade poterono, o possono esen-tarsi da cotesta regola» (ICP, 9.10.1879). Le civiltà nascono, si svilup-pano e corrono grazie ai trasporti e ai mezzi di comunicazione (IPG, 8.10.1879; IP, 25.10.1879), e il tramway è parte di questo processo, trattandosi di uno «dei più comodi e vantaggiosi mezzi di comuni-cazione e trasporto che sieno stati escogitati e attuati dall’operosità del nostro secolo, il quale ha finalmente capito che senza i grandi progressi materiali, anco i morali sempre si ritardano, e qualche volta si rendono affatto impossibili» (ICP, 27.09.1879).
Il tramway significa anche fine dell’ignoranza (IPG, 19.11.1879), al punto che «Il Progresso» scrive: «Ho letto una volta nel Corriere di Mondovì, un buon giornaletto mondovigese, che oramai il tramway è cosa popolare sicchè i bambini hanno imparato a compitare pa-pà, mamma e tramway. Allora ho riso, ma ora capisco […] che quel giornalista aveva ragione» (IP, 2.10.1879)…
Gli argomenti deterministici sono spesso presentati in negativo, come minacce nel caso in cui il processo/progresso del tramway ve-nisse rifiutato. In tal caso, «è probabile che un dì o l’altro cresca l’erba in Piazza Cavalli» (ICP, 17.10.1878), con le distanze «sussisto-no l’ignoranza, i pregiudizii, spesso la barbarie, sempre la miseria» (ICP, 7.10.1879).
4. Motivi morali
Molti degli argomenti presentati dai media sono di natura morale.L’unanimità e l’armonia sono citate più volte: tra partiti differenti,
310
LORENZO CANTONI
che pure supportano unanimemente il progetto (IP, 18.10.1879); tra diversi membri del consiglio comunale, che hanno votato all’unanimità il contributo per il tramway, come nel caso del comune di Piacenza (IP, 18.10.1879; IPG, 19.10.1879), della deputazione provinciale (IP, 13.11.1879) e del consiglio provinciale (che vota a grande maggioran-za: IP, 20.11.1879; IPG, 23.11.1879); tutti i comuni hanno approvato il progetto con grande unanimità (IPG, 19.11.1879, 17.12.1879). Al punto che «Il Piccolo. Giornale della Democrazia», nell’informare che vi era stato un incontro di tutti i sindaci coinvolti (ad esclusione di quello di Castelvetro, «gravemente impedito») con l’ingegner Manfredi per definire il contributo di ciascuna amministrazione al progetto, scrive: «Alle due la seduta è tolta in mezzo a quel cortese e lieto affiatamen-to di persone che vogliono non l’utile dei loro comuni solamente, ma il benessere di tutti, il benessere generale! E noi facciamo eco alla loro gioia; ed a loro gridiamo: avanti! Avanti sempre! Il mondo è dei coraggiosi!» (IPG, 30.11.1879). Il comune di Farini è presentato come modello di questa attitudine: anche se non sarà toccato dal tramway, vota all’unanimità un contributo per il progetto (ICP, 14.10.1879).
Non solo gli amministratori sono unanimi, ma anche i cittadi-ni: come già visto in precedenza, viene riportato che il progetto ha «fatto buonissima impressione in Piacenza; e tanto che dovunque se ne sente parlare con molto favore dal grosso capitalista al modesto borghese, e giù giù sino all’ultimo operaio» (IPG, 28.07.1878). I citta-dini hanno un grande interesse per il tramway, e quando il consiglio comunale di Piacenza ne discute, il pubblico manifesta la propria felicità per l’approvazione del progetto, e poi lascia la sala perché meno interessato alle altre tematiche in discussione (ICP, 18.10.1879).
Il tramway contribuirà all’onore e al decoro di Piacenza (IPG, 28.07.1878), la decisione in merito che prenderanno Piacenza e gli enti cointeressati «non potrà non essere splendidamente favorevole; che all’utilità evidente della cosa in sè medesima, s’unisce il lustro ed il decoro che sarà per ridondarne alla città e alla provincia tutta» (IP, 30.09.1879).
Le persone non dovrebbero buttar via giorni preziosi della loro vita, altrimenti i più furbi «emigreranno nei centri ove splende la luce della civiltà» (ICP, 19.11.1878). I piacentini non sono sufficientemente intraprendenti, e hanno paura delle innovazioni (ICP, 4.10.1879); an-che se Piacenza è tra le province più ricche del regno, questo status è solo virtuale, dal momento che i cittadini non fanno abbastanza (ICP, 4.10.1879); essere entusiasta del tramway non significa essere cieco, ma puntare a grandi risultati (IP, 25.10.1879). Senza i pro-gressi materiali non si possono raggiungere i progressi morali (ICP, 27.09.1879), e il tramway può promuovere addirittura l’educazione e l’uguaglianza (ICP, 7.10.1879, 8.10.1879).
311
THE PIACENZA, BETTOLA AND CREMONA TRAMWAY COMPANY (LIMITED)
Mentre biasima i suoi concittadini per la loro indolenza, «Il Corriere Piacentino» (ICP, 4.10.1879) scrive che nei tempi antichi – temporibus illis – non era così, ma i loro antenati erano più attivi e di più alto valore morale; i cittadini non dovrebbero accontentarsi di poco, come durante le dominazioni straniere, essi potrebbero avere molto di più. Ma la diagnosi non è completamente negativa: i giovani sembrano voler par-tecipare al movimento commerciale e industriale in corso, «Il tramway oggi progettato da Bettola al Po per Monticelli d’Ongina, e l’altro che indubbiamente in tempo non lontano si progetterà da Pianello a Piacenza sono sintomi evidenti di questo ridestarsi dell’antica e troppo lungamente assopita virtù piacentina, per forma che dobbiamo oramai vivere a buona speranza dell’avvenire e star certi che, tosto o tardi, figureremo anche noi alla pari con tutta l’altra gente del mondo civile» (ICP, 4.10.1879).
Giuseppe Manfredi è presentato come un eroe morale: è un inge-gnere – dunque appartenente a una professione che guida il progresso –, «un giovane di forte ingegno e di molto studio, già valentissimo nelle matematiche discipline» (IPG, 17.07.1878), è un piacentino (ICP, 17.10.1878) che è stato capace di trovare una «società di capitalisti inglesi» interessata a investire in Piacenza (ICP, 27.09.1879). Nella sua lettera a Pasquali, Manfredi dichiara di essere «spinto dal desiderio di contribuire, per quanto me lo permettono le mie forze al benessere del mio paese, e conscio delle difficili condizioni in cui versano il suo commercio e la sua industria» (IP, 16.10.1878).
Anche in un contesto in cui i locali – come è stato documentato più sopra – sono considerati in genere inferiori se confrontati con gli stranieri, «Il Piccolo. Giornale della Democrazia» fa appello alla virtù locale: si tratta di un «Tram piacentino, da mente piacentina ideato, si va costruendo con mezzi piacentini: e per lui gli interessi piacentini gloriosamente rifioriranno» (IPG, 19.11.1879).
L’identificazione della virtù e della moralità con il promotore dell’i-niziativa, con coloro che la sostengono, e con il tram stesso, già suggerisce che coloro che vi si oppongono sono da considerarsi mo-ralmente dalla parte sbagliata…
5. Argomenti contrari
Bisogna anzitutto osservare che i media menzionano solo in poche occasioni oppositori del progetto, suggerendo così che non sono si-gnificativi né numericamente, né culturalmente/moralmente. Si tratta infatti di «gente piccina e brontolona» (IP, 16.10.1878), di pochi «pei quali le cose nuove non sono mai serie abbastanza, ed ogni nuova idea è un’utopia» (IP, 18.10.1879), timorosi di nuovi collegamenti per-ché possibile causa di conflitti (ICP, 7.10.1879).
312
LORENZO CANTONI
«Il Piccolo. Giornale della Democrazia» insinua addirittura che i dubbi sul tramway tocchino «certe persone del timor di Dio» (IPG, 9.11.1879), un commento molto negativo dal punto di vista del giornale…
6. Motivi connessi con i viaggiatori
Benché, in generale, tutti gli argomenti presentati sopra possano essere visti in stretta relazione con i benefici dei viaggiatori, in alcuni testi se ne tratta esplicitamente.
Il tramway «allontana meno dal lavoro i cittadini, accorciando il tempo che essi debbono impiegare per recarsi dall’una all’altra lo-calità» (IP, 1.10.1879). «Dovremo noi stessi perdere giorni preziosi della nostra breve vita e logorare la nostra salute col farci trascinare per lunghe ore entro baracche sconnesse, che, scorrendo in ruvide e ghiaiose vie, cagionano una ridda nello interno dei nostri visceri?» (ICP, 19.11.1878), si chiede «Il Corriere Piacentino».
Un interessante articolo de «Il Progresso. Gazzetta di Piacenza» enumera vantaggi di natura turistica. L’autore comincia con il dichia-rare che nell’articolo del giorno precedente (IP, 1.10.1879) era stato «duro e compassato», mentre ora sarà più spigliato «Diamine sono sulla locomotiva e corro dalle amene vallate del Nure alle terre uber-tose di Caorso e di Monticelli, dalle terre classiche della rubiola e delle bondiole ai paesi del frumento e di prati, e valete [sic] che stìa duro impalato lì come un piuolo? Fossi matto! Dunque sappiate che io invece vado matto per il tramway» (IP, 2.10.1879). Quando fa cal-do a Piacenza, con il tramway potrà andare sulle colline, e fermarsi lungo il tragitto per un buon bicchiere di vino; di più: sarà possibile tornare il giorno stesso per correggere le bozze del giornale. In futuro, nel periodo di Natale, potrebbe andare a Cremona per comprar tor-roni per i suoi bambini. «E tu, lettore, non hai famiglia? Non pensi che con poche lire potevi far fare alla moglie ai figli e alla serva una buona scampagnata al dì della madonna del Rosario e al giorno di Santa Rosa spendendo poche lire e impiegando poco tempo? Vada-no pure gli speculatori a trovarmi il vantaggio dei commercianti: mi dicano gli economisti tutto il bene che economicamente può derivare dal tramway, io dico sempre che il cagionamento [sic] è in completo [sic] perché si dimentica questo gran beneficio della buona boccata d’aria, dei torroni della mostarda e della scampagnata» (IP, 2.10.1879).
Un tale approccio turistico/edonistico non occorre altrove, se non per un breve cenno che ne fa «Il Piccolo. Giornale della Democra-zia», che si augura venga presto «il giorno, in cui si possa tranquil-lamente e prestamente scarrozzarcela da Piacenza a Bettola etc…» (IPG, 16.11.1879).
313
THE PIACENZA, BETTOLA AND CREMONA TRAMWAY COMPANY (LIMITED)
7. Motivi connessi con l’azienda proponente
Trattando della società investitrice, «Il Progresso» sottolinea che la sua richiesta di supporto pubblico è molto ragionevole (IP, 4.10.1879, 16.10.1879), inferiore a quanto richiesto dal governo italiano come contributo locale per le ferrovie nazionali (IP, 15.10.1879), e da pagar-si solo dopo trenta giorni di piena operatività (IP, 30.09.1879); è vero che si tratta di una società straniera, ma non se ne è trovata nessuna nazionale interessata a costruire e gestire il tramway (IP, 27.09.1879).
La società è seria (IP, 12.11.1879), e merita fiducia, lo stesso non può essere detto dell’offerta fatta dal Curci (ICP, 17.10.1879). Come prova dell’impegno della società inglese, i media danno informazio-ne del deposito versato alla deputazione provinciale (IP, 23.10.1879, 6.11.1879; IPG, 9.11.1879).
8. Immagini usate per presentare il tramway
Una sezione a sé meritano le immagini e le metafore usate dai media locali per presentare il tramway e i suoi effetti.
L’immagine del mondo che corre come un cavallo senza morso (ICP, 17.10.1878) è già stata citata, e l’energia inarrestabile del pro-gresso è suggerita anche dall’immagine della miccia di una bomba: «Si tratta di inserire, attraverso ai nostri monti ed attraverso alle nostre valli, quella gran miccia della civiltà, per la quale i fuochi del progresso fiammeggiano dalle cime bettolesi sino ai bassi fondi dell’ubertoso comune castelvetrese – quella gran miccia della civil-tà – io diceva – che ha nome: facilitazione di comunicazioni» (IPG, 19.11.1879); si legge anche che tutti hanno «un desiderio ardentissi-mo, una febbre di facili comunicazioni e pronte» (ICP, 23.10.1878).
Il tramway è anche interpretato come elemento naturale, «indi-spensabile nesso (come ne insegna la natura tutta che mai va a sal-ti) tra le ferrovie ordinarie e le strade carrettiere» (ICP, 23.10.1878).
Il tramway ha il potere di vivificare una provincia che dorme (IPG, 19.11.1879), le strade «sono le arterie per cui circola la vita sociale, e il paese che ne manca sarà oggi povero, dimani tisico, e diman l’altro lascierà dopo sè il deserto e la morte» (ICP, 8.10.1879). Ma se in un centro morto si attiva un tramway, si assiste al miracolo della resurrezione: «Allorchè si riesce ad attivare un tramways [sic] anche in un centro minore ove manca la vita, il moto e regna la morte, si vede il miracolo della risurrezione» (ICP, 19.11.1878)…
Quest’ultima immagine introduce una serie di riferimenti alla Bib-bia e al Vangelo, che sono di particolare interesse non solo perché se-gnalano una profonda partecipazione emotiva rispetto al nuovo mezzo
314
LORENZO CANTONI
di trasporto, ma anche perché usati da media esplicitamente (e talora anche violentemente) anticlericali, che considerano la religione come semplice superstizione.
«Il Corriere Piacentino» scrive che i collegamenti avvicinano il trionfo della democrazia, «promessaci dal Martire del Golgota, che debbe fare della terra un unico popolo o un governo unico. Unum ovile et unus pastor, come dice il linguaggio mistico delle sacre carte» (ICP, 7.10.1879), invita «finchè ne siamo in tempo, ad accomunare coi nostri fratelli da fuori i profitti ottenuti: chiamiamoli anch’essi al banchetto della civiltà» (ICP, 9.10.1879), e biasima Piacenza perché assomiglia al «servo infingardo del vangelo», che ha sepolto il suo talento anziché trafficarlo (ICP, 4.10.1879).
La costruzione della linea tramviaria costituisce una «provvidenza insperata» (ICP, 17.10.1879) per i lavoratori, è «tanta manna piovutaci dal cielo», come suggerisce «Il Piccolo. Giornale della Democrazia» (IPG, 28.09.1879).
Quest’ultimo vorrebbe avere addirittura «il potere del Nazareno» e far risorgere un montanaro del Nure morto da cinquant’anni. «Vorrei risuscitarlo – e mostrargli di lassù la vaporiera del Tram, che fles-suosamente serpeggiando appiedi dei poggi, corre, come incoronata dal suo pennacchio di fumo, schernendo gli ostacoli, distruggendo le distanze, bravando i periodici furori del Nure […]. E vorrei udire cosa diamine direbbe il mio montanaro, da mezzo secolo sepolto! Se non che, probabilmente, ei rimarrebbe istupidito. Piglierebbe la vaporiera del Tram per la carrozza del diavolo, il macchinista per Satanasso in persona, ed i carrozzoni di passeggieri per la coda animata di Bel-zebù… O tutt’al più urlerebbe atterrito: – Ma è la fine del mondo questa!» (IPG, 19.11.1879).
V. Conclusioni e limiti
Nelle sezioni precedenti è stato offerto un resoconto dei primi pas-si del progetto di tramway a Piacenza, poi realizzato dalla Piacenza, Bettola and Cremona Tramway Company (Limited), e si è riporta-to e analizzato il dibattito che ha avuto luogo sui media piacentini dell’epoca.
Questo articolo, oltre ad aver colmato un vuoto di ricerca sul progetto di tramway negli anni 1878 e 1879, ha combinato due di-stinti approcci: quello della storia istituzionale e quello della storia delle idee, ricostruita – in questo caso – attraverso un’analisi conte-nutistica e argomentativa degli articoli dedicati al progetto comparsi sui giornali locali.
Sulla base di questa ricerca, si annuncia come molto produttiva
315
THE PIACENZA, BETTOLA AND CREMONA TRAMWAY COMPANY (LIMITED)
un’analisi di come i media hanno trattato il tramway nel periodo successivo, durante la costruzione, all’inaugurazione delle varie trat-te, al passaggio alla nuova società e all’elettrificazione, fino alla sua chiusura e allo smantellamento definitivo. Fino a quella che, almeno nella mia esperienza di piacentino nato l’anno stesso di chiusura del tramway, è apparsa come una vera e propria damnatio memoriae.
Tra i limiti della ricerca, si possono senz’altro annoverare la man-canza di controllo incrociato su altre fonti coeve, come per esempio media non piacentini, e il fatto che l’analisi e la codifica dei testi sono state fatte da una sola persona, esposta a possibili fraintendi-menti ed errori.
Lugano, Università della Svizzera italiana, gennaio 2013