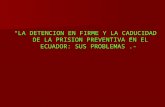La fontana arcaica de Tusculum. Idee per la sua conservazione
Conservazione preventiva nelle biblioteche di Puglia
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Conservazione preventiva nelle biblioteche di Puglia
Conservazione preventiva
nelle biblioteChe di puglia
valentina t
erlizzi e giuseppe d
e Filippis Co
nse
rv
az
ion
e p
re
ve
nt
iva
ne
ll
e b
ibl
iot
eC
he
di p
ug
lia
a cura di valentina terlizzi e giuseppe de Filippis
il progetto Conservazione preventiva nelle biblioteche di Puglia nasce ufficial-mente nel 2008 su iniziativa dell’associazione culturale Folio e grazie al finanziamento delle Regione Puglia nell’ambito del concorso Prin-cipi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore, promosso dall’assessorato alla trasparenza e Cittadinanza attiva.la cooperazione e il costante confronto fra le professionalità multidi-sciplinari coinvolte nelle attività progettuali, nello specifico esperti nel monitoraggio e diagnostica dei beni culturali, storici dell’arte e cura-tori del libro, hanno permesso di redigere delle linee guida per cia-scuna delle biblioteche coinvolte nel monitoraggio dei parametri am-bientali, finalizzate all’applicazione della conservazione come buona pratica per la prevenzione e riduzione del degrado delle collezioni.
valentina terlizzi è dottore di ricerca in Conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale presso l’università del salento ed è la referente dell’associazione Culturale Folio.
giuseppe de Filippis è direttore tecnico del laboratorio Codex partner del progetto.
lupoeditore.com
Conservazione preventiva
nelle biblioteChe di puglia
a cura di Valentina Terlizzi e Giuseppe De Filippis
5
presentazione
ConserVazione preVenTiVa nelle biblioTeChe Di puGlia: appliCazione Di una buona praTiCa
il progetto Conservazione preventiva nelle biblioteche di Puglia nasce ufficialmente nel 2008 su iniziativa dell’associazione culturale Folio e grazie al finanziamento dalla Regione Puglia nell’ambito del concorso Principi attivi – Giovani Idee per una Puglia Migliore, promosso dall’Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva.
Anni di ricerche e studi nelle biblioteche pugliesi, nazionali e internazionali hanno fatto emergere una differente gestione, in ambito conservativo, degli am-bienti e dei fondi librari. Le biblioteche pugliesi per una serie di motivi che spazia-no dalla scarsità di finanziamenti, di personale specializzato, di attrezzature scien-tifiche e di spazi idonei a una corretta conservazione dei beni, non riescono ad applicare gli standard nazionali e internazionali di “conservazione preventiva”.
Dall’indagine empirica condotta nelle biblioteche e musei della Puglia durante il 2007 a mezzo questionario è difatti emerso che le uniche attività svolte all’inter-no di tali istituzioni (ci si riferisce nello specifico a musei e biblioteche di piccole dimensioni) riguardano la catalogazione delle collezioni, sebbene anche questa non sia costante, l’organizzazione di eventi e incontri con autori o artisti, la re-alizzazione di materiale divulgativo sulla storia dell’istituto e delle collezioni in esso conservata. Si è riscontrata nella maggior parte dei casi oggetto di indagine la presenza, se pur parziale, di laboratori di restauro, e la totale assenza di stru-mentazione per i rilevamenti dei parametri ambientali, di personale specializzato e di un piano programmatico finalizzato alla corretta distribuzione delle attività nel corso dell’anno.
Questa prima sperimentazione, in Puglia, ha avuto come obiettivo finale la sensibilizzazione dei curatori, dei responsabili delle strutture e degli utenti che accedono al servizio.
La cooperazione e il costante confronto fra le professionalità multidisciplinari coinvolte nelle attività progettuali, nello specifico esperti nel monitoraggio e dia-gnostica dei beni culturali, storici dell’arte e restauratori del libro, hanno permesso di redigere delle linee guida per ciascuna delle biblioteche coinvolte nel monito-raggio dei parametri ambientali, finalizzate all’applicazione della conservazione come buona pratica per la prevenzione e riduzione del degrado delle collezioni.
Le biblioteche e archivi pugliesi che per un anno sono stati coinvolti nelle at-
Titolo |ConserVazione preVenTiVa nelle biblioTeChe Di puGlia: appliCazione Di una buona praTiCa
a cura di | Valentina Terlizzi e Giuseppe De FilippisImpaginazione |Rossana Scrimieri
Tutti i diritti riservati© lupo editore 2010
isbn 978-88-96694-40-4
Nessuna parte di questo libro può essere riprodottasenza il preventivo assenso dell’Editore.
Via Prov.le Copertino-Monteroni (km. III - cp. 34)73043 Copertino (Lecce) • Tel. 0832.931743Skype: Lupo Editore
www.lupoeditore.com • [email protected]
6 7
parTe i
ConSERVAzIonE PREVEnTIVA: DEFInIzIonE E noRME
1.1 conservazione preventiva: definizione
La conservazione preventiva comprende ricerche e interventi finalizzati alla ridu-zione delle cause di degrado, biologiche ed ambientali, e dei rischi per i manufatti artistici. Essa prevede il controllo della quantità di luce nel visibile, il manteni-mento della umidità relativa favorevole e il debellamento di tutti gli altri fattori di degrado (insetti, polvere, sporcizia, ecc.).
La conservazione preventiva, descrivendo i modi attraverso cui una biblioteca o un museo possono evitare o ridurre qualsiasi rischio in grado di pregiudicare la fruizione di una collezione dovrebbe, in altri termini, indicare come raggiungere degli ottimali livelli di protezione delle raccolte nonché come quantificare le risor-se necessarie a tale scopo.
In un’accezione moderna e avanzata, essa si configura come una vera e pro-pria disciplina trasversale e interdisciplinare che coinvolge svariati aspetti, da quelli meramente tecnici e scientifici fino a quelli gestionali, finanziari, di forma-zione del personale1.
Per tracciare la recente storia di questo ramo della conservazione, si deve risa-lire al 1963, all’opera Teoria del restauro di Cesare brandi in cui si parla di restauro preventivo. Il restauro è definito dall’autore come il “ momento metodologico del rico-noscimento dell’opera d’arte nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione al futuro”, mentre il restauro preventivo è definito come “la tutela, la rimozione dei pericoli, l’assicurazione di condizioni favorevoli”.2
Questo concetto, nato in Italia non molto tempo fa, è stato poi approfondito da altri studiosi a partire dagli anni Settanta. Ricordiamo, in particolare, Gaël de Giuchen, il quale ha delineato la conservazione preventiva come la disciplina che
1. Servizi e Professionalità “nuove” per la tutela. La Conservazione preventiva delle raccolte museali a cura di c. Menegazzi, i. silvestri, atti del Convegno organizzato da istituto per i beni Culturali e naturali della Regione Emilia Romagna in occasione di Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e Ambientali – VII ed., Ferrara Fiere, 27 marzo 1999, pp. 7-8.
2. c. Brandi, Teoria del Restauro, Roma 1963, p. 6 e p. 54.
tività dell’associazione Folio, sono quattro e sono stati identificati sulla base della disponibilità dei direttori ad accogliere i sopralluoghi del nostro personale per il monitoraggio ambientale; della loro collocazione geografica, in modo da estende-re quanto più possibile il progetto sul territorio interessando biblioteche dislocate nelle province di Bari, Brindisi e Lecce; del loro ente gestore al fine di cogliere, qualora vi fossero, differenti modalità di programmazione delle azioni di conser-vazione e restauro dei fondi librari.
il progetto Conservazione preventiva è stato composto da due fasi. La prima ha avuto inizio a settembre 2009 ed è consistita nell’individuazione delle biblioteche, nel monitoraggio mensile dei parametri ambientali (temperatura e umidità rela-tiva) e di illuminamento, nella creazione di un database in cui sono stati inseriti tutti i dati registrati durante i sopralluoghi, nella stesura di relazioni tecniche di-stribuite in ogni biblioteca coinvolta.
Durante i sopralluoghi nelle biblioteca, l’Associazione Folio, insieme ai re-sponsabili degli istituti, ha individuato e avuto in consegna dei volumi, nello spe-cifico sei, che versando in pessimo stato di conservazione necessitavano di urgenti interventi di restauro.
La seconda fase del progetto, animata dalla professionalità del personale tec-nico del laboratorio di restauro del libro Codex, partner del progetto, è stata fi-nalizzata al restauro, gratuito per gli enti coinvolti, dei sei volumi manoscritti e a stampa.
Il presente studio è suddiviso in due parti. La prima introduce al concetto di conservazione preventiva e cerca di fornire un quadro chiaro ed esaustivo sugli studi internazionali e nazionali in questa disciplina. La seconda parte, invece, illustra i quattro casi di studio ed è suddivisa a sua volta in più parti che compren-dono il commento dei risultati di un anno di monitoraggio; le linee guida per una più idonea conservazione dei fondi librari; la presentazione delle fasi di restauro dei volumi. Queste sono introdotte dalle ricostruzioni storiche e codicologiche elaborate da Salvatore Sansone per il volume dell’Encyclopédie della biblioteca In-nocenziana di lecce, da Federica Viola per gli atti notarili del XVi e XVii secolo della biblioteca comunale E. Rogadeo di Bitonto e da Stefano Milillo per i due documenti manoscritti della Biblioteca Archivio vescovile di Bitonto.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto. La Regione Puglia, in primis, che ha creduto nella sua validità. Tutti i direttori e responsabili delle biblioteche che hanno ospitato le nostre attività. La dott.ssa Lorella Ingrosso, il prof. Stefano Milillo e la sig. Francesca Leone per la grande disponibilità. Giuseppe per il continuo supporto. Alessandro e Andrea per la loro creatività. Tore, amico di sempre. Raffaella, nicola e Silvia, instancabili sostenitori.
8 9
del monitoraggio periodico sullo stato di conservazione dei fondi, dei valori termo igrometrici ambientali al fine di accertare che si mantengano, nell’arco dell’anno, entro certi limiti considerati ottimali per la conservazione dei libri.
Agli inizi degli anni novanta quello della conservazione preventiva è diventato un tema condiviso a livello internazionale. Questi anni sono stati segnati da quat-tro importanti eventi: il Primo Colloquio internazionale sulla conservazione preventiva tenutosi a Parigi dal 8 al 10 ottobre del 1992 e organizzato dall’Association des Restaurateurs d’art et d’Archéologie de Formation Universitaire (ARAAFU); il congresso dal titolo Preventive Conservation – Practise, Theory and Research, tenutosi ad otawa dal 12 al 16 settembre del 1994 ed organizzato dall’International Institute for Conservation of Historic and artistic Works (IIC); l’emanazione, nel 1991, in olanda del Piano DELTA, programma nazionale di salvaguardia del patrimonio culturale; il lancio del programma di prevenzione nei musei africani, PREMA, della durata di quattordici anni, applicato a 42 paesi; infine, la creazione nel 1994 di un corso di studio specifico in Conservazione preventiva all’Università Paris I.6
Dalla seconda metà degli anni novanta questa disciplina è cresciuta sensibil-mente grazie alla discussione maturata all’interno di una intensa attività di ricerca scientifica, di convegni specifici, di corsi di formazione professionale, nonché di scambi di dati e informazioni tra i diversi paesi incentivati da associazioni culturali e scientifiche di livello e prestigio internazionale come l’ICCRoM (International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Proper-ty), l’ICoM (International Council of Museums) e l’IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works).
Il XXI secolo si apre con l’importante incontro Preventive Conservation Strategy a Vantaa, Filadelfia, durante il quale avviene la stesura e la condivisione del docu-mento contenente le principali linee guida per lo sviluppo e la messa in opera di una strategia comune sulla conservazione preventiva in Europa7.
Si è giunti alla formulazione di una definizione di conservazione preventiva attraverso un profondo cambiamento di mentalità, ancora in atto, che ha portato gli studiosi a pensare:- alle collezioni nel loro insieme e non più al singolo oggetto;- all’edificio e non più alle sale espositive;- a un percorso a lungo termine che abbracci l’arco temporale di un anno;
6. La conservation prèventive, ARAAFU troisième Colloque International, Paris 1992; G. de Guichen, La conservation préventive un changement profond de mentalité, Cahiers d’étude Comité de Conservation (ICoM-CC), Parigi 1997, pp. 4-6; C. Meneghezzi, La Conservazione Preventiva: storia e contenuti di una nuova disciplina, in Servizi e Professionalità cit., pp. 9-12.
7. Ibidem.
racchiude tutti gli interventi da intraprendere per migliorare lo stato di conserva-zione di un’intera collezione, tenendo in grande considerazione le interazioni con l’ambiente esterno e le cause di degrado di un bene, suddivise, queste ultime, in cause naturali, ovvero prodotte dall’ambiente, e cause umane che possono generare a loro volta effetti immediati e drastici o effetti lenti e cumulativi.3
l’International Federation of Library Associations (IFLA) ha pubblicato nel 1979 un primo intervento dal titolo Principles of Conservation and Restoration in libraries,4 rivisto successivamente da J.M. Dureau e da D. W. G. Clements e pubblicato dall’IFLA HQ nel 1986 come «Professional Report n. 8» con il titolo Principles for the preser-vation and conservation of library materials, per tornare a dare direttive nel 1998 con i Principles for the care and handling of library material.5
nel 1987 la Carta della Conservazione e del Restauro degli oggetti d’arte e di cultura del Consiglio nazionale delle Ricerche (CnR) ha fornito chiare definizioni dei si-gnificati di alcuni termini chiave quali “conservazione”, “prevenzione”, “salvaguardia”, “restauro” e “manutenzione”. Con la parola “conservazione” si intende l’insieme degli atti di prevenzione e salvaguardia rivolti ad assicurare una durata tendenzialmente illimitata alla configurazione materiale dell’oggetto considerato; con il termine “prevenzione” si racchiude l’insieme degli atti di conservazione, motivati da conoscenze predittive al più lungo termine pos-sibile, sull’oggetto considerato e sulle condizioni del suo contesto ambientale. La “salvaguardia” è invece legata a qualsiasi provvedimento conservativo e preventivo che non implichi interventi diretti sull’oggetto; il “restauro” è da intendersi come qualsiasi intervento che […] sia rivolto a restituire all’oggetto, nei limiti del possibile, la relativa leggibilità e, ove occorra, l’uso, e infine la “manutenzione” definita come l’insieme degli atti programmatici ricorrenti rivolta a man-tenere le cose di interesse culturale in condizioni ottimali di integrità e funzionalità, specialmente dopo che abbiano subito interventi eccezionali di conservazione e/o restauro. Questo impor-tante documento, agli allegati E e F intitolati La conservazione e il restauro del libro e La conservazione e il restauro dei beni archivistici, ha sottolineato il ruolo fondamentale
3. g. de guichen, Preventive Conservation: a mere fad or a far-reaching change?, Museum International, UnESCo, Parigi n. 201, vol. 51, 1 (1999).
4. Principles of conservation and resturation in libraries, «IFLA Journal», V (1979); ed. italiana: IFLA (FIAB) – Commissione permanente della sezione per la conservazione, Conservazione e Restauro nelle biblioteche, trad. di M. Silli, Firenze 1980.
5. Core programme on preservation and conservation – Council on library and information re-sourses, Principles for the care and handling of library material, compiled and edited by e.p. adock, with the assistance of M.t. varlaMoff and v. kreMp, Paris, IFLA-PAC 1998. Edizione italiana a cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali, IFLA – Core programme on preserva-tion and conservation – Council on library and information resourses – Associazione italiana biblio-teche, Principi dell’IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, a cura di e.p. adock, con la collaborazione di M.t. varlaMoff e v. kreMp, trad. di L. Carcerieri e R. Martucci, Roma 2005.
10 11
sia intere biblioteche) di enti diversi dallo Stato e dai privati furono considerate funzioni residue di competenza statale e delegate alle Regioni in base al dettato dell’art.1118 c.2 della Costituzione. In materia di tutela, il settore dei beni librari non statali fu scorporato dal resto dei beni culturali, che rimase affidato allo Sta-to, infatti, le funzioni di tutela di cui erano titolari le Soprintendenze ma che non erano comprese nelle materie di competenza regionale elencate all’art. 117 della Costituzione,11 furono oggetto di delega.
Le radicali modifiche introdotte all’inizio degli anni settanta, portarono nel 1977 all’emanazione del D.P.R. 24 luglio, n. 616 che all’art. 47 precisa quali sono le funzioni amministrative relative alla materia di musei e biblioteche di enti locali trasferite alle regioni e specifica che esse concernono tutti i servizi e le attività riguardanti […] la conservazione […] delle raccolte di interesse […] bibliografico, delle biblioteche […] appartenenti alla regione o ad altri enti non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale.
Il valore non solo giuridico ma anche culturale del patrimonio archivistico librario è stato sancito dalla normativa in tempi relativamente recenti con l’atto di istituzione del Ministero per i Beni culturali e ambientali nel 1974 che derivò dallo scorporo delle funzioni del Ministero della Pubblica Istruzione e degli archi-vi di Stato presso il Ministero degli Interni.
Le novità più significative per l’ordinamento giuridico del patrimonio cultu-rale sono arrivate a partire dal 1997 quando in seguito allo sviluppo di un nuovo corpus legislativo e normativo, si è avuto un vasto e radicale cambiamento nelle politiche dei beni culturali12. La legge n.59 del 1997 è stata difatti animata da tre obiettivi strategici quali la semplificazione del sistema amministrativo, il decen-tramento fondato sul governo locale piuttosto che sull’amministrazione statale e il ripensamento delle funzioni e dell’organizzazione a livello centrale e periferi-co13. Conseguenza diretta è stata l’emanazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n.112,
11. a. garlandini, Regione Lombardia in Strumenti di valutazione per i musei italiani. Esperienze a confronto, a cura di a. Maresca coMpagna, Roma 2005, p. 280: L’art.117 della Costituzione attribuisce alle Regioni potestà legislative sullo stesso piano di quelle statali, da una parte ribadisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella tutela dei beni culturali, dall’altra assegna alle Regioni poteri legislativi concorrenti per la valorizzazione dei beni e la promozione delle attività. L’art. 118, inol-tre, individua i tre principi su cui deve basarsi la gestione dei servizi culturali: la sussidiarietà, la differenziazione e l’adeguatezza.
12. l. randelli, f. Mastragostino, I comuni e le province, Bologna 1998, p. 40: Le disposizioni sulla delega per il conferimento di funzioni (la c.d. Bassanini) e di funzioni (la c.d. Bassanini bis) modifica-te e integrate dalla L.18 giugno 1998, n.191 (c.d.Bassanini ter) hanno comportato una «devoluzione di poteri e compiti alle Regioni e alle autonomie locali che, per novità di criteri e per qualità e quan-tità degli ambiti toccati, si è presentata come una delle riforme più incisive che l’amministrazione pubblica italiana abbia conosciuto».
13. M. caMMelli, Il decentramento difficile, «Aedon,», 1(1998), p.1.
- alla formazione di un’equipe interdisciplinare;- all’esigenza di stilare un piano programmatico annuale8.
Rendere fruibili le preziose collezioni ereditate dal passato, cercando di limi-tare i danni del tempo con una corretta conservazione e adeguati interventi di restauro, è il principale compito delle istituzioni culturali.
1.2 la conservazione nel quadro norMativo nazionale e regionale
I primi passi verso l’assunzione di responsabilità a livello legislativo in materia di conservazione dei beni librari furono fatti con l’istituzione, nel 1919, delle So-printendenze bibliografiche, organi periferici dello Stato, dapprima in numero di dodici, poi elevato a quindici nel 1935. Con esse si volle soprattutto tutelare il patrimonio librario antico, raro e di pregio delle biblioteche degli enti locali e dei privati garantendone la conservazione. A questo è seguita l’emanazione della legge fondamentale per la tutela delle cose di interesse storico e artistico del 1 giugno 1939 n.1089 che è rimasta in vigore fino al 1999 ed ha avuto come obiettivo prin-cipale quello di proteggere il bene garantendone la conservazione da tutto ciò che potesse comprometterne l’integrità9.
Il successivo processo di decentramento dello Stato e dello sviluppo delle auto-nomie locali, con l’istituzione delle Regioni, è stato fondamentale per il settore dei beni librari: il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.3 trasferì alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali concernenti: l’istituzione, l’ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o d’interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati; la manutenzione, l’integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o d’interesse locale; gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità; il coordinamento dell’attività dei musei e delle biblioteche di enti locali e d’interesse locale; le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell’ambi-to dei musei e biblioteche di enti locali o d’interesse locale (art.7)10. Con l’art.9 le funzioni relative alla tutela del materiale bibliografico (sia singoli documenti,
8. guichen, La conservation cit., p.6
9. Legge n.1089, 1 giugno 1939, Tutela delle cose di interesse artistico e storico.
10. D.P.R. 14 gennaio 1972, n.3, Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e dei musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.
12 13
mazioni bibliografiche: con compiti in materia di catalogazione e documentazio-ne del patrimonio librario conservato nelle biblioteche pubbliche;- l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivi-stico e Librario: con compiti in materia di ricerca, restauro e conservazione di materiale bibliografico;- l’Istituto Centrale per il Restauro: con compiti di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di conservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storico-artistico.
Con il recente decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, il governo ha varato il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che fornisce uno strumento per definire e promuovere il patri-monio culturale anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali. Il Codice ha sostituito il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490). nel Codice si esplicita la necessità di restauro preventivo, inteso come l’insieme di tutte le azioni mirate a garantire la conser-vazione del bene culturale, e, all’articolo 29 della Sezione II, intitolata Misure di conservazione, si definiscono:1. la conservazione del patrimonio culturale, assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e re-stauro. 2. la prevenzione intesa come il complesso delle attività idonee a limitare le situa-zioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.3. la manutenzione intesa come il complesso delle attività e degli interventi desti-nati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’inte-grità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.4. il restauro definito come l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.
Il Codice fornisce, inoltre, delle chiare definizioni di istituti e luoghi della cultura (art.101) descrivendo la biblioteca come una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualun-que supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio e l’archi-vio come una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
Per quanto riguarda la produzione normativa della Regione Puglia nel settore dei beni culturali è da rilevare che nel 1979, in seguito all’approvazione del già citato D.P.R. 616/1977, furono emanate ben cinque leggi riguardanti ambiti fon-damentali per la gestione culturale (musei, biblioteche, cultura musicale, centri
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59, che ha imposto alle Regioni un complessivo aggiornamento della normativa al fine di legiferare sulle funzioni amministrative devolute dallo Stato nel tentativo di ripartire, in maniera equili-brata, le competenze in materia. Il Titolo IV di questo decreto, concernente i ser-vizi alla persona e alla comunità, affronta al Capo V, la materia dei beni e attività culturali suddividendola in otto articoli che definiscono i termini tutela, gestione, promozione e valorizzazione (art.148). Quest’ultima è intesa come ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione (c.1, lettera e). Si aggiunge, inoltre, che lo Stato e le Regioni concorrono alle attività di conservazione dei beni culturali (art.149 c.2).
Il decreto 112/98 ha introdotto inoltre il concetto di standard in ambito mu-seale prevedendo che “con proprio decreto il Ministero per i beni Culturali e ambientali definisca i criteri tecnico scientifici e gli standard minimi da osservare nell’esercizio delle at-tività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la sicurezza e la prevenzione dei rischi” (art.150, comma 6). Conseguenza di questo assunto è stata l’emanazione del D.M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” redatto da un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti del Ministero dei Beni e le attività culturali, delle regioni, Dell’anCi (associazione nazionale dei Comuni d’Italia) e dell’UPI (Unione delle Province d’Italia). Questo decreto, sebbene strettamente legato alle attività delle istituzioni museali, nell’Ambito VI intitolato Gestione e cura della collezione, raccomanda di osservare precisi criteri di conservazione preventiva attraverso il monitoraggio delle condizioni ambienta-li, al fine di garantire la sicurezza delle opere. Fra queste si annoverano anche la carta, la pergamena e il cuoio, tutti materiali che compongono un libro, si for-nisce un elenco dettagliato di parametri fisici, chimici e biologici da monitorare e si suggeriscono i valori di riferimento per assicurare le condizioni ottimali di conservazione dei beni.
Il 1998 è anche l’anno in cui viene istituito, presso il Ministero, l’Istituto Cen-trale per gli Archivi (art. 6 del D.lgs. 368 del 1998, sostituito dall’art. 4 del D.lgs. 3 del 2004) cui sono stati attribuiti compiti di definizione delle modalità tecniche per l’inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio e di applica-zione di nuove tecnologie. Esso si è aggiunto ad altri quattro Istituti Centrali pree-sistenti ereditati dall’ex Ministero per i beni culturali e ambientali, vale a dire:- l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione: con compiti in materia di catalogazione e documentazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico artistico e ambientale;-.l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane per le infor-
14 15
CEn (Comitè Européen de normalisation) e l’ISo (International organization for Standardization).
Il ruolo dell’UnI è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal Governo Italiano con la Legge n. 317 del 21 giu-gno 1986. I suoi principali compiti sono quelli di elaborare norme che vengono sviluppate dagli organi tecnici preposti; di rappresentare l’Italia nelle attività di formazione a livello mondiale ed europeo; di pubblicare e diffondere le norme tecniche. Questo ente ha pubblicato numerose norme tecniche anche nel settore dei beni culturali che hanno il merito di dare risposte pratiche a problematiche legate alla misurazione dei parametri ambientali rispetto ai materiali conservati fornendo, se non altro, dei parametri consigliati.
Fra le norme UnI riguardanti i beni culturali, vi sono quelle specifiche per i beni librari o per i materiali che li compongono:
- uni10586,1997, Documentazione-Condizioni climatiche per ambienti di conservazione di documenti grafici e caratteristiche degli alloggiamenti: la nor-ma definisce i parametri microclimatici ambientali per la conserva-zione di documenti grafici, con particolare riferimento ai materiali cartacei membranacei in edifici di nuova costruzione o preesistenti- uni10829,1999, Beni di Interesse storico e artistico-condizioni ambien-tali di conservazione, misurazione ed analisi: il documento prescrive una metodologia per la misurazione di parametri termo igrometrici e di illuminazione ai fini della conservazione dei beni storico e artistici.- uni10969, 2002, Beni culturali, principi generali per la scelta e il controllo del microclima per la conservazione dei beni culturali in ambienti interni: la norma fornisce linee guida per la scelta e il controllo del microclima nei musei, gallerie, archivi, ecc. ai fini della conservazione dei beni culturali.- UnI11131, 2005, Beni culturali- Misurazione in campo dell’umidità dell’aria: la norma indica i parametri fisici e gli strumenti idonei alla misurazione dell’umidità dell’aria ai fini della conservazione del pa-trimonio culturale.
Su iniziativa del Consiglio nazionale delle Ricerche (CnR) e dell’Istituto Centrale del Restauro (ICR) è nata nel 1977 la Commissione noR.MA.L. che, organizzata in più gruppi di lavoro, ha avuto il compito di definire metodologie unificate per lo studio di materiali costituenti i beni e per il controllo dell’efficacia dei trattamenti conservativi dei manufatti. Tra i documenti noR.MA.L., ve ne sono alcuni che risultano interessanti ai fini della nostra ricerca in quanto riguar-
dei servizi culturali, edilizia culturale) . Di particolare interesse per questa ricerca è la legge riguardante le biblioteche, L.R. n. 22 del 17 aprile 1979 Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale.
la legge applicava a livello regionale la soppressione della soprintendenza ai beni librari (art. 9) e il trasferimento alla Regione di tale settore, che sarebbe stato guidato in seguito dall’istituendo Ufficio Regionale per i beni librari. Essa definiva già istituti culturali le biblioteche pubbliche di enti locali e di enti ed istituzioni di interesse locale e permetteva agli enti locali, sempre “nell’ambito della loro autonomia”, di istituire nuove biblioteche e soprattutto di associarsi per dare vita a sistemi bibliotecari con l’intento di favorire il “decentramento nei Comuni maggiori e quello associativo tra i Comuni minori” . In tal modo gli enti locali sub-regionali iniziavano a configurarsi come gli effettivi gestori sul territorio delle biblioteche locali, responsabili anche, in accordo con la Regione, della conserva-zione del patrimonio archivistico-librario (art.3). Questa legge sebbene risultasse estremamente importante ed innovativa nell’ambito della gestione delle biblio-teche degli enti locali, ha avuto vigenza intermittente in quanto, come anche la legge n.21 sui musei, è stata abrogata nel 1988 e rimessa in vigore soltanto nel 1993.14
1.3 paraMetri aMBientali: norMe e linee guida
La conservazione preventiva, così come è stata definita nelle pagine precedenti, è composta da un piano di attività volte a rallentare gli effetti del degrado causati dal tempo e dall’uso dei materiali dei beni culturali. Fra queste attività ha un ruolo fondamentale il monitoraggio ambientale dei fondi librari ed archivistici in rela-zione ai materiali che li costituiscono e agli ambienti che li ospitano.
Esistono, a tal proposito, norme nazionali ed internazionali sulla conservazio-ne preventiva che, sebbene abbiano carattere generale, suggeriscono i parametri microclimatici ottimali per gli ambienti di biblioteche e archivi.
I principali enti in Italia preposti all’emanazione di standard15 e norme tecniche in diversi settori sono il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e l’Ente nazio-nale Italiano di Unificazione (UnI); mentre in ambito internazionale troviamo il
14. La legge è stata abrogata dall’art.18 della L.R. 11 febbraio 1988 n.6, Bilancio di previsione per l’eser-cizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale e riportata in vigore dall’articolo unico della L.R. 23 giugno 1993 n.10 Regime transitorio per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di musei, biblioteche ed archivi.
15. r. alcántara, Standards in Preventive Conservations: meanings and applications, ICCRoM 2002, p.11: «In general, though, standards are defined simply as a set of core principles or a statement of best practice, arrived at by consensus among appropriately qualified individuals or groups».
16 17
France che diffondono le proprie ricerche attraverso il Bollettino della Bibliotèque e riviste internazionali,17 le attività di normalizzazione di strategie e normative sono coordinate dall’aFnor che oltre a vigilare su 25 Bureaux è membro france-se delle istanze di normalizzazione europee (CEn) ed internazionali (ISo).
In Inghilterra, le organizzazioni preposte alla emanazione di norme in ambito conservativo sono l’Institute of Paper Conservation e il Museums, Libraries and Archives Council (MLA). Quest’ultimo all’interno degli Accreditation Standards ha fissato le azione per ridurre il degrado delle opere d’arte e, per quanto concerne il controllo del microclima, ha esplicitato la necessità di effettuare il monitoraggio ambientale utilizzando una strumentazione adeguata. La British Libray ha inol-tre sostenuto nel 2003 il national Preservation office nella pubblicazione di linee guida sulla conservazione preventiva nelle biblioteche e archivi intitolata Basic Preservation Guidelines for library and Archive Collections.
Due importanti manuali sulla conservazione sono il risultato di ricerche scien-tifiche e progetti del Getty Conservation Institute (GCI) del Paul Getty Museum, intitolati Re-Collections: Caring for Collections Across Australia che fanno riferimento alle indicazioni sulla prevenzione del degrado di manufatti artistici emanate dall’Au-stralian Institute for the Conservation of Cultural Material.
Degni di nota sono, infine, gli importanti bollettini tecnici pubblicati dal Ca-nadian Conservation Institute (CCI) che dal 1972 sostiene la conservazione, la scienza e la tecnologia applicate al patrimonio culturale canadese fornendo fon-damentali linee guida ai conservatori e curatori di archivi e musei18.
17. p. nguyen, p. vallas, La conservation des documents papier : point sur l’évolution des techniques et des stratégies, «Bulletin des Bibliothécaires Français», 51, n.4 (2006); t.p. nguyen, M. duBus, M. saheB, s. Mareynat, Qualité de l’air dans les magasins de la Bibliothèque nationale de France, I - Premiers résultats, in Support Tracé, vol.6,Parigi 2006, pp. 48-57; t. Basset, Preventive, preservation a day to day work, «International Preservation News», 41 (juillet 2007), pp. 14-18.18. s. Michalski, Guidelines for Humidity and Temperature for Canadian Archives, «Technical Bulletin», 23 (2000); J. tetrault, Airborne pollutants in Museums, Galleries, and Archives: Risk Assessment, Control Strate-gies, and Preservation Management, Canadian Conservation Institute 2003.
dano nello specifico il monitoraggio ambientale e sono: noR.MA.L. 5/81, 5/82, 5/83, 5/86 e 5/87 sulla Misura dei Parametri Ambientali.
A questo si aggiunge che nel 1996, attraverso una convenzione fra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e l’UnI, è stata istituita la Commissione UnI-nor.Ma.L. Scopo della convenzione, come cita l’art. 1, è quello di attivare una collaborazione finalizzata alla elaborazione comune di norme tecniche, valide a livello nazionale ed idonee ad essere proposte a livello europeo per la creazione di un corpo armonico nel campo del recupero e del restauro. In particolare tale collaborazione ha lo scopo di: far interagire la struttura tecnica del Ministero per i Beni Culturali e la struttura tecnica dell’UnI per la messa a punto di norme tecni-che d’interesse del Ministero; individuare le modalità, con la collaborazione della Commissione norMaL, di utilizzo da parte del Ministero per i Beni Culturali delle norme UnI a supporto di dispositivi legislativi nazionali relativi al settore della conservazione e del restauro; proporre a livello europeo le normative messe a punto congiuntamente in ambito nazionale sia in ambito CEE che CEn.
Si ricorda, inoltre, la formazione nel 2001, su richiesta dell’UnI Italia al CEn (Comité Européen de normalisation), di un nuovo Technical Commitee (TC) finalizzato alla conservazione del patrimonio culturale, il CEn/TC 346. Questo gruppo di lavoro si occupa della standardizzazione e definizione di terminologia, metodi e analisi sulla composizione dei materiali e del loro degrado e sui prodotti e tecnologie utilizzati per la pianificazione ed esecuzione della loro conservazione, restauro e valorizzazione.16
nel panorama internazionale vi sono diversi enti ed organizzazioni che prov-vedono all’emanazione di standard tecnici, come ad esempio la national In-formation Standards organization (nISo) accreditata dall’ American national Standards Institute (AnSI), che ha il compito di identificare, sviluppare e pubbli-care standard tecnici sulla gestione di informazioni dei cambiamenti ambientali. Questa organizzazione no-profit è stata fondata nel 1939 ed è oggi composta da centinaia di esperti organizzati in gruppi di lavoro e commissioni tecniche.
Per quanto riguarda nello specifico la conservazione dei materiali cartacei, l’AnSI (American national Standards Institute) ha pubblicato nel 2001una nor-ma che costituisce una guida per bibliotecari, archivisti e tutti coloro che si oc-cupano di esposizione di materiale librario e archivistico, fornendo i criteri per ridurre il degrado dovuto ai parametri ambientali (AnSI/nISo z39.39, Environ-ment and Conditions for Exhibiting Library and Archival Materials).
In Francia, oltre ai laboratori di conservazione della Bibliothèque national de
16. Oggetti nel Tempo. Principi e tecniche di conservazione preventiva, a cura dell’istituto per i beni artistici Culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, «Materiali e Ricerche», 7 (2007), pp. 179-196.
18 19
lativa costantemente al di sopra del 65% può provocare sia nel materiale librario tradizionale che in quello moderno un ammorbidimento delle colle con perdita della loro forza adesiva. Al di sopra del 70% di umidità relativa gli attacchi biolo-gici sono altamente probabili anche a bassa temperatura. In zone con scarsa cir-colazione d’aria l’umidità relativa non dovrebbe superare il 60%. In realtà anche quando c’è una buona ventilazione, l’umidità relativa non dovrebbe superare il 65% allo scopo di evitare lo sviluppo di muffe. Una umidità relativa bassa (infe-riore al 40%) riduce al minimo le alterazioni chimiche, ma può provocare restrin-gimento, irrigidimento, rottura e infragilimento dei materiali21.
Si deduce dunque che la scelta di determinati livelli di umidità relativa e di temperatura è sempre legata ad un compromesso ed è ampiamente influenzata da diversi fattori:• natura delle raccolte• condizioni climatiche locali• risorse disponibili per il condizionamento dell’ambiente.
Sulla base di questi assunti, si può affermare che per una corretta conservazio-ne preventiva nelle biblioteche e archivi si dovrebbe garantire un livello di umidità sufficientemente elevato per mantenere la flessibilità delle carte e, allo stesso tem-po, un livello sufficientemente basso per rallentare il deterioramento dei materiali e per tenere sotto controllo l’insorgere di insetti e muffe. nella tabella seguente sono stati identificati i parametri di temperatura e umidità relativa consigliati per la prevenzione di attacchi microbiologici su manufatti organici come dipinti su tela e su tavola, il legno archeologico, disegni ad acquerello su carta, libri e mano-scritti, materiale grafico, cuoio, pelli e pergamene, tessuti di natura organica e le collezioni etnografiche.
21. Principi dell’IFLA cit., pp. 24-38.
1.4 Monitoraggio aMBientale: livelli raccoMandati di teMperatura, uMidità e luce
Le condizioni climatiche, come l’orientamento e l’esposizione dei libri, l’eccesso di umidità relativa,19 di temperatura20 elevata o di asciuttezza, la scarsezza o la mancanza di aerazione, determinano in qualsiasi specie di materiale librario varie modificazioni che ne alternano fisicamente la struttura producendo deformazioni e dissociazioni di fibre.
La natura chimica, meccanica e biologica delle reazioni di degrado agli agenti atmosferici può variare a seconda dei materiali. i Principi dell’IFLA identificano alcuni punti fermi per la comprensione delle modifiche chimico-fisiche dei fondi librari e documenti archivistici al variare di temperatura e umidità relativa:1. per tutti i tipi di materiali librari non esiste un livello ideale di temperatura e di umidità relativa ma solo intervalli di valori che riducono al minimo specifici tipi di alterazione.2. Un’ampia gamma di esperimenti scientifici prova che la carta mantiene la sta-bilità chimica e la consistenza fisica più a lungo in un deposito costantemente a bassa temperatura (sotto i 10°C) e a bassa umidità relativa (30-40%). 3. La pelle e la pergamena richiedono una umidità relativa almeno al 50% per continuare a svolgere la loro funzione meccanica.4. L’umidità catalizza le reazioni chimiche e l’aumento della temperatura ne ac-celera la velocità: il caldo accompagnato da bassa umidità relativa porta all’ina-ridimento e all’infragilimento di materiali come pelle, pergamena, velino, carta, adesivi, etichette adesive su cassette audio e video, etc. Il caldo accompagnato da umidità relativa elevata favorisce lo sviluppo di muffe e crea un ambiente propizio per animali infestanti e insetti. 5. Le sostanze organiche che compongono un libro sono igroscopiche, di conse-guenza i materiali si espandono e si contraggono a seconda dei livelli di umidità. Una umidità relativa compresa tra il 55 e il 65% rende minimo il danno mecca-nico dal momento che i materiali conservano la loro flessibilità. Una umidità re-
19. g. de guichen, Biblioteche – Archivi e prevenzione contro gli agenti fisici, «Bollettino dell’Istituto Cen-trale per la patologia del libro», 36 (1980), speciale, p. 66: «L’umidità relativa di un certo volume d’aria ad una certa temperatura è il rapporto tra l’umidità assolutà (o la quantità di vapore d’acqua che contiene l’aria) e la saturazione alla stessa temperatura (o la quantità di vapore d’acqua massi-ma che potrebbe contenere l’aria. […] L’umidità relativa varia da 0 a 100%. Se l’umidità relativa è uguale a 63% ciò vuol dire che a questa temperatura l’aria è capace di assorbire 37% di vapore di acqua in più».
20. Oggetti nel tempo cit., p.8: «La temperatura è la grandezza fisica che esprime lo stato termico di un sistema e descrive la sua attitudine a scambiare calore con l’ambiente o con altri corpi».
20 21
assorbita o riflessa dagli oggetti sui quali cade generando reazioni chimiche che trasformano la materia di cui è composto l’oggetto. L’entità del danno creato dalle radiazioni elettromagnetiche dipende da più fattori:- la lunghezza d’onda e intensità della radiazione - il tempo di esposizione del materiale - il tipo di materiale.
L’illuminazione solare diretta dovrebbe essere assolutamente evitata perché la molecola della cellulosa assorbe fortemente le radiazioni elettromagnetiche nella zona degli ultravioletti (lunghezza d’onda inferiore ai 200 nanometri). La conse-guenza di questo assorbimento sulla catena cellulosica è data dall’insorgere di re-azioni chimiche (di fotolisi) che modificano la struttura molecolare del composto. Sfortunatamente il processo non si arresta anche quando la causa del problema viene rimossa, pur procedendo con una velocità minore.
Il più comune danno fotochimico è la foto-ossidazione della molecola. Sostan-zialmente, dal punto di vista strettamente chimico, si possono avere due mecca-nismi simultanei. Il primo, ossidazione dei gruppi ossidrilici con formazione di gruppi carbonilici (cambia sia la solubilità della cellulosa che le sue proprietà di assorbimento e rilascio dell’acqua) che esteriormente si manifesta con l’ingial-limento/imbrunimento della carta, mentre il secondo è dato dalla rottura del legame glucosidico che si ha per effetto dell’energia associata alle onde incidenti. Il prodotto formatosi determina la scissione della macromolecola in due tratti a minor peso molecolare (l’uno con terminale chetonico cromoforo e l’altro carat-terizzato da un radicale ancora attivo che permette la formazione di reticolazioni) causando una diminuzione della lunghezza della catena che si traduce nel cam-biamento delle proprietà meccaniche delle carte.24
La cellulosa foto ossidata è normalmente rigida e fragile e la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche è limitata. Preme ribadire, quindi, che la luce del gior-no, a causa della elevata presenza di raggi ultravioletti, è particolarmente dannosa per la conservazione dei beni archivistico-librari.25
I livelli di illuminazione dovrebbero essere mantenuti bassi, per quanto pos-
nosa emessa da una superficie in una data direzione e l’area apparente di tale superficie».
24. e. pedeMonte, La carta. Storia, produzione, degrado, restauro, Venezia 2008, pp. 125-127.
25. M. copedé, La carta e il suo degrado, Firenze 1991, p. 65: «La sorgente di luce naturale e la mag-gior parte di quelle artificiali (lampade di vario tipo) producono, oltre alle radiazioni visibili anche altre onde elettromagnetiche, con lunghezze d’onda maggiori e minori di quelle visibili: le radiazio-ni infrarosse, più lunghe (comprese fra i 760 e 400.000 nm) e le radiazioni ultraviolette, più corte (comprese tra 380 e 100 nm)».
Manufatti organici
umidità relativa (%)
Max variaz. giornaliera
temperatura (°C)
Max variz. giornaliera
Dipinti su tela 40-55 6 19-24 1,5su tavola 50-60 2 19-24 1,5
legno 50-60 2 19-24 1,5archeologico 50-60 2 19-24 1,5bagnato - <4
Carta 40-55 6 18-22 1,5pastelli, acquerelli
<65 <10
libri e manoscritti
45-55 5 <21 3
materiale grafico
45-55 5 <21 3
Cuoio, pelli, pergamene
40-55 5 4-10 1,5
Tessuti di natura cellulosica
30-50 6 19-24 1,5
di natura proteica
>50-55 19-24 1,5
Collezioni etnografiche
20-35 5 15-23 2
fonte: Atto di Indirizzo, Condizioni microclimatiche per la prevenzione di attacchi micro-biologici su materiali organici, pp. 149-150.22
Un altro fattore di degrado degli elementi organici che compongono un libro è la luce,23 sia naturale che artificiale. Essa, come forma di energia, può essere
22. Le raccomandazioni riportate nell’Atto di Indirizzo del 2001 sono frutto del compendio di un arti-colato quadro di raccomandazioni e di proposte normative emesse fin dall’inizio degli anni settanta dagli organismi internazionali (principalmente ICoM, IES e CIBS) e successivamente sviluppati da gruppi di lavoro del Comitato Tecnico Italiano-UnI.
23. Oggetti nel tempo cit., pp. 18-19: «La luce è la parte dello spettro elettromagnetico che il nostro occhio può vedere. La lunghezza d’onda della luce visibile va identificata da 400 nanometri a 700 nanometri […]. Il flusso luminoso è misurato in lumen e indica la quantità di energia luminosa emessa nell’unità di tempo (il secondo) da una sorgente. Per energia luminosa si intende quella emessa nell’intervallo da 380 a 780 nanometri che comprende quindi la radiazione infrarossa e ul-travioletta. L’intensità luminosa la cui unità di misura è la candela indica la quantità di flusso lumi-noso emessa da una sorgente all’interno dell’angolo solido in direzione data […]. L’illuminamento la cui unità di misura è il lux rappresenta il rapporto fra il flusso luminoso ricevuto da una superficie e l’area stessa. In altre parole indica la quantità di luce che colpisce un’unità di superficie […]. La luminanza la cui unità di misura è la candela per metro quadrato, è il rapporto tra l’intensità lumi-
22 23
Sarebbe opportuno, come avviene nelle gallerie e nei musei, che anche per le sale di lettura e per i magazzini delle biblioteche ci fosse personale tecnico spe-cializzato con il compito di scegliere e garantire l’illuminazione più adatta alla conservazione dei beni. nella seguente tabella sono riportati i valori annuali di illuminamento raccomandati, espressi in lux per ora/anno (Lo), per le categorie di manufatti sensibili alla luce.
Categoria fotosensibilità lux ora/anno (lo)2Media 500.000
3Alta 150.000
4Molto alta 50.000
fonte: Atto di Indirizzo, Esposizione energetica – Dose di luce annuale, pp. 130-131.
La luce artificiale oggi è generata da lampade commercializzate in tipologie sempre più differenziate, sebbene le più utilizzate rimangano quelle a incande-scenza ed a fluorescenza. Le prime emanano un contenuto minimo di UV ma, per la elevata produzione di IR, provocano un riscaldamento elevato; le seconde (i cosiddetti tubi a neon) hanno una forte emanazione di UV, quindi se usate devono essere opportunamente schermate con particolari filtri.26
nella seguente tabella sono elencati e confrontati diversi tipi di lampade con i propri vantaggi e svantaggi.
26. copedé, La carta cit., p. 73.
sibile, sia nei magazzini che nelle sale di lettura e di esposizione in modo da non accelerare la decomposizione chimica dei materiali, causando danni irreversibili.
nella seguente tabella vengono recepite le raccomandazioni internazionali che classificano in quattro categorie di fotosensibilità (molto bassa, media, alta, molto alta) i reperti ed i manufatti e stabiliscono i livelli massimi di illuminamento.
Categoria fotosensibilità illuminamento massimo (lux)
1Molto bassa
Reperti e manufatti relativamente insensibili alla luce: metalli, materiali lapidei e stucchi senza strato di finitura, ceramiche,gioielleria, smalti, vetri, vetrate policrome, repertifossili.
Superiore a 300 lux
2Media
Reperti e manufatti moderatamente sensibili alla luce:pitture ad olio ed a tempera verniciate, affreschi – materiali organici non compresi nei gruppi 3 e 4 quali quelli in corno, osso, avorio, legno
150 lux
3alta
Reperti e manufatti altamente sensibili alla luce, tessili, costumi, arazzi, tappeti, tappezzeria; acquerelli, pastelli, stampe, libri, cuoio tinto; pitture e tempere non verniciate, pittura a guazzo, pitture realizzate con tecniche miste o “moderne” con materiali instabili, disegni a pennarello; piume, pelli e reperti botanici, materiali etnografici e di storia naturale di origine organica o tinti con prodotti vegetali; carta, pergamena, legni bagnati
50 lux
4Molto alta
Reperti e manufatti estremamente sensibili alla luce:mummie; sete, inchiostri, coloranti e pigmenti a maggior rischio di scoloritura come lacche,
50 lux
fonte: Atto di Indirizzo, Controlli fotometrici-Illuminamenti raccomandati, pp. 129-130.
24 25
adatto al loro sviluppo; essi utilizzano la carta come terreno nutritivo e vi svolgo-no interamente o parzialmente l’intero ciclo vitale producendo danni di natura meccanica, chimica ed estetica.
I danni meccanici possono essere causati da insetti che intaccano il materiale o da miceti, le cui ife penetrano nelle pareti delle fibre cellulosiche.
I danni di natura chimica si manifestano con il peggioramento delle caratte-ristiche meccaniche delle fibre e la conseguente riduzione della funzionalità del supporto arrivando, in alcuni casi, alla sua completa distruzione.
I danni estetici, infine, sono riconducibili ad alterazioni cromatiche dovute alle attività di batteri e funghi che hanno la capacità di sintetizzare coloranti diffe-renti a seconda della specie, della fase di crescita, dell’acidità o basicità della carta, della sua diversa aerazione ed illuminazione.28
valentina terlizzi
28. pedeMonte, La carta cit., pp. 128-129; f. gallo, p. gallo, Insetti e microrganismi nemici dei libri, «Bollettino dell’Istituto per la Patologia del libro», luglio-dicembre 1967, pp. 143-190; M. Monta-nari, Agenti biologici che danneggiano i materiali librari ed archivistici, «Bollettino dell’Istituto per la Patolo-gia del libro», 1980, pp.163-193.
principali tipi di lampade a confrontotipo di lampada vantaggi svantaggiincandescenza costo d’acquisto basso;
dimensioni contenute; ottimo indice di resa cromatica; regolazione possibile
breve durata; elevati costi di esercizio; elevato sviluppo di calore; bassa efficienza
Fluorescenza elevata efficienza; lunga durata; sviluppo modesto di calore; possibilità di scegliere la temperatura di calore; costo di esercizio basso
costo iniziale elevato; sensibile alla temperatura; controllo ottico limitato; è necessario un alimentatore; luce con componente UV
alogene elevata efficienza; lunga durata; ottimo indice di resa cromatica; piccole dimensioni; regolazione possibile; luce bianca brillante
elevato sviluppo di calore; è necessario un alimentatore; luce con componente UV
Alogenuri metallici elevata efficienza; lunga durata; buona resa cromatica; buon controllo ottico; costo di esercizio basso
costo iniziale elevato; lungo periodo di accensione; è necessario un alimentatore
sodio ad alta pressione
elevata efficienza; lunga durata; buon controllo ottico; basso decadimento del flusso; costo di esercizio basso
costo iniziale elevato; è necessario un alimentatore; lungo periodo di accensione; bassa resa cromatica
leD luce pulita priva di componente IR e UV; scelta della temperatura di colore; assenza di costi di manutenzione; bassa tensione; lunga durata; costo d’acquisto basso
è necessario un alimentatore
fonte: Oggetti nel Tempo. Principi e tecniche di conservazione preventiva cit., p. 22
1.5 polvere e MicroorganisMi
La polvere è fra i nemici più tenaci dei libri. Il pulviscolo atmosferico è costituito da un insieme di detriti di sostanze minerali, vegetali ed animali, nonché di batteri e di microbi messi in moto da correnti atmosferiche e sospesi nell’aria. Quando nel chiuso di una biblioteca circola aria satura di questi elementi, la polvere si adagia e si sovrappone lentamente sui libri aderendovi. Inizia così l’azione no-civa dei detriti acidi o decoloranti e la moltiplicazione dei batteri ed organismi biodeteriogeni27. L’elevata umidità nei substrati delle carte fornisce un ambiente
27. a. gallo, Le malattie del libri. Le cure ed i restauri, Bologna 2006, pp.7-12.
26 27
parte ii
Casi Di sTuDio*
introduzione
il progetto “Conservazione preventiva nelle biblioteche di Puglia”, che ha avuto la durata di un anno (settembre 2009 - settembre 2010), si suddivide in due parti. La prima è consistita nel monitoraggio del microclima in quattro biblioteche pugliesi che, nello specifico, sono la biblioteca seminarile Innocenziana di Lecce, la bibliote-ca comunale Francesco Trinchera di ostuni, la biblioteca comunale Eustachio Rogadeo di Bitonto, la biblioteca e archivio vescovile Mons. Aurelio Marena di Bitonto. Delle quattro biblioteche tre sono collocate in palazzi storici (del XVII-XVIII secolo) e una in un palazzo moderno, costruito appositamente per ospitare la biblioteca. Ciascuno di essi è composta da ambienti aventi diverse destinazioni d’uso: sale lettura, depositi, uffici, sale conferenza e sale espositive.
Durante i sopralluoghi si è cercato di coinvolgere il personale delle biblioteche con la finalità di sensibilizzarlo alla prevenzione.
I dati raccolti mensilmente sono stati digitalizzati e confrontati con gli stan-dard stabiliti dalle istituzioni nazionali ed internazionali.
Le criticità ambientali e conservative riscontrate presentate in questo report finale.
La seconda parte del progetto si è svolta all’interno del laboratorio di restauro del libro, Codex. Qui sono stati restaurati, gratuitamente per l’ente proprietario, sei volumi, 2 a stampa e 4 manoscritti, che versavamo in pessimo stato di conser-vazione.
1.1 struMentazione utilizzata per il Monitoraggio aMBientale
Le misurazioni di umidità relativa (RH), temperatura (°C) e illuminamento (Lux) sono state effettuate con strumentazione portatile composta da un termoigrome-tro con sonda esterna, un luxomentro e da un termoigrometro a contatto.
Sono stati utilizzati anche dei misuratori passivi di umidità relativa e di illu-minamento disposti nelle zone in cui era conservato materiale librario di partico
* Sebbene questa seconda parte sia frutto di un lavoro congiunto, si attribuiscono a Valentina Terlizzi i contenuti delle seguenti pagine da 27 a 40, da 55 a 63, da 75 a 89; da 95 a 107; e a Giu-seppe De Filippis quelli da pagina 45 a 54, da 65 a 68; da 71 a 74; da 89 a 94; da 110 a 120.
parametri ambientali per biblioteche e archivi: fonti
anno Fonte istituzione luce temperatura umidità relativa
1980 Biblioteche Archivi e prevenzione contro gli agenti fisici
ICCRoM, autore G. de Guichen
50 lux 15-20°C 50-65%
1995 Draft of Enviromental standards for Exhibiting Library and archival Materials
national Information standard organization (US)
luce nel visibile max 150 lux
max 21°C e una variazione max giornaliera di 3°C
valori compresi fra il 35 e il 50% con una variazione giornaliera del 5% max.
1997 Documentazione-Condizioni climatiche per ambient di conservazione di documenti grafici e caratteristiche degli alloggiamenti
uni 10586 max 50 lux per disegni, acquerelli e pastelli su supporto cartaceo; max 150 lux per documenti archivistici su carta, pergamena, manoscritti volumi a stampa
19-24°C per disegni, acquerelli e pastelli su supporto cartaceo; 13-18°C per documenti archivistici su carta, pergamena, manoscritti volumi a stampa
45-60% per disegni, acquerelli e pastelli su supporto cartaceo; 50 -60% per documenti archivistici su carta, pergamena, manoscritti volumi a stampa
1998 principles for the care and handling of library material
iFla-paC 50-200 lux Max 20-22 °C 55-65%
2001 atto di indirizzo D.M. 10maggio 2001
Ministero per i beni e le attività culturali (Italia)
150-50 lux valori compresi fra i 19 e 24°C
valori compresi fra il 50-60%
28 29
- misurare l’illuminamento posizionando il sensore del luxometro perpendicolare alla superficie che riceve il flusso luminoso.
Sono state realizzate, inoltre, delle schede descrittive sulle biblioteche che com-prendono informazioni relative a:- tipologia di struttura. Consiste in una breve introduzione storica sulle bibliote-che coinvolte nel progetto, una descrizione dei fondi conservati e della struttura dell’edificio; - numero di sale monitorate. É stata realizzata una pianta delle biblioteche in cui sono schematizzate le sale monitorate e i punti di misurazione;- presentazione dei dati raccolti. I grafici e le permettono di avere una visualizzazione più immediata dei valori stagionali massimi, medi e minimi rilevati;- problematiche riscontrate. L’analisi critica dei risultati ottenuti e i confronti con stan-dard nazionali ed internazionali ha permesso di identificare i punti di debolezza delle biblioteche in ambito conservativo;- proposte di miglioramento. Sono delle linee guida per una più attenta conservazione dei beni archivisto-librari negli ambienti monitorati;- restauro dei volumi. L’introduzione storica e codicologica dei volumi avuti in con-segna è seguita dalla descrizione dettagliata e dalla documentazione fotografica delle fasi di restauro eseguite nel rispetto del Capitolato Speciale Tecnico Tipo, istitu-ito dall’ICPAL del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
2. analisi dei casi di studio
2.1 BiBlioteca seMinarile innocenziana di lecce: cenni storici
La biblioteca del seminario prende il nome di Innocenziana nel 1927, in occasio-ne dei festeggiamenti per il venticinquesimo anno di episcopato di mons. Genna-ro Trama che la intitola al Pontefice Innocenzo XII, al secolo Antonio Pignatelli, vescovo di lecce dal 1677 al 168229.
Le origini della biblioteca risalgono alla prima metà del ‘700. L’assenza di fon-ti documentarie non consente di stabilire una data esatta di fondazione. Secondo Fiorillo la biblioteca viene costruita tra il 1682, anno che segna l’inizio dell’epi-scopato di Michele Pignatelli, e il 1734. Caterino invece la collora tra il 1706 e il 1730 e ne attribuisce lo sviluppo al vescovo Fabrizio Pignatelli30.
29. o. Mazzotta, Il Seminario di Lecce (1694-1908), Lecce 1994, p. 85, M.e. Buccoliero, f. Marza-no, Incunaboli e Cinquecentine della Biblioteca Innocenziana di Lecce, Lecce 2004, p.7.
30. r. fiorillo, Incunaboli delle Biblioteche di Puglia, napoli 1942, p. 71; a. caterino, Il servizio biblio-grafico in Puglia e Lucania, Bari 1960, p. 127.
lare pregio. nello specifico, i lightcheck sono delle strisce di carta ricoperte da una sostanza sensibile alla luce che cambia colore durante l’esposizione e permette di valutare la quantità di luce ricevuta dall’oggetto comparando la colorazione finale della striscia con una scala che riporta i codici di esposizione luminosa equivalente (ELE). Sullo stesso principio si basano le humidity indicator cards che mostrano una scala di valori di umidità relativa costituita da dischetti di colore blu che diventano di colore rosa quando raggiungono il valore di RH corrispondente. I vantaggi di questi indicatori sono rappresentati dai loro costi contenuti e dalla loro efficacia.
fig.1-2-3-4-5: strumentazione utilizzata per il monitoraggio ambientale
Importante è stata l’identificazione di semplici linee guida metodologiche che possono essere sintetizzate nei seguenti punti:- mantenere l’efficienza degli strumenti controllando il livello della batteria di alimentazione prima di effettuare le misure;- non influenzare la misurazione con la vicinanza del corpo;- scegliere punti di misurazione, cercando di evitare le perturbazioni date dalle sorgenti di luce, umidità e calore;- organizzare preventivamente le misure annotando tutte le informazioni fonda-mentali che riguardano le condizioni in cui si stanno effettuando (luogo, ora, data, coordinate del punti di misura, clima);- scattare fotografie indispensabili per l’interpretazione dei dati;- ripetere più volte nello stesso punto nell’arco del sopralluogo le misurazioni;
1 2
3 4 5
30 31
autunnale l’umidità relativa è compresa fra il 58% e il 63% mentre la temperatu-ra oscilla fra i 20 e i 24°C.
Una decisiva diminuzione della RH si ha nei mesi invernali (dicembre-feb-braio) in seguito all’accensione del riscaldamento centralizzato. I valori registra-ti sono difatti compresi fra il 56 e il 38%. Quest’ultimo dato rilevato nel mese di febbraio, è però accompagnato dall’aumento eccessivo di temperatura (pari a 25,3°C) da ricollegare alle condizione climatiche esterne non particolarmente rigide e all’accumulo di calore interno.
Con l’arrivo della primavera i parametri tornano stabili e sono compresi fra il 50 e 58% di RH e tra i 20 e 23°C. All’inizio dei mesi estivi invece si registra nuo-vamente un innalzamento della temperatura che è ora compresa fra i 25 e 28°C.
Con un termoigrometro a contatto sono stati rilevati i parametri di umidità relativa e temperatura all’interno dei volumi. nella stagione autunnale i valori di RH sono compresi fra il 57 e il 59% e quelli della temperatura fra i 20 e 21°C; mentre durante l’inverno sono rispettivamente compresi fra il 54,4 e il 58,8% e i 19 e 23,8°C. Durante la primavera l’umidità relativa fra le carte dei volumi oscilla fra il 50,5 e il 57,7%, mentre la temperatura fra i 21 e i 23°C. I valori di quest’ultima aumentano notevolmente fino ad arrivare a 27,9°C nel periodo esti-vo (giugno-luglio) e l’umidità è compresa fra il 59 e 63,1%.
La prima sala della biblioteca è illuminata da cinque finestre molto grandi di cui soltanto due sono sempre schermate da tende di colore bianco, le altre sono lasciate con il vetro a vista. A questo si aggiunge la luce artificiale, necessaria per illuminare gli scaffali posti più internamente alla sala, ottenuta con lampade a fluorescenza.
nel seguente grafico sono stati sintetizzati i valori minimi e massimi di illumi-
Il patrimonio librario viene arricchito negli anni sia dai volumi provenienti dal 1799 dalle biblioteche di conventi soppressi di Lecce, Domenicani di San Giovani d’Aymo e dall’Annunziata, Gesuiti, Agostiniani Scalzi di Santa Maria di ognibene e Cappucini di Rugge, che dagli acquisti eseguiti da parte dello stesso seminario31.
Attualmente la biblioteca possiede 100 manoscritti e circa 27.000 volumi com-prendenti edizioni antiche e varie collane di opere moderne.
Purtroppo oggi è un patrimonio gravemente danneggiato per l’incuria o per «il comportamento dei lettori, collezionisti, antiquari poco scrupolosi che hanno sottratto materiale di pregio, reso mutili del materiale illustrativo gran parte dei libri antichi, smembrato opere in continuazione». 32
Fra i donatori ecclesiastici se ne ricordano alcuni vissuti nell’arco di due secoli: gli arcidiaconi Giovanni Camillo Palma, Principe dell’Accademia dei Trasforma-ti, Giovanni Battista Carro e Vincenzo Quarta, il cronista can. nicolò Fatalò e il protonotario apostolico can. Giovanni Battista Bernardini, il rettore can. oronzo Coppola e il prof. Paolo De Giorgi. Tra i laici merita di essere ricordato Francesco Giuliani, medico di nardò, morto nel 1821 che donò la sua biblioteca composta da un centinaio di libri, quasi tutti di gran pregio.
I libri che provengono da Gallipoli, Galugnano, Palmariggi, Torrepaduli, Tor-re Santa Susanna, Monopoli, Ugento, Parma, Roma, napoli, sono, in gran parte un segno di riconoscenza da parte di ecclesiastici o laici che avevano studiato nel seminario di Lecce.
2.2 Monitoraggio aMBientale
I parametri microclimatici della biblioteca Innocenziana sono stati rilevati in quattro sale comprendenti, a loro volta, un soppalco, nella prima sala, e un picco-lo vano-corridoio fra la seconda e quarta sala. In tutti questi spazi, i volumi sono collocati su moderni scaffali in metallo zincato.
La prima sala è suddivisa dall’arredo in due parti: la prima funge da sala lettu-ra con tavoli, computer per il personale e scaffali lungo la parete destra, la secon-da, invece, è adorna di scaffali sia lungo le tre pareti perimetrali che nella parte centrale, formando due corridoi percorribili.
nel seguente grafico sono segnalati i parametri di umidità relativa (RH) e di temperatura (T) registrati dal mese di settembre a quello di luglio. nella stagione
31. L. ingrosso, Un fondo librario Un fondo librario da salvare nella biblioteca “Innocenziana” di Lecce, lecce 1997, cit., p. 17.
32. t. rapanà, Cenni storici e situazione attuale, in La Biblioteca Innocenziana del Seminario Arcivescovile, «Bollettino diocesano», 3, 1983, p. 47.
32 33
posizionando un lightcheck ultra vicino a questi scaffali è stato possibile moni-torare l’illuminamento fra il mese di febbraio e il mese di marzo. La striscia di carta è diventata in soli 35 giorni del suo colore più chiaro; facendo, dunque, un semplice calcolo è possibile stimare l’esposizione o la quantità di luce ricevu-ta dall’oggetto: 75.000 lux (codice di esposizione ELE) per 365 giorni diviso 35 (giorni di esposizione del lightcheck) è uguale a 782.142, valore che supera di circa cinque volte i parametri standard di dose di luce annuale consigliati per gli oggetti appartenenti alla terza categoria di fotosensibilità.
Proseguendo con il monitoraggio ambientale, nella sala due sono stati regi-strati i valori di RH e T compresi, per il periodo autunnale, fra il 62 e il 64% e i 20 e 24°C. nei mesi invernali l’umidità relativa oscilla fra il 60 e 69% mentre la temperatura fra i 16 e 21°C. I parametri rilevati nei mesi invernali in questa sala e nelle prossime due non sono stati condizionati dall’accensione del riscaldamento che risulta essere limitata alla prima stanza della biblioteca. Durante la primavera
namento da settembre a luglio. I valori segnalati dal luxometro sui libri posti negli scaffali in prossimità delle finestre vanno dai 150 ai 370 lux; mentre nelle zone più interne dei corridoi creati dalle scaffalature, raggiunte soltanto dalla luce artificia-le, si hanno valori compresi fra i 20 e i 290 lux.
É doveroso segnalare che i volumi in prossimità delle finestre sono investiti direttamente dalla luce solare (ricca come già ricordato della componente IR e di quella UV) e che la tipologia di lampade utilizzate è ad alta emissione di UV e calore.
Il soppalco della sala è realizzato in ferro ed ha il piano di calpestio composto da lamine traforate. Questa tipologia di pavimentazione non è molto adatta alle biblioteche in quanto non permette di riparare i libri sottostanti dalla polvere sollevata, durante i camminamenti, dal personale o dai fruitori.
Durante i mesi autunnali, i valori dell’umidità relativa sono compresi fra il 58 e 61% mentre quelli della temperatura fra i 20 e 25,6°C. In inverno, per via dell’ac-censione del riscaldamento, l’umidità si abbassa registrando parametri compresi fra il 40 e il 57% mentre la temperatura oscilla fra i 19 e 25°C. nel periodo primaverile, si ha l’umidità relativa compresa fra il 53,4 e il 57,6% mentre, nei mesi estivi, si registra un aumento della temperatura (fino ai 28°C) e dell’umidità relativa fino al 62%.
nel grafico che sintetizza l’illuminamento è espresso il numero minimo e mas-simo dei lux rilevati durante l’anno. Si passa da valori molto bassi compresi fra i 20 e 50 lux per gli scaffali posti più al centro a valori compresi fra i 180 e 500 lux per i libri posti su scaffali vicini alle finestre.
34 35
Per quel che riguarda l’illuminamento, invece, le fonti di luce sono rappresen-tate da due finestre non schermate, posizionate ai lati opposti della sala, e dalla luce artificiale di lampade a fluorescenza.
Il luxometro ha segnalato, durante gli undici mesi di rilevamenti, dei valori compresi fra i 30 lux per i libri posizionati su scaffali lontani da fonti luminose e i 556 lux in prossimità delle finestre o in caso di luce artificiale in funzione.
Da questa sala si accede, attraverso pochi gradini, alla stanza successiva. La temperatura, durante le quattro stagioni, ha valori compresi fra i 16,8 e i 25°C mentre l’umidità relativa fra il 58 e il 72,3%; i picchi di maggiore percentuale di umidità sono stati rilevati nei mesi di dicembre, marzo e luglio.
Con il termoigrometro a contatto sono stati controllati i parametri di RH e T all’interno dei volumi rilevando dei parametri compresi fra il 58,3 e il 69,8% di RH e i 20,6 e 19,5°C.
i valori si mantengono compresi fra il 53 e 69,4% per l’umidità relativa e i 19,5 e 23 °C per la temperatura. Decisamente allarmanti sono invece i parametri rilevati all’inizio del periodo estivo. L’umidità relativa sale al 71,5% e la temperatura si mantiene costante intorno ai 25-26°C.
fig.6-7: danni causati dall’umidità fig. 8-9: finestre prive di schermatura
6
7
8
9
36 37
I lux rilevati sui libri lontani dalla finestra sono fra i 35 e i 70; mentre, quelli registrati in prossimità della fonte luminosa sono fra i 120 e i 490. È opportuno specificare però che al momento non sono posizionati scaffali vicino alla finestra.
nella tabella successiva sono sintetizzati in una visione d’insieme i valori mini-mi, medi e massimi di temperatura e umidità relativa rilevati fra settembre 2009 e luglio 2010.
stagioni tmin tmed tmax rhmin rhmed rhmax
autunno 19 20,3 25,6 59 63 67,7
inverno 16,1 17,8 25,3 38,3 59,7 73,2
primavera 19,3 21,5 23,2 49,7 54,3 69,8
estate 23 25 27,5 51 57 73,8
2.3 linee guida
Durante il monitoraggio ambientale, l’Associazione Folio ha non solo monitorato temperatura, umidità relativa e lux, ma ha anche valutato la pulizia della biblio-teca, l’areazione e l’idoneità della scaffalatura.
Per quanto riguarda la prima, è stata riscontrata la presenza eccesiva di polvere nelle sale non quotidianamente vissute dal personale della biblioteca. Si consiglia di provvedere con un intervento di pulitura soprattutto nelle zone in prossimità delle finestre, infestate da ragnatele e strati di polvere sui vetri.La polvere è una miscela di frammenti di particelle minute di materiale minerale e vegetale, fibre tessili, fumi, grasso da impronte digitali e altri materiali organici e
Questa sala è illuminata, oltre che da luce artificiale a fluorescenza, anche da una finestra non schermata. I rilevamenti effettuati hanno registrato dei valori di illuminamneto compresi fra i 30 e i 100 lux negli scaffali più lontani dalla sorgente luminosa e fra i 286 e 623 lux in prossimità della finestra.
L’ultima sala monitorata è la sala 4. Durante i mesi autunnali l’umidità relati-va è compresa, secondo i nostri rilevamenti, fra il 64,5 e il 67,7% e la temperatura fra i 16,7 e 23°C. nei mesi invernali i valori si mantengono pressocché costan-ti e compresi fra il 62 e 67%, con un picco nel mese di dicembre che segnala un’umidità relativa pari al 73,4%. nei mesi primaverili e quelli estivi i parametri di umidità relativa si mantengono fra il 64 e il 71% mentre la temperatura oscilla fra i 19 e i 25°C.
I valori dell’illuminamento, anche in questo caso, sono determinati dalla pre-senza di una finestra non schermata e da quella di luce artificiale a fluorescenza.
38 39
Per la massima protezione dei libri dovrebbero essere rispettate le seguenti regole:- collocare i libri sui palchetti in modo che non sia difficoltoso prenderli o ricol-locarli;- utilizzare reggilibri per sostenere i volumi quando i palchetti non sono pieni. I libri lasciati inclinati si distorcono, e i reggilibri, dalle superfici lisce e sponde lar-ghe, hanno la funzione di impedire che le coperte siano escoriate e i fogli strappati o sgualciti;- non lasciare che i libri sporgano oltre il bordo dei palchetti verso i corridoi;- tenere separate le legature in carta e in tela da quelle in pelle. L’acidità e gli oli che si trovano nelle pelli migrano nella carta e nella tela e accelerano il loro de-terioramento;- spostare i libri o risistemare i palchetti se i libri sono troppo alti per restare dritti; - non appoggiare i libri sul taglio anteriore perché si danneggia la struttura del libro e si allenta la legatura.
Per quanto riguarda i parametri microclimatici rilevati, è evidente nella sala 1 la necessità di provvedere, in tempi brevi:- nella schermatura con pellicole anti UV delle finestre. Si potrebbe ovviare con l’applicazione di tende alle due finestre posizionate ai due estremi del soppalco, facendo però attenzione a non oscurare troppo i palchetti centrali della sala;- nel posizionamento di deflettori alle luci artificiali a fluorescenza. Le lampade attualmente montate sono dotate di alette che però non svolgono la loro funzione in quanto la luce colpisce direttamente il dorso dei libri;- durante i mesi invernali, a non azionare il riscaldamento in giornate non proprio rigide al fine di non creare degli sbalzi eccessivi di umidità relativa e temperatura;- a tenere sotto controllo la temperatura che nei mesi primaverili ed estivi oscilla fra i 26 e i 27°C con una umidità relativa pari al 60%. Il caldo accompagnato da umidità relativa elevata favorisce lo sviluppo di muffe e crea un ambiente propizio per animali infestanti e insetti.Indispensabili in tutte le altre sale monitorate sono:- dei deflettori di luce artificiale; - la schermatura delle finestre con pellicole anti UV;- l’areazione dei locali e la realizzazione di un impianto di deumidificazione al fine di mantenere l’umidità relativa intorno al 50-55%.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, è importante sottolineare che nelle sale 2-3 e 4, sono custoditi soltanto libri moderni e riviste, e non, come nella sala 1, legature in cuoio e pergamena. Un’ umidità relativa costantemente al di sopra del 65%, come quella rilevata durante i nostri monitoraggi, può provocare, sia nel materiale librario antico che in quello moderno, un ammorbidimento delle colle
inorganici. In questa miscela chimica ci sono spore di innumerevoli muffe, funghi e microrganismi che vivono del materiale organico contenuto nella polvere. È im-portante non dimenticare che la polvere è igroscopica, e questa sua propensione può favorire lo sviluppo di muffe all’interno dei volumi.Purtroppo durante i sopralluoghi non è stata fotografata una realtà ottimale: i libri antichi della biblioteca hanno spesso all’interno vecchie carcasse di insetti, resti di legature ormai fatiscenti, frammenti di carte sbriciolate da attacchi micro-bici e insetti. Il personale della biblioteca Innocenziana è molto attento e sensibile allo stato di conservazione della biblioteca e dei volumi, alcuni progetti di spol-veratura e restauro sono stati già realizzati sebbene i risultati, come si evince dai dati raccolti, siano ancora lontani dal raggiungimento di parametri ottimali per la conservazione dei fondi librari.
fig.10-11-12: accumuli di polvere sui volumi e nelle sale
Le scaffalature della biblioteca sono moderne, in metallo, ma non sono idonee a contenere i diversi formati dei libri, costringendoli in posizioni non del tutto consone alla conservazione delle legature. Inoltre la mancanza di piani di ap-poggio nelle parti laterali dei palchetti impedisce lo sfruttamento dello spazio in profondità.
fig.13-14: libri custoditi sui palchetti in posizione errata
1413
10 11 12
40 41
la traduzione in francese del Medicinal Dictionary di Robert James, pubblicato tra il 1743 e il 1745 valse a Diderot una solida esperienza e una buona fama di traduttore, che spinse l’editore le breton a progettare un’altra traduzione, ancora in francese, della Cyclopedia or an universal dictionary of Arts and Sciences di Ephraim Chambers (1680-1740), uscita per la prima volta a Londra nel 1728. non si trat-tò, tuttavia, di una semplice trasposizione in un’altra lingua, ma dell’evento che diede il via all’Encyclopédie illuminista:
Enciclopedia, (Filosofia). Questa parola significa «concatenazione delle scien-ze»; […]. Scopo di un’enciclopedia è infatti raccogliere conoscenze sparse sulla faccia della terra, esporne ai nostri contemporanei il sistema generale, trasmet-terle ai posteri, affinché l’opera dei secoli passati non sia stata inutile per i secoli a venire […].34
nel suo Prospectus, ristampato poi come seguito del Discours préliminaire di d’Alembert all’interno del primo tomo dell’Encyclopédie, che uscirà nel 1751, Di-derot, inoltre, si chiedeva cosa avrebbe pensato il pubblico francese se si fosse tradotto il testo di Chambers, nascosto sotto un nuovo titolo, e dunque «si sa-rebbero presentate ricchezze che esso [il pubblico] già possedeva»35. Il 16 agosto del 1747, dopo l’abbandono di Gua de Malves, Denis Diderot e Jean Le Rond d’Alembert subentrarono nella direzione dell’opera. La Cyclopedia era così diven-tata Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par un société de gens de lettres: 28 volumi in folio, 71818 voci, 2885 tavole che poggiavano le basi su criteri razionali di misurazione dell’attività dell’uomo.
Tale rottura con le conoscenze tradizionalmente accettate dall’autorità intel-lettuale misero in scacco l’opera. Gli enciclopedisti fuorno accusati di voler di-struggere la religione e di voler minare le fondamenta dello Stato. Come spesso succede, furono proprio queste insinuazioni, tuttavia, a rendere ancora più po-polare l’Encyclopédie. Le sottoscrizioni aumentavano considerevolmente. L’opera da una tiratura di partenza di 1625 copie giunse a 4255 copie nel 175436. Ma le accuse divennero ancora più incalzanti negli anni dal 1757 al 1759. nel 1758, infatti, Claude Helvétius aveva pubblicato il suo De l’esprit. Il libro fece scandalo e fu accusato di propagandare l’ateismo più sfrenato. Le colpe, sebbene l’autore non fosse annoverato tra i redattori dell’Encyclopédie, ricaddero, nemmeno a dirsi,
Lumi. Storia editoriale dell’Encyclopédie. 1775-1800, Milano 1998, pp. 17-18: Si veda anche Ragione e civiltà. La visione illuministica del mondo nell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, a cura di E. vitale, Milano 1998.
34. s.v. Enciclopedia, in Enciclopedia, o dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, a cura di A. pons, Milano 1966, p. 473.
35. In dioguradi, Dossier cit., p. 174.
36. darnton, Il Grande Affare cit., p. 21.
con perdita della loro forza adesiva; se a questo si aggiunge la presenza di zone con scarsa circolazione d’aria, l’insorgere di muffe diventa pressoché inevitabile.
Il volume avuto in consegna dalla biblioteca Innocenziana per il restauro è intitolato Planches pour l’encyclopédie ou pour le dictionnaire raisonné des sciences des arts libéraux et des arts mechaniques avec leur explication (Tome Premier), datato al 1765, stampato a Lucca presso Vincenzo Giuntini, ed è composto da 298 carte.
2.4 encyclopédie: introduzione storica
2.4.1 l’edizione lucchese dell’encyclopédie nella BiBlioteca innocenziana di lecce
[…] / Fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza
Dante, Inferno, XXVi, 119-120
1. Parigi
nel seguire i percorsi che portarono alla stampa dell’Encyclopédie parigina, nella seconda metà del secolo XVIII, quello che a una prima visione salta agli occhi è il carattere a dir poco avventuroso, quasi romanzato, dell’intera impresa. È la storia di spie e di spiati, di attacchi velenosi e di censure, di volumi sequestrati e di volumi nascosti, di esili volontari e di arresti illustri. È la storia del libero pensiero e della conoscenza che si raggiunge grazie ai sensi ed è ordinata dalla ragione coadiuvata dalle facoltà sorelle, la memoria e l’immaginazione. È anche la storia di un gruppo di pensatori illustri, che furono poi chiamati enciclopedisti o philoso-phers, Diderot, d’Alembert, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, d’Holbach, Turgot, Grimm tra gli altri. È la storia, infine, di un grandioso progetto editoriale, che vide stampatori ed editori unirsi in società e sottoscrittori che acquistarono, in Francia e all’estero, i volumi sulla carta, ancor prima di vederli stampati, convinti e per-suasi dalle idee e dallo spirito cosmopolita e illuminista che percorreva il progetto e l’intero continente europeo33.
33. La bibliografia sull’Encyclopédie, come ovvio, è vastissima. Qui si rimanda a pochi volumi e alle opere ivi segnalate: F. venturi, Le origini dell’enciclopedia, Torino 1977; J. proust, L’Encyclopédie: storia, scienza, ideologia, Bologna 1978; Saggi e note sull’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, a cura di A. calzolari, XVIII, Milano 1980; G. dioguardi, Dossier Diderot, Palermo 1995; R. darnton, Il Grande Affare dei
42 43
Promotore di tale fatica fu ottaviano Diodati, in collaborazione con lo stam-patore Vincenzo Giuntini42. Il Diodati – che con Diderot aveva in comune, oltre al giorno di nascita, il 5 ottobre, non soltanto l’impresa editoriale, ma anche un matrimonio contrastato che lo portò all’espulsione dalle file del patriziato che reg-geva la Repubblica – aveva già promosso la stampa della traduzione italiana del Journal encyclopédique di Liegi, sebbene edulcorato con alcune aggiunte43. Questo sistema di aggiunte e note venne utilizzato anche per la ristampa dell’Encyclopédie, con funzione non soltanto di correggere errori del testo originale, ma anche, e soprattutto, di fornire un’interpretazione ortodossa dei passi più controversi. La redazione fu affidata a religiosi lucchesi, tra i quali spicca Domenico Mansi, favo-revole alla diffusione delle idee dei philosophers, a patto che queste non mostrassero eccessi deisti, atei o anticlericali44.
La ristampa lucchese riproduceva, comunque, lo stesso impianto dell’edizione parigina. Tale scelta comportava, come è stato a ragione sottolineato, un notevole ribasso dei costi di produzione: si trattava, infatti, di lavorare su forme già predi-sposte, e con una minore spesa per i disegnatori e per gli incisori delle tavole, che prendevano a modello quelle dell’Encyclopédie francese45. Da sottolineare è anche il fatto che l’edizione lucchese usciva pressappoco negli stessi anni della princeps, per lo stesso pubblico aristocratico e alto-borghese, così come per le ricche istituzioni monastiche. Era ovvio, dunque, che anch’essa soffrisse degli stessi mali dell’opera
italiano», 18 (1873), pp. 64-90; E. levi-Malvano, Les éditions toscanes de l’Encyclopédie, in «Revue de Littérature Comparée», 3 (1923), pp. 213-256; Secondo centenario della edizione lucchese dell’Enciclopedia, Firenze 1959; più recentemente si veda darnton, Il Grande Affare cit., pp. 244-247; V. Baldacci, L’Enciclopedia nella Toscana del ‘700: sucessi e fallimenti di progetti editoriali, in «Rassegna storica toscana», 31 (1985), pp. 195-230; P. Bellucci, Le edizioni toscane dell’Encyclopédie, in «Ibid.», 34 (1988), pp. 189-223; L’enciclopedismo in Italia nel XVIII secolo, Atti del Convegno (Perugia, 20-22 ottobre 1994), a cura di G. aBBattista, napoli 1996; L’edizione lucchese dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert (1758-1776) e i suoi incisori, a cura di M. paoli, I. Manfredini, Lucca 2002.
42. Cfr. M. rosa, Diodati, Ottaviano, in Dizionario biografico degli italiani, 40, Roma 1991, pp. 179-183 (d’ora in poi DBI). Sul frontespizio dei primi volumi si legge: EnCyCLoPÉDIE, oU DICTIonnAIRE RAISonné DES SCIEnCES, DES ARTS ET DES MéTIERS. PAR UnE SoCIÉTÉ DE GEnS DE LETTRES. Mis en ordre & publié par M. DIDERoT, de l’Académie Royale des Sciences & des Belles-Lettres de Prusse; & quant à la PARTIE MATHÉMA-Tique, par M. D’ALEMBERT de l’Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse, & de la Société Royale de Londres. Seconde Edition enriche de notes, & donnée au Public par M. oCTAVIEn DioDaTi noble luCquois. A LUCQUES Chez VInCEnT GIUnTInI Imprimeur.43. Il Giornale enciclopedico apparve dapprima presso il Giuntini, poi presso lo stampatore Giusti, quando il primo inziò la ristampa dell’Encyclopédie, cfr. rosa, Diodati cit., p. 180.
44. F. vannini, Mansi, Giovanni Domenico, in DBI, 69, Roma 2007, pp. 144-148.
45. L’edizione lucchese dell’Encyclopédie cit., p. 8.
su Diderot e d’Alambert37. nel gennaio del 1759 il Parlamento proibì la vendita dell’Encyclopédie, mentre nel frattempo era in stampa l’ottavo volume, e nominò una commissione d’inchiesta. L’8 marzo il Conseil d’État, che aveva avocato a sé l’autorità del re sulla stampa francese, ordinò la distruzione dell’opera e proibì agli editori di proseguirla, annullando contestualmente il privilegio a loro conces-so. Il 3 settembre dello stesso anno, infine, l’enciclica Ut primum di papa Clemente XIII si apriva con una «damnatio et prohibitio operis in plures tomos distribuiti, cujus est Titulus: Encyclopédie, ou Dictionaire raisonnè […]»: se tutti i possessori non l’avessero fatta bruciare sarebbero stati scomunicati38.
La struttura illuminista, nondimeno, sosteneva tutto il peso; l’Encyclopédie conti-nuò a circolare a Parigi e Versailles, raggiungendo le province dell’estero. Si narra che fu lo stesso Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, il Directeur de la Librarie, dunque soprintendente al commercio librario negli anni cruciali dal 1750 al 1763, e potente protettore dei philosophers, ad avvisare Diderot del pro-babile sequesto delle sue carte e dei suoi appunti da parte della polizia. Quando Diderot si rese conto che non avrebbe avuto il tempo per nascondere tutto il ma-teriale, Malesherbes propose di inviarlo a casa sua. Lì nessuno l’avrebbe cercato39. nei mesi successivi gli editori riuscirono a ottenere un nuovo privilegio: gli ultimi dieci tomi di testo uscirono tutti insieme nel 1765, sotto una falsa sigla editoriale, come avveniva spesso per evitare la censura nazionale.
Lo stesso Le Breton, per evitare future persecuzioni, pensò bene di mutilare e correggere molti dei migliori articoli, bruciandone poi i manoscritti. Diderot non gli perdonò mai tale atrocité. Continuò a lavorare agli ultimi due volumi di tavole, che uscirono nel 1772, con uno spirito diverso, senza più gioia, senza più slancio, abbandonato da d’Alembert, da Voltaire e dalla maggior parte degli autori che parteciparono al progetto iniziale. «nello spazio di qualche mese ho visto in peri-colo il mio onore, la mia fortuna, la mia libertà, la mia vita»40.
2. Lucca
Il 16 giugno 1758 fu presentato solennemente al Senato della Repubblica di Luc-ca il primo volume della seconda ristampa dell’Encyclopédie, impresa editoriale ini-ziata nel 1756 e che sarebbe terminata nel 177641.
37. Ibid., pp. 21-22.
38. Per l’intera bolla cfr. http://encyclopedie.uchicago.edu/node/117.
39. Cfr. J.B. Borges, Prologo, in Saggi e note cit., p. 12; darnton, Il Grande Affare cit., p. 22.
40. Così Diderot, in Borges, Prologo cit., p. 12-13.
41. Sull’edizione lucchese dell’Encyclopédie cfr. S. Bongi, L’Enciclopedia in Lucca, in «Archivio storico
44 45
possibile, tuttavia, in questa sede, scorrendo il catalogo dell’Innocenziana, segna-lare che le opere erudite del XViii secolo rappresentano un gruppo consistente dell’intero patrimonio librario.51 L’esemplare lucchese dell’Encyclopédie ne è, per ovvie ragioni, la punta di diamante.
È possibile, restando sempre nel campo delle ipotesi, che l’acquisto dell’opera sia stato di poco successivo all’edificazione della biblioteca, annessa al Seminario di Lecce, collocabile intorno alla prima metà del Settecento. I fondi che la com-pongono, come è stato notato, sono prevalentemente di indirizzo filosofico, con testi anche di natura teologica, liturgica, letteraria e scientifica.52 l’Encyclopédie, dunque, sarebbe andata ad arricchire significativamente tali fondi. E forse non è un caso che proprio l’edizione lucchese, con le aggiunte e le annotazioni dei reli-giosi di quella città, che avrebbero dovuto correggere gli “errori” dei philosophers, sia entrata a far parte del patrimonio librario di un’istituzione ecclesiastica.
non può escludersi neppure la possibilità che l’opera provenga da una dona-zione privata, come per un numero notevole di esemplari dell’Innocenziana. Il silenzio dei volumi che, come si diceva, non riportano né ex libris, né alcuna nota di possesso, tuttavia, rende più labile tale eventualità. Ma non va dimenticato che, almeno per il primo volume delle Planches, è andato perduto l’occhiello e il fronte-spizio, e che la coperta era di riuso:53 è in questi luoghi che riecheggia più spesso la voce del possessore.
nonostante il silenzio che circonda la vicenda di questo esemplare, vicenda che si svolse da Parigi a Lecce, passando per l’intera Europa, appare suggestivo, quasi contrappasso della storia, il destino che, fino ad anni recenti, aveva caratterizzato tutti i tomi dell’Encyclopédie leccese. Essi erano stati murati all’interno di una gran-de stanza, con altri volumi “infestati” da insetti lucifughi. Senza via d’uscita, come se, d’un tratto, si fosse compiuta la volontà lucifuga della Chiesa di Roma.
salvatore sansone
2.5 restauro dell’encyclopédie della BiBlioteca innocenziana di lecce
Il volume in folio (430x265x65) era in pessimo stato di conservazione. La coperta che lo comprendeva era in piena pergamena rigida formata da due piatti in car-tone pesto di colore bruno foderati con carte di reimpiego derivanti da un testo giuridico (presumibilmente del XIX secolo) e da un dorso molto frammentario che presentava, in testa, dei tagli netti con asportazione del supporto.
51. Ibid., p. 20.
52. Ibid., p. 15
53. Cfr. il contributo sul restauro del volume.
condotta dai philosophers. L’aggiunta delle note, infatti, non contribuì a risolve-re i problemi legati alla censura della Chiesa di Roma, sebbene la Repubblica di Lucca godeva di un’ampia tradizione libertaria e avesse creato nel 1549 un “offizio sopra la Giurisdizione”, sorta di organo di controllo che non sottostava all’ingerenza romana46. Domenico Mansi fu ammonito a non continuare quel lavoro, che sospese solo ufficialmente: le sue note, anonime, apparvero almeno fino al quinto volume47. Sotto il pontificato di Clemente XIII, dopo una lunga se-rie di questioni relative all’attribuzione di competenze, l’edizione lucchese venne condannata così come qualunque altra edizione del Dictionaire raisonnè48. A Lucca, tuttavia, il Senato rifiutò di concedere l’exquantur al breve papale. In nessun conto furono tenuti i proclami della Chiesa di Roma nel suo più alto rappresentante, né dal Senato appunto, né dai nobili, né dagli editori, ché anzi vennero considerati una pesante ingerenza nelle libere scelte culturali della città: l’edizione lucchese uscì regolarmente, anch’essa però senza luogo di stampa e senza l’indicazione di ottaviano Diodati come curatore.
Gli storici non sono concordi sul successo dell’edizione lucchese. È un fatto, in ogni caso, che all’uscita del primo volume, nel 1758, i sottoscrittori erano già 700, che dell’edizione furono tirati 1500 esemplari completi e che l’Encyclopédie fu venduta non soltanto in Italia, ma anche all’estero49.
3. Lecce
La presenza di uno degli esemplari dell’edizione lucchese presso la Biblioteca innocenziana di lecce apre una serie di interrogativi che soltanto studi futuri potranno contribuire a chiarire. I tomi dell’Encyclopédie, infatti, che si conserva incompleta e spesso mutila di occhielli e frontespizi,50 non riportano nessun tipo di indicazione che possa in qualche modo far risalire al possessore dell’opera e, più in generale, alle vicende storiche legate ai volumi. Le pessime condizioni di con-servazione, inoltre, rendono ancora più ardua la ricerca. L’importante intervento di restauro, appena concluso, sul primo volume delle Planches rappresenta soltanto il primo passo verso una visione più ampia della particolare situazione storica. È
46. Cfr. Bellucci, Le edizioni toscane cit., p. 196 e H.K. Weinert, L’opera degli enciclopedisti di Lucca, in Secondo centenario della edizione cit., p. X.
47. vannini, Mansi cit., p. 147.
48. L’intera vicenda può leggersi in Bellucci, Le edizioni toscane cit., pp. 198-204.
49. Bellucci, Le edizioni toscane cit., pp. 208-209; darnton, Il Grande Affare cit., p. 37 e nota 140 p. 450.
50. Si veda, in questo volume, l’intervento di restauro sul primo tomo delle Planches e ingrosso, Un fondo librario cit, Lecce 1997, pp. 20-21 e pp. 192-195.
46 47
Di seguito si riportano tutti gli interventi e le fasi di restauro eseguite sul vo-lume.
Progettazione degli interventi di restauro
La scheda progetto, compilata dal personale tecnico del laboratorio, riassume, in una visione d’insieme, lo stato di conservazione del volume, le caratteristiche dei danni riscontrati ed evidenzia le cause della compromessa integrità di tutte le componenti del libro. Sulla base di questa preventiva ricognizione sono state valutate le tecniche e metodologie da impiegare nella fase di restauro.
Rilevamenti fotografici
Sono state realizzate diverse sequenze fotografiche, in digitale ed alta definizione, al fine di documentare lo stato di conservazione del volume al momento dell’ac-quisizione, tutte le fasi del restauro e l’allestimento della nuova coperta. Utiliz-zando un obiettivo macro, è stato possibile fotografare nel dettaglio alcune delle planches presenti nel volume al fine di approfondire la conoscenza sulla tecnica di esecuzione delle incisioni.
L’osservazione allo stereomicroscopio delle carcasse di insetti ritrovate all’in-terno del libro durante la fase di smontaggio ha permesso di identificare la loro famiglia di appartenenza.
Smontaggio
Durante la fase di smontaggio, eseguita utilizzando bisturi, forbici e spatole, il volume è stato scucito e sono stati asportati i resti dei fili di cucitura che attraver-savano il centro dei fascicoli. nel presente volume, le Planches erano state asportate dalle originali braghette e unite tra loro formando fascicoli di tre carte (un bifolio e una carta singola) ancorati al corpo del libro con delle strisce di carta sovrap-poste.
Lungo il dorso, in prossimità della piega di cucitura, è stata riscontrata la pre-senza di crepe e sfaldature causate da vecchi collanti di tipo animale ormai indu-riti.
La coperta era gravemente danneggiata da camminamenti di insetti che ave-vano intaccato le parti perimetrali. Durante le fasi di progettazione, sono state riscontrate alcune anomalie: la coperta risultava infatti composta da due coperte di riuso, la prima in quarto e la seconda in ottavo. nel rimbocco anteriore del piatto posteriore è stato possibile leggere parte del titolo originariamente presente sulla coperta in quarto, D. Dionisio […] Opera.
Lo stesso stato di conservazione è stato riscontrato nelle cuciture, ormai prive di funzionalità, realizzate su cinque nervi singoli in traccia Il dorso, inoltre, non presentava tracce di indorsatura e di capitelli.
I camminamenti di insetti all’interno del volume hanno reso le carte estrema-mente fragili e frammentarie soprattutto lungo i margini ed hanno causato lievi compattamenti e perdita di supporto.
figg.16-17: stato di conservazione del volume
Il volume, mutilo di occhiello e frontespizio, conserva la numerazione antica com-posta da numeri romani, da I a VII, nella introduzione dal titolo État par ordre alphabe-tique des matieres qui formeront le complet de ce Recueil général e nelle Tavole, e numeri arabi per il resto delle carte. Queste riportano, in basso a destra, i richiami di pagina.
La prima parte del volume (da carta 1 a 18) illustra l’agriulture et economie rustique e si compone di 83 tavole; si passa poi all’aiguillier (ricamo) descritto in 4 tavole; se-gue la parte dedicata all’anatomie composta da 20 carte che descrivono le 33 plan-ches. L’esemplare risulta però mutilo delle tavole LXXXVIII, IXIV, IXVI, IXIX, CI. L’argomento successivo è Antiquitates composto originariamente, come speci-ficato nella introduzione descrittiva, da 11 tavole di cui ne sono rimaste soltanto 4 (VIII-IX-X-XI); l’Architecture descrive in 19 carte le 81 planches sull’argomento; il volume risulta però mutilo di 13 tavole. Il mestiere dell’argenteur e quello dell’ar-murier sono descritti ciascuno da due tavole; l’arte dell’archibugiere è descritta in 6 tavole. L’art militaire suddivsa in Exercice, Evolutions de l’infanterie, Evolutions de la cavallerie, Fortification et artillerie si compone di 38 tavole. L’ultimo mestiere, quello dell’Artificier è composto da sette tavole.
16 17
48 49
dorso e sui piatti del volume. Questi insetti arrecano danni alle carte, al cuoio, alla pergamena, alla colla di amido sia nello stato larvale, scavando nei materiali gallerie tortuose a sezione circolare, che nella fase adulta, creando profondi fori che si estendono dai margini verso il centro della pagina.
specie Lepisma saccarina
Sviluppo embrionale a 22°C 43 giornia 32°C ….19 giornile uova schiudono a temperature comprese tra 22°C e 37°C a seconda dell’umidità. Per esempio: a 22°C è necessaria una UR superiore al 50%; a 29/32°C è necessaria una UR superiore al 75%
sviluppo delle neanidi a 27°C….90/120 giorniVitalità dell’adulto a 27 °C….circa 3 anni e mezzo
a 29 °C….circa 2 anni e mezzoa 32 °C….circa un anno e mezzoGli adulti possono sopravvivere parecchi mesi a 1 °C
Condizioni termo igrometriche ottimali per la specie
Temperatura 16/24 °C; umidità relativa 90%
fonte: Gallo, Il biodeterioramento cit., p. 15
specie Anobium punctatum Stegobium paniceum
Sviluppo embrionale a 20 °C 87% UR…15.5 gga 20 °C..43%UR….23.3 gga 22.5 °C le uova non schiudono se l’umidità relativa è inferiore al 45%; a questa tempera-tura i valori igrometrici ottimali per la schiu-sa delle uova sono compresi fra il 65 e il 95%
le uova non si sviluppano a 4 °C ma possono conservare la loro vitalità per mesi anche a -5%
sviluppo larvale A 20 °C lo sviluppo si verifica se l’umidità relativa dell’aria è superiore al 65%
a 22°C..70% UR..50gga 18 °C 110/140 gg
Condizioni termo igrometriche ottimali per la specie
T 22-23°C..UR 80/90%. Questi insetti resistono a temperature inferiori a 0°C purché l’abbassamento di temperatura sia graduale. Temperature letali: superiore a 30°C a 51°C le larve muoiono in 5 minuti
T 28°C 70%URTemperature letali: 10°C 44°C
Durata del ciclo vitale
generalmente 2 anninei climi caldi si possono avere 2 generazioni in 1 anno
a temperature relativamente basse una generazione l’anno negli ambienti riscaldati 3-4 generazioni in un anno
fonte: Gallo, Il biodeterioramento cit., p. 36
figg. 18-19: smontaggio della coperta e dei fascicoli
Tra i fascicoli e i frammenti di indorsatura, sono stati ritrovati i resti e le car-casse di Lepisma saccharina e Anobidi.
il Lepisma saccharina meglio noto con il nome pesciolino d’argento appartiene alla famiglia Lepismatidae composta da più di 200 specie. La presenza di questi insetti è stata segnalata in numerosi paesi con clima temperato, tropicale e subtropicale. I lepismidi vivono negli ambienti umidi e hanno abitudini notturne. Le femmine de-pongono le uova in luoghi ripartiti e nascosti. Essi si nutrono di amidi (per esempio adesivi di origine vegetale), tessuti di nylon, lino e cotone e la carta. Avendo inoltre bisogno di piccole quantità di proteine, si cibano anche di insetti morti e colle di origine animale.54 I lepismidi provocano erosioni superficiali e contornate.55
Per quanto riguarda gli anobidi, l’intero ciclo vitale avviene all’interno dei ma-teriali in cui sono annidati e, per tanto, dalla loro presenza quasi sempre ci si accorge quando l’insetto adulto rompe la superficie che lo separa dall’esterno e fa su di essa fori di forma circolare. Tali fori di sfarfallamento erano evidenti sul
54. f. gallo, Il biodeterioramento di libri e documenti, ICCRoM, Roma 1992, pp. 12-17 e 32-43.
55. Il volume delle Planches restaurato in questa occasione è solo uno dei tanti presenti nella biblio-teca Seminarile di Lecce che versano in pessimo stato di conservazione. Una esaustiva descrizione di parte del fondo librario è fornita da gallo nel libro Le malattie del libro cit., alle pp. 9 e 43:«In alcune regioni d’Italia l’umidità atmosferica e quella del sottosuolo assorbita dalle pareti tufacee per imbibizione producono danni di alta specie» e ancora «verso il 1929 avemmo occasione di osser-vare i danni impressionanti prodotti dagli insetti nelle biblioteche di Terra d’otranto, specialmente nella Provinciale e nella Seminarile di Lecce, nella comunale di Galatina e nella Vergari di nardò. Imponenti gruppi di libri erano stati in pochi anni divorati e gli altri erano infestati da insetti che serpeggiavano da ogni parte con un intenso formicolio. Un esame accurato di essi ci mise in con-dizioni di accertare che appartenevano alla famiglia dei lepismidi […].Essa non solo mostrava una spiccata predilezione per i libri umidi e per la carta a mano, ma non colpì in nessun luogo i vari legni […]. Caratteristici i camminamenti ramificati dai dorsi o dai tagli all’interno dei libri, in seni a fondo cieco. Probabilmente una così vasta propagazione di lepismidi derivò dai numerosi magazzini di tabacco della regione, alcuni dei quali furono simultaneamente infestati dagli stessi insetti».
18 19
50 51
fig. 20: lavaggio di deacidificazione
Restauro meccanico (leaf casting)
Si è proceduto con il restauro meccanico delle carte in quanto il volume presen-tava gravi danni causati da camminamenti di insetti in tutte le carte. L’intervento di restauro meccanico ha consentito di risarcire tutte le lacune e le lacerazioni reintegrando le parti mancanti del documento. Tra le fibre di cellulosa depositate nelle parti mancanti e quelle del supporto originale si instaurano gli stessi lega-mi chimici presenti all’atto della fabbricazione della carta. Contemporaneamen-te alla fase di reintegro si è proceduto alla collatura. Essa consiste nel porre sul supporto, dopo l’aspirazione dell’acqua, un reemay precollato con tylose MH300P al 2% che consente di reintegrare la percentuale di colla dispersa dal supporto durante la permanenza in acqua.
fig.21: restauro leaf casting
Pulizia a secco
Gli interventi di pulizia a secco sono stati eseguiti tenendo conto dello stato con-servazione del volume ed evitando azioni abrasive sulle carte danneggiate. L’in-tervento è consistito nell’asportazione delle polveri superficiali, deiezioni di insetti e frammenti di collanti dalla superficie delle carte mediante leggere pressioni con aghi, bisturi, pennellesse e un depolveratore per libri.
Interfoliazione e lavaggio
Al fine di identificare la tipologia di lavaggio più idonea e meno invasiva per il vo-lume, sono stati effettuati preliminari test tampone sugli inchiostri e sul supporto cartaceo che hanno dimostrato la non solubilità dei primi e un pH (misurazione del grado di acidità o alcalinità del supporto) pari a 4.75 per le carte. La misura-zione è stata effettuata con un pHmetro ad elettrodo piatto.
le carte sciolte sono state interposte tra reemay (tessuto non tessuto) al fine di preservarle da sollecitazioni dovute alla manipolazione e al contatto per immer-sione con l’acqua deionizzata a temperatura compresa fra i 25-30 °C durante la fase di lavaggio in vasca termostatica.
Deacidificazione
Avendo riscontrato un’eccessiva acidità di tutte le carte, si è proceduto con un intervento di deacidificazione. Esso consiste nel trattare il documento con una soluzione a base di sostanze alcaline che neutralizza l’acidità, causa principale del degrado della cellulosa, dei supporti e degli inchiostri, e ne inibisce la futura in-sorgenza. Il trattamento di deacidificazione va effettuato sempre dopo il lavaggio. nel presente caso si è deciso di operare per immersione in una soluzione di bicar-bonato di calcio che ha la funzione, penetrando nelle fibre della carta, di elevare il PH del supporto rilasciando una riserva alcalina contro l’acidità.
20
21
52 53
al fine di permettere alla carte di assestarsi prima di procedere con la cucitura. nel frattempo, utilizzando carta ingress acid free, sono state preparate le carte di guardia (carte bianche interposte tra i piatti e la compagine) costituite da due bifolii nella parte anteriore ed altri due in quella posteriore.
Cucitura
Prima di iniziare la cucitura del volume, sono state operate delle scelte sui ma-teriali da utilizzare al fine di operare nel rispetto delle tracce originarie dei fili di cucitura e, allo stesso tempo, per il recupero della funzionalità del volume. La cucitura è stata realizzata a mano su un telaio preparato con cinque nervi in pelle allumata con anima in spago di canapa grezza posizionati sulle antiche tracce di cucitura. É stata realizzata una cucitura alternata riproducendo la tipologia originale.
figg. 24-25: cucitura del volume
Capitelli
Si è proceduto con la realizzazione dei capitelli. Questi elementi annessi alla le-gatura sono costituiti da un’anima che può essere di materiali diversi come spago, cuoio, pelle allumata e pergamena, ed hanno essenzialmente due funzioni. La prima è quella di protegge il libro dalle infiltrazioni di polveri e la seconda è quella di agire da punto di resistenza durante la manipolazione dei libri. nel caso in esa-me, si è deciso di realizzare a mano due capitelli passanti su un supporto di pelle allumata rinforzati con anima di filo di canapa grezzo.
Sul verso di tutte le tavole è stata posta una velatura per rinforzare il supporto cartaceo e tenere ben salde le fibre di cellulosa reintegrate. Il velo usato è Tengujo 56100.
Asciugatura
L’asciugatura è stata effettuata in due tempi. Inizialmente le carte sono state poste tra carte assorbenti e cartone di pasta di fibra vegetale in modo da formare una pila. Questa è stata poi messa sotto pressa a lieve pressione al fine di assorbire l’eccesso di acqua. Dopo circa 10 ore, sono stati sostituiti i fogli assorbenti ed è stato ripetuto il processo fino a quando le carte sono diventate umide. A quel punto, sono state poste su stenditoi e lasciate asciugare a temperatura ambiente. Successivamente è stato realizzato, con particolare cura, il distacco delle carte dai reemay usati per l’asciugatura facendo attenzione a non causare ulteriori danni alle lacune risarcite con polpa di cellulosa.
Rifilatura
La rifilatura consiste nell’asportazione lungo i margini degli eccessi di cellulosa e di carta giapponese utilizzate per il restauro. Questa fase è stata eseguita a mano utilizzando delle forbici rispettando i margini originali delle carte.
figg. 22-23: tavole restaurate
Collazione
la collazione consiste nel ricollocare carte e fascicoli al loro posto di origine veri-ficando che non vi siano incoerenze. Una volta effettuata, l’insieme dei fascicoli è stato posto sotto peso esercitando una lieve pressione della durata di circa 24 ore
22 23
24 25
54 55
figg.28-29: allestimento e montaggio della coperta
3. BiBlioteca archivio diocesano Mons. aurelio Marena di Bitonto: cenni storici
L’archivio Storico Diocesano sezione di Bitonto è stato istituito dal vescovo A. Marena (1950-1978) con l’intento di raccogliere in un unico luogo il materiale d’archivio depositato in vari ambienti della Curia del Capitolo della cattedrale. Lo stesso vescovo ne affidò la cura al Prof. Stefano Milillo nel 1972. L’archivio storico diocesano, situato assieme alla Biblioteca vescovile di Bitonto al piano ter-ra dell’ex convento di San Francesco della Scarpa, in questi ultimi anni è stato notevolmente arricchito da lasciti di privati, ma anche da depositi effettuati da varie istituzioni religiose. Comprende innanzitutto il fondo capitolare con volumi delle deliberazioni, gli introiti ed esiti, le donazioni, i testamenti, platee, gli atti amministrativi, i legati, i fascicoli relativi alle varie cariche capitolari, concorsi per canonicati ed altro. Buona parte dell’archivio contiene le carte della Curia raccol-te in circa 140 buste. Emerge l’ampia documentazione riservata ai processi civili e criminali ma anche ai processi matrimoniali, a quelli per le sacre ordinazioni.
Sono stati raccolti gli archivi parrocchiali con i registri dei battesimi, matrimo-ni e morti, benefici, concorsi parrocchiali e rapporti con la Curia.
Circa 500 pergamene sono collocate e ordinate in appositi scaffali. Sono stati recuperati gli archivi di quasi tutte le confraternite bitontine, nonché materiale d’archivio afferente a monasteri e conventi soppressi. Donazioni di archivi di fa-miglia, come la famiglia Martucci, hanno contribuito a rendere l’archivio storico diocesano uno dei più ricchi e cospicui della Regione Puglia. L’archivio storico diocesano è stato riconosciuto di interesse storico locale con decreto del Presiden-te della Regione n.265 del 10 maggio 1984, nonché di notevole interesse storico con dichiarazione del Sovrintendente archivistico in data 26 maggio 1989.
Indorsatura
Questo intervento ha tre funzioni importanti: compensare, fino ad uniformare, la superficie del dorso; consolidarla ed irrigidirla quanto basta per una corretta apertura del volume; sostenere con compattezza e uniformità il volume quando viene posizionato sugli scaffali.
per l’Encyclopédie si è operato nel seguente modo: dopo aver dato il tondo al dorso del libro, precedentemente stretto nel battidorso, sono state posizionate del-le strisce di carta ingress acid free nelle caselle tra i nervi e fissate con collante misto composto tra Tylose MH300p e Vinavil 59 a bassa percentuale. L’intervento è stato ripetuto due volte. Dato il notevole spessore e il grande formato del libro, sono state inserite due bande in tela di canapa grezza tagliate a pettine e ricadenti su entrambi i piatti formando le alette su cui andranno ancorati.
figg.26-27: cucitura dei capitelli e indorsatura
Allestimento e montaggio della nuova coperta
L’ultimo intervento è consistito nella realizzazione di una nuova coperta. Essa non è altro che il rivestimento dei piatti e del dorso e serve essenzialmente a pro-teggere le carte. I materiali solitamente utilizzati sono il cuoio, la pergamena, la tela e la carta. Le coperte possono essere di diverse tipologie e prendono il nome dai materiali e le tecniche impiegati.
la coperta dell’Encycolopédie in piena pergamena è stata realizzata con la tecni-ca dell’incartonatura. ogni piatto è costituito da due cartoni durevoli per la con-servazione accoppiati uno contro verso all’altro, e hanno il compito di equilibrare le trazioni e dare più consistenza alla coperta. La pergamena, appositamente ta-gliata e posizionata sul corpo del volume, è stata montata effettuando i rimbocchi; si è proceduto con la realizzazione dei laccetti di chiusura in pelle allumata e il montaggio delle controguardie a tamburo; infine, con il mallo di noce, è stato scritto il titolo sul dorso.
28 29
2726
56 57
La sala due, nella stagione autunnale ha una umidità relativa compresa fra il 57 e 63 ed una temperatura fra i 18,5 e i 20°C. La percentuale di umidità relativa non è molto differente nel periodo invernale quando i valori sono compresa fra il 58 e 59,5%; la temperatura, invece, si abbassa notevolmente ed è compresa fra i 13 e 17 °C. È importante sottolineare che la biblioteca è aperta soltanto due volte a settimana, in orari pomeridiani (dalle 17 alle 19,30) questo rende quasi nullo l’effetto del riscaldamento, azionato durante i mesi invernali, sui parametri microclimatici.
Utilizzando il termoigrometro a contatto è stato possibile monitorare anche l’umidità relativa e la temperatura fra le carte di alcuni volumi presi a campio-ne. Durante i mesi i autunnali e invernali l’umidità relativa si è mantenuta fra il 56 e il 59,2% e la temperatura fra i 14 e il 16,6°C. Sostanzialmente stabili sono i parametri rilevati nel periodo primaverile (56-59% RH e 17-19,5°C) mentre quelli estivi sono compresi fra il 59 e 61% di umidità relativa e i 23 e 24°C di temperatura.
3.1 Monitoraggio aMBientale
I parametri microclimatici della Biblioteca Archivio Diocesano di Bitonto sono stati rilevati in quattro sale. nella prima sala, durante la stagione autunnale, sono stati registrati valori com-presi fra il 60,5 e il 69% di umidità relativa e una temperatura compresa fra i 18,5 e i 20°C. nel periodo invernale i valori di umidità e temperatura si abbassano, la prima è compresa fra il 52,4 e il 58,6% e la seconda fra i 14 e 18°C.
nei mesi primaverili si registra un aumento di umidità relativa, fra il 59 e 65%, mentre la temperatura risulta stabile sui 18°C. I valori dei parametri microcli-matici continuano ad aumentare anche nei primi giorni dei mesi estivi quando l’umidità raggiunge il 69,5% e la temperatura i 23°C.
Per quanto riguarda l’illuminamento, questa prima sala riceve sia la luce natu-rale, che penetra da uno piccolo lucernaio, che la luce artifciale a fluorescenza. I documendi d’archivio sono però conservati all’interno di scaffali scorrevoli chiuso che vengono esposti alla luce soltando nel momento della consultazione e cata-logazione. I valori di illuminamento registrati sono compresi fra i 60 e i 90 lux in presenta della sola luce artificiale; e fra i 110 e i 130 lux in presenza delle due fonti luminose.
58 59
Anche questa terza sala è illuminata da due finestre non schermate, da un lucernaio e dalla luce artificiale a fluorescenza. In prossimità delle finestre sono stati registrati valori fra i 230 e i 293 lux mentre fra gli scaffali più interni sono stati rilevati valori fra i 30 e 50 lux a luce spenta e fra i 110 e 175 lux con la luce artificiale accesa.
Il posizionamento di un lighcheck su uno scaffale disposto in prossimità della finestra ha permesso di valutare la quantità di luce ricevuta dall’oggetto: la striscia di carta ha raggiunto la sua tonalità più chiara dopo soli 25 giorni. Facendo un semplice calcolo è possibile stimare l’esposizione annua dell’oggetto:75.000 lux (codice di esposizione ELE) per 365 giorni diviso 25 è uguale a 1.095.000, valore che supera di circa sette volte i parametri standard di dose di luce annuale consi-gliati per gli oggetti appartenenti alla terza categoria di fotosensibilità.
La sala due è illuminata dalla luce naturale che penetra da due finestre quasi mai schermate e un lucernaio, oltre che da luce artificiale a fluorescenza. I para-mentri di illuminamento rilevati sono quindi di molto superiori a quelli consiglia-ti. Se nelle zone d’ombra degli scaffali è possibile registrare valori compresi fra i 30 e i 50 lux, per i libri posti negli scaffali vicino alle finestre o in direzione del lucernaio i valori cambiano radicalmente (210-250 lux) fino ad arrivare a 1000 lux di luce naturale.
nella terza sala, i valori di umidità relativa, nel periodo autunnale, sono com-presi fra il 56,5 e il 63,5% e quelli della temperatura fra i 20 e 18°C. Durante i mesi invernali, sia l’umidità che la temperatura diminuiscono e sono rispettiva-mente comprese fra il 55,8 e il 59,4% e i 13 e 18°C. Con i mesi primaverili i due paramentri registrano valori in aumento: la temperatura è compresa fra 17,7-19,1°C e l’umidità relativa fra il 60 e il 67,4%. Durante i mesi estivi si ha un netto aumento sia di RH (67,4-70) che di temperatura (22,5-23,8).
60 61
nella tabella successiva sono sintetizzati in una visione d’insieme i valori mini-mi, medi e massimi di temperatura e umidità relativa rilevati fra settembre 2009 e luglio 2010.
stagioni tmin tmed tmax rhmin rhmed rhmax
autunno 18 19,5 20,1 56,5 63,1 69
inverno 13,3 15,2 16 49,7 55,3 59,4
primavera 17,1 18 19,2 54,5 60 65,2
estate 23 24 25 67 68 70
3.3 linee guida
I parametri microclimatici rilevati nelle sale della Biblioteca Archivio diocesano di Bitonto si mantengono, durante il corso dell’anno, stabili. L’apertura limita-ta della biblioteca da un lato difende, nei mesi invernali, i libri dalle variazioni di umidità relative e temperatura causate dall’accensione del riscaldamento per troppe ore al giorno, dall’altro però è causa dell’accumulo di polvere fra i libri, sugli scaffali e nelle sale.
Gli scaffali della biblioteca sono in metallo e la superficie liscia, unita alla di-sposizione non corretta dei volumi, costringe molti di essi in posizioni dannose per la conservazione delle legature e dell’intera compagine. Alcuni volumi restaurati sono conservati all’interno di cassettiere in metallo, che sebbene difendano i libri dalla polvere, sono totalmente prive di areazione.
L’emergenza conservativa di maggior evidenza nella biblioteca in oggetto è costituita dalla polvere. Essa, come specificato nella prima parte del presente vo-lume, è comunemente una miscela di materiale minerale e vegetale, fibre tessili, grasso da impronte digitali e altri materiali organici e inorganici. In questa misce-
figg. 30-31-32: illuminazione artificiale non idonea alla conservazione
L’ultima sala è la sala 4 in cui i valori più alti di umidità realtiva e temperatura si registrano nei mesi primaverili ed estivi e sono compresi fra il 63 e il 70% e fra i 19 e 23°C. Durante l’autunno l’umidità è compresa fra il 58 e il 62% mentre la temperatura fra i 18 e 20 °C; in inverno ad una temperatura compresa fra i 14 e 18,8°C corrisponde una RH fra il 56,4 e 58,6%.
Due finestre non schermate illuminano questa sala. I libri posizionati in prossi-mità delle finestre ricevono una quantità di luce compresa fra i 79 e i 360 lux. La luce artificale, quasi sempre spenta, è costituita da lampade a incandescenza che non determinano variazioni sui paramentri registrati in quanto sono posizionate molto lontano dagli scaffali.
30
31
32
62 63
neanche in tutte le sale. Ben più rilevante è invece il degrado causato dalla luce naturale che penetra quotidianamente dalle finestre non schermate presenti in tutte le sale. Le tende oscuranti poste ai vetri delle finestre non coprono la parte alta delle stesse lasciando penetrare, senza alcun filtraggio, la luce solare.
In seguito a quanto emerso durante un anno di monitoraggio delle sale della biblioteca, si ritengono necessarie ed urgenti per la conservazione del patrimonio archivistico-librario le seguenti misure:- schermare le finestre con una pellicola anti UV che permette alle sale di esse-re comunque illuminate dalla luce solare, resa innocua per i supporti cartacei dall’eliminazione della componente ultravioletta;- spolveratura dell’intero fondo librario (questa operazione dovrebbe essere ese-guita da personale specializzato ogni 2 anni);- riposizionamento sui palchetti dei libri utilizzando reggilibri dalle superfici lisce e sponde larghe per sostenere i volumi quando i palchetti non sono pieni ed evi-tare che i libri lasciati inclinati distorcano la loro struttura;. - non lasciare che i libri sporgano oltre il bordo dei palchetti verso i corridoi;- tenere separate le legature in carta e in tela da quelle in pelle. L’acidità e gli oli che si trovano nelle pelli migrano nella carta e nella tela e accelerano il loro de-terioramento;- stilare un elenco di volumi intaccati da microrganismi (alcuni già identificati dal personale dell’associazione Folio) in modo da favorire un intervento immediato di disinfezione;- provvedere ad installare un sistema di deumidificazione da azionare durante le ore notturne al fine di mantenere l’umidità relativa costante.
Il personale dell’Archivio Biblioteca Vescovile di Bitonto ha identificato due volumi in cattivo stato di conservazione e li ha consegnati al personale dell’Asso-ciazione Folio per l’immediato restauro. Il primo consiste in un breve documento manoscritto che tramanda la visita pastorale del vescovo Cornelio Musso, del 1543-1565 (325X225X4), composto da 26 carte e il secondo è un libro delle ob-bligazioni che comprende 750 carte manoscritte e raccoglie gli atti che vanno dal 1641 al 1781.
la chimica ci sono spore di innumerevoli muffe, funghi e microrganismi che vivo-no del materiale organico contenuto nella polvere. inoltre, la polvere ha potere igroscopico; questa propensione, unità a fattori microclimatici favorevoli (umidità relativa superiore al 60%), facilita lo sviluppo, come è stato riscontrato durante i monitoraggi, di attacchi microbici.
figg.33-34-35-36: volumi in posizione errata ricoperti da cumuli di polvere ed attacchi microbici
La percentuale di umidità relativa registrata oscilla durante le ore del giorno intorno al 60%, purtroppo però durante le ore serali e notturne la percentuale tende ad aumentare. Le humidity indicator cards, posizionate fra i libri durante il mese di maggio, hanno difatti segnalato, colorandosi di rosa, un valore di RH superiore al 70%.
Per quanto riguarda l’illuminazione delle sale, si ritiene minimo il danno cau-sato dalla luce artificiale (sebbene questa risulti inadeguata alla conservazione dei volumi) in quanto viene accesa soltanto due volte a settimana, per poche ore e
33 34
36
35
64 65
3.5 restauro del docuMento Manoscritto “visita pastorale di cornelio Musso”
Il documento si presentava in pessimo stato di conservazione; le 26 carte che costituiscono un unico fascicolo, erano state intaccate da microrganismi, insetti e polvere, e perforate dall’acidità degli inchiostri. Le condizioni microclimatiche sfavorevoli hanno causato l’insorgere di evidenti gore e attacchi microbici che, a loro volta, hanno indebolito il supporto rendendolo feltroso e privo di elasticità. Gli insetti hanno contribuito, con massicci perforamenti, alla distruzione della parte centrale delle carte.
figg.37-38: stato di conservazione del documento
inoltre, l’elevata acidità dell’inchiostro ferro-gallico ha causato la perdita di parte del supporto. Questa tipologia di inchiostro di colore nero, a base acquosa, si otteneva con l’aggiunta di estratto di galle di varie piante, vetriolo, solfato di ferro, solfato di rame e resina o gomma arabica che facevano da “legante” tra carta ed inchiostro e acqua.56
Il documento era mutilo di coperta e custodito in un foglio di carta moderno. Le carte del fascicolo erano tenute assieme da due punti di cucitura a filzetta posti rispettivamente in testa e in piede.
Di seguito si riportano tutti gli interventi e le fasi di restauro eseguite sul volume.
Progettazione degli interventi di restauro
La scheda progetto, compilata dal personale tecnico del laboratorio, riassume le
56. c. prosperi, Il restauro dei documenti d’archivio. Dizionarietto dei termini, «Quaderni della Rassegna degli archivi di Stato», 89 (1999), p.73.
3.4 visita pastorale di cornelio Musso: introduzione storica
3.4.1 il Brano Manoscritto della visita pastorale di cornelio musso
Il manoscritto, datato 1565, è una parte della visita pastorale compiuta in quella data dal vescovo di Bitonto Cornelio Musso, padre conciliare e massimo esponente della controriforma cattolica, oltre che oratore tra i più ascoltati del suo tempo.
Le visite pastorali, divenute obbligatorie con il Concilio di Trento, avevano lo scopo di imporre la presenza del vescovo nella propria diocesi e obbligarlo a vistare i luoghi e le persone della stessa con una certa periodicità.
Le visite pastorali, come le relationes ad limina (relazioni sullo stato delle proprie diocesi che periodicamente i vescovi erano tenuti a presentare al Sommo Pontefi-ce) pur trascurate per secoli dalla storiografia, rappresentano utili e indispensabili fonti per la conoscenza non solo della storia ecclesiastica, ma anche di quella relativa ad una grossa fetta di sociètà che gravitava attorno alla chiesa. cultura, società, arti. mestieri, religiosità popolare, vita quotidiana, sono ambiti in cui la storiografia può svolgersi attingendo a queste fonti.
Il grano della visita pastorale di nostro interesse, riguarda non le chiese, così bene descritte con arredi e stato di conservazione, ma questa volta le persone ec-clesiastiche, anch’esse oggetto di indagine da parte del vescovo per capire meglio il loro stato ecclesiastico, i loro titoli, i benefici di cui godevano, la data del conse-guimento dei benefici siano essi laicali che ecclesiastici, la data e il luogo della loro ordinazione, le proprietà e i redditi di cui disponevano.
Compaiono qui dinanzi al vescovo tra gli altri: Pietro Paolo Barone, Giovanni Tirone, Pietro Dentice, che dice di possedere tra l’altro il beneficio di nicola de Iannipulo consistente in due vigne e mezza di olive in territorio di Bitonto in lo-calità Candela, oltre che alcuni mandorleti e case in Bitonto: Angelo Raffaele de Petruccio presenta delle bolle di beni conferitigli dallo stesso Musso, Pietro Anto-nio de Lionetto presenta le lettere dell’accolitato, Pietro Guastamacchia presenta le lettere dell’accolitato, Leonardo de Bonaria presenta un testamento del maestro Marino de Tauris, Giovanni della Torre presenta le lettere del suddiaconato ac-compagnato dai relativi benefici. Compaio ancora dinanzi al vescovo il chierico Silvestro de Caterinis, Giacomo de Bonaria, il chierico De Ripa, il diacono Mi-chele Urbano ed altri appartenenti al clero bitontino che, volenti e non, si sotto-pongono alla giurisdizione vescovile intesa al controllo delle rendite di ciascuno onde evitare sperequazioni e accumulo indebito di capitali.
stefano Milillo
3837
66 67
deacidificante in soluzione satura di carbonato di calcio e anidrite carbonica al fine di bloccare il processo di acidità dei supporti e fornire una riserva alcalina.
figg. 39-40: misurazione del PH e prove di solubilità degli inchiostri
Restauro meccanico (leaf casting)
Le tre tipologie di danni presenti in tutte le carte del documento (causati dell’ele-vata umidità, l’insorgere di microrganismi e camminamenti di insetti) hanno reso indispensabile l’intervento del restauro meccanico che ha consentito di risarcire tutte le lacune e le lacerazioni reintegrando le parti mancanti del documento. Tra le fibre di cellulosa depositate nelle parti mancanti e quelle del supporto originale si instaurano gli stessi legami chimici presenti all’atto della fabbricazione della carta.
Contemporaneamente alla fase di reintegro si è proceduto alla collatura. Essa consiste nel porre sul supporto, dopo l’aspirazione dell’acqua, un reemay precol-lato con tylose MH300P al 2% che consente di reintegrare la percentuale di colla dispersa dal supporto durante la permanenza in acqua.
Sul recto e verso di tutte le carte è stata posta una velatura per rinforzare il suppor-to e tenere ben salde le fibre di cellulosa reintegrate. Il velo usato è Tengujo 56100.
figg. 41-42: restauro meccanico
fasi di lavorazione, le tecniche impiegate, le diverse soluzioni (e le motivazioni che le hanno ispirate) rispetto alle prescrizioni iniziali. Tale scheda è un vero e proprio documento di registrazione e collocazione del volume in ogni fase del lavoro e consente di valutare, attraverso le annotazioni dei tempi e dei materiali utilizzati, i costi reali del restauro.
Durante la collazione del fascicolo è stata eseguita anche la cartulazione in quanto la numerazione originaria non era integra.
Rilevamenti fotografici
Dal momento dell’acquisizione, sono state realizzate diverse sequenze fotografi-che, in digitale ed alta definizione, al fine di documentare lo stato di conservazio-ne iniziale del volume, le fasi preliminari e di restauro fino al condizionamento del volume in una nuova coperta. Utilizzando un obiettivo macro, è stato possibile fotografare nel dettaglio i danni meccanici riscontrati.
Smontaggio
Durante lo smontaggio del documento sono stati recisi i fili di cucitura, asportate le polveri con pennelli morbidi e le deiezioni di insetti azionando lieve pressioni con la lama del bisturi.
Lavaggio, interfoliazione e deacidificazione
I frammenti di carta che erano staccati dal supporto sono stati collocati al loro posto e fissati con delle strisce di velo precollato, preparato con un’emulsione di Plextol B500 (30%), Acrilico E411 (30%) e acqua (40%).Al fine di identificare la tipologia di lavaggio più idonea e meno invasiva per il documento, sono stati effettuati preliminari test tampone sugli inchiostri e sul supporto cartaceo. I primi, eseguiti con acqua calda e fredda, hanno dimostrato la non solubilità degli inchiostri; gli altri hanno rilevato un pH (misurazione del grado di acidità o alcalinità del supporto) con valori compresi fra 4.48 e 5.40. La misurazione è stata effettuata con pH metro ad elettrodo piatto.
Evidenti erano l’imbrunimento e l’odore acre delle carte causati dall’acidità della cellulosa e degli inchiostri, trasferiti dal recto al verso delle carte rendendo la lettura del documento poco agevole.
le carte sono state interposte tra reemay (tessuto non tessuto) al fine di preser-varle da sollecitazione dovute alla manipolazione e al contatto per immersione con l’acqua deionizzata a temperatura compresa fra i 25-30 °C utilizzata per la fase di lavaggio in vasca termostatica. Successivamente è stato eseguito un bagno
39 40
41 42
68 69
dei fori di cucitura, con degli inserti in pergamena. La stessa metodologia è stata adoperata per l’inserimento dei laccetti di chiusura in pelle allumata.
figg. 45-46: cucitura del fascicolo con ancoraggio diretto
figg. 47-48: fascicolo restaurato e nuova coperta
3.6 il liBro delle oBBligazioni: introduzione storica
3.6.1 il liBro delle oBBligazioni dell’archivio diocesano Mons. a. Marena di Bitonto
Il libro delle obbligazioni esistente presso l’Archivio diocesano di Bitonto, fa parte del fondo archivistico della Curia vescovile di Bitonto.
Uno dei tanti registri che vanno sotto il nome anche di obligationes penes acta. Tali volumi riguardano generalmente obblighi contratti da due o più persone che
Asciugatura
Le carte restaurate sono state posizionate tra carte assorbenti e cartone di pasta di fibra vegetale e poste l’una sull’altra, fino a formare una pila. Questa è stata poi messa sotto pressa a lieve pressione al fine di assorbire l’eccesso di acqua. Dopo circa 10 ore, sono stati sostituiti i fogli assorbenti ed è stato ripetuto il processo fino a quando le carte sono diventate umide. Sono state, dunque, poste su stenditoi e lasciate asciugare a temperatura ambiente. Successivamente si è proceduto al distacco delle carte dai reemay impiegati per l’asciugatura facendo attenzione a non causare ulteriori danni al documento e alle lacune risarcite con polpa di cellulosa.
Le carte sono state poi rifilate. Questo intervento, eseguito a mano utilizzando delle forbici, consiste nell’asportazione, lungo i margini, degli eccessi di cellulosa e carta giapponese utilizzate per il restauro.
figg. 43-44: rifilatura e carte restaurate
Collazione
questa fase consiste nel ricollocare carte e fascicoli al loro posto di origine veri-ficando che non vi siano incoerenze. Una volta terminata, il fascicolo è stato po-sizionato sotto una pressa esercitando una lieve pressione per circa 24 ore al fine di permettere l’assestamento delle carte prima di procedere con la cucitura. nel frattempo, utilizzando carta ingress acid free, sono state preparate le carte di guardia costituite da due bifolii che avvolgono l’intero fascicolo.
Cucitura
La cucitura ad ancoraggio diretto è stata eseguita sul fascicolo mediante tre fori e passando per il centro. Con questo intervento le carte sono state cucite contem-poraneamente ai fogli di guardia e alla coperta. Quest’ultima è stata realizzata in cartone durevole per la conservazione e rinforzata, lungo il dorso in prossimità
4443
45 46
47
48
70 71
3.7 restauro del voluMe delle oBBligazioni dell’archivio vescovile di Bitonto
Il secondo volume manoscritto restaurato per la Biblioteca Archivio vescovile A. Marena nell’ambito del progetto Conservazione preventiva nelle Biblioteche di Puglia, era in discreto stato di conservazione, era mutilo di coperta e di legatura e composto da numerosi fascicoli tenuti assieme con delle cuciture a filzetta non più integre. nel centro del volume, alcuni fascicoli erano legati con cuciture a sopraggitto semplice, tecnica che consente, effettuando il passaggio del filo sul dorso, di ab-bracciare le carte in un’unica soluzione. Questo tipo di cucitura ha causato delle piccole lacerazioni in corrispondenza del filo di cucitura (figura 28).
figg. 49-50: stato di conservazione del manoscritto
Le carte presentavano notevoli danni come vistose gore, sporadici cammina-menti di insetti e perforazioni del supporto dovute all’acidità della mediazione grafica. All’interno dei fascicoli era, difatti, presente della polvere nera derivante dalla ossidazione degli inchiostri. Inoltre, i margini del supporto erano sfrangiati, imbruniti e presentavano pieghe, strappi e piccole lacune.
All’interno di alcuni fascicoli è stata riscontrata la presenza di numerosi allega-ti e di cinque sigilli in cera impressi direttamente sul documento.
figg. 51-52: allegati e sigilli all’interno dei fascicoli
si impegnano a soddisfare i loro impegni nei termini, nei modi e nei tempi previsti dalla contrattazione.
Anche se si tratta di carte private, tuttavia conservano la ufficialità degli atti pubblici giacché sono sottoscritti in un libro conservato dal cancelliere della curia e sottoscritti oltre che dai contraenti, anche dall’attuario, che era un ufficiale della curia che sovrintendeva alla redazione degli atti civili, e più tardi dal cancelliere di Curia che aveva praticamente le stesse mansioni.
Gli Atti sono stipulati presso la Curia vescovile, il che significa che almeno uno dei contraenti doveva essere persona ecclesiastica. ogni obbligazione, qualora non fosse stata portata a termine come previsto, prevedeva adeguate pene e cen-sure. Talvolta gli atti erano stipulati dinanzi alla persona del Vicario generale che faceva le veci del Vescovo. Infatti il Vicario apponeva la sua firma accompagnan-dola dalla formula pro episcopo.
Il nostro volume cartaceo comprende 750 carte manoscritte da mano diversa e raccoglie gli atti che vanno dal 1641 al 1781.
Raccoglie obbligazioni per debiti, per prestiti con o senza interessi, affitti di terreni, locazione di fondi rustici, non mancano dichiarazioni spontanee, pro-messe fatte dinanzi all’autorità ecclesiastica di non molestare qualcuno, di non passare dinanzi alla casa di tizio per non dare occasione di molestia ed altri atti che rispecchiano momenti di vita quotidiana.
Si notano obbligazioni per annui censi, quietanze di somme ricevute, contratti per affitto di case, per vari canoni come il terratico, fideiussoni. Gli stessi vescovi in alcuni casi si sottopongono al vincolo del giuramento con obbligazioni che si riscontrano nel presente volume.
Gli atti trascritti in qualche caso, non raro però, sono sottoscritti dai notai.Il libro delle obbligazioni ha una sua rilevanza storica e documentaria in quan-
to ci permette di entrare in un contesto economico che corre lungo 140 anni, permettendoci di scoprire tipi di contratto e contenuti degli stessi. Il che equivale a cogliere il tessuto sociale di una realtà cittadina nell’età moderna.
L’attenta lettura degli atti può portare anche ad interessanti scoperte come quella che rileviamo alla carta n. 318 dove si legge un obbligo che nicola Gliro sottoscrive con il Capitolo della Cattedrale per dipingere il soffitto della stessa chiesa madre di Bitonto.
stefano Milillo
49 50
51 52
72 73
perforamento delle carte causati dall’acidità degli inchiostri e delle carte, erano difatti evidenti ed avevano reso il documento poco leggibile in alcune sue parti.
le carte sono state interposte tra reemay (tessuto non tessuto) al fine di preser-varle da sollecitazione dovute alla manipolazione e al contatto per immersione con l’acqua deionizzata a temperatura compresa fra i 25-30 °C utilizzata per la fase di lavaggio in vasca termostatica.
Deacidificazione
Essa consiste nel trattare il documento con una soluzione a base di sostanze al-caline che neutralizza l’acidità, causa principale del degrado della cellulosa, dei supporti e degli inchiostri, e ne inibisce la futura insorgenza. Il trattamento di de-acidificazione va effettuato sempre dopo il lavaggio. nel presente caso si è deciso di operare per immersione in una soluzione di bicarbonato di calcio che ha la fun-zione, penetrando nelle fibre della carta, di elevare il PH del supporto rilasciando una riserva alcalina contro l’acidità.
Restauro meccanico (leaf casting) e manuale
Si è proceduto con il restauro meccanico delle carte che ha consentito di risarcire tutte le lacune e le lacerazioni reintegrando le parti mancanti del documento. Contemporaneamente alla fase di reintegro si è proceduto alla collatura. Essa consiste nel porre sul supporto, dopo l’aspirazione dell’acqua, un reemay precollato con tylose MH300P al 2% che consente di ristabilire la percentuale di colla disper-sa dal supporto durante la permanenza in acqua.
Asciugatura
L’asciugatura è stata effettuata in due tempi. Inizialmente le carte sono state po-ste tra carte assorbenti e cartone di pasta di fibra vegetale fino a formare una pila. Questa è stata poi messa sotto pressa a lieve pressione al fine di assorbire l’eccesso di acqua. Dopo circa 10-12 ore, sono stati sostituiti i fogli assorbenti ed è stato ripetuto il processo fino a quando le carte sono diventate umide. A quel punto, sono state poste su stenditoi e lasciate asciugare a temperatura ambiente. Successivamente è stato realizzato il distacco delle carte dai reemay facendo atten-zione a non causare ulteriori danni alle lacune risarcite con polpa di cellulosa e al supporto originale.
progettazione degli interventi di restauro
La scheda progetto riassume lo stato di conservazione del volume evidenziando le caratteristiche dei danni riscontrati e comprende la descrizione e i tempi di tutte le fase di restauro da eseguire. Sulla base di questa ricognizione vengono valutate le tecniche e metodologie da impiegare.
Rilevamenti fotografici
Le numerose sequenze fotografiche prodotte hanno la finalità di documentare lo stato di conservazione del documento dal momento dell’acquisizione fino al montaggio della nuova coperta.
Smontaggio
Durante la fase di smontaggio, eseguita utilizzando bisturi, forbici e spatole, sono stati recisi i fili di cucitura posizionati al centro dei fascicoli e quelli di ancoraggio posizionati in testa e in piede alle carte.
figg. 53-54: stato di conservazione delle carte e smontaggio
Lavaggio e interfoliazione
Prima di procedere con il lavaggio di deacidificazione delle carte, sono stati ese-guiti dei preliminari test tampone sugli inchiostri e sul supporto cartaceo al fine di identificare la tipologia di lavaggio più idonea e meno invasiva per il documento. I test sugli inchiostri, compiuti con acqua calda e fredda, hanno dimostrato la loro non solubilità; quelli sulle carte, hanno rilevato un pH (misurazione del grado di acidità o alcalinità del supporto) con valori compresi fra 4,20 e 5,50. La misura-zione è stata effettuata con pH metro ad elettrodo piatto. L’imbrunimento e il
53 54
74 75
figg. 55-56-57-58-59-60: collazione, cucitura, allestimento e montaggio della nuova coperta
4. BiBlioteca coMunale f. trinchera di ostuni: cenni storici
L’Atto di nascita della biblioteca comunale di ostuni è da rintracciare nella rac-colta delle deliberazioni del Consiglio Comunale dell’anno 1868. Il 29 aprile di quell’anno, la massima assise cittadina deliberò la «istituzione di una bibliote-ca pubblica».57 La vita della biblioteca non fu semplice: all’indomani dell’Unità
57. BC o. Asco, Archivio postunitario, Deliberazioni originali del Consiglio, b. I. aa. 1863-1875,
Restauro manuale
Il restauro delle carte è stato completato da piccoli interventi manuali, durante i quali, grazie all’utilizzo di un piano luminoso ricoperto da carta siliconata, sono state identificate le restanti lacune che sono state restaurate facendo aderire al supporto originale un pezzo di carta giapponese dello spessore idoneo (tecnica per sovrapposizione). Con un ago sono stati tracciati i contorni delle singole lacune e, incidendo la carta giapponese, sono state disegnate le sagome per il reintegro. Queste, poi, sono state fatte aderire al supporto mediante leggere pressioni pro-gressivamente divergenti in maniera da salvaguardare al massimo la lunghezza delle fibre che consente un’uniforme distribuzione dell’adesivo (Tylose MH200 al 3-4%) e una superficie di contatto con il supporto originale senza interruzioni.
Rifilatura
La rifilatura consiste nell’asportazione lungo i margini degli eccessi di cellulosa e carta giapponese utilizzate per il restauro. Essa è stata eseguita a mano utilizzan-do delle forbici al fine di rispettare i margini originali delle carte.
Collazione
la collazione consiste nel ricollocare carte e fascicoli al loro posto di origine veri-ficando che non vi siano incoerenze. Una volta effettuata, il volume è stato posto sotto una pressa esercitando una lieve pressione della durata di circa 24 ore al fine di permetterne l’assestamento prima di procedere con la cucitura. nel frattempo, utilizzando carta ingress acid free, sono state preparate le carte di guardia costituite da due bifolii nella parte anteriore ed altri due in quella posteriore.
Cucitura
Il volume è stato cucito su tre nervi in cuoio spaccati utilizzando filo di canapa grezza. La cucitura impiegata, di tipo alternato, è risultata la più idonea dato lo spessore del libro e la presenza di alcuni fascicoli all’interno di altri (quinterno nel quinterno).
Per il volume delle Obbligazioni è stata realizzata ex novo una coperta in piena pergamena, priva di adesivo in tutte le sue parti, composta da corregge in cuoio con disegni a losanghe in pelle allumata, lacci di chiusura e punti di fissaggio in pergamena posti sul dorso ad ancorare la compagine alla coperta.
55 56
57 58
6059
55 56
76 77
4.1 Monitoraggio aMBientale
Il monitoraggio ambientale nella Biblioteca comunale di ostuni ha riguardato le stanze del deposito posizionate nel sotterraneo della biblioteca. Per meglio de-scrivere i parametri rilevati si è preferito suddividere l’ambiente unico in tre parti identificando, nei grafici, come sala 1 la parte di fronte alla porta d’ingresso, sala 1bis la parte all’estrema sinistra rispetto all’entrata e con sala 1ter quella all’estre-ma destra; alla sala 2 corrisponde invece la stanza posta sul retro e, infine, alla sala 3 quella in cui sono custoditi gli incunaboli e il materiale libraio di particolare pregio.
Come si evince dal grafico seguente, nella sala 1, nel periodo autunnale, l’umi-dità relativa registrata è compresa fra il 60 e 67% e la temperatura fra i 19,8 e i 22,7°C. Durante l’inverno, i valori della temperatura variano di poco (sono compresi fra i 23,9 e i 21,8) rispetto all’umidità che invece è fra il 42,9 e il 52%. È da sottolineare che il riscaldamento all’interno del deposito non viene azionato durante i mesi invernali ma che i parametri sono comunque influenzati dal ri-scaldamento acceso per numerose ore al giorno nei piani superiori dell’edificio. Difatti, nei mesi primaverili, l’umidità relativa torna ad essere compresa fra il 51,9 e il 62,5% e la temperatura fra i 20,5 e i 21,8°C. All’inizio dell’estate (giugno-luglio) l’umidità relativa oscilla fra il 53,8 e il 60,7% e la temperatura si stabilizza sui 24°C.
Per quanto riguarda le fonti di luce, in questa zona del deposito si ha soltanto la luce artificiale, costituita da tubi di luce a fluorescenza, accesi tutti i giorni e per tutto il giorno in quanto il sistema d’illuminazione della biblioteca è centralizzato. I parametri di illuminamento rilevati sono estremamente elevati, risultano difatti compresi fra i 500 e gli 870 lux.
d’Italia con la soppressione delle corporazioni religiose (legge n.3036, 7 luglio del 1877), il Municipio acquisì intere librerie claustrali; durante il periodo fascista, si ordinò la chiusura della biblioteca e iniziarono i numerosi trasferimenti dei fondi librari: dal palazzo del Seminario al convento dei Riformati e da questo al Ginnasio, con la perdita, in questi 40 anni, di circa millecinquecento volumi; nel dopoguerra, la biblioteca fu nuovamente trasferita, questa volta nell’aula magna del liceo della città situato nel palazzo in cui oggi si trova la scuola media Borro-mei.58
nel 1954 si ebbe un altro trasferimento, in un palazzo comunale, precedente-mente adibito a teatro. Questa operazione,sebbene rappresenti la tappa più im-portante della storia recente della biblioteca in quanto ne ha permesso la rinasci-ta, risultò però di grande depauperamento.
nel 1964 la biblioteca fu intitolata a F. Trinchera «seniore quale segno della più alta considerazione che l’Amministrazione comunale e la cittadinanza tutta intendono tributare al concittadino maggiormente benemerito, che più di ogni altro rifulse per virtù ed operosità e che più di ogni altro costituì l’onore e il vanto della Patria che egli amò quanto la sua ostuni».59
Sebbene già a metà degli anni Settanta, trascorso appena un quindicennio dall’ultimo trasferimento, i locali del palazzo municipale cominciarono a rivelarsi del tutto insufficienti a contenere il patrimonio librario e incapaci a sostenere le accresciute esigenze dei lettori, bisognerà attendere il 1996 affinché si compia e si inauguri la biblioteca attuale.
Il registro cronologico di entrata conta circa 68.000 unità bibliografiche, ma si tratta solo di un numero indicativo perché non tiene conto di alcune consistenti donazioni acquisite di recente, nonché di gran parte delle annate di numerosi periodici, in corso di inventariazione. La biblioteca custodisce: 40 manoscritti, 50 carte geografiche, topografiche e corografiche; il fondo antico, proveniente dalle biblioteche monastiche è costituito da circa 4.000 unità, tra cui 12 incunaboli e circa 130 cinquecentine, è tuttora in fase di restauro e di catalogazione informa-tizzata.
delibera n. 24, 29 aprile 1868.
58. a. Minna, La Biblioteca pubblica dell’Alto Salento, Congedo 2000.
59. BC o, Asco, Archivio Postunitario, Deliberazioni originali del Consiglio, b. 12, aa. 1966-1967 delibera n. 34, 7 marzo del 1967, Intitolazione della biblioteca comunale al prof. Francesco Trin-chera seniore, in Minna, p. 107
78 79
figg. 61-62: illuminazione artificiale non idonea alla conservazione
nella zona a sinistra (rispetto alla porta d’entrata) l’umidità relativa durante i mesi autunnali è compresa fra il 65,5 e il 59% e la temperatura fra i 18,6 e i 25°C; da dicembre a febbraio la RH scende fra il 43,8 e il 59% e la temperatura resta compresa fra i 20 e i 23,3°C. Durante la primavera, l’umidità relativa oscilla fra il 51,3 e il 55,6% mentre la temperatur anon supera i 21°C. In estate si registra una umidità compresa fra il 56,5 e il 61% e una temperatura intorno ai 24°C.
Le fonti di illuminazione in questa zona sono sia artificiale (luci a fluorescenza) che naturale (presenza di piccole finestre non schermate). I parametri di illumina-mento registarti sono compresi fra i 200 e i 700 lux, con picchi intorno ai 1400 lux in prossimità delle finestre e degli scaffali posti più vicino alla luce artificiale.
61 62
80 81
Anche questa zona della biblioteca è illuminata da luce artificiale a fluorescen-za che risulta essere davvero eccessiva e prolungata nel tempo: i parametri di illu-minamento sono compresi fra i 450 e i 600 lux negli scaffali più in basso mentre in quelli più vicini alla fonte luminosa si raggiungono i 950-970 lux. Questo tipo di illunimazione risulta essere non idonea alla conservazione del materiale librario sia per l’eccesiva quantità di luce emanata, sia per la quantità di calore emesso.
I parametri microclimatici della sala 2 sono sicuramente quelli più critici dal punto di vista conservativo. Durante tutte le quattro stagioni l’umidità relativa è compresa fra il 68,5 e il 74% mentre la temperatura oscilla fra i 14°C (nel mese di gennaio) e i 23,3°C nel periodo estivo.
figg. 63-64: eccesso di illuminazione naturale ed artificiale nella sala 1
nella zona a destra (rispetto all’entrata), l’umidità relativa rilevata è compresa fra il 58 e il 65,6% e la temperatura fra i 19 e 26 °C nel periodo autunnale. nei mesi invernali quest’ultima si stabilizza fra i 21 e i 23°C mentre l’umidità è fra il 45,8 e il 54%. Fra marzo e maggio l’umidità relativa ha avuto degli sbalzi note-voli, passando dal 46,2 al 55 e poi al 62,2% mentre la temperatura registrata è di 23,3 - 21°C. Durante i mesi estivi, infine, l’umidità oscilla fra il 55,4 e il 62,2% e la temperatura fra i 23,8 e i 24°C.
63 64
82 83
figg. 65-66-67: degrado strutturale
L’ultima stanza monitorata è la sala 3. Come si evince dal grafico successivo, i parametri registrati durante l’anno sono sostanzialmente stabili per via dell’at-tivazione costante di un deumidificatore. nei mesi autunnali l’umidità relativa oscilla fra il 56,7 e il 63% mentre la temperatura è fra i 18,6 e i 22,7°C. Fatta ec-cezione per il mese di dicembre in cui l’umidità è pari al 61,8% e la temperatura è di 18,4°C, durante i restanti mesi invernali, primaverili ed estivi si hanno valori compresi fra il 42 e il 45,6% per quanto riguarda la RH e fra i 20 e 24°C per la temperatura. Avendo riscontrato un brusco abbassamento dell’umidità nell’am-biente, si è consigliato al personale della biblioteca di mantenere al minimo il deumidificatore in modo da stabilizzare i parametri intorno al 50% di RH al fine di avere un microclima più idoneo alla conservazione dei libri con coperte in pergamena custoditi all’interno di questa sala.
Le fonti di illuminazione della sala sono due; la prima è costituita da piccole finestre non schermate da cui penetra la luce naturale e la seconda da luci a fluo-rescenza quasi sempre spente.
I parametri di illuminamento rilevati sono compresi fra i 20 e 30 lux fra gli scaffali lontani dalle due fonti luminose; fra i 250 e 550 lux fra gli scaffali posi-zionati di fronte alle finestre e, infine, intorno ai 750 lux con la luce artificiale accesa.
La luce artificiale a fluorescenza è quasi sempre spenta ma, anche in questo caso, si registrano parametri di illuminamento compresi fra i 200 e 520 lux quan-do viene accesa.
65 66 67
84 85
figg. 68-69: eccesso di illuminazione naturale e artificiale nella sala 3
nella tabella successiva sono sintetizzati in una visione d’insieme i valori mini-mi, medi e massimi di temperatura e umidità relativa rilevati fra settembre 2009 e luglio 2010.
stagioni tmin tmed tmax rhmin rhmed rhmax
autunno 17 22 25,7 56,7 63 73,9
inverno 14 18,4 23,9 41,5 45,6 73,8
primavera 20 21 23,3 43,6 54 74
estate 22,3 23,4 24,4 43,7 56,5 74,3
4.2 linee guida
Le sale del deposito della biblioteca comunale di ostuni non sono idonee alla con-servazione del materiale librario in esse custodite. La sala più grande (identificata in questo studio come sala 1) presenta notevoli problematiche legate all’allesti-mento, alla tipologia di illuminazione utilizzata, alla cattiva manutenzione degli ambienti (polvere e presenza di insetti).
Le oscillazioni di umidità relativa e quelle della temperatura durante il corso dell’anno sono accompagnate dalla totale mancanza di areazione dei locali, da un eccessivo affollamento dei palchetti e dal sistema di illuminazione scorretto. Quest’ultimo è infatti la causa principale dell’irrigidimento dei volumi, dell’im-brunimento e del viraggio dei colori delle coperte dei libri.
È stato posizionato un lightcheck in corrispondenza dei volumi illuminati da luce naturale al fine di monitorare l’illuminamento fra il mese di febbraio e quello del mese di marzo. La striscia di carta, in 32 giorni, ha assunto la colorazione che identifica una esposizione luminosa equivalente ai 45.000-75.000 lux per ora. Fa-cendo un semplice calcolo è possibile stimare l’esposizione annua o la quantità di luce ricevuta dall’oggetto: 45.000 lux (codice di esposizione ELE) per 365 giorni diviso 32 (giorni di esposizione del lightcheck) è uguale a 513.281, valore che supera di circa tre volte i parametri standard di dose di luce annuale consigliati per gli oggetti appartenenti alla terza categoria di fotosensibilità.
68 69
86 87
mento della sala. Inoltre, è assente ogni forma di areazione; l’unica apertura verso l’esterno è stata la causa principale, durante l’inverno, degli allagamenti della sala.
Difficile è in questo caso formulare delle linee guida efficaci. Ci limitiamo a fornire delle indicazioni che possano aiutare ad una più idonea manutenzione del depositi auspicando che si possa agire nel più breve tempo possibile. Di fonda-mentale importanza è:- l’immediata pulizia degli ambienti. L’accumulo di polvere e la presenza di fattori climatici favorevoli può causare l’insorgere di attacchi microbici;- limitare per quanto possibile l’utilizzo della luce artificiale o se possibile cercare di posizionare delle pellicole filtranti in modo da limitare i danni causati dalle radiazioni luminose;- liberare i palchetti più in basso, a stretto contatto con la polvere, e quelli più in alto, troppo vicini alla fonte di luce artificiale;- allontanare di dieci centimetri gli scaffali posti lungo i muri in modo da evitare il contatto con le pareti umide;- evitare di conservare materiale cartaceo nella sala 2 se non sottoposta a inter-venti di bonificata.
I libri custoditi nella sala 3 sono salvaguardati da migliori condizioni microcli-matiche, favorite dalla presenza di un deumidificatore e dalla luce artificiale quasi sempre spenta. Questo però non basta a conservare in maniera ottimale i volumi, si è difatti consigliato di:- schermare le finestre con delle pellicole anti UV in modo da filtrare la luce na-turale che quotidianamente batte sui dorsi in pergamena dei volumi custoditi sui palchetti posizionati di fronte alle finestre;- azionare il deumidificatore al minimo al fine di mantenere l’umidità relativa fra il 50 e 60% e non seccare troppo l’aria della piccola sala.
Il volume avuto in consegna per il restauro è intitolato Sacra Rituum Congrega-tione […] Beatificationis et Canonizationis ven. servi dei P. Josephi a Cupertino […] Nova Positio Super dubio An et de quibus Miracuilis constet in casu et ad effectum etc.; è datato al 1751 ed è stato stampato a Roma presso la Tipografia della Reverenda Camera Apostolica.
4.3 sacra rituum congregatione: introduzione storica
Il volume è suddiviso in due parti, la prima intitolata novae Animadversiones R.P. Fidei Promotoris Super Dubio An et de quibus Miracuilis constet in casu et ad effectum, de quo agitur (2 Marzo 1751) comprende la descrizione di due miracoli compiuti da
figg. 70-71: variazione fotocromatica dei supporti
Gli scaffali in metallo partono dal basso ed arrivano fin quasi al soffitto, met-tendo i libri a stretto contatto con la fonte di luce artificiale che rilascia calore e raggi ultravioletti. Inoltre, nei palchetti più in alto, si sopperisce all’assenza di reggilibri in maniera del tutto inconsueta appoggiando i volumi ai tubi di colore rosso che percorrono il soffitto dell’intera sala. Questi fanno parte del sistema an-tincendio della biblioteca, la cui entrata in funzione inonderebbe l’intero deposito con la conseguente perdita dei fondi librari.
A questi fattori, si aggiunge l’accumulo di polvere nella sala che ha causato l’insorgere di intere colonie di insetti di varie specie.
figg. 72-73-74: cattivo stato di conservazione dei volumi in ambienti malsani
La sala 2 non è idonea alla conservazione dei documenti e dei volumi al suo in-terno. La percentuale di umidità relativa si mantiene costante oltre il 70% durante l’intero anno, causando l’insorgere di attacchi microbici e un degrado accelerato dei supporti cartacei e dei collanti. Vani sono stati i tentativi compiuti durante l’an-no per porre rimedio a questo problema: i due deumidificatori posizionali all’inter-no della stanza sono assolutamente insufficienti e in più la mancanza di personale addetto al loro svuotamento ha causato spesso degli accumuli d’acqua sul pavi-
7170
72 73 74
88 89
dei Frati Minori all’età di 21 anni. Giuseppe dopo essere stato ordinato diacono nel 1627, fu consacrato sacerdote il 18 marzo del 1628.
Il primo volo estatico avvenne il 4 ottobre del 1630 nella chiesa delle Clarisse di Copertino.
nel 1631 fu spinto dal desiderio di andare a visitare la tomba di San Francesco, ma durante questo viaggio, mentre era in terra di Bari, cominciarono i sospetti sui miracoli del Santo; da Giovinazzo fu emanato, difatti, un atto di accusa in cui ve-niva deferito al tribunale dell’Inquisizione di napoli con la formulazione seguente «Scorre per quelle Provincie un uomo sui trentatre anni, e qual altro Messia, con-dursi seco dietro intere popolazioni con prodigi ad ogni passo, accreditati dalla plebe che sempre a tutti crede e non mai distingue il verisimile dal vero: darne perciò notizia ai Superiori, affinché o il rimedio prevenga il mal futuro o il mal futuro non si renda restio ed incapace al rimedio» (Giaccaglia, 2000, p.73). Da napoli l’incartamento passò a Roma, dove fu avviato il processo presso il tribuna-le dell’Inquisizione. Il padre fu assolto e, in quel periodo, ebbe anche una levita-zione alla presenza delle suore della chiesa napoletana di San Gregorio Armeno e, un’altra levitazione a Roma alla presenza del papa Urbano VIII. Giuseppe fu dunque mandato ad Assisi, era il 25 aprile del 1639. Da questo momento in poi furono anni in cui il pellegrinaggio di nobili, principi e re al cospetto del padre si intensificarono al tal punto che nel 1651 il cardinale Ludovisi dispose che nessuno avrebbe più potuto parlargli senza una espressa licenza. nel contempo, il tanto parlare del Santo, aveva riportato l’attenzione dell’Inquisizione sulle vicende del frate; ne fu infatti ordinato il trasferimento, nel 1653, in un remoto monastero , il convento di San Lazzaro in provincia di Pesaro. Dopo tre mesi fu trasferito a Fossombrone dove predisse, durante un’estasi, la morte del papa Innocenzo X. Successivamente per volere di Alessandro VI fu trasferito nel monastero di San Francesco di osimo dove morì il 18 settembre del 1663. Infine, nell’adunanza del 27 gennaio 1767, il papa Clemente XIII fissò al 16 luglio la data della solenne celebrazione a Santo del beato Giuseppe61.
4.4 restauro del voluMe sacra rituum congregatione
La prima parte del volume si compone di 16 fascicoli, di cui 15 costituiti da 2 bi-folii e uno, con segnatura antica B, costituito da un ternione più una carta singola. La seconda parte è introdotta da un frontespizio, il fascicolo A composto da 9 bi-folii; mutilo della carta 34 (numerazione araba) e 5 fascicoli da due bifolii (B-F).
61. a. di Marzo, a. siMonetti, La via e la diffusione iconografica, in Il santo dei voli cit., pp.29-44; p. Bonaventura danza, San Giuseppe da Copertino. Il Santo dei voli, Copertino 2001.
San Giuseppe da Copertino, uno sulla guarigione di sorella Teresa Margherita da un’orrenda cefalea e l’altro circa l’integrazione dell’occhio destro del signore Stefano de Mattheis. Fanno seguito i responsi dell’analisi dei miracoli, Novae re-sponsiones facti et juris ad novas animadversiones. La seconda parte è invece intitolata Summarium addizionale novae responsionis e tratta i seguenti argomenti: 1. Restrictus addizionalis super II Miraculo alias inter informandum distributus occasione Congregationis Antaepraeparatoriae habitae die 2 Martii 1751. sub Tit. Ristretto additionaleper modo di elenco risponsivo alle obbiezzionisopra il Miracolo II; 2. Casus a clar. D. Meryo relatus in Act. Regiae Accademiae Scientar. sub die 23 Augusti 1707 Gallice et Italice; 3. Miraculum approbatum in Causa S. Vincentii a Paulo in Persona parisiensis pueri Claudii Josephi Compoin ab omnimoda Caecitate; 4. Novae Responsiones Medico Physicae DD. Peritorum in Urbe scribentium pro veritate, super miracolis, quae examini subiiciuntur.
L’agiografia di San Giuseppe da Copertino comincia, come dimostrato dagli studiosi, già un cinquantennio dopo la sua morte e quasi un secolo prima della be-atificazione. nel 1677 padre Roberto nuti dei minori conventuali dava alla stam-pa La vita di fra Giuseppe da Copertino; nel 1722 esce la Vita del Ven. Padre Fr. Giuseppe da Copertino, curata da Domenico Bernini che come quella di Padre nuti descrive un fanciullo di otto anni sorpreso per la prima volta dall’Estasi che manifestava «ò all’udito di suoni, e canti, ò alla vista delle immagini sacre, ò all’assistenza del Divin sacrificio». Il topos della santità precoce trova riscontri in numerose altre biografie e miscellanee dedicate al santo, molte delle quali anonime, conservate nell’archivio dei santi apostoli: Vita del Venerabile; neritonen. Beatificationis Et Cano-nizationis; Ven S.Dei Josephi de Cupert.; Vita dell’Ammirabile; di cui è forse autore padre Marcheselli del Sacro convento di Assisi; Vita di san Giuseppe del padre Giacomo Roncalli da Mondaino; Compendio della Vita Virtù e Miracoli del 1762 del frate Do-menico Andrea Rossi, Ministro generale dei Minori Conventuali e Storia della Vita Virtù Doni e Grazia60.
Giuseppe da Copertino nacque in una famiglia modesta ma molto credente, e, fin da piccolo, aveva desiderato entrare a far parte della Grottella della sua città in cui era conservata l’immagine della Vergine riscoperta fra il 1540 e il 1550. Riuscì a essere ammesso al noviziato nel convento di Martina Franca nell’ago-sto del 1620 con il nome di frate Stefano da Copertino. Il giovane si ammalò e fu allontanato dal convento, in più, morto suo padre fu ricercato per i debiti di quest’ultimo; fu dunque costretto a nascondersi, e lo fece grazie all’aiuto di suo zio che lo accolse sulla soffitta del convento della Grottella. Entrò così nell’ordine
60. M. a. nocco, San Giuseppe da Copertino celebrato da agiografi, pittori, architetti e incisori, in Il santo dei voli: San Giuseppe da Copertino: arte, storia, culto, Catalogo della mostra, Lecce-Copertino, napoli 2004, pp. 61-72.
90 91
no nei materiali gallerie tortuose a sezione circolare che si estendono dai margini verso il centro della pagina
figg. 75-76: stato di conservazione del volume
figg.77-78: smontaggio dei fascicoli
Pulizia a secco
Gli interventi di pulizia a secco sono stati eseguiti evitando azioni abrasive sulle carte danneggiate. L’intervento è consistito nell’asportazione delle polveri super-ficiali, deiezioni di insetti, frammenti di collanti e corpi estranei sulla superficie del documento mediante leggere pressioni con aghi, bisturi, pennellesse e un de-polveratore per libri.
Interfoliazione e lavaggio
Al fine di identificare la tipologia di lavaggio più idonea e meno invasiva per il volume in fase di restauro, sono stati effettuati preliminari test tampone sugli in-
Il volume si presentava in cattivo stato di conservazione. Esso era legato con una coperta non originaria in cartone grigio accoppiato rivestito con carta marmor e dorso in finta pergamena. L’esemplare era mutilo di capitelli. Le carte erano dan-neggiate da fori e camminamenti di insetti sia lungo il taglio di piede che lungo il dorso ed erano, inoltre, compromesse da attacchi microbici, con presenza di macchie rossastre (foxing).Le carte di guardia del volume erano moderne e, molto probabilmente, furono inserite in concomitanza alla realizzazione della coperta. I fascicoli erano assem-blati tramite nervi in traccia; le cuciture erano presenti solo in alcuni fascicoli, i restanti erano accorpati con collante moderno.
Progettazione per gli interventi di restauro
La scheda progetto appositamente compilata dal personale tecnico del laborato-rio riassume lo stato di conservazione del volume evidenziando le caratteristiche dei danni riscontrati e la compromessa integrità delle varie componenti. Sulla base di questa ricognizione sono state valutate, di concerto con il team operante, le tecniche e metodologie da impiegare nella fase di restauro.
Rilevamenti fotografici
Dal momento dell’acquisizione, sono state realizzate diverse sequenze fotografi-che, in digitale ed alta definizione, al fine di documentare lo stato di conservazio-ne iniziale del volume, le fasi preliminari e di restauro fino al condizionamento del volume in una nuova coperta. Utilizzando un obiettivo macro, è stato possibile fotografare nel dettaglio i danni meccanici riscontrati.
Smontaggio
Durante la fase di smontaggio, eseguita utilizzando bisturi, forbici e spatole, sono stati recisi i fili di cucitura che attraversano il centro dei fascicoli. Sono state inol-tre rimosse con delle leggere pressioni e l’utilizzo del bisturi le lamine di colla presenti sul dorso e fra i fascicoli che avevano creato crepe e sfaldature al supporto cartaceo.
Dai rilevamenti effettuati sulla tipologia di camminamenti e dei fori riscontrati nelle carte, è stato possibile identificare gli anobidi come gli insetti responsabili del danno. Essi compiono l’intero ciclo vitale all’interno dei materiali in cui sono annidati e, per tanto, della loro presenza, quasi sempre, ci si accorge soltanto quando l’insetto adulto rompe la superficie che lo separa dall’esterno e fa su di essa fori di sfarfallamento di forma circolare. Gli anobidi allo stato larvale scava-
75 76
77 78
92 93
diventate umide. A quel punto, sono state posizionate su stenditoi e lasciate asciu-gare a temperatura ambiente. Successivamente è stato realizzato, con particolare cura, il distacco delle carte dai reemay usati per l’asciugatura.
Rifilatura
La rifilatura consiste nell’asportazione lungo i margini degli eccessi di cellulosa e carta giapponese utilizzate per il restauro. Essa è stata eseguita a mano utilizzan-do delle forbici al fine di rispettare i margini originali delle carte.
figg. 79-80: distacco delle carte dai reemay e rifilatura
Collazione
la collazione consiste nel ricollocare carte e fascicoli al loro posto di origine veri-ficando che non vi siano incoerenze. Una volta effettuata, l’insieme dei fascicoli è stato posto sotto peso esercitando una lieve pressione della durata di circa 24 ore al fine di permettere alla carte di assestarsi prima di procedere con la cucitura. nel frattempo, utilizzando carta ingress acid free, sono state preparate le carte di guardia (carte bianche interposte tra i piatti e il volume) costituite da due bifolii nella parte anteriore ed altri due in quella posteriore.
Cucitura
Prima di iniziare la cucitura del volume, sono stati selezionati i materiali da utiliz-zare operando nel rispetto delle tracce originarie e, allo stesso tempo, per il recupe-ro della funzionalità del volume. La cucitura è stata rieseguita a mano su un telaio preparato con tre nervi singoli in spago posizionati sulle antiche tracce di cucitura. É stata realizzata una cucitura a tutto punto riproducendo la tipologia originale.
La coperta del volume in piena pergamena è stata realizzata con la tecnica dell’incartonatura procedendo con l’inserimento dei piatti in cartone durevole per la conservazione, l’allestimento della pergamena, l’inserimento dei capitelli passanti e il montaggio delle controguardie.
chiostri e sul supporto cartaceo che hanno dimostrato la non solubilità dei primi e un pH (misurazione del grado di acidità o alcalinità del supporto) pari a 4,98 per le carte. La misurazione è stata effettuata con pH metro ad elettrodo piatto. Le carte sciolte sono state interposte tra reemay (tessuto non tessuto) al fine di preser-varle dalle sollecitazioni dovute alla manipolazione e al contatto, per immersione, con l’acqua deionizzata a temperatura compresa fra i 25-30 °C utilizzata per la fase di lavaggio in vasca termostatica.
Deacidificazione
Avendo riscontrato un’eccessiva acida delle carte di tutto il volume, si è proceduto con un intervento di deacidificazione. Esso consiste nel trattare il documento con una soluzione a base di sostanze alcaline che neutralizza l’acidità causa principale del degrado della cellulosa, dei supporti e degli inchiostri, e ne inibisce la futura in-sorgenza. Per il volume di ostuni si è deciso di operare per immersione in una solu-zione di bicarbonato di calcio che ha la funzione, penetrando nelle fibre della carta, di elevare il PH del supporto rilasciando una riserva alcalina contro l’acidità.
Restauro meccanico (leaf casting)
Si è proceduto con il restauro meccanico delle carte che presentavano danni cau-sati, come in precedenza specificato, da camminamenti di insetti. L’intervento di restauro meccanico ha consentito di risarcire tutte le lacune e le lacerazioni reintegrando le parti mancanti del documento. Tra le fibre di cellulosa depositate nelle parti mancanti e quelle del supporto originale si instaurano gli stessi legami chimici presenti all’atto della fabbricazione della carta.
Collatura
Contemporaneamente alla fase di reintegro si è proceduto alla collatura. Essa consiste nel porre sul supporto, dopo l’aspirazione dell’acqua, un reemay precol-lato con tylose MH300P al 2% che consente di reintegrare la percentuale di colla dispersa dal supporto durante la permanenza in acqua.
Asciugatura
L’asciugatura è stata effettuata in due tempi. Inizialmente le carte, poste tra carte assorbenti e cartone di pasta di fibra vegetale, sono state messe sotto pressa a lieve pressione al fine di assorbire l’eccesso di acqua. Dopo circa 10 ore, sono stati so-stituiti i fogli assorbenti ed è stato ripetuto il processo fino a quando le carte sono
79 80
94 95
unità comprendenti: 435 pergamene, 15 incunaboli, 465 cinquecentine, il Libro Rosso (XIII-XVII), un Evangelario miniato (XII sec), materiale audiovisivo, atti dattiloscritti e tesi, fotografie, 3500 opuscoli e una corposa emeroteca.
5.1 Monitoraggio aMBientale
Il personale dell’associazione culturale Folio ha monitorato otto sale della biblio-teca comunale. Per maggiore chiarezza della lettura dei grafici seguenti, si speci-fica che con la sala 1 si intende la sala lettura; la sala 2 è la stanza Traetta; la sala 3 è quella Rogadeo e la sala 4 è la sala del Risorgimento; la sala 5 corrisponde alla sala Caiati, la 6 alla sala convegno; la sala 7 è la sala mostra e infine la sala 8 corrisponde alla stanza deposito.
Il monitoraggio ambientale effettuato nella sala 1 durante l’anno 2009-2010, ha rilevato, nei mesi autunnali, un’umidità relativa compresa fra il 48 e il 59,6% ed una temperatura fra i 22 e i 20°C. Durante l’inverno, stagione in cui viene acceso il riscaldamento in tutte le sale, l’umidità relativa scende a al 41,4-46,3% e la temperatura si stabilizza fra i 17 e i 18°C. nei mesi primaverili, l’umidità relativa oscilla fra il 47 e il 55% mentre la temperatura fra i 19 e i 21 °C. All’ini-zio dell’estate (giugno-luglio) quest’ultima sale fino ai 27°C e l’umidità relativa è compresa fra il 44 e il 42%.
L’illuminazione della sala è garantita dalla presenza di una finestra non scher-mata e da luce artificiale a fluorescenza. Il grafico sintetizza i valori minimi e massimi di illuminamento rilevati durante l’anno. Si passa dai 100 ai 900 lux a seconda della posizione degli scaffali. naturalmente i valori più alti si hanno in prossimità della finestra.
figg. 81-82-83-84: cucitura e montaggio nuova coperta
5. BiBlioteca coMunale e. rogadeo di Bitonto: cenni storici
La Biblioteca comunale di Bitonto, denominata inizialmente Vitale Giordano, fu fondata nel 1841. Il primo nucleo librario era costituito da un centinaio di testi giuridico-amministrativi, da opuscoli e periodici.
nel 1934 la biblioteca incrementò il proprio patrimonio acquisendo il fondo librario della famiglia Rogadeo.
Il 22 dicembre del 1973, in seguito alla munifica donazione dei Conti Franco Rogadeo e Maddalena De Reseis, la biblioteca fu trasferita dalla sede del Comune al primo piano del settecentesco palazzo Rogadeo, ubicato nella via omonima nel centro storico della città. La biblioteca fu intitolata ad Eustachio Rogadeo padre del donatore e studioso di storia locale.
nel corso degli anni, grazie a continue acquisizioni e numerose donazioni, la biblioteca ha incrementato il patrimonio librario ed oggi vanta all’incirca 60.000
8281
83 83
96 97
nella sala 3, l’umidità relativa durante il periodo autunnale è compresa fra il 55 e il 60% e la temperatura fra i 20 e i 21°C. In inverno, invece, la prima oscilla fra il 42,2 e il 49,5% e la seconda fra i 16 e i 17°C. Durante i mesi primaverili l’umidità relativa è compresa fra il 49,6 e il 54,1% mentre la temperatura è stabile sui 19°C. nei mesi di giugno e luglio, l’umidità oscilla fra il 45,3 e il 42,2% e la temperatura fra i 25,5 e i 26,6°C.
nella sala 2, durante l’autunno, si registra un’umidità relativa compresa fra il 60 e il 55% e la temperatura fra i 20 e 21°C. nei mesi invernali, l’umidità è fra il 41 e il 47,5% e la temperatura compresa fra i 16 e i 18°C. Durante i mesi primaverili, l’umidità relativa oscilla fra il 47,5 e il 53,9% mentre la temperatura si stabilizza fra i 19,8 e i 21°C. nei mesi estivi, i parametri microclimatici sono compresi fra il 45,5 e il 55% per quanto riguarda l’umidità relativa e fra i 23 e il 26°C per quel che riguarda la temperatura.
La sala Traetta è illuminata da due finestre non schermate e dalla luce ar-tificiale a fluorescenza, la cui fonte è posizionata al centro della stanza. I valori massimi di illuminamento sono stati rilevati in direzione delle finestre e quando la luce artificiale era accesa (400-500 lux). I volumi conservati in questa sala sono posizionati in un’antica libreria chiusa da ante in legno, nella parte bassa, e da vetri nella parte centrale. Il tipo di allestimento non consente dunque un ricliclo di aria all’interno degli scaffali e soffre dell’assorbimento del calore proveniente dalla luce naturale che colpisce direttamente i vetri della libreria.
98 99
Questa stanza riceve la luce da una finestra, i cui battenti sono sepre chiusi, e dalla luce artificiale a fluorescenza, accesa dal personale della biblioteca soltanto durante il posizionamento dei testi sugli scaffali. Anche in questa sala i volumi sono conservati all’interno di armadi-librerie in legno schermate da ante in legno. Queste sono però lasciate sempre aperte in modo da garantire lo scambio di aria con l’esterno.
La sala 5 oltre a custodire le cinquecentine, ospita anche le attività del persona-le della biblioteca. Questa doppia funzione dell’ambiente implica però una mag-giore esposizione del materiale librario alla luce artificiale. I parametri registrati nei mesi autunnali rilevano una umidità relativa che oscilla fra il 59,7 e il 56%, e una temperatura compresa fra i 19 e i 21°C. In inverno, anche in questa sala, l’accensione del riscaldamento, determina un abbassamento dell’umidità fino al 39,2% nel mese di gennaio, e la stabilità della temperatura compresa fra i 19 e
Anche questa sala è illuminata grazie alla presenza di due finestre non scher-mate e dalla luce artificiale a fluorescenza che però raramente viene accesa. negli scaffali più vicini alla finestra si ha un illuminamento compreso fra i 200 e 350 lux.
nella sala 4 l’umidità relativa, nei mesi autunnali, è compresa fra il 53 e 55%, mentre la temperatura fra i 19,6 e i 21°C; in inverno, la concentrazione di umidi-tà relativa si abbassa a valori compresi fra il 43 e il 48,2% e la temperatura oscilla fra i 16 e il 17 °C. Durante i mesi primaverili, la percentuale di umidità relativa torna a essere compresa fra il 48 e il 54% e la temperatura fra i 19 e 20°C. Fra giugno e luglio, invece, l’umidità oscilla fra il 53 e il 46% e la temperatura fra il 23,5 e il 26,5.
100 101
La sala 6 ha solo la funzione di deposito di libri; durante tutto l’anno le finestre sono schiuse, i battenti oscurati ed è assente qualsiasi forma di riciclo di aria. Du-rante i mesi autunnali, la concentrazione di umidità relativa si mantiene costante al 56% e la temperatura fra i 19 e i 20°C. Durante la stagione invernale, l’umidità oscilla fra il 46,5 e il 50% mentre la temperatura è stabile sui 16°C. Con l’arrivo della primavera, la percentuale di umidità torna ad essere compresa fra il 54 e il 56% e la temperatura fra i 18 e i 19°C. nei mesi estivi, in seguito all’apertura di porte e finestre, si assiste ad una netta diminuzione della umidità relativa (che oscilla fra il 51 e il 46%) e ad un inevitabile innalzamento della temperatura (24-26,2°C).
Per quanto riguarda l’illuminamento, il numero massimo di lux rilevato è pari a 200, quantità di luce monitorata durante l’accensione della luce artificiale a fluorescenza.
20°C. Durante i mesi primaverili, la temperatura aumenta soltanto di un grado, mentre la percentuale di umidità relativa gradualmente passa dal 49,6 al 56,7%.
nei mesi estivi si ha invece una diminuzione improvvisa della percentuale di umidità (dal 47 al 41%) e un elevato aumento di temperatura (26,3-27,2°C).
Sebbene il materiale custodito nella stanza sia di particolare pregio, in alcun modo si cerca di limitare l’azione nociva della luce solare che penetra attraverso due finestre non schermate, e dalla luce artificiale a fluorescenza costantemente accesa. I valori massimi di illuminamento sono compresi fra i 320 e il 530 lux.
posizionando un lightcheck ultra in corrispondenza degli scaffali che custodisco-no le cinquecentine è stato possibile monitorare l’illuminamento durante il mese di marzo. La striscia di carta è diventata in soli 30 giorni del suo colore più chiaro; facendo, dunque, un semplice calcolo è possibile stimare l’esposizione o la quan-tità di luce ricevuta dall’oggetto: 75.000 lux (codice di esposizione ELE) per 365 giorni diviso 30 (giorni di esposizione del lightcheck) è uguale a 912.500, valore che supera di circa sei volte i parametri standard di dose di luce annuale consigliati per gli oggetti appartenenti alla terza categoria di fotosensibilità.
102 103
La sala 8 è il deposito della biblioteca. L’umidità relativa, durante i mesi au-tunnali, è pari al 60% e la temperatura compresa fra i 18 e i 19°C. Quest’ultima in inverno si stabilizza sui 16°C mentre l’umidità oscilla fra il 51 e il 55%. Resta sostanzialmente invariata la percententuale di umidità durante la primavera e il mese di giugno. Con l’avanzare dell’estate si ha un brusco abbassamento dell’umi-dità relativa (41,2%) e un innalzamento della temperatura (27,5°C).
Questa stanza è quasi sempre al buio. I battenti in legno delle finestre impe-discono alla luce di entrare e la luce artificiale a fluorescenza viene accesa dal personale della biblioteca, soltanto in caso di utilizzo della sala. I valori massimi di illuminamento, compresi fra i 120 e i 180 lux, sono stati rilevati nei momenti in cui la luce era accesa.
La sala 7 custodisce una piccola raccolta museale, composta di reperti cera-mici e monete, e in alcuni armadi, incassati nelle pareti, dei libri moderni. Du-rante i mesi autunnali l’umidità relativa registrata è compresa fra il 58 e il 59,6% mentre la temperatura risulta stabile sui 19°C. In primavera, con lo spengimento del riscaldamento, i parametri si ristabilizzano (RH fra il 55 e 56,5%, T fra i 18 e i 19°C), mentre durante i mesi estivi si assiste nuovamente ad un abbassa-mento dell’umidità (46,5%) e ad un aumento della temperatura che raggiunge i 26,2°C.
Questa stanza è inondata di luce naturale proveniente da una finestra non schermata e da dei lucernai posizionati nella parte alta delle pareti. I valori mas-simi di illuminamento registrati sono compresi fra i 300 e i 700 lux.
104 105
figg. 85-86-87-88: variazione cromatica e irrigidimento dei supporti
nella sala 2, come si è già sottolineato, i volumi sono custoditi all’interno di un’antica libreria i cui ripiani in legno sono occupati da due file di libri. La libreria è chiusa da ante in legno e vetro, non vi è dunque riciclo di aria come si deduce anche dall’odore acre che si sprigiona all’apertura delle ante. All’interno della libreria è stata riscontrata la presenza di polvere, calcinacci, attacchi microbici e insetti (lepisma), fattori che hanno portato alla estrema fragilità delle carte, feltrose e friabili; al compattamento delle carte di interi volumi; alla polverizzazione dei supporti.
figg. 89-90-91: volumi infestati da ife e attacchi microbici
nella tabella successiva sono sintetizzati in una visione d’insieme i valori mini-mi, medi e massimi di temperatura e umidità relativa rilevati fra settembre 2009 e luglio 2010.
stagioni tmin tmed tmax rhmin rhmed rhmax
autunno 18,2 20,2 21 54 56,3 64
inverno 16,1 18,5 20 39,2 43 50,2
primavera 17,8 19,3 22 47 51 56,7
estate 25,3 26,5 27,5 41 45,6 47,5
5.2 linee guida
Durante il monitoraggio ambientale sono stati valutati anche altri aspetti fonda-mentale per la conservazione dei fondi librari, come la presenza di scaffalatura idonea e di pulizia nelle sale e sui palchetti.
Sono state riscontrante anomalie differenti in tutte le sale monitorate. La sala 1 custodisce i libri su degli scaffali in metallo esposti, nel corso dell’anno, all’azione nociva della luce solare e di quella artificiale, ad una elevata temperatura (non dovrebbe superare i 21 °C) che, come abbiamo visto, durante il periodo primave-rile ed estivo, sfiora i 27°C. A questo si aggiunge che, durante l’inverno, a causa dell’accensione del riscaldamento, la percentuale di umidità relativa (dovrebbe essere compresa fra il 50 e il 60%) scende a valori non idonei alla conservazione dei supporti cartacei. I danni riscontrati sono strettamente legati alle condizioni climatiche: imbrunimento delle carte, irrigidimento e perdita di flessibilità del supporto.
90 9189
8685
87 88
106 107
- stilare una lista esaustiva dei volumi (alcuni già identificati dall’associazione Fo-lio) in pessimo stato di conservazione il cui restauro deve essere eseguito nel più breve tempo possibile.
Per quanto riguarda la sala 5 che custodisce le cinquecentine della biblioteca, il monitoraggio dei parametri ambientali ha consentito di rilevare un eccessivo aumento della temperatura nei mesi primaverili ed estivi oltre ad un eccessivo ab-bassamento dell’umidità relativa durante i mesi invernale. A questi dati negativi si aggiunge la presenza eccessiva di luce, naturale ed artificiale, nell’ambiente. Si dovrebbe intervenire nel più breve tempo possibile:- schermando le finestre con pellicole anti UV;- limitare l’utilizzo della luce artificiale o, se possibile, sostituire la fonte luminosa posta al centro della sala con delle luci schermate o ancora con delle lampade da tavolo in modo da non impedire al personale di svolgere le proprie funzioni;- limitare l’accensione del riscaldamento o mantenerlo stabile sui 20°C;- utilizzare un umidificare nel periodo estivo.
nel caso in cui non si potesse procedere con queste piccole azioni conservative si consiglia di spostare i volumi in ambienti più consoni, separandoli dalle attività amministrative che si svolgono all’interno della biblioteca.
nelle altre sale, in particolare la 6 e la 8, si consiglia di aerare in maniera co-stante gli ambienti, di posizionare dei filtri alle finestre della sala 6 e di procedere in entrambe con azioni riordino e pulizia dei volumi.
figg. 97-98: libri accantonati nei depositi
Il personale della biblioteca comunale di Bitonto ha affidato all’associazione Folio per un immediato restauro due documenti manoscritti, uno intitolato Fram-menti di scrittura del notaio Giovanni Bernardino Helia e l’altro Frammenti di scrittura del notatio Morea.
figg. 92-93: libreria non idonea alla conservazione
Per la conservazione dei libri è essenziale l’areazione che agisce come elemen-to meccanico, chimico ed antisettico. Se a tale mancanza si aggiunge la presenza della polvere che essendo costituita da particelle microscopiche di varia natura, tra cui anche inquinanti chimici e particolato di origine biologica (spore fungine, batteri, uova di insetti), le fonti di rischio aumentano, in concomitanza di fattori climatici favorevoli, per l’integrità del materiale librario custodito.
nella sala 3, oltre alla presenza della polvere sui tagli dei libri, è stata riscontra-ta la presenza di palchetti non idonei al contenimento di alcuni formati di volumi difficilmente prelevabili, e l’eccessivo riempimento degli scaffali.
figg. 94-95-96: materiale collocato forzatamente in palchetti non idonei
Le azioni più urgenti da compiere per la conservazione dei libri custoditi in queste sale, in particolare nella sala Traetta, sono:- schermatura delle finestre con pellicole filtranti la luce naturale, in modo da evitare i danni causati dai raggi UV;- posizionamento di deflettori della luce artificiale;- azionare degli umidificatori nel periodo estivo;- limitare l’uso del riscaldamento o cercare di mantenere la temperatura costante a 20°C;- compiere azione di disinfezione della libreria e del suo contenuto (eliminare la polvere, spolveratura dei testi, eliminare la presenza degli insetti);
97 98
92 93
94 95 96
108 109
prensione degli atti ivi contenuti. Prevalgono gli atti di quietanza o costituzione di debiti e i mutui65, alcuni dei quali facilmente individuabili anche a un rapido sguardo perché depennati dal notaio a seguito della loro estinzione. Seppur scarse, le informazioni ricavate evidenziano un’intensa attività creditizia nella comunità e pongono le basi per uno studio sulle occasioni che determinano tali movimenti di denaro e sull’individuazione delle principali personalità impegnate nel settore finanziario. Un’altra tipologia ricorrente è quella della vendita di beni agrari, con una netta prevalenza delle vendite di vigne66, che punteggiano le contrade agrico-le delle campagne bitontine, spesso in associazione con gli olivi67. A testimonianza dell’alta redditività dei prodotti della terra sui mercati cittadini, non mancano esempi di debiti quietati proprio con la cessione dei frutti della vigna68, ma non è possibile ricavare alcuna indicazione sulle tecniche di coltivazione o sui principali vitigni a causa della mancanza di contratti di locazioni di particolare interesse69.
Si segnala, per la lunghezza e la ricchezza di informazioni fornite, la divisione di beni tra i fratelli onorato e Giuseppe di Colangelo70.
Il protocollo di Angelantonio Morea consta di 7 carte, datate tra il 10 e il 29 di-cembre del 1626. La numerazione originale è visibile dall’attuale carta 6r.71 i contrat-ti presentano le stesse caratteristiche formali di quelli rogati un secolo prima da Gio-vanni berardino de helia: l’indicazione dei contraenti e della tipologia contrattuale precede il testo dell’atto vero e proprio. Dal punto di visto tipologico, i pochi rogiti superstiti testimoniano come, ancora nel XVII secolo, la coltivazione della vigna ri-vestisse un ruolo fondamentale nell’economia della comunità di Bitonto. Prevalgono, infatti, le locazioni di terreni vitati, solitamente di breve durata (2-3 anni), con canone in denaro. Di notevole interesse le clausole sulle pene previste per i danneggiamenti del bene e l’invito a bene et diligenter colere la vigna per garantirne la produttività.
federica viola
65. A titolo di esempio, cc. 2r, 3r, 6v, 7r.
66. Ad esempio, cc. 3v-4r, 7v-8r.
67. cc. 11v-12r.
68. c. 10v.
69. cc. 15v-16r. Si tratta di un contratto di affitto di una vigna per due anni a decorrere dal settem-bre del 1579 per un canone annuo di 205 ducati.
70. Cc. 12v-14v.
71. La carta era numerata in origine con il numero 39.
5.3 fraMMenti di scrittura dei notai helia e Morea: introduzione storica
5.3.1 le carte dei notai giovanni Berardino de helia e angelantonio Morea
Il recente restauro a cui sono stati sottoposti i frammenti di scrittura dei notai Giovanni berardino de helia62 (6-27 settembre 1578) e Angelantonio Morea (10-29 dicembre 1626)63, conservati presso la Biblioteca Comunale “Eustachio Ro-gadeo” di bitonto64, ha restituito alla fruizione degli studiosi alcuni interessanti documenti sul passato della città.
È nota, infatti, l’importanza del notaio in età medievale e moderna. In qualità di pubblico ufficiale, aveva il compito di redigere, secondo le norme legislative, i contratti fra privati, conferendo loro pubblica fede, curandone la trascrizione nei propri registri, garantendone la conservazione e impegnandosi a rilasciare, a richiesta, una copia o un estratto di un qualsiasi contratto. La sua presenza, quin-di, era richiesta in una straordinaria varietà di situazioni e certamente in misura molto maggiore rispetto all’attuale concezione dell’ufficio notarile. Gli atti notarili del passato, pertanto, rivestono un ruolo di primo piano nella ricerca storica.
I due protocolli si presentano nella forma di quaderni di piccole dimensioni e in materiale cartaceo, con gli atti rogati l’uno di seguito all’altro in ordine cro-nologico. Dal punto di vista formale, i contratti si aprono con l’indicazione della data cronica e dei testimoni presenti alla stesura dell’atto a cui fa seguito la parte dispositiva con le clausole finali espresse nella forma ceterata. La tipologia degli atti è varia e dipende in buona misura dal tipo di clientela e dalla eventuale spe-cializzazione del notaio.
Il protocollo di Giovanni Berardino de Helia consta attualmente di 27 carte. La numerazione moderna, vergata in matita in alto al centro, differisce di un’uni-tà rispetto a quella originale – visibile, tuttavia, solo a partire dalla carta 12r –, a testimonianza dell’avvenuta perdita di una carta. I 39 atti superstiti coprono un arco cronologico compreso tra il 6 e il 27 settembre del 1578. Ad apertura di con-tratto il notaio indica i nominativi dei contraenti e, in alcuni casi, la tipologia del rogito. Tuttavia, la lacunosità delle prime carte rende difficile la completa com-
62. Dello stesso notaio si conservano presso l’Archivio Storico del Comune di Bitonto 14 protocolli che coprono un arco di tempo compreso tra il 1570 il 1584.
63. Il frammento si aggiunge ai 43 protocolli presenti nell’Archivio comunale, datati tra il 1625 e il 1671.
64. Sulle vicende relative alla presenza di queste e altre carte nella Biblioteca comunale, cfr. L’archivio storico del Comune di Bitonto. Inventario dell’«Archivio antico» (secoli XV-XIX), a cura di e. vantaggiato,pp. 64-84, Bari 2001.
110 111
figg. 99-100: stato di conservazione del volume
Progettazione degli interventi di restauro
La scheda progetto compilata dal personale tecnico del laboratorio riassume lo stato di conservazione del volume evidenziando le caratteristiche dei danni ri-scontrati e la compromessa integrità delle varie componenti. Sulla base di questa ricognizione sono state valutate, di concerto con il team operante, le tecniche e metodologie da impiegare nella fase di restauro.
Rilevamenti fotografici
Sono state realizzate diverse sequenze fotografiche, in digitale ed alta definizio-ne, al fine di documentare lo stato di conservazione del documento al momento dell’acquisizione, le fasi preliminari e di restauro, fino al reinserimento della co-perta precedentemente smontata.
Smontaggio
Durante la fase di smontaggio, eseguita utilizzando bisturi, forbici e spatole, sono stati recisi i fili di cucitura che attraversano il centro dei fascicoli. Sono state inol-tre rimosse con delle leggere pressioni e la lama di un bisturi le restanti parti di indorsatura e di collante presente fra i fascicoli. Si è proceduto con l’asportazione delle fettucce di cucitura e della coperta.
5.4 restauro dei fraMMenti di scrittura del notaio helia e dei fraMMenti di scrittura del notaio Morea
Il primo manoscritto, Frammenti di scrittura del notaio Giovan Bernardino Helia (320X230X10), è datato al 1578.
le ventisette carte dei Frammenti costituivano due fascicoli ed erano legate con tre fettucce di lino e indorsate con una banda di carta riciclata ed una di canapa. La coperta era in mezza pelle di colore marrone e quadranti in cartone grigio accoppiato rivestiti con carte marmor. Sul dorso era visibile il titolo del documento impresso in oro. Le carte di guardia, una anteriore e una posteriore, erano coeve al documento; le altre due erano invece di tipo moderno, e furono applicate, pre-sumibilmente, insieme alla legatura.
Il documento notarile era in pessimo stato di conservazione per via dei danni causati principalmente dall’elevata umidità degli ambienti in cui era conserva-to, che, penetrando fra le fibre delle carte, ha causato rigonfiamenti, rotture dei legami della catena cellulosica e la formazione di evidenti gore. Le carte, in se-guito all’evaporazione dell’acqua, risultavano compattate, prive di elasticità ed estremamente fragili. I danni causati dagli agenti microbici nel documento sono essenzialmente riconducibili ai seguenti tipi:
a) alterazioni cromatiche;b) alterazioni strumentali del componente di base dei materiali; Le alterazioni cromatiche, provocate dai pigmenti batterici e fungini, si pre-
sentavano prevalentemente di colore violaceo e bruno. Le alterazioni strutturali, che si verificano generalmente negli stadi più avan-
zati dell’infezione, sono stati causate dagli enzimi e si sono manifestate con la fragilità del supporto e con la distruzione di alcune sue parti. numerose carte avevano ormai assunto un aspetto feltroso e tendevano a sbriciolarsi.
L’umidità ha arrecato danni anche agli inchiostri del documento rendendoli evanescenti in alcune carte. A causa dello stato conservazione del documento che ne rendeva impossibile la manipolazione e la consultazione, nella seconda metà del XX secolo, furono applicate delle strisce di carta moderna a difesa del supporto.
99 100
112 113
figg. 101-102-103: smontaggio del volume ed asportazione dei restauri pregressi
Pulizia a secco
L’intervento, eseguito tenendo conto dello stato conservazione del documento, è consistito nell’asportazione delle polveri superficiali, frammenti di collanti e corpi estranei sulla superficie del documento mediante leggere pressioni con pennelles-se morbide in modo da evitare azioni abrasive sulle carte danneggiate.
Interfoliazione e lavaggio
Al fine di identificare la tipologia di lavaggio più idonea e meno invasiva per il volume in fase di restauro sono stati effettuati preliminari test tampone sugli in-chiostri e sul supporto cartaceo. I primi , eseguiti con acqua calda e fredda, hanno dimostrato la non solubilità degli inchiostri; gli altri hanno rilevato un pH (misu-razione del grado di acidità o alcalinità del supporto) pari a 4,82. La misurazione è stata effettuata con pHmetro ad elettrodo piatto. Le carte sciolte sono state interposte tra reemay (tessuto non tessuto) al fine di preservarle da sollecitazioni do-vute alla manipolazione e al contatto, per immersione, con l’acqua deionizzata a temperatura compresa fra i 25-30 °C utilizzata per la fase di lavaggio in vasca ter-mostatica. Le carte che presentavano evidenti gore sono state trattate più volte.
figg. 104-105: stato di conservazione delle carte
104 105
DeacidificazioneAvendo riscontrato un’eccessiva acidità di tutte le carte, si è proceduto con un intervento di deacidificazione. Esso consiste nel trattare il documento con una soluzione a base di sostanze alcaline che neutralizza l’acidità causa principale del degrado della cellulosa, dei supporti e degli inchiostri, e ne inibisce la futura in-sorgenza. Il trattamento di deacidificazione va effettuato sempre dopo il lavaggio. nel presente caso si è deciso di operare per immersione in una soluzione di bicar-bonato di calcio che ha la funzione, penetrando nelle fibre della carta, di elevare il PH del supporto rilasciando una riserva alcalina contro l’acidità.Restauro meccanico(leaf casting)
Si è proceduto con il restauro meccanico del documento che presentava par-ti lacunose causate dell’elevata umidità, incuria e l’insorgere di microrganismi. L’intervento di restauro meccanico ha consentito di risarcire tutte le lacune e le lacerazioni reintegrando le parti mancanti del documento. Tra le fibre di cellulosa depositate nelle parti mancanti e quelle del supporto originale si instaurano gli stessi legami chimici presenti all’atto della fabbricazione della carta. Contempo-raneamente alla fase di reintegro si è proceduto alla collatura. Essa consiste nel porre sul supporto, dopo l’aspirazione dell’acqua, un reemay precollato con tylose MH300P al 2% che consente di reintegrare la percentuale di colla dispersa dal supporto durante la permanenza in acqua.
Sul recto e verso di tutte le carte è stata posta una velatura per rinforzare il supporto cartaceo e tenere ben salde le fibre di cellulosa reintegrate. Il velo usato è Tengujo 56100.
figg. 106-107: lavaggio di de acidificazione e restauro leaf-casting
107106
101 102 103
114 115
figg. 108-109-110: carte restaurate
Il secondo manoscritto, Frammenti di scrittura del notaio Morea (300X203X4), è composto da 7 carte che costituivano un unico fascicolo. Erano legate con tre fettucce di lino e indorsate con una banda di carta riciclata ed una di canapa. La coperta era in mezza pelle di colore marrone e quadranti in cartone grigio accoppiato rivestiti con carte marmor. Sul dorso era visibile il titolo del documento impresso in oro. Le carte di guardia, una anteriore e una posteriore, erano coeve al documento; le altre due erano invece di tipo moderno e furono applicate, pre-sumibilmente, insieme alla legatura.
Il documento notarile era in pessimo stato di conservazione per via dei dan-ni causati principalmente dall’umidità che penetrando fra le fibre delle carte ha causato rigonfiamenti, rotture dei legami della catena cellulosica e la formazione di evidenti gore. Le carte, dopo l’evaporazione dell’acqua, si sono compattate fra loro, hanno perso l’elasticità e sono diventate estremamente fragili. L’umidità ha arrecato dei danni anche agli inchiostri del documento rendendoli evanescenti in alcune carte.
Lo stato di conservazione del documento ne rendeva impossibile la manipo-lazione e consultazione, numerose erano, infatti, le lacune e le rotture in verticale delle carte che hanno portato alla perdita di alcune parti di supporto scrittorio. Presumibilmente nella seconda metà del XX secolo, si cercò di bloccare l’avanza-mento del degrado, applicando strisce di carta moderna e conservando il docu-mento in una coperta.
Progettazione degli interventi di restauro
La scheda progetto, compilata dal personale tecnico del laboratorio, riassume lo stato di conservazione del volume evidenziando le caratteristiche dei danni ri-scontrati e la compromessa integrità di tutte le componenti del documento. Sulla
AsciugaturaLe carte sono state poste tra carte assorbenti e cartone di pasta di fibra vegetale e messe sotto pressa a lieve pressione al fine di assorbire l’eccesso di acqua. Dopo circa 10 ore, sono stati sostituiti i fogli assorbenti ed è stato ripetuto il processo fino a quando le carte sono diventate umide. A quel punto, sono state poste su stenditoi e lasciate asciugare a temperatura ambiente. Successivamente è stato re-alizzato il distacco delle carte dai reemay usati per l’asciugatura facendo attenzione a non causare ulteriori danni alle lacune risarcite con polpa di cellulosa.
Rifilatura
La rifilatura consiste nell’asportazione lungo i margini degli eccessi di cellulosa e carta giapponese utilizzate per il restauro. Essa è stata eseguita a mano utilizzan-do delle forbici al fine di rispettare i margini originali delle carte.
Collazione
questo intervento consiste nel ricollocare carte e fascicoli al loro posto di origine verificando che non vi siano incoerenze. Una volta effettuato, l’insieme delle carte è stato posto sotto peso esercitando una lieve pressione della durata di circa 24 ore al fine di permettere il loro assestamento prima di procedere con la cucitura. nel frattempo, utilizzando carta ingress acid free, sono state preparate le carte di guardia (carte bianche interposte tra i piatti e il volume) costituite da due bifolii nella parte anteriore ed altri due in quella posteriore.
Cucitura
La cucitura, realizzata a mano, è stata eseguita su tre nervi singoli in pelle al-lumata, equidistanti gli uni dagli altri, senza tener conto della posizione delle fettucce precedentemente asportate. Allo stesso tempo, sono stati inseriti nuovi fogli di guardia (carta ingress acid free) conservando quelli originali, cuciti, mediante l’inserimento di una braghetta i prolungamento, al fascicolo costituito dai fogli di guardia.
Montaggio coperta
Su richiesta dell’ente, è stata conservata e reinserita la coperta già esistente, seb-bene i restauratori fossero consapevoli della non idoneità della stessa. Questa esi-genza ha portato alla realizzazione dell’indorsatura del fascicolo finalizzata all’in-serimento della coperta.
108
109 110
116 117
Pulizia a secco
Gli interventi di pulizia a secco sono stati eseguiti tenendo conto dello stato con-servazione del documento evitando azioni abrasive sulle carte danneggiate. L’in-tervento è consistito nell’asportazione delle polveri superficiali, frammenti di col-lanti e corpi estranei sulla superficie del documento mediante leggere pressioni con pennellesse morbide.
Interfoliazione e lavaggio
Al fine di identificare la tipologia di lavaggio più idonea e meno invasiva per il vo-lume in fase di restauro sono stati eseguiti preliminari test tampone sugli inchiostri e sul supporto cartaceo. I primi, effettuati con acqua calda e fredda, hanno dimo-strato la non solubilità degli inchiostri; gli altri hanno rilevato un pH (misurazione del grado di acidità o alcalinità del supporto) pari a 4,74. Per la misurazione è stato utilizzato un pHmetro ad elettrodo piatto. Le carte sciolte sono state interposte tra reemay (tessuto non tessuto) al fine di preservarle dalle sollecitazioni causate dalla manipolazione e dal contatto, per immersione, con l’acqua deionizzata a tempera-tura compresa fra i 25-30 °C, utilizzata per la fase di lavaggio in vasca termostati-ca. Le carte che presentavano evidenti gore sono state trattate più volte .
Deacidificazione
Questo intervento consiste nel trattare il documento con una soluzione a base di sostanze alcaline che neutralizza l’acidità, causa principale del degrado della cellulosa, dei supporti e degli inchiostri, e ne inibisce la futura insorgenza. Il trat-tamento di deacidificazione va effettuato sempre dopo il lavaggio. nel presente caso si è deciso di operare per immersione in una soluzione di bicarbonato di calcio che ha la funzione, penetrando nelle fibre della carta, di elevare il PH del supporto rilasciando una riserva alcalina contro l’acidità.
Restauro meccanico (leaf casting)
Si è proceduto con il restauro meccanico delle carte del documento che presen-tava parti lacunose causate dall’elevata umidità, incuria e dall’insorgere di mi-crorganismi. Il restauro meccanico ha consentito di risarcire tutte le lacune e le lacerazioni reintegrando le parti mancanti del documento. Tra le fibre di cellulosa depositate nelle parti mancanti e quelle del supporto originario si instaurano gli stessi legami chimici presenti all’atto della fabbricazione della carta. Contempo-raneamente alla fase di reintegro si è proceduto alla collatura. Essa consiste nel
base di questa prima ricognizione, sono state valutate, di concerto con il team operante, le tecniche e metodologie da impiegare nella fase di restauro.
figg. 111-112: stato di conservazione e smontaggio
Rilevamenti fotograficiSono state realizzate diverse sequenze fotografiche, in digitale ed alta definizio-ne, al fine di documentare lo stato di conservazione del documento al momento dell’acquisizione, le fasi preliminari e di restauro, fino al reinserimento della co-perta precedentemente smontata.
figg. 113-114: rilevamenti fotografici
Smontaggio
Durante la fase di smontaggio, eseguita utilizzando bisturi, forbici e spatole, sono stati recisi i fili di cucitura che attraversano il centro del fascicolo. Sono state inol-tre rimosse con delle leggere pressioni e con l’utilizzo di un bisturi le restanti parti di indorsatura e di collante fra le carte. Si è proceduto con l’asportazione delle fettucce di cucitura e della coperta.
114
113
111
112
118 119
zando carta ingress acid free, sono state preparate le carte di guardia (carte bianche interposte tra i piatti e il volume) costituite da due bifolii nella parte anteriore ed altri due in quella posteriore.
figg. 117-118: carte restaurate
CucituraLa cucitura, realizzata a mano, è stata eseguita su tre nervi singoli in pelle al-lumata, equidistanti gli uni dagli altri, senza tener conto della posizione delle fettucce precedentemente asportate. Allo stesso tempo, sono stati inseriti nuovi fogli di guardia (carta ingress acid free) conservando quelli originali, cuciti, mediante l’inserimento di una braghetta di prolungamento, al fascicolo costituito dai fogli di guardia.
Montaggio coperta
Su richiesta dell’ente, è stata conservata e reinserita la coperta già esistente, seb-bene i restauratori fossero consapevoli della non idoneità della stessa. Questa esi-genza ha portato alla realizzazione dell’indorsatura del fascicolo finalizzata all’in-serimento della coperta.
porre sul supporto, dopo l’aspirazione dell’acqua, un reemay precollato con tylose MH300P al 2% che consente di reintegrare la percentuale di colla dispersa dal supporto durante la permanenza in acqua. Sul recto e verso di tutte le carte è stata posta una velatura per rinforzare il sup-porto cartaceo e tenere ben salde le fibre di cellulosa reintegrate. Il velo usato è Tengujo 56100.
figg. 115-116: restauro leaf casting e asciugatura delle carte
AsciugaturaLe carte, poste tra carte assorbenti e cartone di pasta di fibra vegetale, sono state messe sotto pressa a lieve pressione al fine di assorbire l’eccesso di acqua. Dopo circa 10 ore, sono stati sostituiti i fogli assorbenti ed è stato ripetuto il processo fino a quando le carte sono diventate umide. A quel punto, sono state poste su sten-ditoi e lasciate asciugare a temperatura ambiente. Successivamente i reemay usati per l’asciugatura sono stati distaccati dalle carte facendo attenzione a non causare ulteriori danni alle lacune risarcite con la polpa di cellulosa.
Rifilatura
La rifilatura consiste nell’asportazione lungo i margini degli eccessi di cellulosa e carta giapponese utilizzate per il restauro. Essa è stata eseguita a mano, utilizzan-do delle forbici, al fine di rispettare i margini originali delle carte.
Collazionequesto intervento consiste nel ricollocare carte e fascicoli al loro posto di origine verificando che non vi siano incoerenze. Una volta effettuata, le carte sono state poste sotto peso ed esercitando una lieve pressione della durata di circa 24 ore, si dato loro il tempo per l’assestamento prima della cucitura. nel frattempo, utiliz-
117 118
116
115
121
ConClusioni
il progetto “Conservazione preventiva nelle biblioteche di Puglia” ha tentato di applicare sul territorio regionale una buona pratica.
il gruppo di lavoro coinvolto nelle attività del progetto ha fornito un servizio agli istituti pubblici coinvolti cercando di sensibilizzare il personale e soprattutto le amministrazioni comunali a una corretta conservazione del patrimonio archi-vistico librario.
notevoli sono gli sforzi da compiere per migliorare le condizioni strutturali de-gli ambienti delle biblioteche presenti sul nostro territorio, immediati dovrebbero essere, alla luce di quanto emerso da questo studio, i provvedimenti da porre in essere.
Intere collezioni, interi fondi librari sono messi in serio pericolo dalle condi-zioni microclimatiche in cui sono custoditi. Abbiamo più volte fatto presente al personale delle biblioteche di non sottovalutare i danni causati dalla luce naturale ed artificiale, dagli sbalzi di umidità e temperatura, mostrando visivamente i gravi segni di degrado presenti sui libri (mancanza di elasticità delle carte, irrigidimento dei volumi, attacchi microbici, degrado delle legature) che quotidianamente ma-nipolano, consultano e conservano.
La nostra conoscenza del territorio ci permette di affermare che occorrerebbe un impegno maggiore su tutto il territorio affinché la conservazione preventiva fosse applicata a livello regionale, mappando e registrando il microclima di tutte le strutture in possesso di patrimonio storico artistico, attivando convenzioni e collaborazioni con enti e laboratori specializzati e creando gruppi di lavoro in-terdisciplinari impegnati nella raccolta dei dati e nell’elaborazione di linee guida applicabili nell’immediato.
Le biblioteche, come tutti gli istituti culturali pubblici, soffrono, in questo pe-riodo, di mancanza di fondi per il coordinamento delle comuni attività e in più sono assolutamente sprovviste di personale specializzato che possa occuparsi della prevenzione e della conservazione dei fondi librari. In questo clima, si potrebbero cercare soluzioni comuni facendo sistema e affidando a personale specializzato esterno le attività di monitoraggio e restauro.
figg. 119-120: reinserimento della coperta
119 120
123
biblioGraFia
- alcántara r., Standards in Preventive Conservations: meanings and applications, ICCRoM, Roma 2002.- L’archivio storico del Comune di Bitonto. Inventario dell’«Archivio antico» (secoli XV-XIX), a cura di e. vantaggiato, Bari 2001.- Baldacci v., L’Enciclopedia nella Toscana del ‘700: sucessi e fallimenti di progetti editoriali, «Ras-segna storica toscana», 31 (1985).- Basset t., Preventive, preservation a day to day work, «International Preservation news», 41(juillet 2007).- Bellucci p., Le edizioni toscane dell’Encyclopédie, «Rassegna storica toscana», 34 (1988).- Bonaventura danza p., San Giuseppe da Copertino. Il Santo dei voli, Copertino 2001.- Bongi s., L’Enciclopedia in Lucca, in «Archivio storico italiano», 18 (1873).- Brandi c., Teoria del Restauro, Roma 1963.- Buccoliero M.e., Marzano f., Incunaboli e Cinquecentine della Biblioteca Innocenziana di Lecce, Lecce 2004.- caMMelli M., Il decentramento difficile, «Aedon,», 1(1998). - La Carta italiana della conservazione e del restauro degli oggetti d’arte e di cultura, CnR, 1987. - caterino a., Il servizio bibliografico in Puglia e Lucania, Bari 1960. - La Conservation Prèventive, ARAAFU, 3e Colloque International, Parigi 1992.- levi-Malvano e., Les éditions toscanes de l’Encyclopédie, «Revue de Littérature Comparée», 3 (1923).- copedé M., La carta e il suo degrado, Firenze 1991.- darnton r., Il Grande Affare dei Lumi. Storia editoriale dell’Encyclopédie. 1775-1800, Milano 1998.- di Marzo a., siMonetti a., La via e la diffusione iconografica, in Il santo dei voli: San Giuseppe da Copertino: arte, storia, culto, Catalogo della mostra, napoli 2004.- dioguardi g., Dossier Diderot, Palermo 1995.- L’edizione lucchese dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert (1758-1776) e i suoi incisori, a cura di M. paoli, i. Manfredini, Lucca 2002.- Enciclopedia, o dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, s.v. “Enciclopedia” a cura di a. pons, Milano 1966. - L’enciclopedismo in Italia nel XVIII secolo, Atti del Convegno (Perugia, 20-22 ottobre 1994), a cura di g. aBBattista, napoli 1996.- fiorillo r., Incunaboli delle Biblioteche di Puglia, napoli 1942.- gallo a., Le malattie del libri. Le cure ed i restauri, Bologna 2006.- gallo f., gallo p., Insetti e microrganismi nemici dei libri, «Bollettino dell’Istituto per la Patologia del libro», luglio-dicembre 1967.- gallo f., Il biodeterioramento di libri e documenti, ICCRoM, Roma 1992.- garlandini a., Regione Lombardia in Strumenti di valutazione per i musei italiani. Esperienze a
124 125
Strategies, and Preservation Management, Canadian Conservation Institute 2003.- vannini f, Mansi, Giovanni Domenico, in Dizionario biografico degli italiani, 69, Roma 2007.- venturi f., Le origini dell’enciclopedia, Torino 1977.
RIFERIMEnTI noRMATIVI
- Legge n. 185, 12 giugno del 1902, Per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d’arte e antichità.- Legge n. 364, 20 giugno 1909, Per le antichità e le belle arti.- Legge n.1089, 1 Giugno 1939, Tutela delle cose di interesse artistico o storico.- Costituzione della Repubblica Italiana artt. 116, 117, 118. Testo sito istituzionale: www.governo.it. - D.P.R. n. 3, 14 gennaio 1972, Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni am-ministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.- D.P.R. n. 616, 24 luglio 1977, Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 Legge 512 del 1982. - Legge n. 59, 15 marzo del 1997, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle re-gioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.- Legge n. 127, 15 maggio 1997, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.- Legge n. 191, 16 giugno 1998, Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.- D.lgs. n. 112, 31 marzo 1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.- D.lgs. n. 490, 29 ottobre 1999, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.- D.lgs. n. 42, 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.- Legge Cost. n.3, 18 ottobre 2001, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.- D.M. 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzio-namento e sviluppo dei musei (art.150, coma 6, D.L. n.112/1998), ‹‹Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana››, Roma 19 ottobre 2001.- D.lgs. n. 368, 20 ottobre 1998, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.- D.lgs. n. 267, 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
confronto, a cura di A. Maresca Compagna, Roma 2005.- guichen (de) g., Biblioteche – Archivi e prevenzione contro gli agenti fisici, «Bollettino dell’Apos», 36 (1980), speciale.- guichen (de) g., La conservation préventive un changement profond de mentalité, «Cahiers d’étude Comité de Conservation», Parigi, ICoM, 4-5 (1997).- guichen (de) g., Preventive Conservation: a mere fad or a far-reaching change?, «Museum Inter-national», UnESCo, n.201, vol. 51, n.1(1999).- IFLA, Core programme on preservation and conservation, Council on library and in-formation resourses, Associazione italiana biblioteche, Principi dell’IFLA per la cura e il trat-tamento dei materiali di biblioteca, a cura di e.p.adock, Roma 2005.- ingrosso l., Un fondo librario da salvare nella biblioteca “Innocenziana” di Lecce, Lecce 1997.- Mazzotta o, Il Seminario di Lecce (1694-1908), Lecce 1994.- Michalski s., Guidelines for Humidity and Temperature for Canadian Archives, «Technical Bul-letin» 23 (2000).- Minna a., La Biblioteca pubblica dell’Alto Salento, Congedo 2000.- Montanari M., Agenti biologici che danneggiano i materiali librari ed archivistici, «Bollettino dell’Istituto per la Patologia del libro», 1980.- nguyen t.p., duBus M., saheB M., Mareynat s., Qualité de l’air dans les magasins de la Bibliothèque nationale de France, I - Premiers résultats, in Support Tracé, vol.6, 2006. - nguyen t.p., vallas p., La conservation des documents papier: point sur l’évolution des techniques et des stratégies, «Bulletin des Bibliothécaires Français», 51, 4 (2006). - nocco M.a., San Giuseppe da Copertino celebrato da agiografi, pittori, architetti e incisori, in Il santo dei voli: San Giuseppe da Copertino: arte, storia, culto, Catalogo della mostra, napoli 2004.- Oggetti nel Tempo. Principi e tecniche di conservazione preventiva, a cura dell’istituto per i beni arti-stici Culturali e naturali della Regione Emilia Romagna «Materiali e Ricerche», 7 (2007).- pedeMonte e., La carta. Storia, produzione, degrado, restauro, Venezia 2008.- Principles of conservation and resturation in libraries, «IFLA Journal», V (1979).- prosperi c., Il restauro dei documenti d’archivio. Dizionarietto dei termini, «Quaderni della Ras-segna degli archivi di Stato», 89 (1999).- proust J., L’Encyclopédie: storia, scienza, ideologia, Bologna 1978.- Ragione e civiltà. La visione illuministica del mondo nell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, a cura di e. vitale, Milano 1998. - randelli l., Mastragostino f., I comuni e le province, Bologna 1998.- rapanà t., Cenni storici e situazione attuale, in La Biblioteca Innocenziana del Seminario Arcivesco-vile, «Bollettino diocesano», 3 (1983).- rosa M., Diodati, Ottaviano, in Dizionario biografico degli italiani, 40, Roma 1991.- Saggi e note sull’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, a cura di a. calzolari, XVIII, Milano 1980.- Secondo centenario della edizione lucchese dell’Enciclopedia, Firenze 1959.- Servizi e Professionalità “nuove” per la tutela. La Conservazione preventiva delle raccolte museali, atti del Convegno (Ferrara Fiere, 27 marzo) a cura di c. Menegazzi, i. silvestri, Ferrara 1999.- tetrault J., Airborne pollutants in Museums, Galleries, and Archives: Risk Assessment, Control
126 127
- Legge regionale n. 22 17 aprile 1979, Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale.- Legge regionale n. 21, 12 aprile 1979, norme in materia di musei di enti locali e istituzioni di interesse locale.- Disegno di legge, Seduta Consiglio Regionale n. 135, 21 settembre 1978, norme in materia di Musei di Enti locali o di interesse locale.- Legge regionale n. 6, 11 febbraio 1988, Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale.- Legge regionale n. 10, 23 giugno 1993, Regime transitorio per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di musei, biblioteche ed archivi.
inDiCe
presenTazione p. 5parte iConSERVAzIonE PREVEnTIVA: DEFInIzIonE E noRME
1.1 conservazione preventiva: definizione p. 71.2 la conservazione nel quadro norMativo nazionale e regionale p. 101.3 paraMetri aMBientali: norMe e linee guida p. 141.4 Monitoraggio aMBientale p. 181.5 polvere e MicroorganisMi p. 24
parte iiCasi Di sTuDio
1. introduzione p. 271.1 struMentazione utilizzata per il Monitoraggio aMBientale p. 272. analisi dei casi di studio
2.1 BiBlioteca seMinarile innocenziana di lecce: cenni storici p. 292.2 Monitoraggio aMBientale p. 302.3 linee guida p. 372.4 encyclopédie: introduzione storica
2.4.1 l’edizione lucchese dell’encyclopédie nella BiBlioteca innocenziana p. 402.5 restauro dell’encyclopédie della BiBlioteca innocenziana di lecce p. 453. BiBlioteca archivio diocesano Mons. a. Marena di Bitonto: cenni storici p. 553.1 Monitoraggio aMBientale p. 563.3 linee guida p. 613.4 visita pastorale di cornelio Musso: introduzione storica
3.4.1 il Brano Manoscritto della “visita pastorale di c. Musso” p. 643.5 restauro del docuMento Manoscritto “visita pastorale di c. Musso” p. 653.6 il liBro delle oBBligazioni: introduzione storica
3.6.1 il liBro delle oBBligazioni dell’archivio diocesano Mons. a. Marena p. 693.7 restauro del voluMe delle oBBligazioni dell’archivio vescovile di B. p. 714. BiBlioteca coMunale f. trinchera di ostuni: cenni storici p. 754.1 Monitoraggio aMBientale p. 774.2 linee guida p. 854.3 sacra rituuM congregatione: introduzione storica p. 874.4 restauro del voluMe sacra rituuM congregatione p. 895. BiBlioteca coMunale e. rogadeo di Bitonto: cenni storici p. 945.1 Monitoraggio aMBientale p. 955.2 linee guida p. 1045.3 fraMMenti di scrittura dei notai helia e Morea: introduzione storica
5.3.1 le carte dei notai g. Berardino de helia e a. Morea p. 1085.4 restauro dei fraMMenti di scrittura del notaio helia e del notaio Morea p. 110
ConClusioni p. 121biblioGraFia p. 123