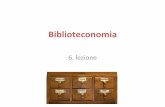Biblioteche d'autore in biblioteca: una catalogazione speciale?
Transcript of Biblioteche d'autore in biblioteca: una catalogazione speciale?
A L B E R T O P E T R U C C I A N I
Biblioteche d'autore in biblioteca: una catalogazione speciale?
I l mio intervento non risponderà 'sì' o 'no ' alla domanda formulata nel t itolo . Vuole piuttosto condividere con voi alcune riflessioni sulla catalogazione, oggi e i n prospett iva, a p a r t i r e , naturalmente , d a l l'esperienza d i oltre u n decennio d i lavoro della Commissione per la revisione delle RICA, le «Regole italiane d i catalogazione per autori», che è ormai i n d i r i t t u r a d 'arr ivo . Dopo v a r i documenti e testi parz ia l i , da febbraio 2008 è disponibile una bozza complessiva del nuovo codice (anche se con qualche piccola lacuna e varie cose da completare o ver i ficare, oltre che aperto a osservazioni e suggerimenti), che vorremmo pubblicare, dopo l 'u l t ima revisione, nei p r i m i mesi del 2009.^
Nel corso del rifacimento del codice itahano d i catalogazione è stato necessario mettere a punto dei c r i t e r i , e d ire i anche una mentalità, che potessero costituire una guida costante i n un lavoro molto impegnat ivo , lungo e complesso, i n cui le scelte da compiere si contano a centinaia se non a migliaia, grandi o piccole che siano.
Una decisione d i partenza, sostanzialmente obbligata, è stata quella d i redigere norme generali e complessive, per t u t t i i materiah d i bibl ioteca, non solo per i l i b r i (e i periodici) a stampa. Ma non si trattava semplicemente d i aggiungere qua e là un po' d i audiovisivi o d i pubblicazioni elettroniche, oggi largamente presenti nei cataloghi generali delle nostre biblioteche.
Piuttosto, occorreva rendersi conto, a mio avviso, d i due considerazioni d i base: 1) che la scelta, necessaria e corretta per le esigenze dell 'utente, d i un catalogo (elettronico) generale, i n cui confluisca possibilmente la segnalazione d i tutto i l materiale che la biblioteca mette a sua disposizione, significa allargare l 'orizzonte, non solo a questo o
' Le nuove Regole italiane di catalogazione R E I C A T , a cura della Commissione permanente delle regole italiane di catalogazione, sono state pubblicate d a U ' I C C U nel giugno 2009.
50 Alberto Petrucciani
quel materiale 'speciale', ma a una varietà molto maggiore e sfaccettata d i fenomeni, e 2) che, i n quest'ottica, le peculiarità tradizionalmente associate a singoli materiali 'speciali ' , o che la loro casistica comunque ci evidenzia, vanno considerate non come part ico lar i (paragrafi o regolette) da aggiungere ma come opportunità che si offrono per sviluppare una visione più generale, cr i t ica , trasversale se volete, del paesaggio documentario e dei pr inc ip i d i catalogazione.
Tornando al primo punto, non si tratta tanto d i inseguire la tipologia materiale dei nuovi documenti o supporti (audio, video, elettronici, fino ai dual disc e agh a l t r i prodott i che si propongono variamente d i 'superare ' i CD e i DV D ormai consueti), ma d i rendersi conto che la varietà d i materiali da considerare parte da queUi ' tradiz ional i ' - per esempio i l i b r i per bambini , ma anche i l materiale minore o la letteratura grigia -e va considerata sempre anche nella sua dimensione diacronica.
Basterà questo, credo, per capire che l 'approccio adottato non è stato quello d i una sommatoria d i regolette specifiche, ma si è anzi basato sul r i f iuto dei ' compartimenti stagni ' , compresa la dicotomia astratta (e ingenua) t ra materiale moderno e 'antico ' , che non rende affatto conto d i un'evoluzione che differenzia assai, com'è del resto ovvio , gli incunabo l i e le pr ime cinquecentine da l l i b r o a stampa 'maturo ' , i l l ibro del Settecento da quello dei secoli precedenti e dell 'Ottocento, quest'ultimo — al d i là della cesura convenzionale dell'anno 1830 - sia dall 'antico che dal contemporaneo. Anche i l l ibro del X X secolo, del resto, è t u t t ' a l t r o che omogeneo.
Nelle nuove norme, naturalmente, ci sono qua e là indicazioni relative a singole categorie d i materiale, o eccezioni o precisazioni per le 'pubblicazioni antiche' (entro i l l imite convenzionale citato). Insomma si è tenuto conto, com'è ovvio, delle esigenze d i carattere pratico e operat ivo , soprattutto i n u n contesto d i cooperazione sempre più capillare. Ma l 'ottica resta quella d i «norme generah, unitarie , integrate», i n cui particolarità e precisazioni vengono a inserirsi i l più possibile come articolazioni d i un approccio unitar io . I n pratica, questo approccio ha consentito d i eliminare una quantità interminabile d i eccezioni e var iazioni , che formicolano spesso senza alcuna ragione comprensibile, per esempio, nei testi delle ISBD specifiche e i n a l t r i codici.
I n più - e qu i r iprendo la seconda considerazione - le peculiarità generalmente associate a singoli material i o che la loro casistica evidenzia si rivelano i n genere, non appena si indaga un po ' più a fondo.
Biblioteche d^autore in biblioteca: una catalogazione speciale? 51
come fenomeni non circoscritti a un unico tipo di materiale. Piuttosto, sono tratti di un complesso paesaggio di condizioni bibliografiche, spesso abituali per certi materiali e occasionah o eccezionali per altr i , ma in continuo mutamento. Si può citare, per esempio, i l caso delle audioregistrazioni (su DVD-Audio o dual disc) arricchite di sottotitoli o di videoclip. Di conseguenza, spesso le soluzioni elaborate per singoli materiah si rivelano inadeguate a venire generahzzate, o incoerenti con quelle applicate a materiali diversi.
Per queste considerazioni abbiamo ritenuto necessario basare i l lavoro su un'indagine approfondita e a largo spettro sulla casistica, esaminando molte mighaia di documenti dei più diversi generi e periodi, e quest'analisi si è confermata fondamentale per arricchire la comprensione dei fenomeni e dare solidità alle norme.
I l nuovo codice («Regole italiane di catalogazione», non più «per autor i» ) dice chiaramente, proprio come prima frase (par. 0.1.1 del-VIntroduzione), che:
Queste norme forniscono indicazioni per la catalogazione di pub-bMcazioni di qualsiasi genere e su qualsiasi supporto (par. 0.1.2.1) e di documenti non pubblicati che si ritenga opportuno includere nel catalogo (cap. 6).
Non sono comprese nel codice, ricordo per inciso, le norme per l'indicizzazione per soggetto, ma non sarebbe impossibile, almeno in linea di principio, inserirvele, come una Parte IV. Poco più avanti, al par. 0.1.4 sempre delVIntroduzione, si dice:
Le norme sono destinate a biblioteche di ogni tipo e dimensione e ad altri istituti di qualsiasi natura che raccolgono, conservano o documentano pubblicazioni di qualsiasi genere e su qualsiasi supporto. Sono rivolte in primo luogo alla reahzzazione di cataloghi generah, che comprendano qualsiasi tipo di materiale.
Le norme tengono conto particolarmente delle esigenze di una catalogazione dettagliata, rigorosa e uniforme che caratterizzano i cataloghi di sistemi bibliotecari o reti di cooperazione (nei quali in genere immettono dati numerosi catalogatori che operano indipendentemente in più istituti o sedi) e quelli di grandi biblioteche.
Alcune indicazioni contenute nelle norme possono risultare non necessarie o difficilmente praticabili in piccole biblioteche o in man-
52 Alberto Petrucciani
canza di strumenti informativi e tecnologici adeguati. Inversamente, istituti specializzati possono avere bisogno di norme più dettagliate per particolari materiali o tipi di pubblicazioni.
I l contesto di cataloghi generah, elettronici, sempre più largamente cooperativi (dalla partecipazione alla rete nazionale SBN fino ai sistemi bibliotecari urbani o d'ateneo), costituisce quindi i l punto di riferimento. A cataloghi 'speciali' si fa riferimento, neìYIntroduzione, in quanto ovviamente - sempre salvaguardando la segnalazione di tutto d materiale nel catalogo generale - può essere opportuno predisporre altri prodotti e servizi, con finahtà o destinazioni diverse (compresi i tra-dizionah cataloghi speciah a stampa, che non hanno esaurito la loro utilità per gU studiosi), che potranno includere ulteriori elementi di ricerca o di descrizione.
Nei paragrafi 1.3.1 e 1.3.2, nella Parte I , si formulano altri avvertimenti:
1.3.1. Applicazione delle norme ai diversi tipi di materiali Le norme si apphcano a qualsiasi tipo di materiale pubblicato da
includere in un catalogo generale. [...] Quando necessario le norme includono aggiunte o precisazioni relative a particolari materiah o tipi di pubbhcazioni [...]. In alcuni casi le norme avvertono che per determinati materiali o tipi di pubbhcazioni si può preferire un trattamento particolare, che differisce daUe norme generali ma è applicato in contesti specifici o cataloghi speciah.
1.3.2. Applicazione delle norme alle pubblicazioni antiche Molte norme comprendono aggiunte, eccezioni o precisazioni per
le pubblicazioni antiche. Queste indicazioni si riferiscono alla descrizione di pubbhcazioni antiche in cataloghi generah, mentre si riconosce che esigenze e modahtà di descrizione possono variare in contesti o per finalità differenti (p.es. in cataloghi speciali o repertori bibliografici).
Tra i punti di partenza delle nuove norme, in un momento in cui spesso gli entusiasmi tecnologici portano a confondere ambiti vicini ma differenti e a comprenderne poco le specificità di funzioni e natura, c'è d richiamo, come abbiamo visto, alla «catalogazione di pubbhcazioni di qualsiasi genere e su qualsiasi supporto», che è l'ambito di riferimento
Biblioteche d'autore in biblioteca: una catalogazione speciale? 53
proprio delle biblioteche (e differente, p.es., rispetto agli archivi ) , ma anche, subito, l 'avvertimento che le norme possono essere utilizzate anche per la catalogazione d i «documenti non pubblicati che si ritenga opportuno includere nel catalogo», ai quali è dedicato u n capitolo della Parte I (cap. 6).
Le ragioni d i questa indicazione sono diverse, dal confine non sempre netto t ra le due categorie alla considerazione pratica, banale ma decisiva, che le biblioteche d i fatto raccolgono, conservano e mettono a disposizione anche materiale non pubbl icato , i n misura minore ma quasi mai del tutto assente, e che è opportuno che questo materiale sia catalogato e facilmente rintracciabile - per gli utent i , ma oserei dire anche per il personale stesso - nello strumento d i riferimento d i base, i l catalogo generale. Particolarmente, a mio avviso, quando non si t rat ta di raccolte d i larga consistenza e notorietà, ma d i presenze minor i o isolate: le grandi raccolte d i manoscritti delle biblioteche storiche, per esempio, sono ovviamente registrate i n strumenti appositi , per v a r i aspetti impostati i n modo differente rispetto al catalogo generale, ma ben not i e quindi autonomamente f r u i b i l i dagli studiosi.
Ult ima ma forse p i l i importante d i queste premesse è la chiara i n d i cazione che se l 'obiettivo d i base è la catalogazione d i «pubblicazioni», l'oggetto reale d i partenza, e qu ind i d i trattamento , è la «copia» o «esemplare» (non entro qu i nella possibile distinzione t ra i due ter
mini ) . A entrambi questi oggetti concettualmente d i s t i n t i , q u i n d i , è dedicata la Parte I del codice:
0 . 1 . 2 . 1 . Per pubblicazione si intende ogni documento destinato all'uso pubblico e fruibile mediante la lettura, l'ascolto, la visione o i l tatto, prodotto o riprodotto in più esemplari con qualsiasi procedimento tecnico e su qualsiasi supporto o messo a disposizione per l'accesso a distanza (trasmissione tramite una rete informatica), qualsiasi siano le sue modalità di edizione, distribuzione o diffusione. Sono comprese sia le pubblicazioni poste in commercio sia quelle diffuse gratuitamente, al pubblico generale o a categorie determinate, oltre l'ambito esclusivamente privato. 0.1.2.2. Per esemplare si intende i l singolo oggetto materiale (copia) prodotto e posto in circolazione come supporto di una pubblicazione, o la copia digitale, integrale o parziale, di una pubblicazione elettronica accessibile a distanza, trasmessa tramite una rete informatica.
54 Alberto Petrucciani
Un esemplare può presentare differenze rispetto ad altri esemplari della stessa pubblicazione, sia fin dal momento della sua produzione sia per eventi o interventi successivi. Al singolo esemplare si riferiscono, inoltre, informazioni relative alla proprietà, disponibilità, collocazione, etc.
L'esemplare, q u i n d i , è subito messo i n pr imo p iano , sia come «fonte» su cui la catalogazione si basa, sia come «oggetto d'interesse» i n sé, per le sue peculiarità e vicende successive alla fase d i produzione e messa i n circolazione, e naturalmente come «mezzo d i accesso» al contenuto, per l 'utente.
La considerazione dell'esemplare è qu ind i messa, metodologicamente, i n pr imo piano, per la sua portata generale, non l imitata (come talvolta si sente dire superficialmente) aU"ant ico ' , o al materiale d i pregio. 11 pr imo capitolo della Parte I comprende perciò varie problematiche i n qualche modo pre l iminar i , che vanno da che cosa si intenda per «esemplare» nel caso d i pubblicazioni on-demand o accessibili a distanza tramite una rete informatica (e non distribuite o diffuse su un supporto materiale) alle questioni, concrete e spesso non banal i , dell 'analisi dell'esemplare stesso, della distinzione t ra elementi non origi n a r i e quindi da non considerare come pertinenti all'insieme delle copie prodotte (a cui si riferisce la descrizione bibliografica), delle manipolazioni , degli «ibridi» (costituiti da p a r t i d i pubblicazioni diverse o anche da p a r t i d i esemplari incompleti differenti) , dei lacerti non agevolmente a t t r ibu ib i l i a questa o quella edizione.
Tornando alVIntroduzione, v i si spiega quindi che la catalogazione comprende comunque l 'ambito della «descrizione bibhografica» (riferito alla pubblicazione) e quello delle «informazioni relative all'esemplare», che anche se ridotte al minimo m i pare che non possano mai mancare. Quest'ultimo ambito in fa t t i comprende non soltanto le informazioni d i carattere 'storico ' , a cui più facilmente si pensa (dediche, note d i possesso, ecc.), ma anche dat i d i genere diverso come la consistenza (a cui pensiamo d i solito solo per i periodici) o le eventuali mancanze o m u t i laz ioni , e ancora più i n generale la collocazione, senza dimenticare informazioni sullo stato (per esempio la disponibihtà per i l prestito) e, se occorrono (e i n genere occorrono), dati d i carattere amministrativo o gestionale (a part ire per esempio dal numero d ' inventario) .
I n forma brevissima, i l par. 0.3.2 deWIntroduzione r icorda:
Biblioteche d'autore in biblioteca: una catalogazione speciale? 55
0.3.2. Informazioni relative all'esemplare Le informazioni relative all'esemplare (cap. 7) includono gli ele
menti necessari per: 1) identificare l'esemplare stesso; 2) precisare sue caratteristiche rdevanti per l'uso (p.es. la sua
incompletezza o imperfezione); 3) segnalare sue caratteristiche peculiari, sia sotto l'aspetto mate
riale sia per quanto riguarda le sue vicende e gli interventi che ha subito (p.es. la sua provenienza, i precedenti possessori, la presenza di postille, etc) .
Con queste informazioni possono essere registrati ulteriori dati di interesse gestionale.
Come sappiamo, però, un catalogo non si hmita a registrare le informazioni, ma comporta anche l'allestimento d i un «sistema d i accesso o selezione», i n cui necessariamente anche le informazioni relative all 'esemplare devono r ientrare . A questo proposito sarà bene notare che queste informazioni non sono relative soltanto al possesso o alla conservazione, ma coinvolgono anche ambiti che siamo abituati ad associare solo ai l i ve l l i dell 'opera e dell 'edizione. Ecco q u i n d i i «titoli» ( t i to l i manoscritt i , o d i miscellanee fattizie, e t c ) , ma anche le «responsabilità» per i l contenuto intellettuale o artistico (per usare la frase classica delle ISBD) , per esempio quelle d i chi abbia postillato i l testo o lo abbia corretto o emendato a mano, d i chi abbia aggiunto dlustrazioni o decorazioni, o realizzato una legatura d 'arte , etc. I n f a t t i già i l pr imo paragrafo del testo (0.1.1 cit.) ricorda che nella Parte I I I sono incluse le norme «per l'assegnazione [...] delle intestazioni alle persone ed enti che rivestono responsabilità per le opere o le loro espressioni ed eventualmente per le pubblicazioni stesse o loro esemplari».
Alle responsabilità relative all'esemplare è dedicato un breve capitolo della Parte I I I (cap. 20), a cui rimandano le definizioni introduttive:
14.1.6. Responsabilità relative a singoli esemplari Persone ed enti possono essere responsabdi di attività che riguar
dano singoli esemplari di una pubbbcazione, sia relativamente alle loro caratteristiche intellettuali o artistiche (correzioni al testo, postille, illustrazioni o decorazioni aggiunte, legature di pregio, etc.) sia relativamente al loro possesso o alla loro conservazione (acquisto, vendita, dono, collocazione, restauro, etc) . Tuttavia, la distinzione
56 Alberto Petrucciani
tra attività relative a un singolo esemplare, attività relative a un gruppo di esemplari della stessa pubblicazione e attività relative alla pubblicazione in quanto tale (o a un sottoinsieme del complesso degli esemplari prodotti, p.es. una tiratura o emissione distinta) non è sempre netta o determinabile con certezza.
Queste responsabilità possono essere oggetto di una registrazione sistematica e controllata, come le responsabilità per le opere e le espressioni e quelle per la produzione materiale. Questo trattamento è raccomandato almeno per le pubblicazioni antiche e i l materiale di pregio.
Questa è quindi l 'architettura complessiva, i l quadro entro i l quale la considerazione delle caratteristiche dell'esemplare si inserisce, e m i è sembrato opportuno soffermarmi su questa, piuttosto che sui particolari del cap. 7 {Informazioni relative all'esemplare), a prima vista più direttamente pertinente al tema. D i questo capitolo, però, vorrei presentare almeno l ' indice:
7. Informazioni relative all'esemplare 7.1. Indicazione di ristampe, varianti o riproduzioni
7.1.1. Note relative a ristampe o tirature 7.1.2. Note relative a varianti e stati 7.1.3. Note relative a esemplari numerati o adpersonam 7.1.4. Note relative a riproduzioni locali
7.2. Consistenza di pubblicazioni periodiche o seriaU 7.3. Completezza, mutilazioni e imperfezioni 7.4. Altre caratteristiche materiali
7.4.1. Caratteristiche del supporto 7.4.2. Illustrazione, ornamentazione, decorazione 7.4.3. Dimensioni 7.4.4. Legatura
7.5. Note di possesso, altri elementi di provenienza e postille 7.5.1. Note di possesso, provenienza, omaggio, etc. 7.5.2. A l t r i elementi relativi alla provenienza e ai possessori 7.5.3. Postille e altre annotazioni manoscritte 7.5.4. Inserti
7.6. Note sullo stato di conservazione e sul restauro 7.7. Informazioni suUa disponibdità e dati amministrativi o gestionali
Entro questo schema si è preferito , almeno fino ad oggi, l imitars i a indicazioni molto sintetiche ed esemplificative (6 pagine scarse sulle
Biblioteche d'autore in biblioteca: una catalogazione speciale? 57
374 della bozza complessiva d i febbraio 2008, quindi meno del 2 % del totale). Sarà opportuno ampliare questo capitolo? Se ne può discutere, naturalmente, ma almeno per l ' immediato ci è sembrato opportuno > he questo capitolo rimanesse entro dimensioni molto contenute, con una funzione d i orientamento generale. Svilupparlo fino alle dimensioni necessarie per costituire una guida esauriente per i l catalogatore alle prese con la casistica effettiva — insomma al livello d i efficacia operativa a cui abbiamo puntato nelle altre p a r t i del codice - sarebbe mfatt i u n impegno lungo e gravoso, data la varietà dei problemi che si mcontrano nella pratica. U n lavoro che sarebbe megho affrontare separatamente, con tutte le necessarie competenze e con ampio respiro.
Entro questi l i m i t i , però, i l capitolo dedicato dalle nuove norme alle informazioni sull'esemplare cerca d i fare alcune cose a mio avviso miportant i , che speriamo aprano una riflessione su varie questioni.
I n pr imo luogo, costituisce un primo tentativo d i r icondurre a un trattamento unitario e strutturare i l complesso degli elementi e delle mformazioni pertinenti alla sfera dell'esemplare (comprese le indicazioni relative a var iant i e ristampe non oggetto d i descrizione separata) . Queste in formazion i , i n f a t t i , sono state fino ad oggi viste i n maniera del tutto slegata. Si può r icordare, per esempio, che anche i n un progetto organico e d i alto respiro come quello dell 'Indice del Ser-\izio bibliotecario nazionale le informazioni sull'esemplare sono state strutturate secondo tre logiche di f ferent i , a seconda che si t r a t t i d i monografie moderne, d i monografie antiche o d i periodici , con complicazioni e l imitazioni che forse si potevano evitare adottando fin dal principio un approccio generalizzato.
I n secondo luogo, questo capitolo si propone d i mostrare, i n concreto, la pervasività d i questa problematica, non l imitata alle pubb l i cazioni antiche o d i pregio, ma pertinente a tutto i l materiale descritto nel catalogo.
I n terzo luogo, si è tentato d i ricondurre a unità, o riconcdiare, per cpianto possibde, tradizioni e usi molto differenti, a seconda dei periodi , dei materiali o delle funzioni: per esempio, come si sa, la descrizione d'esemplare nella catalogazione degli incunaboli differisce per tant i aspetti da quella usuale per le cinquecentine (o per i l l ibro antico dei secoh successivi), ed entrambe hanno attualmente poco i n comune con quella del materiale moderno d i pregio (soprattutto novecentesco), i n particolare riguardo alla terminologia e all 'ordine delle informazioni.
58 Alberto Petrucciani
Si è cercato infine, per quanto possibile, d i disporre e presentare le informazioni sull'esemplare tenendo presente per analogia (o almeno per evitare le dissonanze più stridenti) lo sviluppo delle informazioni descrittive sulla pubblicazione, ossia delle aree ed elementi del l ' ISBD.
Molto lavoro, naturalmente, resta da fare, ma ci auguriamo che questo breve capitolo possa costituire una buona base d i partenza.
Numerose sono le questioni specifiche sulle quali sarebbe utUe soffermarsi , a part i re , per esempio, dall 'ordine delle informazioni e dalla maniera d i presentarle, molto variabifi nelle diverse tradizioni e nell'uso (anche perché le buone ragioni, d i sohto, non stanno tutte dalla stessa parte). Meglio indicare i var i elementi a part ire dall'esterno del l ibro e procedendo verso l ' interno , o viceversa? Le indicazioni d i possesso e provenienza è meglio fornirle i n ordine 'topografico' (nell 'ordine delle p a r t i i n cui compaiono) o cronologico (considerando che, i n molt i casi, elementi relat ivi a un singolo possessore possono comparire i n punt i diversi)? Arr ivando alla singola informazione, è preferibile scrivere «Dedica dell'autore sul frontespizio» (prima 'cosa?', poi 'dove?') oppure «Sul frontespizio t imbro del Convento...» (prima 'dove?', poi 'cosa?')?
Se le informazioni relative alla provenienza e ai precedenti possessori sono oggi quelle che richiamano i l maggiore interesse, non dimentichiamo a l t r i campi (ciascuno dei quali è un intero continente...) come la decorazione (che dalla miniatura arr iva a tant i esemplari particolari del X I X e X X secolo) o la legatura (anche questa non solo antica), e anche tutto ciò che può riguardare l 'uso, la lettura . Anche q u i , si spazia dalle postdle del Poliziano alle stelline a pennarello colorato d i Elsa Morante, senza dimenticare le semplici (e deprecate) orecchiette alle pagine e l ' informazione (pure per a l t r i aspetti deprecabile) che i fogh sono ancora chiusi, non tagl iati , e quindi i l l ibro non può essere stato letto. Non trascuriamo, inol tre , gli insert i , d i ogni genere: lettere, r i t a g l i , foglietti d i appunt i , bozze d i stampa, ma anche fotografie, conti d'albergo, fiori seccati...
Non vanno dimenticate, infine, le informazioni sulla conservazione e l'eventuale restauro, non solo come notizie d'interesse interno. Questo genere d i informazioni ci ricorda due cose a cui vorrei ancora accennare.
Pr imo , che anche i n questo caso (come per i possessori, le provenienze, ecc.) è concettualmente infondata e praticamente dannosa ogni discr iminazione verso elementi 'non a n t i c h i ' o ' n o n i m p o r t a n t i ' : vogliamo poter studiare anche i restauri d i cinquanta o venti anni fa e
Biblioteche d'autore in biblioteca: una catalogazione speciale? 59
non solo quel l i settecenteschi o ottocenteschi, e chi stabilisce che i l fijaior Rossi che ha apposto la sua firma nel X X secolo sia da trascurare non essendo Montale) e Hfrater Franciscus non meglio specificato d i
tìne Quattrocento no? Le norme avvertono, i n particolare, d i non t r a --<"urare annotazioni e segni non decifrati o obliterati (che a l t r i potranno magari decifrare o identificare), le informazioni connesse (per esempio niunerazioni o segnature precedenti), fonti esterne pertinenti (per esempio per gli acquisti i n antiquariato) e quanto riguarda lo stesso istituto fwjssessore (per esempioi suoi t i m b r i non più i n uso).
Secondo, le informazioni relative alla conservazione e al restauro ma non solo quelle!) sono informazioni per loro natura non 'statiche':
ìesemplare con legatura danneggiata descritto qualche anno fa può •essere ora un esemplare restaurato, con legatura originale distaccata e nìnservata a parte. Ino l t re , com'è ovvio, la descrizione per i l catalogo •^ivo' d i una biblioteca è sempre u n work in progress, che dipende tiallo sviluppo delle conoscenze e dalle attività che l ' i s t i tuto riesce a realizzare.
La rapida (e incompleta) ricognizione degli ambit i più significativi tra le informazioni relative all'esemplare suscita immediatamente una domanda: 'a quale hvel lo ' , queste informazioni?
Gh esempi inseriti nel cap. 7 delle norme presentano informazioni i n forma sintetica, ma più o meno sommarie a seconda dei casi. A l p r inc i pio del paragrafo su provenienza e possessori troviamo, per esempio, •lue esempi d i livello diverso:
Dedica dell'autore.
Dedica dell'autore a Elsa Morante, Roma, 24 maggio '70.
Personalmente ritengo che non abbia molta importanza (oltre ad «^sere difficilmente praticabile i n u n codice d i catalogazione) fissare 'liveUi' i n generale, mentre d i solito si dovrà farlo per un singolo pro -Xf-tto (con finahtà e tempi precisi). La coesistenza d i descrizioni a diversi EveUi d i dettaglio non costituisce, nei cataloghi elettronici d i oggi, un problema. Dubito che convenga impegolarsi i n discussioni su quale sia i l livello più appropriato a un catalogo generale (o a un catalogo collettivo! rispetto al catalogo d i un singolo fondo, a un catalogo a stampa, iUe schede del catalogo d i una mostra, ecc.
I
60 Alberto Petrucciani
Da l punto d i vista del l 'utente ogni informazione è benvenuta, quando c 'è, e non è quindi i l caso, a mio parere, d i tagliare informazioni comunque prodotte o rilevate, anche se per a l t r i scopi. Se una descrizione d'esemplare r isulta più dettagliata d i a l tre , meglio: nessuno è obbligato a leggerla, e tantomeno a leggerla per intero. E inevitabile, d 'a l tra parte , che nella maggior parte dei casi sia sommaria, o anche, purtroppo , che manchi del tutto .
E inevitabUe, del resto, anche il rischio che i n una certa percentuale dei casi (piccola) l ' informazione sia errata o imprecisa: l 'utente che fa ricerca deve, per forza d i cose, utilizzare font i catalografiche prodotte nell 'arco d i v a r i secoli ( i l patrimonio d i molte biblioteche storiche i ta liane, come si sa, è ancora i n gran parte descritto i n cataloghi settecenteschi o del primo Ottocento), qu ind i con norme diverse (o senza...), a livello diverso d i dettaglio, con variabilissime competenze (o incompetenze).
Aggiungerei solo che le informazioni relative all'esemplare, contrariamente a quanto talvolta si sente d i re i , devono certamente figurare anche nei cataloghi collettivi . I l fatto che riguardino un singolo esemplare (e non l ' intera edizione), in fa t t i , non è affatto un buon motivo per obbligare gli utenti a ricercarle solo i n cataloghi singoli, uno alla volta, con enorme spreco d i tempo e d i energie. Farle confluire i n cataloghi collett ivi non è solo più comodo, ma anche più stimolante, perché sappiamo che i l i b r i amano viaggiare, e a volte evadere, e quindi si trovano spesso molto lontano da dove 'dovrebbero' essere conservati.
Torniamo, per concludere, al punto d i partenza: Biblioteche d'autore in biblioteca: una catalogazione speciale? 'Speciale' è tut ta la catalogazione, i n quanto affronta sempre un singolo oggetto che ha una sua specialità. Ma è meglio evitare d i parlare d i catalogazione 'speciale' se questo porta , come ha portato , alla proliferazione d i inutUi variazioni nelle norme o nelle prassi (mentre lo spirito d i standardizzazione e cooperazione è un valore centrale i n questo campo), o a pro cedere a compartimenti stagni t r a i diversi materiaU o generi d i pubb l i cazioni.
Una catalogazione 'speciale', qu ind i , semplicemente nel senso dell'esigenza d i rendere conto d i - cioè rflevare, descrivere, organizzare, mettere a disposizione - ogni elemento significativo che i l materiale comporta o evidenzia, dentro un quadro d i pr inc ip i organici e d i norme unitarie e fl più possibile uni formi. «Da ciascun l ibro al suo utente» (tra-
Biblioteche d'autore in biblioteca: una catalogazione speciale? 61
mite la catalogazione), «da ciascun utente al suo libro» (tramite d catalogo), parafrasando un po ' le leggi d i Ranganathan.
Nel catalogo, inteso 'a tutto tondo ' , ci sono sempre due finalità fondamentali, i l ritrovamento d i un particolare l ibro già noto e cercato (compito imprescindibde ma anche l imitato e oggi, nella maggior parte dei casi, facile da svolgere) e l ' individuazione d i tutto i l materiale che risponde a un particolare interesse d i ricerca. Questa seconda finalità è per sua natura non solo molto più complessa della pr ima , ma pr iva d i l i m i t i , ossia delimitata solo dall ' importanza che riconosciamo a certi interessi d i ricerca (per gli autor i , per gli argomenti, per i dat i t ipogra-fico-editoriafi nel caso almeno del materiale antico, ecc.) e dalla capacità di allestire gli strumenti necessari a soddisfarli. Le informazioni relative all'esemplare sono sicuramente un campo d i pr imario interesse a cui i cataloghi (e la catalogazione) dovranno dedicare molta più attenzione d i quanto non sia avvenuto fino ad oggi.
Antologia
Quadrimestrale Nuova serie - a. X I V , n. 41-42 maggio-dicembre 2008
Collezioni speciali del Novecento Le biblioteche d'autore
Atti della Giornata di studio Firenze, Palazzo Strozzi, 21 maggio 2008
Premessa G L O R I A M A N C H E T T I pag. 3
Saluti PAOLO C O C C H I
Assessore alla Cultura Turismo e Commercio della Regione Toscana » 5 ANTONIA IDA FONTANA
Direttrice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze » 9
MAURO G U E R R I N I
Presidente dell'Associazione Italiana BibUoteche » 13
Esemplari postillati di biblioteche d'autore L A U R A D E S I D E R I » 17
Biblioteche d'autore in biblioteca: dall'acquisizione alla valorizzazione GIULIANA ZACRA » 37
Biblioteche d'autore in biblioteca: una catalogazione speciale? A L B E R T O P E T R U C C I A N I » 49
Dai libri alle carte: la gestione dei materiali «anfibi» ANNA MANFRON » 63
Le biblioteche d'autore nel Censimento dei fondi librari della Regione Toscana: tipologie e localizzazioni PAOLA R I C C I A R D I , C E C I L I A CALABRI » 75
Le biblioteche d'autore nelle raccolte e nel catalogo del Sistema Documentario Interbibliotecario dell'Area Fiorentina (SDIAF) MARCO PINZANI pag. 107
La valorizzazione delle raccolte dello SDIAF dal catalogo cumulato al catalogo integrato e personalizzato L U C A BROGIONI » 111
Raccolte private in una biblioteca di ricerca SANDRA D I MAJO » 119
Per una rete delle biblioteche d'autore a Roma F U L V I O S T A C C H E T T I » 131
Verso una mappa delle biblioteche d'autore? Tavola rotonda con LuiSA F I N O C C H I , MASSIMO C A N E L L A , E L I S A B E T T A F O R T E , ROSARIA CAMPIONI » 137
Appendice 155