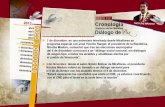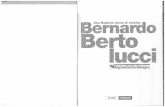CAMBIAMENTI NELL’ARCHITETTURA GIAPPONESE TRA OTTO-NOVECENTO: ORIENTE E OCCIDENTE A DIALOGO
Il dialogo tra le istituzioni della memoria e la città. Convegno "Biblioteche in cerca di alleati",...
Transcript of Il dialogo tra le istituzioni della memoria e la città. Convegno "Biblioteche in cerca di alleati",...
Il dialogo
tra le
istituzioni
della
memoria
e la città
MAURIZIOVIVARELLI
Dipartimento di Studi storici
Università di Torino
Sala Bramante, venerdì 15 marzo 2013. Biblioteche, archivi, musei: la convergenza possibile
M.C. Escher, Galleria di stampe, 1956 (particolare)
ITALO CALVINO, Le città invisibili, 1972
«Il Gran Kan possiede un atlante
in cui sono raccolte le mappe di
tutte le città: quelle che elevano le
loro mura su salde fondamenta,
quelle che caddero in rovina e
furono inghiottite dalla sabbia,
quelle che esisteranno un giorno e
a cui ancora non s’aprono che le
tane delle lepri […]. Il catalogo
delle forme è sterminato: finché ogni
forma non avrà trovato la sua
città, nuove città continueranno a
nascere».
In cerca del «catalogo»
In copertina: RENÉ MAGRITTE, Il castello dei Pirenei, 1959
La funzione di biblioteche, archivi, musei per la realizzazione di questo
«catalogo» sta attraversando un periodo di crisi, per numerosi motivi
di natura:
economica e finanziaria;
politica, normativa, istituzionale;
organizzativa;
disciplinare, che investe cioè il livello dei princìpi, delle
metodologie, delle procedure;
comunicativa, connessa alle relazioni tra modelli documentari
classici e configurazione del web;
sociale, che riguardano le modalità di utilizzo da parte delle
persone delle informazioni documentarie;
formativa, che investe i percorsi di costruzione delle
‘professionalità’ in ambito bibliotecario, archivistico, museale.
Elementi di contesto
Elementi di contesto
In questo scenario è stato formalmente costituito il 12 giugno del
2011, da parte di AIB, ANAI, ICOM, il MAB Italia che, tra l’altro:
1. si propone come strumento di rappresentanza delle istanze dei
professionisti degli istituti culturali;
2. promuove il coordinamento culturale, tecnico-scientifico e
organizzativo delle attività degli operatori di archivi, biblioteche,
musei
5. propone programmi e appronta strumenti per la crescita e il
rafforzamento degli istituti culturali esistenti e la promozione di
nuove iniziative;
8. effettua studi e ricerche;
11. svolge ogni altra attività che si renda necessaria per la
realizzazione dei fi ni individuati nel presente atto costitutivo.
Atto costitutivo di MAB Italia, http://www.mab-italia.org/index.php/musei-archivi-biblioteche/mab-italia
L’organizzazione delle memorie culturali in ambiente
digitale implica in ogni caso un ripensamento profondo
delle tre tradizioni disciplinari, definitesi entro paradigmi
pre-digitali.
L’organizzazione delle relazioni tra le rappresentazioni
digitali degli oggetti documentari costituisce forse il
principale problema teorico ed applicativo.
Il rischio principale è quello di confondere i dati ed i
metadati con gli oggetti del mondo fisico, e soprattutto con
i rispettivi contesti interpretativi.
Da ciò consegue il rischio di realizzare un ambiente
documentario frammentario, in cui i dati non sempre
riescono a qualificarsi come informazioni.
Elementi di contesto
Giordano Bruno, 1582
Il tema della connessione e della
universalità del sapere è stato uno
degli elementi fondanti della
riflessione filosofica del Cinquecento,
e si radica in una nuova
interpretazione delle tradizionali arti
della memoria, fondate sulla teorie
dei loci.
Giordano Bruno modifica ed innova i
concetti di luogo e di immagine, che,
non più statici, devono invece
esprimere le relazioni che correlano
le diverse tipologie di informazioni.
‘Relazioni’ e arti della memoria
GIORDANO BRUNO, Ars memoriae, in: De umbris idearum, 1582, http://giordanobruno.filosofia.sns.it/index.php?id=939
In seguito al graduale definirsi dei «campi» disciplinari, per
motivi diversi, e connessi anche alle politiche accademiche, i
ricercatori/contadini (P. Burke, Storia sociale della
conoscenza, 2002) si sono preoccupati di difenderne con
determinazione i «confini».
L’interesse della comunità scientifica si è dunque orientato
più a discutere e motivare le differenze tra i «campi» che a
prendere in esame gli elementi comuni.
Ciò vale per le diverse relazioni in linea teorica individuabili
tra metodi e pratiche disciplinari di archivi e biblioteche,
archivi e musei, biblioteche e musei, musei ed archivi.
La nascita delle ‘discipline’
1794-1928. Archivistica Tra 1794: la Convenzione francese afferma il principio della «pubblicità»
degli archivi e 1928: EUGENIO CASANOVA sistematizza il campo disciplinare
nel suo trattato Archivistica.
1808-1839. Biblioteconomia 1808-29: MARTIN SCHRETTINGER, Versuch eines vollständigen Lehrbuches der
Bibliothek-Wissenschaft ; 1834: Handbuch der Bibliothek-Wissenschaft: nasce la
«scienza della biblioteca», tradotta con ‘bibliothéconomie’ da Léopold
Auguste Constantin Hesse nel 1839.
1948. Museologia 1948: si costituisce l’ICOM. International Council of Museums, che, oltre la
tradizione museografica settecentesca, definisce la museologia come la
scienza applicata che si occupa del museo come istituzione permanente
che acquisisce, conserva e comunica le testimonianze materiali ed
immateriali dell’umanità per studio, educazione e diletto.
I «campi» delle discipline della memoria
Sul piano scientifico ciò suggerisce il rafforzamento di una linea
di riflessione sulla matrice storica comune che le attuali
istituzioni della memoria condividono.
La stessa costituzione del MAB può far ipotizzare l’utilità di
una maggiore integrazione tra biblioteche, archivi e musei.
Sul piano professionale, in maniera pragmatica, va valutato di
volta in volta quale livello di collaborazione garantisca i risultati
migliori ai soggetti partecipanti.
I due livelli (scientifico e professionale) si intrecciano
indissolubilmente quando si prendono in esame le questioni
connesse al trasferimento delle memorie culturali in ambiente
digitale.
Verso nuove forme di integrazione
Per questo può essere utile esaminare con attenzione
alcune delle relazioni istituite, o istituibili, tra:
Archivi e biblioteche;
Biblioteche e musei;
Archivi e musei;
Archivi e biblioteche e musei.
In questo modo può essere possibile valutare meglio
le opportunità derivanti dall’approfondimento di temi
e questioni comuni.
Verso nuove forme di integrazione
Archivi e biblioteche
Centro Internazionale di Studi Primo Levi, Torino
http://www.primolevi.it/
Istoreto, Torino. Fondo Bruno Vasari
http://metarchivi.istoreto.it/
Il concetto di ‘collezione’
In questo ambito possono
essere messi in evidenza temi
comuni i connessi a:
ordinamento nei musei e
classificazione nelle
biblioteche;
allestimento nei musei e
presentazione dell’offerta
documentaria nelle
biblioteche.
Biblioteche e musei
LORENZO LOTTO, Ritratto di Andrea Odoni,1527
GEORGES PEREC, Brevi note sull’arte e
il modo di riordinare i propri libri,
1985
per ordine alfabetico
per continente o paese
per colore
per data di acquisizione
per formato
per genere
per grandi periodi letterari
per lingua
per priorità di lettura
per rilegatura
per collana
Interpretare lo spazio Il tema della valutazione della percezione,
interpretazione ed uso dello spazio da parte
degli utenti è importante e scarsamente
studiato, o almeno studiato con intensità
diversa nelle diverse aree disciplinari.
Biblioteche e musei
Biblioteca San Giorgio, Pistoia
Palazzo Madama, Torino
Installazione di Robert Wilson, 20012
Questo tema può costituire un
proficuo punto di incrocio tra le
esperienze di studio a matrice
museologica e quelle che
riguardano invece la valutazione
dell’uso dello ‘spazio bibliografico’
delle biblioteche.
Lo spazio dell’archivio
«Il pittore, che si accinge a fare un quadro,
non potrebbe dire se al primo suo bozzetto
sarà per corrispondere in ogni parte l’opera
finita; ma il soggetto, i principali personaggi,
l’espressione e l’atteggiamento e le vesti
loro, e molte altre cose, le sa prima di
portare i colori dalla tavolozza alla tela […]
Applicando l’esempio, dirò che quando
pensai l’Archivio Centrale dello Stato […]
ebbi però chiarissimo il concetto […] di un
edifizio, in cui dargli sede […] pensai che
l’ordine delle sale avrebbe conferito all’ordine
dei documenti». (F. Bonaini, 1864).
Archivi e musei
L’Archivio Centrale di Stato di Firenze.
Lettera del prof. Francesco Bonaini al
direttore del giornale fiorentino “La
Nazione”, 20 dicembre 1864, Firenze,
Cellini, 1864.
Cit. tratta da Diana Toccafondi, Archivi,
retorica e filologia […], 2002,
http://www.archiviodistato.firenze.it/nu
ovosito/fileadmin/template/allegati_me
dia/libri/150_Archivi_Storia/150_Tocca
fondi.pdf.
Nell’immagine una prospettiva dei depositi dell’Archivio di Stato di Firenze agli Uffizi, http://www.archivi.beniculturali.it/
Lux in arcana
Mostra di documenti dell’Archivio Segreto Vaticano
Archivi e musei
http://www.luxinarcana.org
Portali tematici del SAN. Sistema archivistico nazionale
Archivi della moda del Novecento
Archivi e musei
http://www.moda.san.beniculturali.it/wordpress/
Livelli di integrazione personale: Museo Galileo (1)
territoriale: MuseoTorino (2)
universale: World DigitalLibrary (3)
Archivi e biblioteche e musei
http://www.wdl.org/en/http://www.museotorino.it/
http://www.museogalileo.it/
1
2 3
MiBAC, 2007 e 2013
Convegno: La convergenza tra archivi, biblioteche e musei e
l'interoperabilità, Roma 2007
Rossella Caffo, La convergenza tra archivi, biblioteche e musei e
l'interoperabilità. Iniziative concrete: CulturaItalia, MICHAEL,
MINERVAeC (http://eprints.rclis.org/3808/1/caffo.pdf).
Convegno: Il catalogo nazionale dei beni culturali, Roma 2013
Programma(http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/150/news/
134/convegno-il-catalogo-nazionale-dei-beni-culturali-roma-16-e-
17-gennaio-2013-complesso-del-san-michele-a-ripa-sala-dello-
stenditoio).
SIGECweb, Sistema Informativo GEnerale del Catalogo
(http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-
informativo-generale-del-catalogo-sigec).
IFLA, 2008
ALEXANDRAYARROW, BARBARA CLUBB and JENNIFER-LYNN
DRAPER for the Public Libraries Section Standing Committee,
Public Libraries, Archives and Museums: Trends in Collaboration
and Cooperation (2008) (International Federation of Library
Associations and Institutions. IFLA Professional Reports, No.
108).
Conclusioni:
«Libraries, archives and museums must respond to these
challenges by similarly defying physical boundaries: finding
new ways to deliver information to the public, collaborating
to preserve and digitise heritage information, and
pursuing new joint-use facilities».
IFLA, 2008
Ambiti di collaborazione:
Condivisione di informazioni;
Metodologie per la conoscenza del contesto;
Esperienze di programmazione e progettazione, in particolare
per quanto riguarda:
Co-localizzazione;
Co-gestione;
Attività di comunicazione e di marketing dei servizi;
Integrazione di risorse documentarie eterogenee;
Analisi dell’uso dello spazio documentario;
Attività di formazione ed aggiornamento professionale.
OCLC, 2011-2012
KAREN SMITH-YOSHIMURA - CYNDI SHEIN, Social Metadata for Libraries,
Archives and Museums. Part 1: Site Reviews; Part II Survey Analysis; Parte
III Recommendations and Readings, Dublin (Ohio), OCLC Research,
2011-2012.
«Single-organization sites […] tend to serve a specific niche
audience. They may not attract much traffic, but what they do
attract may suffice for the site’s purposes. However, niche sites are
also vulnerable to staff leaving and the burdens of maintaining the
site. The more vibrant sites (with lots of user-contributed content)
tend to be national or multi-institutional based, or serve a specific
discipline. A critical mass and sense of community - whether existing or
created - generates more user contributions and more outreach to new
communities. Sites that have a community or national “brand”
attract contribution and traffic». (Part I, p. 10-11).
Lavori in corso: Montelupo Fiorentino
L’Amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino ha
maturato la volontà di co-localizzare, negli spazi attualmente
occupati dal solo Museo della Ceramica, la biblioteca comunale
(Centro Nautilus) e l’Archivio storico.
I motivi della scelta, connessi anche a difficoltà di ordine
finanziario, hanno tuttavia indotto l’Amministrazione verso un
ridisegno radicale delle identità delle istituzioni coinvolte.
Per raggiungere questo obiettivo si è operato:
costituendo un gruppo di lavoro locale;
affidando un incarico ad un gruppo esterno costituito da
esperti di biblioteconomia e di museologia.
La conclusione del primo stralcio progettuale è prevista per il
prossimo mese di settembre.
Lavori in corso: Montelupo Fiorentino
Alcune immagini dell’edificio che ospita
attualmente il Museo della Ceramica e,
a sinistra, due ambienti interni.
Luoghi comuni della memoria
Per concludere
Negli archivi, nelle biblioteche, nei musei si situano e si
ordinano gli oggetti documentari cui è affidata la
conservazione e la comunicazione della memoria culturale.
Le rappresentazioni di questi oggetti, le relazioni tra questi
oggetti, le relazioni tra le rappresentazioni di questi oggetti
sono complesse: «Il catalogo delle forme è sterminato», come
ha scritto nelle Città invisibili Italo Calvino.
Archivi, biblioteche, musei, meglio se collaborando, possono
tuttavia rendere visibili i molti linguaggi con cui il catalogo è
scritto, sottrarli all’oblio, ed insegnare a comprenderli.
In questo modo archivi, biblioteche, musei, hanno creato, e
continueranno a creare in futuro, luoghi comuni della memoria.