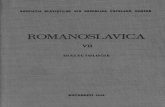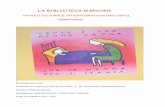'STUDI CULTURALI' (2015) Etnografia, studi visuali e metodi visuali in criminologia: Un dialogo con...
Transcript of 'STUDI CULTURALI' (2015) Etnografia, studi visuali e metodi visuali in criminologia: Un dialogo con...
Il Mulino - Rivisteweb
Luigi Gariglio
Etnografia, studi visuali e metodi visuali in crim-inologia. Un dialogo con Eamonn Carrabine eRonnie Lippens sulla criminologia visuale(doi: 10.1405/79446)
Studi culturali (ISSN 1824-369X)Fascicolo 1, aprile 2015
Ente di afferenza:Consorzio Bess (bess)
Copyright c© by Societa editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it
Licenza d’usoL’articolo e messo a disposizione dell’utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senzascopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamenteprevisto dalla licenza d’uso Rivisteweb, e fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimentiutilizzare l’articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.
— 101 —
STUDI CULTURALI - ANNO XII, N. 1, AprIle 2015
Etnografia, studi visuali e metodi visuali in criminologia
Un dialogo con Eamonn Carrabine e Ronnie Lippens sulla criminologia visuale
di Luigi Gariglio
intErvista
l’etnografia si appoggia sempre più spesso ai metodi visuali, e questa tendenza sembra acquistare una pregnanza particolare proprio in alcune istituzioni, relativa-mente invisibili, della nostra cultura come il carcere, cui si sono dedicate non solo l’etnografia di taglio socio-antropologico, ma anche discipline più «di intervento» come la criminologia. In questo triplice dialogo, il lettore potrà accostarsi allo sviluppo della così detta «visual criminology» [criminologia visuale] attraverso la discussione dei seminari inclusi nella serie Visual Criminology: Crime, Criminal Justice, and the Image animata da ronnie lippens ed eamonn Carrabine1. Se, per chi scrive, questi seminari hanno rappresentato, in generale, l’occasione per un confronto interdisciplinare con alcuni dei protagonisti di un ambito di ricerca ancora largamente assente nel dibattito italiano, nello specifico essi hanno offerto l’opportunità di raccogliere dalla viva voce di due dei principali protagonisti della criminologia visuale alcune riflessioni sulle più fertili questioni teorico-definitorie che la nascita di tale sotto-campo di studi sta portando con sé, e, allo stesso tem-po, sulle più spinose questioni aperte da tale sviluppo, consentendo di risalire dalla criminologia visuale sino ad un ripensamento della ricerca sociale visuale più latamente intesa.
1 eamonn Carrabine della University of essex e ronnie lippens della Keele University sono stati tra i curatori e i relatori di questa serie di sei seminari. l’elenco completo dei curatori comprende anche: Chris Greer della City University london, Yvonne Jewkes della University of leicester e, infine, Tony Kearon, anch’egli della Keele University. Gli incontri si sono tenuti nel periodo compreso tra l’inizio del 2013 e la fine del 2014. essi si sono svolti in quattro sedi accademiche inglesi e hanno coinvolto e fatto dialogare tra loro criminologi, sociologi, antropologi, filosofi, storici, documentaristi, giornalisti e fotogra-fi. le decine d’interventi inclusi in questa prima serie di seminari e la loro prossima pubblicazione in un volume in progettazione rappresentano certamente una linea emergente di ricerca internazionale che fa parte del cosiddetto visual turn e che si caratterizza per la sua interdisciplinarità e per l’ibridazione che introduce tra le pratiche accademiche e le pratiche artistiche e /o documentarie. Si veda anche il sito: http://visualcriminology.com.
lUIGI GArIGlIO
— 102 —
Il visual turn nelle scienze sociali, oggigiorno, non rappresenta certo più una novità (Sassatelli 2011). le origini dei visual research methods e degli studi visuali2, infatti, risalgono entrambi agli anni sessanta. In quegli anni, da un lato, i metodi di ricerca visuali cominciarono ad entrare nella cassetta degli attrezzi delle scienze sociali e, dall’altro, la cultura visuale cominció a diventare un og-getto d’analisi rilevante in alcuni campi disciplinari appartenenti sia agli studi umanistici sia alle scienze sociali. Quello che da qualche anno è descritto ex post – o piuttosto che è stato costituito ex novo – con il nome di visual social research (pauwels 2012) (d’ora in poi VSr) è un «contenitore» che comprende sia 1) i metodi di ricerca visuali sul campo, sia 2) gli studi visuali. Si può sostenere, parafrasando rose (2012, 10), che malgrado il tempo trascorso da quei lontani anni sessanta, a tutt’oggi, c’è ancora poco dialogo tra chi all’interno delle scienze sociali adotta i metodi visuali sul campo e chi, invece, studia la cultura visuale (Hughes 2012). Una delle principali ragioni sottostante la mancanza di dialogo cui si è appena accennato può essere riconducibile alle origini della VSr. la VSr, infatti, fu costruita come un unico campo all’interno del quale furono aggregati, o confluirono, i due insiemi di pratiche di ricerca che hanno avuto fin dalle origini ben poche occasioni di contatto reciproco. Due insiemi, peraltro, già articolati ciascuno al proprio interno e che hanno attribuito alle immagini, e alla cultura visuale più in generale, ruoli ben distinti. Infatti, se, da un lato, le immagini e la cultura visuale furono e sono l’oggetto centrale delle ricerche degli studi visuali, dall’altro, i metodi visuali di ricerca sul campo consideravano e considerano le immagini soprattutto come uno strumento adeguato per rispondere a specifiche domande cognitive. le domande cognitive nel campo dei metodi visuali di ricerca, poi, spesso esulano del tutto dai temi centrali della cultura visuale (rose 2012), attenendo piuttosto ai temi «tradizionali» della ricerca qualitativa3.
l’origine della prima pratica, quella dei visual research methods, risale com’è noto alla fine dell’Ottocento (Gariglio 2010)4. Tuttavia, il testo cruciale, quello che introdusse alcuni dei metodi visuali «contemporanei» fu pubblicato a metá degli anni Sassanta (Collier e Collier 1967). Visual Antrolopogy: Photography as a Research Method5 fu, infatti, il primo manuale che mise a tema l’uso della foto-grafia come strumento di ricerca nelle scienze sociali (Wagner 1979). pubblicato
2 Mitchell (2002, 166) propone una utile distinzione tra visual studies e visual culture, dove i primi «sono la disciplina che studia la visual culture».
3 È utile ricordare con Banks (2001) che l’adozione del termine «visual» in visual research methods rischia di far sovrastimare la rilevanza degli aspetti visuali. In effetti, come spiega pink (2007, 21), «i me-todi di ricerca visuali non sono metodi esclusivamente visuali, piuttosto sono metodi che prestano una particolare attenzione alla componente visuale della cultura».
4 A tal proposito lippens (infra; si veda anche Gariglio 2010) ricorda che «da un certo punto di vista la pratica etnografica è sempre stata, almeno in parte, visuale. Ci sono sempre “metodi visuali” nel lavoro etnografico».
5 Si tenga conto che la fotostimolo era giá stata oggetto un articolo di taglio antropologico-visuale nella rivista American Anthropologist (si veda Collier 1957).
UN DIAlOGO CON CArrABINe e lIppeNS SUllA CrIMINOlOGIA VISUAle
— 103 —
grazie alla collaborazione tra un antropologo e un fotografo, esso ebbe un ruolo rilevante proponendo, tra l’altro, una mappa articolata delle principali pratiche di ricerca e contribuendo così alla costituzione del nascente campo dei metodi di ricerca visuali. In Visual Antrolopogy, tuttavia, non fu prestata molta cura a con-testualizzare i metodi e le pratiche di ricerca presentate all’interno di una cornice interpretativa articolata. Al contrario, persino l’approccio teorico alla fotografia fu piuttosto modesto: la fotografia infatti in quel testo fu considerata soprattutto una traccia indicale della «realtà»; questo, d’altro canto, era l’approccio mainstream di allora alla fotografia. Ciò nonostante, il contributo di Collier e Collier fu rilevante. Benché datato, Visual Anthrolopogy rimane per certi aspetti un manuale di riferi-mento ancora capace di influenzare gli sviluppi futuri della disciplina.
l’origine della seconda pratica di ricerca, gli studi visuali, è invece fatta risalire, da autori o autrici diversi, a periodi distinti. Wagner (2001, 50) la fa risalire agli anni Sessanta. I più concordano, tuttavia, che la storia dell’arte, la semiotica, la psicoanalisi, i media studies, i gender studies e i cultural studies abbiano contribuito in modo rilevante a strutturare il nascente campo degli studi visuali (rose 2012; Sturken e Cartwright 2009)6. Cultura visuale che parafrasando Mitchell (2002) si potrebbe definire come l’insieme dei testi, delle pratiche, delle interazioni, delle azioni, delle condotte e delle emozioni che contribuiscono alla costruzione visuale del sociale e/o alla costruzione sociale della visione.
pur non sottovalutando le origini lontane della Visual social reseach appena tratteggiate, molti studiosi e studiose hanno messo in luce che negli ultimi quin-dici anni si è registrato un significativo incremento della letteratura specialistica. Sarah pink nella sua introduzione ad Advances in Visual Methodologies (2012, 3) richiama ben quattro importanti volumi dell’ultimo quindicennio: Visual Me-thods in Social Research (Banks 2001), Doing Visual Ethnography (pink 2001; 2007), Visual Methodologies (rose 2000; 2010; 2012) e The Handbook of Visual Analysis (Van leeuwen e Jewitt 2001). Tale sviluppo, tutt’altro che casuale, è stato anche influenzato dai processi di mutamento del sistema dei media e dalle nuove pratiche di consumo e di produzione mediale tra cui si possono ricordare: 1) la popolarizzazione dell’evoluzione tecnologica dei dispositivi cross mediali di pro-duzione e di ritocco delle immagini (Gariglio 2007); 2) il diffondersi delle nuove pratiche di condivisione delle immagini online, caratterizzate da diversi gradi d’interattività e di privacy (dagli mms ai blogs) e, infine, 3) la recente diffusione dell’uso dei social network, delle video chiamate, e delle pratiche di consumo online. In questo contesto in rapido mutamento, gli studi visuali hanno cercato,
6 Com’è noto, uno dei primi contributi rilevanti fu Way of seeing (Berger 1972, si vedano anche Sassatelli 2011; Demaria e Sassatelli 2013; Sturken e Cartwright 2009; Mirzoeff 2009; Mitchell 2002). Ori-ginariamente un programma divulgativo della BBC, fu trasformato successivamente in un libro in cui l’autore affronta, in modi da più parti contestati, alcuni temi ancor’oggi centrali negli studi visuali, ed in particolare i codici di genere.
lUIGI GArIGlIO
— 104 —
e a volte sono stati capaci, di tenere il passo soprattutto per ciò che riguarda: lo studio delle pratiche d’interazione online, l’analisi dei testi visuali sul web e lo sviluppo di metodi «più» partecipativi (pink 2012a; pauwels 2015). Tuttavia, il rapido sviluppo quantitativamente significativo di questi approcci è stato solo in parte il volano di nuove pratiche di ricerca propriamente interdisciplinari e ha piuttosto contribuito al costituirsi di specialismi autoreferenziali (in parte iso-lati) che spesso sono stati incapaci di tessere relazioni persino con le contigue discipline dei media studies e dei photographic studies (Tagg 1988; Sekula 1989; Wells 2003) da una parte, e con la storia dell’arte e l’iconografia, dall’altra. Da un lato, la sociologia e l’antropologia mainstream sono state solo occasionalmente interessate all’integrazione delle «nuove» pratiche di ricerca visuali, considerate per lo più ancillari all’interno dei propri confini disciplinari. Dall’altro, la VSr nel suo complesso non ha sempre prestato un’adeguata attenzione alla letteratura mainstream «non visuale».
riconoscendone l’espansione e articolazione, un’autrice centrale negli studi visuali come Gillian rose (2012) pone anch’essa l’accento sulla rigida comparti-mentalizzazione e sulla scarsa comunicazione tra le due componenti principali della VSr: gli studi visuali e i visual research methods. Una compartimentaliz-zazione che peraltro all’interno di ciascuno dei due campi è tagliata da confini disciplinari – nel campo dei visual research methods, ad esempio, è da sempre esistita e tuttora esiste una netta separazione tra la sociologia visuale e l’antro-pologia visuale. Un altro aspetto rilevante di cui rose dà conto è la necessità che le studiose e gli studiosi della VSr, «prenda[no] le immagini seriamente» (ivi, 16; si veda anche Banks 2014). In un saggio recente sempre rose (2014) pone l’accento su aspetti centrali. In primo luogo, la superficialità di una parte della ricerca sociale che adotterebbe le immagini più per essere adeguata alle nuove esigenze di carattere comunicativo che non, invece, per esigenze di carattere euristico-metodologico. per essere benevoli, potremmo dire con rose che «i tanti modi con cui sono adoperate le immagini [da parte dei ricercatori] della ‘Visual research Methods’ sembrano riprodurre i molti modi con cui le immagini sono utilizzate nella cultura visuale contemporanea» (rose 2014, 39-40). In secondo luogo, l’esigenza, o l’opportunità, di considerare gli stessi risultati di ricerca otte-nuti adottando i VrS come uno dei prodotti della visual culture contemporanea. Sarebbe certamente di non poco interesse, segnala rose, un lavoro che mettes-se sotto la lente d’ingradimento con la prospettiva degli studi visuali i prodotti della ricerca dei visual research methods. Sarebbe poi almeno altrettanto utile, a mio avviso, l’adozione consapevole e competente di metodi di ricerca visuale da parte di chi studia la visual culture contemporanea. l’analisi critica proposta da rose rispetto alla compartimentalizzazione e alla scarsa comunicazione tra le due componenti principali della VSr è del tutto condivisibile. Tuttavia, l’autrice in quello che oggi è il manuale più diffuso sulle metodologie visuali (rose 2012)
UN DIAlOGO CON CArrABINe e lIppeNS SUllA CrIMINOlOGIA VISUAle
— 105 —
non riesce a muoversi pienamente nella direzione del suo superamento, in parte per la distinzione (e/o confusione) che sembra proporre tra fare ed analizzare cultura visiva7.
A tutt’oggi, quindi, possiamo sostenere che la struttura del campo della VSr non è mutata, quanto meno significativamente, rispetto alle origini. Solo pochi anni fa pauwels (2011) proponendo una griglia analitica8 che descriveva i tratti essenziali della VSr, e che questa introduzione ha implicitamente adottato, sug-geriva una distinzione al suo interno – già messa in luce agli albori della svolta visuale, da Images of Information (Wagner 1979). Da un lato, i visual studies, un insieme di ricerche che avrebbero per oggetto lo studio delle rappresentazioni visuali disponibili; dall’altro, le ricerche caratterizzate, invece, dalla produzione o selezione di rappresentazioni visuali etnografiche realizzate dal ricercatore o ricercatrice (o da essi sollecitate) nel corso della ricerca sul campo al fine di pro-durre dati. Tale ricostruzione presenta una mappa che descrive le caratteristiche rilevanti di ciascuna area e che mette in luce le tensioni e le affinità possibili tra i metodi visuali e la visual culture. Molte sono state le proposte di griglie di let-tura degli studi/metodi visuali. Quella di pauwels (2011) mi sembra, a tutt’oggi, quella che meglio articola la relazione tra visual studies e visual research me-thods – questione centrale per il dialogo che andremo presto a scoprire. Il noto diagramma proposto da rose (2012, 43), come suggerisce la stessa autrice, può essere molto utile come strumento per orientarsi all’interno del campo degli studi visuali, mentre sembra lasciare diverse zone d’ombra per quanto riguarda una mappa comprensiva della VSr; tale diagramma infatti scompone ed articola gli studi visuali in diversi approcci teorici, proponendo al lettore un possibile uti-lizzo di ciascuna prospettiva. I metodi visuali però non sono trattati con analoga attenzione, ma sono invece descritti come un campo omogeneo di carattere prevalentemente «tecnico» (il nome di questo campo trae in inganno). Nel dia-gramma, i metodi visuali non vengono scomposti nei principali approcci che li caratterizzano, né, di conseguenza, vengono esplicitati i diversi tipi di contributo che ciascun approccio potrebbe fornire.
Nel longevo campo della VSr appena tratteggiato, la criminologia visuale.
è una delle novità più recenti e di fatto quasi sconosciuta in Italia. Si tratta di un approccio ancora emergente, molto frammentato al suo interno, come per altro
7 Scrive, ad esempio, che la fotostimolo consisterebbe nel richiedere ai soggetti studiati di produrre delle immagini che poi successivamente diventerebbero l’oggetto di una intervista con il ricercatore o con la ricercatrice (298). In effetti, la prima parte della tecnica che rose descrive come fotostimolo è da quasi tutta la letteratura metodologica considerata una tecnica a sè (e definita in diversi modi, ad es: photo voice, produzione soggettiva o percezione soggettiva); inoltre, la forostimolo può essere realizzata con qualunque tipo di immagine, indipendentemente dall’autore o autrice della stessa (si veda Gariglio 2010; si veda anche pauwels 2015, pp, 96-99).
8 l’integrated framework di pauwels emerge dall’intrecciarsi di tre dimensioni: l’origine e la natura del materiale empirico visuale; il disegno della ricerca; e i diversi tipi di restituzione.
lUIGI GArIGlIO
— 106 —
accade nella VSr più in generale. Ma anche di un campo in forte crescita per il numero delle studiose e degli studiosi che ne condividono e/o adottano, in modi più o meno critici, gli approcci teorici, gli apparati concettuali e i metodi. la criminologia visuale si è inserita e si inserisce trasversalmente all’interno dei campi disciplinari preesistenti, incontrando il favore di alcuni gruppi di studiosi e studiose e le resistenze di altri e altre, proprio come era già accaduto alcuni decenni prima nella sociologia e nell’antropologia quando al loro interno cominciarono a emergere delle cerchie ristrette di autori che mostravano nuove sensibilità per il visuale. Tuttavia, nel dialogo che qui si introduce, eamonn Carrabine si dichiara ottimista sugli sviluppi e il consolidamento futuro della criminologia visuale. le ragioni di quest’ottimismo poggiano su alcune caratteristiche della criminologia visuale a cui si farà cenno al termine di questa introduzione. Come sottolinea Carrabine, le decine d’interventi inclusi nella serie di seminari Visual Criminology: Crime, Criminal Justice, and the Image, infatti, hanno permesso di «mettere in contatto studiosi, artisti, professionisti e fotografi che stavano già lavorando sul visuale». Ora che la serie si è conclusa, si può intravedere il nucleo della nascente «disciplina». Certamente, questa diffusa sensibilità per il visuale supera di molto la cerchia delle autrici e autori che hanno partecipato direttamente all’iniziativa. Mary Bosworth del Centre for Criminology dell’Università di Oxford, solo per proporre un esempio, ha mostrato da anni una costante attenzione per il visuale nella sua pratica di ricerca etnografica all’interno dei centri di identificazione ed espulsione inglesi (Bosworth 2014), e nella sua direzione della rivista Theoretical Criminology. Quest’ultima ha dedicato proprio recentemente un numero speciale alla visual criminology (Brown e Carrabine 2014)9.
l’esperienza della criminologia visuale – che inizialmente si è concentrata su forme di rappresentazione già circolanti nella cultura, e più recentemente si sta orientando anche verso la produzione diretta delle immagini (da parte sia dei ricercatori e delle ricercatrici che dei loro soggetti, con l’uso, per esempio, di foto stimolo, in Schept 2014; si veda anche Gariglio 2014) – risulta certamente rilevante sia per la VSr in specifico, sia, più in generale, per le scienze sociali, gli studi umanistici e gli studi culturali. lo può essere per diverse ragioni. Innanzitutto, come suggerito e come spiega lippens nel dialogo che andremo presto a leggere, fare interagire tra loro, creando una piattaforma aperta al dibattito interdiscipli-nare, sia discipline contigue (quali ad esempio la sociologia, l’antropologia e la
9 Mary Bosworth, inoltre, ha progettato e coordina il blog Border Criminology molto attento alla criminologia visuale, sia per il dibattito che ha sviluppato sui metodi visuali e sulle rappresentazioni visuali (http://bordercriminologies.law.ox.ac.uk/?s=visual&submit=Search), sia per i contenuti di ricerca e le forme di restituzione che spesso pubblica nei suoi post. Infatti, benché non tutti i post di Border Criminology siano costruiti con immagini adeguate ai testi di ricerca proposti, e talvolta svolgano principalmente una funzione illustrativa, nella maggior parte dei casi si tratta comunque di immagini etnografiche, fotografie documentarie o immagini giornalistiche che hanno una funzione centrale nel senso dell’articolo, proprio come le parole o, meglio, insieme ad esse.
UN DIAlOGO CON CArrABINe e lIppeNS SUllA CrIMINOlOGIA VISUAle
— 107 —
criminologia) sia pratiche fino ad ora più distanti (quali il documentario, la teoria fotografica, la storia dell’arte e i metodi visuali di ricerca sul campo). Un’altra ra-gione si può individuare nel fatto che la criminologia visuale è il prodotto della convergente attenzione per i metodi visuali e/o per la visual culture sia dei più noti e note criminologists e prison sociologists contemporanei (soprattutto di area anglofona), sia delle principali riviste criminologiche mainstream (per esempio Punishment and Society, The British Journal of Criminology e Theoretical Cri-minology, Crime Media & Culture) che ospitano con sempre più frequente perio-dicità importanti contributi teorici e di ricerca in questo campo. la criminologia visuale, inoltre, sembra in grado di offrire una spinta di carattere teorico ad una disciplina come la criminologia caratterizzata più tipicamente (se si esclude la cultural criminology, si veda Hayward e presdee 2010 e la criminologia critica, si veda Walter et al. 2012) – da approcci applicativi e normativi. In particolare la visual criminology ha introdotto una nuova sensibilità per gli aspetti di carattere culturale e rappresentazional/comunicativo della ricerca sociale. e questo, sia riattualizzando il classico dibattito sullo «scrivere le culture», sia – come sottolinea lippens nel dialogo – introducendo una nuova attenzione (ma si vedano i lavori dell’antropologa Sarak pink) alle dimensioni sensoriali di Simmeliana memoria. Infine, la criminologia visuale assume particolare rilevanza per gli studi culturali in generale per la centralità che attribuisce alle questioni etiche nella pratica della ricerca, e questo in continuità con l’importanza che simili riflessioni hanno da sempre avuto per gli studiosi e le studiose visuali (da etnografi/e, fotografi/e, documentaristi/e) (si veda Carrabine 2012).
LG: Dopo quella che è stata definita la svolta visiva, e nel contesto degli sviluppi più recenti della criminologia, potreste illustrare cos’è per voi la crimi-nologia visuale?
EC: Io considero la criminologia visuale un approccio che si sviluppa a parti-re dalla sociologia visuale e che mette a fuoco le stesse questioni già affrontate da alcuni dei padri fondatori di quella disciplina. Mi riferisco, tra gli altri, a Howard Becker, Douglas Harper, pierre Bourdieu ed erving Goffman; tutti autori già noti. Ciò che caratterizza la visual criminology è però il focus sulle rappresentazioni [visuali] dei delitti e delle pene10. Inoltre, tenendo conto del ruolo predominante giocato dalle immagini nella descrizione sia dei crimini sia delle risposte istitu-zionali agli stessi, non si comprende come mai in criminologia il visual turn sia un fenomeno così recente.
10 «Crime and punishment» è anche una nota rivista che ha avuto un ruolo nell’introduzione del visuale nella criminologia mainstream.
lUIGI GArIGlIO
— 108 —
RL: Questa è una domanda fondamentale. In generale la criminologia visua-le, dal mio punto di vista, può essere considerata come una rassegna di domande [vedi risposta rl alla domanda quattro] sull’importanza, o meglio sull’utilità, del visuale nel tentativo di acquisire un senso più profondo – uso la parola «senso» invece che comprensione – di quei fenomeni e di quelle esperienze che talvolta sono rubricati con i termini: «crimine», «devianza», «danno», o «legge» eccetera.
LG: Qual è lo specifico della serie di sei seminari intitolati «Visual crimino-logy seminar series»? Si è trattato di una serie di eventi rilevanti, che ha coinvolto più di cinquanta soggetti attivi tra studiosi e operatori della comunicazione e documentaristi, da cui probabilmente è emerso un «filo rosso», o proposte che in qualche modo caratterizzano una sub-disciplina emergente …
RL: Quando ideammo questa serie di seminari, avevamo in mente alcune domande. Tuttavia, c’erano anche altri interessi sullo sfondo. Due dei quali po-trebbero essere descritti nel modo seguente: primo, ci accorgemmo, e non fummo i soli, che le prospettive post-strutturaliste e il linguistic turn degli anni ottanta e novanta – benché qualcuno possa negarlo – ebbero un serio impatto sulla ricerca accademica. Il linguaggio, in altri termini, cominciò a essere visto con sospetto e a non essere più considerato del tutto adeguato e sufficiente a produrre descri-zioni delle esperienze e della vita quotidiana. Mi accorsi che i dibattiti attorno al linguaggio potevano essere un fertile campo da esplorare. Questo è il motivo per cui un certo numero di noi studiosi della disciplina che normalmente è nota con l’etichetta criminologia divenimmo all’improvviso interessati ai sensi, al mondo sensibile. In quegli anni, infatti, alcuni di noi hanno cominciato a credere che attraverso un uso più consapevole dei sensi fosse possibile un accesso più diretto e articolato alle esperienze soggettive e alla vita quotidiana dei soggetti in studio. Il focus sul visuale fu il modo in cui si realizzò, di fatto, questo cambio di direzione metodologico. Certamente quella adottata non fu l’unica opzione allora disponibile. Si sarebbero potute utilizzare esclusivamente registrazioni audio oppure – perché no? – adottare un approccio sinestetico.
Il tema appena trattato è strettamente in relazione con il secondo [a cui accenno ora]. Tutti i nostri seminari hanno incluso i lavori e i contributi di artisti, fotografi e documentaristi. A dire il vero, tutti [e sei] i seminari sono stati introdotti dalla presentazione di un lavoro di un artista, di un fotografo o di un documen-tarista o da una sua lecture. In questo modo abbiamo cercato di superare gli steccati tra i discorsi e le pratiche accademiche [delle scienze sociali e degli studi umanistici], da un lato, e i discorsi e le pratiche degli operatori [artisti, fotografi e documentaristi], dall’altro. Torniamo per un attimo indietro agli anni ottanta e novanta; se quegli anni ebbero un qualche tipo d’impatto sugli studi umanistici e
UN DIAlOGO CON CArrABINe e lIppeNS SUllA CrIMINOlOGIA VISUAle
— 109 —
le scienze sociali, quel impatto fu che oggi molti di noi sono del tutto consapevoli dell’arbitrarietà dei confini che esistono tra quei due campi.
EC: lo scopo di questi seminari è stato davvero quello di mettere in contatto studiosi, artisti, professionisti e fotografi che stavano già lavorando sul visuale [visual matters] per porci la domanda: dove porterà tutto ciò? la questione è appassionante perché [il visuale] è un campo abbastanza nuovo in criminologia e, malgrado ciò, sembra che stia ottenendo un ampio consenso. Sembra proprio che sia arrivato il momento giusto per occuparsene.
LG: ritornando alla genesi della criminologia visuale, possiamo ripercorrerne la storia nei punti che appaiono più salienti per il presente degli studi visuali?
RL: A seconda della definizione [di criminologia visuale] adottata, la rispo-sta a questa domanda potrebbe cambiare. Si potrebbe citare il panopticon di Foucault – benché ovviamente Foucault avrebbe rifiutato con forza l’etichetta criminologia – e si potrebbe sostenere che lui fu tra i primi autori negli ultimi decenni a occuparsi di questioni inerenti alla criminologia visuale. Ciò detto, si dovette aspettare fino agli anni novanta prima di vedere emergere i primi segnali. A dire il vero, i lavori che hanno indagato le rappresentazioni mediali e i media dal punto di vista della criminologia esistono da molti più anni. Tuttavia, per un’attenzione alle dimensioni visuali si è dovuto attendere fino agli inizi degli anni novanta. Il lavoro di studiose e studiosi del calibro di Alison Young, ad esempio, ebbe un ruolo centrale nell’aprire nuovi percorsi di ricerca. Dagli anni Duemila, circa, la visual criminology ebbe uno rapido sviluppo. Mi ricordo che cominciai ad interessarmi alla dimensione del crimine e della giustizia penale, o più in generale ai processi di regolazione e di governance, più o meno in quegli stessi anni. All’inizio degli anni Duemila fu fondata la rivista Crime Media & Cul-ture [2005] e da allora il numero di studiosi che lavorano sugli aspetti culturali, inclusa la cultura visuale, ha cominciato a crescere in modo quasi esponenziale. Sto usando la parola «cultura» in modo consapevole; infatti, si deve sottolineare che solo alcuni tra i «cultural criminologists» mostrarono davvero interesse per la visual culture.
EC: posso elencare di seguito alcune pubblicazioni rilevanti. la prima fu un numero speciale della rivista Punishment and Society, che credo dati attorno al 2004, curato da ronnie lippens (rl) e da Claire Valier [vedi (Valier e lippens 2004)]. Quella pubblicazione mise a tema per la prima volta l’esistenza di un certo numero di criminologi interessati ad osservare le immagini in modo serio. Facendo riferimento al mio lavoro [eamonn Carrabine], ricordo che rimasi molto colpito dallo scandalo di Abu Graib e, come molti altri, fui spinto a cercare un
lUIGI GArIGlIO
— 110 —
modo adeguato per trovare un senso rispetto a ciò che «succedeva» in quelle note immagini. proprio nella preparazione dell’articolo che pubblicai su quelle imma-gini [vedi (Carrabine 2011)] presi coscienza molto in fretta dell’esistenza di una ampia letteratura che studiava «il visuale» [in altre discipline] da cui c’era ancora molto da imparare. Tuttavia, non credo che sia necessario che si sviluppi una prospettiva omogenea e unitaria nella criminologia visuale e spero, al contrario, che i seminari forniscano un luogo nel quale possano generarsi scambi proficui e ibridazioni [tra le diverse discipline].
LG: potete identificare a grandi linee quali sono i temi centrali di quella che ormai viene definita Visual Criminology?
EC: Questa è una domanda fondamentale. Quali sono I temi centrali? Non credo di poter fornire una lista precisa di temi fondamentali; credo, piuttosto, che l’introduzione delle immagini nelle nostre ricerche debba essere lo stimolo che ci sproni a ragionare attorno al perché si sia deciso di introdurre le immagini e ai criteri con le quali le si adoperano. Questo è un punto che Allan Sekula, tra i primi, ha enfatizzato con forza. egli ha infatti messo in luce la necessità di prestare attenzione all’uso delle immagini affinché non sia limitato all’uso delle immagini come illustrazioni. le immagini sono testi complessi e si deve tenere conto anche della complessità del processo comunicativo attraverso cui le im-magini comunicano ciò che rappresentano. Il tema centrale affrontato da Sekula mette in guardia contro la spettacolarizzazione della storia. In particolare contro il pericolo che gli eventi possano o meno diventare importanti in base alla esistenza o meno della possibilità che vengano fotografati. la trasformazione della storia in uno spettacolo d’intrattenimento produrrebbe una comprensione del passato, aggiunge Sekula, davvero molto parziale.
Inoltre, esiste una numerosità tale di modi con cui le immagini possono essere utilizzate dagli scienziati sociali che questa stessa numerosità presenta sia vantaggi che svantaggi. Si va dalle analisi delle immagini disponibili, popolari o d’élite, alla produzione d’immagini da parte dei ricercatori [...].
In altri termini, la distinzione qui è tra un’interpretazione dettagliata di un aspetto della cultura visuale [disponibile] e gli usi dei metodi visuali nella ricerca sociale, quali la fotostimolo, l’etnografia virtuale, le mappe, i diari, i video e altri tipi di metodi collaborativi adottati per produrre documentari. per alcune per-sone questi mix eclettici di metodi possono, senza dubbio, essere divisi in due campi: da un lato, l’interpretazione delle immagini [già esistenti] e, dall’altro, la loro produzione sul campo. Questa dicotomia potrebbe poi essere ricondotta alla distinzione tra teoria e metodo.
UN DIAlOGO CON CArrABINe e lIppeNS SUllA CrIMINOlOGIA VISUAle
— 111 —
RL: Cercando di essere un po’ più concreti, e concentrando la nostra at-tenzione su un solo aspetto del visuale, ad esempio le immagini, credo che la criminologia visuale riguardi, approssimativamente, un certo numero di questioni tra cui: le immagini possono essere utilizzate o avere una agency come strumenti di accusa o di criminalizzazione? Si pensi a fumetto o ad altri lavori artistici che criticano, quando addirittura non criminalizzano certe persone, gruppi o problemi sociali. Come, fino a che punto e perché avviene così spesso che certe immagini, e il contesto in cui emergono, sono loro stessi criminalizzati? Come e fino a che punto le immagini «devianti» circolano attraverso lo spazio e nel tempo? Natu-ralmente, ci sono una dimensione storica e una geografica che influiscono sui processi di criminalizzazione delle immagini «devianti» o «criminali». Se adesso ci focalizzassimo su un particolare ambiente o area geografica, ci si potrebbe porre domande del tipo: perché e fino a che punto certi spazi sono condannati a essere «devianti» o «criminali» e le immagini di quei luoghi hanno un ruolo in questo processo di criminalizzazione? prendiamo un’immagine. Ad esempio, un dipinto. In che modo e fino a che punto quel dipinto può dirci qualcosa della vita in generale o, in particolare, della precarietà della vita o di quella «problematica»? In altre parole, può il visibile o possono le immagini fornirci informazioni sulle condizioni di vita [degli esseri umani]? Adesso consideriamo un’immagine che sia stata definita come «deviante» o «criminale» o «dannosa». Ci si potrebbe chie-dere: Com’è stato possibile, e com’è successo che, primo, questa immagine sia comparsa, e, secondo, che essa e/o il suo produttore o la produttrice, siano stati fatti bersaglio da parte di questo o di quel gruppo di pressione? Se passassimo adesso a occuparci, diciamo, del contrasto al crimine o della giustizia penale, emergerebbero nuovi interrogativi. Ad esempio, quali sono il ruolo e l’importanza [o meno] del visuale nel contrasto al crimine e nella giustizia penale?
In che modo le pratiche di contrasto al crimine e quelle della giustizia penale si appoggiano o fanno uso del visuale? e quelle pratiche di contrasto al crimine e giustizia penale potrebbero a loro volta essere visualizzate in immagini che potrebbero poi successivamente essere l’oggetto di ulteriori ricerche.
Fino a qui mi sono occupato in particolare d’immagini ma adesso devo pre-cisare che il visuale non è solo costituito da immagini. Si pensi solo allo sguardo panottico di Bentham e Foucault, alle pratiche di sorveglianza, eccetera.
LG: Qual è, o quali sono, a vostro parere i principali limiti e mancanze o le aree di maggior sviluppo di questa nuova sub-disciplina o campo interdisci-plinare?
RL: Non la chiamerei una nuova disciplina poiché non esiste nessun framework metodologico unico e coerente che guidi la criminologia visuale. per fortuna non c’è!
lUIGI GArIGlIO
— 112 —
A questo proposito, intendo precisare: primo, un punto che dovrebbe ap-parire ovvio, e cioè che una fotografia è una cosa diversa rispetto ad un video, un’istallazione, un dipinto, un documentario, un libro di fumetti o la percezione visuale che tutti conosciamo attraverso i nostri sensi quando camminiamo in un certo quartiere, e così via. Dal punto di vista metodologico, tutti quelli appena accennati sono specifici differenti [different beasts] e di ciò si deve tener conto adeguatamente.
Ma nel risponderti, intendevo anche qualcosa di più generale, o di più fondamentale, se preferisci. Il visuale, o le immagini, non si lasciano facilmente imbrigliare da specifici approcci metodologici. le immagini, per esempio, si potrebbe dire – come hanno già detto molti teorici e filosofi – sono intrinseca-mente multidisciplinari. Adesso, prendiamo in considerazione un certo dipinto; consideriamo ad esempio The Third of May di Goya (1808). Quel dipinto cer-tamente non contiene tutti i possibili significati immaginabili che gli sono stati attribuiti. Intendo dire che, probabilmente, ci possono essere ambiti disciplinari che facendo riferimento ad una data immagine ne costruiscono il significato. Ma, pure all’interno di quegli stessi ambiti disciplinari, molte cose diverse potrebbe-ro essere dette a proposito di quel dipinto, e molto di ciò che poi viene detto potrebbe talvolta sembrare contraddittorio. In altre parole nella descrizione di un dipinto sarebbero incluse sia l’esperienza dell’autore della descrizione sia la sua attribuzione di senso. le immagini infatti sono perfettamente in grado di trattenere significati contraddittori al proprio interno (e molto del resto dipende dall’interpretazione degli spettatori).
Tornando alla tua domanda relativa ai gap nella criminologia visuale; che dire? Ce ne saranno tantissimi, immagino. Infatti, se pensi un attimo all’elenco di domande che ti ho proposto come risposta a una tua precedente domanda, ti renderai immediatamente conto che tutte le mie domande erano costruite a partire dalla cornice interpretativa della criminologia. Quelle domande, se si esula dagli aspetti visuali, sarebbero domande che tutti i criminologi, almeno di tanto in tanto, potrebbero prendere in considerazione.
Il punto rilevante, allora, è un nuovo insieme di domande: che cosa succede-rebbe se invece della criminologia utilizzassimo il frame cognitivo, per esempio, dalla teoria dell’arte, o dalla storia dell’arte? O dall’estetica? A quel punto, ancora una volta, tutta una nuova serie di domande sorgere spontanea...
EC: Non sono sicuro che l’interesse nella rappresentazione visuale dei delitti e delle pene si configuri oggi come una nuova disciplina. Non c’è dubbio che si consoliderà con il tempo, ma è ancora troppo presto per dire quali siano i gap e che caratteristiche abbiano.
UN DIAlOGO CON CArrABINe e lIppeNS SUllA CrIMINOlOGIA VISUAle
— 113 —
LG: Secondo voi, qual è la risposta accademica allo sviluppo della cri-minologia visuale? Vediamolo sia facendo riferimento alla sociologia, che alla criminologia ...
RL: la criminologia comprende una vasta area d’interessi e di studiosi e non ci sarebbe da stupirsi se alcuni criminologi contestassero la rilevanza della crimi-nologia visuale. Ad esempio, chi fosse interessato alla prevenzione del crimine potrebbe farsi una domanda circa l’utilità della criminologia visuale, appunto per la prevenzione. Come accade di tanto in tanto, ho appena avuto un dialogo con il mio collega, Tony Kearon, che mi ha mostrato quanto alcuni urbanisti già siano molto interessati agli effetti che produce la presenza delle immagini negli spazi pubblici; in particolare, rispetto alla produzione di un’atmosfera, del senso di disagio, o addirittura della paura. Sarebbero poi anche interessati nella capacità delle immagini di generare rabbia, e alttre sensazioni, negli astanti. Oggigiorno, la maggior parte delle persone è consapevole di quanto detto e ciascuno lo vive nella propria esperienza quotidiana.
Dovrebbe quindi essere chiaro a tutte e a tutti che le questioni di carattere visuale sono, o dovrebbero essere, questioni molto rilevanti anche per chi sia interessato al contrasto al crimine. In alcune comunità accademiche, ad esempio in architettura e in urbanistica, il visuale è già un oggetto di ricerca. Nelle politiche di riqualificazione urbana (ad esempio delle città post-industriali), infatti, molta attenzione è prestata alla natura, alla forma, e al luogo in cui innestare i progetti di «arte pubblica». Ciò avviene non solo per ragioni di carattere estetico, ma anche tenendo conto dell’impatto potenziale che quelle opere potrebbero avere sulle esperienze e sui comportamenti [dei cittadini e delle cittadine].
A dire il vero, alcune di queste questioni sono già anche state al centro dei nostri seminari. Uno degli speaker, Nathan Moore, ha pubblicato lavori impor-tanti sul modo in cui, nella nostra epoca, le regole siano più frequentemente comunicate attraverso le icone o le immagini iconiche piuttosto che attraverso le parole.
Che dire, infine, a proposito del futuro della visual criminology? Mi aspetto che cresca abbastanza rapidamente. Da un lato ci sono storici dell’arte e altri stu-diosi degli studi umanistici che, in un’epoca che diviene sempre più caratterizzata da pragmatismo e da condotte di carattere strumentale, sono assillati dalle richieste di applicare le proprie idee e prospettive teoriche a questioni pratiche tra cui: la criminalità, il contrasto al crimine, e la giustizia penale. Dall’altro, ci saranno sempre più criminologi, molti dei quali si distinguono per l’approccio pragmatico ai problemi che li caratterizza, che si scontreranno con i limiti del linguaggio nei loro tentativi di affrontare, o addirittura risolvere, i problemi sociali.
lUIGI GArIGlIO
— 114 —
EC: È difficile a dirsi; io lo posso solo intuire attraverso i feedback del pub-blico durante i miei seminari nei dipartimenti di criminologia e di sociologia. Il più delle volte la risposta è stata piuttosto positiva, anche se, di tanto in tanto, spunta la domanda: «ma questa è sociologia?» . Questa domanda restituisce il significato che le immagini avrebbero per molti dei luminari della sociologia del XX secolo e non è difficile da commentare.
LG: Cosa pensate dell’introduzione dei metodi visuali nel campo etnografico? Ci sono alcuni documentari sulle carceri o «prison ethnographies» che abbiano adottato i metodi visuali con risultati davvero nuovi, e cosa ci possono dire del futuro della visual criminology e del suo rapporto con (sub)discipline limitrofe?
EC: È importante porre l’accento sul fatto che i metodi visuali erano presenti quasi dall’inizio, sia tra i sociologi che tra gli antropologi, ma che passarono poi in disuso poiché tacciati di soggettività, non sistematicità ed eccentricità rispetto ad altri approcci metodologici. Come ha ben spiegato Howard Becker: «I sociologi persero il loro interesse nell’uso della fotografia quando spostarono la loro atten-zione dalle riforme sociali alla generalizzabilità dei risultati empirici» . Da allora pochissime immagini fotografiche hanno illustrato gli articoli e le pubblicazioni sociologiche. Infatti, benchè originariamente le prime pubblicazioni del American Journal of Sociology includevano immagini in modo routinario, la pubblicazione s’interruppe all’improvviso all’inizio del XX secolo [vedi Stasz 1979].
parallelamente, anche gli antropologi lamentavano che i loro colleghi pro-ducessero fotografie che non differissero da quelle che i turisti scattavano nei paesi esotici di villeggiatura e che, inoltre, tali fotografie non avessero una fun-zione diversa da quella delle immagini prodotte dai fotoamatori. Solo molti anni dopo è stato riconosciuto [anche dagli scienziati sociali] che studiare una società equivalesse, in un certo senso, a scrivere una storia su di essa. Fu il periodo in cui il dibattito su scrivere le culture fece da volano per la messa in primo piano delle questioni dell’autenticità, della riflessività e del «dar voce» [ai soggetti] che caratterizzano da allora il lavoro dell’etnografia. Tutto ciò fece da volano verso una maggiore attenzione alla soggettività e alla sperimentazione nella pratica etnografica. Quindi l’etnografia non solo cominciò a [ri]diventare più visuale, ma divenne anche virtuale, attenta alle questioni di genere, multisituata, intima, in-corporata e più di recente multisensoriale, come ha scritto Sarah pink a proposito di Internet. per terminare, io direi quindi che i metodi visuali abitano il campo etnografico ormai da diverso tempo.
per quanto riguarda invece le carceri, una delle cose che mi colpisce, è la numerosità dei fotografi contemporanei che lavorano nelle carceri producendo modi di vedere [una citazione implicita di John Berger (1972)] la vita nelle istitu-zioni [carcerarie] freschi e di grande interesse.
UN DIAlOGO CON CArrABINe e lIppeNS SUllA CrIMINOlOGIA VISUAle
— 115 —
È chiaro che il tema è in rapido sviluppo; il sito web e blog prisonphotogra-phy11 elenca circa 120 professionisti .... Il tema di uno dei miei prossimi articoli sarà proprio come la prigione sia stata rappresentata nelle pratiche documentarie. per esempio, il tuo lavoro fotografico pubblicato con il titolo di Portraits in Prisons (Visser e Vroege, a cura di, 2007) si è molto concentrato sui ritratti, mentre altri lavori fotografici – come ad esempio quello del fotografo edmund Clark – hanno esplorato l’esperienza dell’invecchiamento in prigione attraverso «nature morte» senza la presenza umana. Da una parte le fotografie offrono uno sguardo intimo che mostra come gli spazi disumanizzanti della detenzione sono riappropriati dai detenuti, dall’altra, l’assenza degli abitanti stessi narra della vita anonima che i detenuti conducono dentro le istituzioni detentive12.
RL: da un certo punto di vista la pratica etnografica è sempre stata, almeno in parte, visuale. Ci sono sempre «metodi visuali» nel lavoro etnografico. Molti dei primi antropologi culturali ad esempio non riuscirono mai a resistere alla tenta-zione di includere fotografie nei loro lavori. In un certo senso, I metodi visuali dovrebbero essere naturali per gli etnografi. Una delle ragioni si riallaccia a cose dette in precedenza, ad esempio il bisogno dei ricercatori di accedere all’esperien-za. Questo è un aspetto che dovrebbe interessare gli etnografi. Alcuni ricercatori in criminologia – ma forse non gli etnografi – lavorano già da molto tempo con il materiale visuale (per esempio sulle immagini delle architetture degli edifici pe-nitenziari). Il lavoro di Michael Fiddler potrebbe essere citato a questo proposito. Altri studiano i prodotti artistici realizzati dai detenuti (c’è persino una fondazione dedicata a quegli oggetti artistici: the Arthur Koestler Trust). e così via.
Io incoraggerei fortemente gli etnografi delle prigioni ad adottare strumenti visuali. la differenza tra ciò che si potrebbe chiamare «prison ethnography» da un lato e, dall’altro, il «prison documentary» è stata oggetto di discussione durante il seminario e personalmente sono d’accordo con il cuore del tuo paper per la nostra serie di seminari [cfr. Gariglio 2014]: come tutte le etnografie, la «visual prison ethnography» ha molto a che fare con la possibilità e i vincoli di accesso al campo. essa dovrebbe voler permettere di cogliere il senso dell’esperienza soggettiva – per esempio, l’esperienza dell’essere un detenuto in una certa pri-gione. È chiaro che il visuale può fornire molti indizi in merito ad una simile
11 Si veda il sito: www.prisonphotography.org.12 Mi permetto alcuni riferimenti al progetto fotografico citato. Portraits in prisons, pensato e poi
curato (Visser e Vroege 2007) per una mostra presso lo Stedelijk Museum di Amsterdam, è uno dei frutti del lavoro decennale di documentazione fotografica che ho progettato e svolto visitando, per periodi di tempo variabili tra una settimana e un mese, un grande numero di istituti carcerari situati in sette paesi europei. Il lavoro è stato un tentativo di restituire una rappresentazione meno stigmatizzante e più empatica degli ospiti che sono reclusi in simili istituzioni. Ho cercato di farlo costruendo dei ritratti in posa, realiz-zati all’interno degli istituti in cui lo sfondo neutro a trame e colori variabili avesse la funzione simbolica liberatoria per i reclusi. Così facendo ho anche voluto mettere a tema le ampie possibilità che la fotografia offre agli autori di «costruire la realtà» che rappresentano.
lUIGI GArIGlIO
— 116 —
esperienza. e qui arriviamo al punto: fintantoché i significati di quelle esperienze provengono, per quanto filtrati attraverso l’attività riflessiva del ricercatore, dagli stessi detenuti [attraverso la fotstimolo o photovoice] staremo facendo etnografia. Al contrario, benchè anche una «prison documentary» sia costituita da materiale visuale, in quest’ultimo caso è l’autore che racconta la sua storia. È l’autore, cioè, che costruisce il filo narrativo in modo assai più scoperto e auto-riferito, e che decide quale materiale debba essere incluso nel documentario e quale viceversa rimanere escluso … Immaginiamo però per un attimo che il regista all’improvviso smetta di filmare e, invece, dia il dispositivo tecnico agli stessi detenuti. In quel caso, quel gesto, cambierebbe la situazione (si veda anche pauwels 2015).
LG: le metodologie visuali confinano spesso con il lavoro documentaristi-co. C’è dal vostro punto di vista una qualche differenza cruciale tra produrre un documentario sul carcere e fare etnografia usando anche i metodi visuali?
EC: Non direi, ma non c’è dubbio che si possano fare delle distinzioni partendo dalla considerazione che alcuni fotografi documentari aspirano ad appartenere a specifici «art worlds» [citando implicitamente Becker], mentre gli etnografi aspirano al linguaggio della scienza, qualunque cosa si voglia intendere. Ciò che conta è che in ogni caso la fotografia, intesa come medium, è da sempre stata adottata in tutte e due campi.
RL: Come ho già detto. la differenza cruciale tra un documentario e un’et-nografia visuale sembra potersi identificare nel luogo o nelle diverse soggettività da cui originano i significati. Naturalmente sono consapevole che la questione non è affatto così semplice. Infatti, anche nella visual ethnography più «delicata», prodotta ad esempio in una mensa della polizia, o in un’aula di un tribunale, la produzione dei significati non sarebbe attribuibile esclusivamente ai soli detenuti coinvolti nella produzione della narrazione visuale. Il fatto stesso che un etnografo o una etnografa si trovi nel campo in un certo momento, dicendo e facendo le cose che dice e che fa, introdurrà certamente una perturbazione che influirà sui risultati dell’esperimento etnografico. Un po’ dell’esperienza di «com’è la vita in carcere» sarà visibile nel risultato filmico, ma moltissima parte di quell’esperienza resterà invisibile. Non perché i detenuti in particolare possono essere tacciati di essere selettivi, ma in quanto tutti quanti lo siamo sempre. A ben vedere, la ragione più importante di questa criticità sta forse proprio nel fatto stesso che si sia chiesto a dei detenuti di diventare etnografi, senza tenere conto delle loro vite e delle loro esperienze di vita e di quanto tutto ciò potesse incidere sulle loro narrazioni.
UN DIAlOGO CON CArrABINe e lIppeNS SUllA CrIMINOlOGIA VISUAle
— 117 —
Ringraziamenti
Vorrei ringraziare Mary Bosworth e il Centre for Criminology dell’Università di Oxford, per l’accoglienza ricevuta nel corso dell’intero 2014. Senza tale lunga permanenza e i continui e proficui scambi che ne sono seguiti, questo contributo non avrebbe visto la luce. Vorrei anche ringraziare eamonn Carrabine e ronnie lippens per aver accettato di contribuire a questo dialogo, per l’invito a partecipare come relatore al ciclo di seminari Visual Criminology e per il supporto offertomi tramite il eSCr Grant ref. eS/J022381/1. ringrazio inoltre il Dipartimento di Studi politici e Sociali e la scuola GSSpS dell’Università di Milano per il supporto al mio periodo di visiting presso Oxford. Da ultimo ringrazio roberta Sassatelli e la redazione di «Studi Culturali» per le preziose critiche e i rigorosi commenti alle varie stesure dell’introduzione che precede il dialogo.
eamonn Carrabine: già direttore del dipartimento di sociologia della Univer-sity of essex. principali pubblicazioni: Crime, Culture and the Media (Cambridge, polity, 2008); Power, Discourse and Resistance: A Genealogy of the Strangeways Prison Riot. (Dartmouth, Ashgate, 2004); Carrabine, e., p. Iganski, M. lee, K. plummer e N. South, Criminology: A Sociological Introduction, (london, rout-ledge, 2004).
ronnie lippens: Head of School (Sociology and Criminology) presso la Keele University; principali pubblicazioni: A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Introduction to Studying Criminology (london: Sage, 2009) Valier, C. e r. lippens (2004) Moving images, ethics and justice, in «punishment & Society», 6: 319-333.
lUIGI GArIGlIO
— 118 —
Bibliografia
Banks, M. (2001) Visual Methods in Social Research, london, Sage. Banks, M. (2014) Analysing Images, in U. Flick, The Sage Handbook of Qualitative Data
Analysis, london, Sage. Berger, J. (1972) Modi di vedere, trad. it. Torino, Bollati Boringhieri, 2004.Bosworth, M. (2014) Inside Immigration Detention, Oxford, Oxford University press.Bourdieu, p., Boltanski, l., Castel, r. e J.C. Chamboredon (1965) La fotografia. Usi e funzioni
sociali di un’arte media, trad. it. rimini, Guaraldi, 2004.Brown, M. e e. Carrabine (2014) (a cura di) Visual Culture and the Iconography of Crime and
Punishment, «Theoretical Criminology», [numero monografico], 18 (2).Carrabine, e. (2008) Crime, Culture and the Media, Cambridge, polity.Carrabine, e. (2011) Images of Torture: Culture, Politics and Power, in «Crime, Media, Culture»,
7 (1): pp. 5-30.Carrabine, e. (2012) Just Images: Aestetics, Ethics and Visual Criminology, in «The British
Journal of Criminology», 52, pp. 463-489.Collier, J. (1957) Photography in Anthropology: a Report on Two Experiments, in «American
Anthropologist», 59, pp. 843-849.Collier, J. e Collier, M. (1957) Visual Anthropology. Photography as a Reseaech Method, Albu-
querque, University of New Mexico press.Demaria, C. e Sassatelli, r. (2013) Visioni del femminile, in «Studi Culturali», 10 (3), pp. 375-
379.elkins, J. (2002) Preface to the book A Skeptical Introduction to Visual Culture, in «Journal Of
Visual Culture», 1 (1), pp. 93-99Gariglio, l. (2007) Dalle «fotografie del fotografabile» alle immagini della vita quotidiana, in
«Biblioteca Teatrale», 81-82, pp. 189-208.Gariglio, l. (2010) I «visual studies» e gli usi sociali della fotografia, in «rassegna Italiana di
Sociologia», 1: 117-140.Gariglio, l. (2014) «Just images? Visual methods in prison ethnography» paper presentato al con-
vegno: Crime, Criminal Justice, and the Image, (eSrC grant reference: eS/J022381/1), Keele University, 25 novembre.
Hayward, K.J. e presdee, M. (2010) Framing Crime: Cultural Criminology and the Image, london, routledge.
Hughes J. (2012) (a cura di) Sage Visual Methods (4 vol.), london, Sage library of research Methods.
lippens, r. (2009) A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Introduction to Studying Criminology, london, Sage.
Margolis, e. e pawels, l. (2011) The Sage Handbook for Visual Research Methods, london, Sage.
Mirzoeff, N. (2009) An Introduction to Visual Culture, london, routledge [II edizione].Mitchell, W.J.T. (2002) Showing seeing: a critique of visual culture, in «Journal Of Visual Cul-
ture», 1(2): 166.pauwels, l. (2011) An Integrated Conceptual Framework for Visual Social Research, in Mar-
golis e pawels (2011).pauwels, l. (2012) Contemplate the State of Visual Research: An Assessment of Obstacles and
Opportunities, in pink (2012a).pink, S. (2001) Doing Visual Ethnography, london, Sage.pink, S. (2012a) (a cura di) Advances in Visual Methodology, london, Sage.pink, S. (2012b) Advances in Visual Methodology: an Introduction, in pink (2012a).
UN DIAlOGO CON CArrABINe e lIppeNS SUllA CrIMINOlOGIA VISUAle
— 119 —
prosser, J. (1998) (a cura di) Image-Based Research, london, Falmer press.rose, G. (2012) Visual Methodologies: an Introduction to Researching with Visual Material,
london, Sage.rose, G. (2014) On the relation between «Visual Research Methods» and Contemporary Visual
Culture, in «The Sociological review», 62(1), pp. 24-46.Sassatelli, r. (2011) Cultura visiva, studi visuali, in «Studi Culturali», 8 (2), p. 147-154. Schept, J. (2014) (Un)seeing like a prison: Counter-visual ethnography of the carceral state ,
in «Theoretical Criminology» 18(2), pp. 198-223.Sekula, A. (1989) The body and the archive , in r. Bolton (a cura di) The context of meaning:
Critical Histories of Photography, london, MIT press.Stasz, C. (1979) The Early History of Visual Sociology , in Wagner (1979).Sturken, M. e Cartwright, l. (2009) Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture,
Oxford, Oxford University press [II edizione].Tagg, J. (1988) The Burden of Representation: Essay on Photographies and Histories, london,
Macmillan.Valier, C. e lippens, r. (2004) Moving images, ethics and justice, in «punishment & Society»,
6, pp. 319-333.Van leeuwen, T. e Jewitt, C. (2001) The Handbook of Visual Analysis, london, Sage.Visser, H. e Vroege, B. (a cura di) (2007) Luigi Gariglio: Portraits in Prison, Milano, Contra-
sto.Wagner, J. (1979) (a cura di) Images of Information: Still Photography in the Social Sciences,
london: Sage.Wagner, J. (2001) Visual Studies and Empirical Social Inquiry, in Margolis e pauwels (2011).Walter, S., De Keseredy, S., e Dragiewicz, M. (2012) Routledge Handbook of Critical Crimino-
logy, london, routledge.Wells, l. (2003) (a cura di) The Photography Reader, london, routledge.