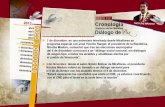"Dire la pace per farla : il dialogo interreligioso a Sant'Egidio"
Transcript of "Dire la pace per farla : il dialogo interreligioso a Sant'Egidio"
Marie Balas
Dire la pace per farla: il dialogo interreligioso a Sant’Egidio
ETNOGRAFIA E RICERCA QUALITATIVA - 1/2008
Declaring Peace in Order to Make it: the Interfaith Dialogue According to Sant’Egidio
During the last two decades the Community of Sant’Egidio has been emerging as a key actor in interfaith dialogue. The Community is devoted to constant work to develop in-stitutional and social links with various religious and political actors, notably through the organisation of the annual conference «Hommes et Religions». Our ethnography of the 2005 conference focuses on how a common world is constructed among the dif-ferent participants. The Community seems to put a high premium on singular religious identities (particularly the Roman Catholic Church). But instead of trying to negotiate various representations of what could be Veritas, it fosters agreement on common ethi-cal and cultural goods, like peace, living together, and the dialogue of civilisations. Thus, the Community of Sant’Egidio endorses a paradigm of «co-existence» more than one of «composition». In the article we elaborate on this specific management of religious con-flicts.
Sant’Egidio, religious pluralism, ritual, conflict
Data questa sua inerente caratteristica di rivelare l’agente mentre agisce, l’azione ha bisogno per il suo completo manifestarsi della luce splendente che un tempo era chiamata gloria e che è possibile solo nella sfera pubblica.
Hannah Arendt, Vita Activa
Tra le grandi questioni che s’impongono oggi al dibattito pubblico, la pluralità culturale e religiosa è sentita come una posta in gioco im-portante all’interno delle società liberali. Come far coesistere dei singoli, sotto quale luce stipulare un nuovo contratto sociale, quale comunità di
Una prima versione di questo articolo è stata presentata nell’ambito dei seminari condotti da Danièle Hervieu-Léger all’EHESS di Parigi. La presentazione è stata seguita da una sti-molante discussione, di cui il saggio porta numerose tracce.
MARIE BALAS
– 14 –
beni e di valori – quale in-comune – elaborare nello spazio e nel tempo globalizzati: tali problemi sollecitano diverse sfere di attività contempo-ranee. Il mondo politico, le istituzioni religiose, i media, le associazioni, gli ambienti letterari e artistici, le scienze umane e sociali esplorano quindi, ciascuno secondo la propria specialità (dal diritto positivo alle utopie), le condizioni del pluralismo nelle nostre società.
Le scienze sociali abbondano di lavori sull’argomento. Tra di essi, rileviamo con interesse le ricerche miranti a descrivere i dispositivi capaci di sostenere delle forme di coordinamento tra le persone. È il caso in particolare delle sociologie attente alle situazioni d’interazione e alle competenze pratiche e normative (critiche) impiegate dagli at-tori, a diversi livelli di esperienza, per coordinarsi o accordarsi 1. Le-gata a questo approccio, la corrente nata dalla filosofia delle scienze si dà come oggetto le cosmopolitiche, vale a dire, letteralmente, la politica dei mondi; si tratta in questo caso di esplorare due problemi antropo-logici e filosofici contemporanei: «da una parte, l’estensione del poli-tico al non-umano; e dall’altra, la costruzione di un mondo plurale ma in comune con altri umani» (Gutwirth, 2004, p. 80) 2. In altri termini, la cosmopolitica prende atto della diversificazione del mondo comune e si interroga sulle condizioni della conciliazione politica odierna, vale a dire le procedure in grado di sostenere nuove forme di coordinamento tra le collettività e al loro interno.
Il primo versante di questa «ecologia politica» prende come oggetto le scienze e le tecniche intese come attori a pieno titolo del mondo co-mune. Se essa non tocca la questione del pluralismo culturale e reli-gioso, attira comunque – e in modo decisivo – l’attenzione sulla parte-
1 Come ad esempio nelle sociologie cosiddette «pragmatiche», nelle quali l’analisi dei modi d’azione e di coordinamento si estende dalla persona allo spazio pubblico, pas-sando per tutte le forme intermedie, quali l’individuo o la comunità. Notiamo che qui l’isti-tuzione non è che un dispositivo fra gli altri di mediazione e coordinamento: «L’aspetto caratterizzante di questo approccio è il suo essere una sociologia dell’“azione situata” che fa dell’“azione strutturante” dei soggetti un filo conduttore attraverso il quale cercare di superare le dicotomie precostituite tra il micro e il macro, le strutture e l’azione, l’indivi-duale e il collettivo. [...] L’azione è messa dunque in relazione al suo ambiente, calandola nella situazione: la situazione è privilegiata come unità di analisi [...] perché essa permette di mettere in luce come l’agire delle persone sia soggetto a “vincoli pragmatici” presenti nella situazione, che orientano il coordinamento tra gli attori» (Centemeri, 2006, pp. 74-75). Si vedano in particolare Boltanski e Thévenot (1991) e Thévenot (2006).
2 La «maternità» di questo concetto la si deve alla filosofa delle scienze Isabelle Stengers (2005). Portato avanti da una rivista, Cosmopolitiques, viene introdotto nelle scienze sociali da diversi ricercatori fra cui Michel Callon e Bruno Latour, teorici del-l’acteur-réseau, i quali conducono ricerche – e formulano proposte – innovative per pen-sare la politica contemporanea. Si veda Latour (2002), che ha ispirato il presente arti-colo; inoltre Callon et al. (2001); Gagliardi e Latour (2006).
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 15 –
cipazione dei «non umani» (vale a dire degli oggetti, dei regni o degli dèi) nelle elaborazioni politiche. Tenendo conto di questa dimensione, il problema della «costruzione di un mondo plurale ma in comune con altri umani» fornisce un accesso stimolante al pluralismo. Osserviamo infine che la nozione di procedure offre uno sguardo d’insieme sull’in-tera proposta: è solo insistendo molto sulla necessità di seguire da vi-cino, con metodi induttivi ed empirici, i fatti studiati, che sarà possibile comprendere il modo in cui entità culturali e/o religiose e/o politiche – denominate qui «mondi» – si costituiscono e interagiscono, si compren-dono o si allontanano, elaborano una prospettiva comune o la rifiutano.
I terreni di osservazione si trovano ovunque sia in gioco questa interazione. Tra di essi, gli eventi qualificati come inter-, ad esempio le manifestazioni interculturali o le riunioni interreligiose, sembrereb-bero presentare situazioni etnografiche molto promettenti 3. Durante tali eventi, lo scarto tra i mondi è non soltanto manifestato, vale a dire stabilito e riconosciuto agli occhi di tutti, ma inoltre si trova concre-tamente «abitato»: ogni sorta di intervenenti (coloro che «vengono in mezzo», sotto forma di dispositivi o di persone, come intermediari, in-terpreti equipaggiati con interfacce, intercessori...) si sforzano di far apparire tra i mondi una comunanza di beni o di interessi. Per gli in-tervenenti-mediatori, questo compito richiede in generale un’attività intensa, proporzionale alla vulnerabilità della situazione. Qualora tali eventi includano scene rituali, la loro pertinenza etnografica si rafforza, poiché il rituale mette in scena questi mondi differenti e allo stesso tempo si sforza di istituire qui e ora il loro avvicinamento.
Considerazioni di questo genere sottolineano l’interesse sociologico di un avvenimento come gli Incontri interreligiosi di Sant’Egidio. A par-tire dal 1987, come prolungamento di un incontro convocato da Gio-vanni Paolo II ad Assisi nel 1986, la Comunità romana di Sant’Egidio organizza ogni anno una sessione interreligiosa denominata «Preghiera internazionale per la Pace», o «Rencontres Hommes et Religions», op-pure «Incontri di Assisi» 4. Assai internazionalizzata e mediatizzata, questa sessione riunisce rappresentanti del mondo religioso ai quali si accompagnano protagonisti del mondo associativo, culturale e politico intorno a dibattiti relativi alla tematica del dialogo tra civiltà. Attività-faro della Comunità di Sant’Egidio, questo incontro si conclude con una cerimonia pubblica al termine della quale i partecipanti firmano un Ap-pello di pace e si scambiano un gesto di pace.
3 Il lettore interessato a simili questioni troverà un’ottima analisi del dialogo inter-religioso in Francia in Lamine (2004).
4 Tutte e tre le etichette verranno impiegate nel corso dell’articolo.
MARIE BALAS
– 16 –
Per queste varie ragioni, la Preghiera internazionale per la Pace sembra dunque interessare una riflessione sulle forme pratiche e sim-boliche che sostengono, nelle società liberali cosmopolite, accordi o in-tese tra singoli (nella fattispecie, singole religioni). È quanto ci propo-niamo di approfondire attraverso uno studio etnografico di questo av-venimento e della sua cerimonia conclusiva. Procedendo con la descri-zione, al fine di identificare quale forma di «intesa tra i mondi» viene proposta, rivolgeremo al nostro oggetto di studio un certo numero di domande. Ci chiederemo quale pluralismo, vale a dire quale concezione del conflitto struttura l’incontro; quale ecclesiologia è in gioco e quali forme (o raffigurazioni) la veicolano; quale protocollo d’intesa è propo-sto nello spazio pubblico.
Per tracciare lo sfondo della nostra scena interreligiosa, comince-remo con una breve storia degli incontri di Assisi, seguita da una ra-pida presentazione della Comunità di Sant’Egidio, durante la quale chiariremo prima di tutto in che modo, a nostro parere, questo incon-tro rientra nell’economia della Comunità. A seguire, presenteremo la descrizione etnografica.
La nostra inchiesta si appoggia su materiali etnografici raccolti du-rante due incontri, a Milano nel 2004 e a Lione nel 2005. Per garantire alla nostra descrizione un’unità di luogo e di azione, e per il fatto che l’incontro lionese ha permesso all’osservatrice francese di confermare senza alcun possibile errore linguistico le osservazioni raccolte l’anno prima a Milano, il presente studio avrà come riferimento principale la Preghiera Internazionale per la Pace di Lione (11-13 settembre 2005).
L’eredità di Wojtyla
Il 27 ottobre 1986 papa Giovanni Paolo II organizza ad Assisi una gior-nata interreligiosa, l’Incontro di Assisi, che rimarrà una data fonda-mentale nella storia del suo pontificato. Da lui invitati, 124 rappresen-tanti di religioni cristiane e non cristiane lo raggiungono così nella città di Assisi, che in tale occasione egli descrive come «luogo che la figura serafica di Francesco ha trasformato in Centro di fraternità universale» (Durand, 2003, pp. 11-12).
Di questo incontro, il pontefice scrive nel 1994: «per la prima volta nella storia, uomini e donne di religioni e credenze diverse si sono ri-trovati insieme a me, nello stesso luogo sacro di Assisi, per invocare il dono della pace in tutto il mondo» (ibidem) 5.
5 Questo incontro ha luogo ogni due anni in una diocesi italiana, disegnando così, secondo l’acuta analisi di Salvatore Abbruzzese (2006), «una sorta di nuova geografia della spiritualità europea».
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 17 –
Questa sessione interreligiosa era concepita come un incontro di preghiera gli uni a fianco degli altri, ogni religione pregando simulta-neamente in luoghi separati, cosa che l’accademico J.-D. Durand, par-tecipante e storico degli incontri interreligiosi di Sant’Egidio, esprime in questi termini: «senza rischi di sincretismo e nel rispetto delle diffe-renze» (ibidem). Lo stesso autore nota con finezza che la riunione del 1986 ha dato, in seno alla Chiesa cattolica, una nuova legittimità al dialogo interreligioso. Ne sono derivate diverse iniziative istituzionali o spirituali, ed è precisamente in questo quadro che si iscrive la sessione annuale di Sant’Egidio.
L’anno seguente la preghiera di Assisi, la Comunità di Sant’Egidio – che era stata impegnata nella preparazione di Assisi in virtù dei suoi legami con il Maghreb 6 – crea un’associazione chiamata «Hommes et Religions». L’associazione è volta a sostenere l’organizzazione, a Roma, di un incontro interreligioso che prolunghi l’esperienza di Assisi e che sia rinnovato ogni anno. Da allora, la Preghiera Internazionale per la Pace si è progressivamente istituzionalizzata, dopo aver incontrato, al-l’inizio, la resistenza della Curia vaticana – ma fin da subito il supporto di Giovanni Paolo II 7. Seguendo, a quanto pare, questa tradizione, il suo successore si è recato di persona all’inaugurazione della Preghiera Internazionale per la Pace a Napoli nell’autunno del 2007 8.
Alimentati dai vari contatti della Comunità, gli Incontri di Assisi riuniscono oggi circa duecento personalità religiose, politiche, culturali e associative di diversi paesi 9. Fra i partecipanti si annoverano una
6 Negli anni Ottanta la Comunità aveva stabilito relazioni con le diocesi di Algeria e alcuni suoi membri avevano l’abitudine di effettuarvi dei soggiorni di scambio e di amicizia islamo-cristiana.
7 Riccardi (1997). Come osserva Abbruzzese (2006), «il sociologo non mancherà di vedere qui un processo di strutturazione che mira a regolarizzare l’evento iniziale, fino a farne un luogo spaziale e temporale nella vita delle comunità ecclesiali».
8 Vedere sotto, nota 40.9 A titolo di esempio, tra gli invitati dell’edizione 2006 ad Assisi erano presenti
responsabili politici (Blaise Campaoré, presidente del Burkina Faso, così come Giorgio Napolitano, Giuliano Amato, Walter Veltroni); numerosi vescovi e metropoliti ortodossi, oltre a due patriarchi (della Chiesa ortodossa di Etiopia e della Chiesa armena di Co-stantinopoli); dignitari ebrei e rabbini di diverse aree geografiche (tra cui i Grandi Rab-bini di Israele e di Russia); vescovi di Chiese luterane ed evangeliche, così come l’arci-vescovo di Canterbury (Chiesa anglicana); numerosi rappresentanti di culti scintoisti e buddisti; diversi rappresentanti di organizzazioni non governative, e inoltre giornalisti e accademici. Da notare che il mondo musulmano è rappresentato soprattutto da per-sone di quest’ultima categoria, come il rettore dell’Università Al-Azhar del Cairo, con alcune eccezioni: l’incontro di Lione contava ad esempio molti dignitari sciiti. La Chiesa cattolica è presente in particolare con numerosi vescovi e cardinali, fra cui tre prefetti di congregazioni pontificie (i cardinali Kasper, Poupard e Trujillo). Per una buona parte,
MARIE BALAS
– 18 –
trentina di vescovi e cardinali. Il pubblico che frequenta la sessione può essere stimato in circa duemila persone, per lo più cattolici: sono mem-bri della Comunità e laici delle diocesi che ospitano l’incontro, oltre a qualche fedele di altre confessioni religiose associate all’evento. La forte presenza cattolica si spiega in base alla natura dell’ospite ufficiale del-l’incontro: è il vescovo locale infatti che invita e riceve i partecipanti.
Negli opuscoli forniti dalla Comunità, la sessione si presenta come «un summit delle religioni e della cultura laica». Riuniti per tre giorni in luoghi generalmente prestigiosi come la Cité Internationale a Lione, i saloni della Generalitat de Catalunya a Barcellona o l’Università del Sacro Cuore a Milano, gli invitati partecipano a una trentina di dibattiti pubblici su questioni di natura politica, socio-economica e religiosa 10. L’incontro vorrebbe affrontare «i grandi temi della guerra e della pace, dell’identità e delle religioni, del dialogo possibile e delle difficoltà della convivenza» e «stabilire nuove direzioni per l’incontro e l’impegno co-mune in favore della pace. [...] Intendiamo dire [...] che è solo tramite il dialogo e il confronto libero con l’altro che potrà costruirsi un nuovo umanesimo, un’autentica civilizzazione del vivere-insieme, necessaria a qualunque società contemporanea» 11. Grazie al rango delle persona-lità invitate, queste sessioni sono fortemente pubblicizzate e mobilitano grandi investimenti finanziari e umani. Per buona parte, i costi ven-gono sostenuti dalla diocesi o dal paese ospitanti 12 e, per quanto con-cerne l’organizzazione logistica, dal volontariato intensivo dei membri di Sant’Egidio.
Questi incontri presentano così una situazione in cui mondi diffe-renti cercano di fabbricare qualcosa di comune. Vi si impiegano in vari modi: in circostanze private, out e dietro le quinte della sessione, da una parte; e dall’altra sulla piazza pubblica e nelle arene dei forum. Questo secondo aspetto dell’incontro, quello che accede allo spazio pub-blico, è quello che qui ci interessa: è lì in effetti che si costruisce il
questi invitati sono degli habitués degli incontri Hommes et Religions e alcuni di essi vi ritornano tutti gli anni, una routine che rimanda al lavoro di rete soggiacente all’incon-tro (cfr. qui la nostra «Seconda conclusione»).
10 Alcuni esempi: «Dopo l’11 settembre: le religioni e il dialogo»; «L’Oriente e l’Oc-cidente: religioni e culture»; «Scrivere la Pace: intellettuali a confronto»; «Chi è l’uomo? La questione antropologica nel XXI secolo»; «Dopo lo tsunami: una nuova solidarietà internazionale?»; «C’è un futuro comune per l’Africa e l’Europa?»; «Dialogo islamo-cri-stiano, oggi e domani»; «Cattolici e Ortodossi: le domande dell’unità».
11 Opuscolo introduttivo agli Incontri di Assisi.12 A mo’ di esempio, la sessione di settembre 2005 ha ricevuto quasi un milione
di euro di finanziamenti pubblici (compresi i benefici in natura come vitto e alloggio), che corrispondono circa ai due terzi del costo dell’incontro.
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 19 –
messaggio esplicito dell’incontro e che si esprime la sua implicita nor-matività – vale a dire l’ecclesiologia dell’incontro e la sua filosofia poli-tica. Tuttavia, nelle conclusioni vedremo come articolare le dimensioni in e out e quale rapporto di complementarietà sembra elaborarsi tra ciò che è «rivelato» e ciò che è nascosto.
Un organizzatore fortemente internazionalizzatoe reticolare 13
Organizzatrice della sessione, Sant’Egidio è una comunità cattolica di laici, fondata a Roma alla fine degli anni Sessanta. Post-conciliare, ri-vendica l’eredità del Concilio Vaticano II e allo stesso tempo quella del ’68 e degli «spostamenti di frontiera» ad esso legati (Riccardi, 1997). Tre assi orientano il progetto comunitario: la preghiera, soprattutto la preghiera comunitaria, sostenuta da una propria liturgia; la solidarietà con i poveri che si esprime, oltre alla liturgia, in un’attività caritativa intensa, tipica del registro virtuoso nel quale la Comunità si inscrive; infine, la comunicazione del vangelo, vale a dire la nuova evangelizza-zione associata a Giovanni Paolo II.
Se in questa sede non è affatto nostro scopo presentare uno studio sulla Comunità, si possono comunque sottolineare alcuni elementi perti-nenti per uno studio dell’interreligiosità di Sant’Egidio.
Fortemente ancorata sul territorio romano, Sant’Egidio è allo stesso tempo un’organizzazione internazionalizzata, e lo è per quattro ragioni:
– la presenza in una sessantina di paesi (soprattutto africani e euro-pei), attraverso comunità locali facenti capo alla (e poste sotto l’au-torità della) comunità-madre a Roma;
– un’attività umanitaria e di sviluppo, garantita in particolare dal progetto DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition) di lotta contro l’AIDS in Africa 14;
– i legami con altre confessioni religiose, mantenuti regolarmente in tutte le comunità con iniziative ecumeniche o interreligiose e con diversi tipi di manifestazioni che associano degli immigrati. Al-
13 Per un’analisi più dettagliata della questione, ci permettiamo di rinviare al no-stro Sociologie d’une diplomatie: décrire l’internationalisation de Sant’Egidio (Balas, 2007).
14 Si tratta di un programma di prevenzione e di tri-terapia in Africa, basato su un protocollo terapeutico che adatta gli standard occidentali al contesto africano. Imple-mentato, assieme ai rispettivi ministeri della salute, in una dozzina di paesi africani, il programma ha ricevuto nel 2004 il premio Balzan. È questo progetto che ufficialmente ha originato l’incontro fra il presidente Bush e Sant’Egidio nel giugno del 2007.
MARIE BALAS
– 20 –
cune comunità locali di Sant’Egidio sono parimenti ecumeniche e la maggior parte delle comunità conta simpatizzanti provenienti da altre affiliazioni religiose o senza religione;
– infine, una rete di contatti molto estesa nel mondo politico e in particolare nella sfera diplomatica. Dalla fine della guerra fredda, Sant’Egidio è un mediatore spesso invocato nella conciliazione di conflitti civili o di «piccole guerre» conseguenti alla fine della bi-polarità e alla riconfigurazione internazionale. A titolo di esempio, l’ultimo accordo di pace raggiunto in Costa d’Avorio porta, almeno in parte, la sua firma. Sant’Egidio ha un forte alleato nelle diplo-mazie francese e italiana, in cerca di nuovi metodi di ricomposi-zione delle dispute.
Questi quattro elementi si uniscono per, allo stesso tempo, legittimare e pubblicizzare il coinvolgimento della comunità romana in un «summit interreligioso»; ed è così che per esempio gli organi pubblici francesi hanno finanziato largamente l’incontro di Lione 15.
A questa pregnanza internazionale della cultura interna alla Comu-nità, si aggiunge un’osservazione di forma o di struttura: l’organizza-zione reticolare di Sant’Egidio è associata al centralismo della comu-nità-madre; questo si traduce soprattutto in una identica «comunalizza-zione» (modi di affiliazione e di cooptazione, distribuzione dell’autorità, repertori simbolico, normativo e organizzativo, modello liturgico) in tutte le comunità locali. Tale complessa organizzazione, con un reticolo paradossale – allo stesso tempo esteso e dalle connessioni multiple, pur restando centripeto e gerarchizzato – conferisce verosimilmente alla comunità romana una plasticità capace di attingere mondi differenti, senza per questo far correre gravi rischi alla propria coesione.
Le (escato-)logiche dell’iniziativa
Dopo queste considerazioni sulla competenza e la plausibilità di un coinvolgimento di Sant’Egidio in tema di interreligiosità, conviene chia-rire che cosa accade ad essa, in quanto comunità, durante un incontro di Hommes et Religions. La questione, che è quella della razionalità e degli interessi dell’attore, verrà trattata qui di seguito. Ponendola come introduzione alla nostra riflessione, piuttosto che al centro di essa, vor-remmo sottolinearne il carattere di importanza senza perciò sopravva-lutarla: se la questione degli interessi e della razionalità è naturalmente
15 Come attesta in particolare il resoconto del consiglio comunale al termine del quale è stata votata la sovvenzione della città all’incontro.
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 21 –
ineludibile per la descrizione, d’altra parte non basta – dal nostro punto di vista, che è quello di un’antropologia dell’azione – ad esaurire la gamma delle ragioni di un’attività, e degli effetti che questa attività produce svolgendosi all’interno di una rete di relazioni.
Quale bene normativo è all’origine degli incontri di Sant’Egidio? Per quanto riguarda la teologia implicita della Comunità, in primo luogo, non c’è alcun dubbio che essa si fondi su una forte etica della comu-nicazione e del dialogo con le altre istituzioni ed esperienze religiose. Da questo punto di vista, e al di là dell’impronta di Giovanni Paolo II, la Preghiera internazionale per la Pace è al tempo stesso un’eredità del Concilio e della nuova teologia (soprattutto attraverso Congar) 16 che ha fortemente influenzato i fondatori della Comunità. Questo incontro pro-cede dunque da una teo-logica, d’altra parte complessa, della quale nel corso del nostro studio preciseremo alcune dinamiche. Allo stesso modo e parallelamente, la cultura politica e le influenze «senzafrontieriste» di sinistra hanno proiettato Sant’Egidio sulla scena umanitaria e poi in di-verse campagne internazionali a partire dalla fine degli anni Settanta. La stessa etica si ritrova anche nel tipo di eventi qui descritto e si tra-duce oggi in un discorso antropologico e sociopolitico in favore di un pluralismo consapevolmente accettato in seno alle società occidentali – specialmente sulla questione dell’immigrazione e dell’accoglienza degli stranieri sul territorio italiano. Infine, come genesi e risultante di tutto ciò 17, «la pace» è il motivo strutturante delle attività della Comunità, in cui è oggetto di una vera e propria pedagogia: una sensibilizzazione alla pace, che nasce da una morale della pace, è costantemente asso-ciata ai progetti caritativi e alle campagne di Sant’Egidio, così come alle pubblicazioni dei suoi membri 18. Questa sensibilizzazione poggia su un messaggio trasversale a tutte le attività, i canti e le catechesi della Comunità: «la pace è alla portata di tutti» 19.
Questa prospettiva etica e didattica è il parametro fondamentale degli incontri di Assisi. Si potrebbero inoltre avanzare due ragioni adia-centi e complementari, che riguardano la posta in gioco, per l’attore, nel presentarsi sullo spazio pubblico e su quello ecclesiale. Tali ragioni derivano a nostro avviso da due problematiche distinte: da una parte
16 Riccardi (1997).17 Per un’analisi molto articolata della genesi dei movimenti per la pace in Italia,
visti in rapporto alle culture politiche incrociate dei cattolici e della sinistra, si veda Tosi e Vitale (2007).
18 Rinviamo qui alle diverse opere della Comunità o dei suoi membri, in partico-lare Comunità di Sant’Egidio (1994); Riccardi (2004; 2006).
19 Si veda, fra le altre opere, Comunità di Sant’Egidio (2006), un libro rivolto ai bambini.
MARIE BALAS
– 22 –
l’istituzione (o la legittimazione) di Sant’Egidio in rapporto agli altri «imprenditori» del dialogo interreligioso; dall’altra la tematica interreli-giosa come vettore di istituzione (o di legittimazione) delle attività poli-tiche della Comunità.
La prima questione può essere efficacemente afferrata attraverso il modello tipico dei manifesti prodotti dalla Comunità in occasione de-gli incontri interreligiosi. Esso consiste in un’illustrazione raffigurante una colomba stilizzata, posta all’interno di un arcobaleno. L’arcobaleno parte dall’alto del manifesto (il cielo) e scende generalmente sulla cat-tedrale o sul monumento emblematico, pure stilizzato, della città che ospita l’incontro. Il manifesto è accompagnato dallo slogan di ogni edi-zione (a Lione, «Il coraggio di un umanesimo di pace»). La figura è riprodotta sul sito internet dell’incontro e sui programmi, sui tesserini indossati dai partecipanti e sui volantini; inoltre, è sia stampata su cartelloni di grande formato posti sopra ciascuna tavola rotonda du-rante l’incontro, sia domina – su un ampio telone – la scena della ceri-monia conclusiva in cui si scambierà il segno di pace tra le personalità religiose.
Quel che più appare interessante in questo manifesto è la poliva-lenza della colomba, che diviene un attante a pieno titolo della ses-sione 20. Essa possiede una doppia competenza: rappresenta da un lato «la pace» che scende, in un movimento di trascendenza, sulla città de-gli uomini; una pace, insomma, che si rende accessibile. Inoltre, que-sta colomba è il logo di Sant’Egidio, il suo marchio identificante, il suo segno di riconoscimento. Vale a dire che la pace che si appresta a scendere per farsi storia al centro di un’assemblea intramondana, si (rap)presenta come la pace di, e per mezzo di, Sant’Egidio. La colomba designa quindi la comunità romana allo stesso tempo come il deposita-rio e l’operatore (esemplare? esclusivo?) 21 di questa pace possibile. Alla sola luce di questo manifesto, che funziona come un filo conduttore tra i diversi luoghi, oggetti e partecipanti dell’incontro, sembra possibile identificare un importante guadagno simbolico per l’organizzatore di una simile iniziativa. Al rischio – accettato – di un costo istituzionale,
20 L’attenzione alle «competenze» effettive – ed eventualmente multiple – di un og-getto significativo, considerato da allora come un attante, può aiutare a esplicare i pro-cessi e le interazioni complesse che si trovano in una situazione. Un esempio eclatante lo si trova in Claverie (2003). Si veda inoltre Latour (2006).
21 Vari attori esterni sollevano la questione: ad esempio, in occasione dell’incon-tro di Lione, furono gli Instituts de Science et de Théologie des Religions, che tra gli Istituti Cattolici sono quelli specializzati in relazioni interreligiose. Gli ISTR, forti di una lunga presenza nelle reti interreligiose francesi e internazionali, nonché di un’esperienza «grassroots» sui singoli punti in discussione, hanno vivamente rimproverato a Sant’Egi-dio di non averli interpellati e nemmeno invitati all’incontro.
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 23 –
che è quello di attirarsi l’ostilità della frangia conservatrice della Curia vaticana, che farebbe anche apparire lo slogan dell’incontro come una sorta di sfida rivolta internamente alla Chiesa cattolica.
L’altro interesse in termini di capitale simbolico va compreso in re-lazione alle altre attività della Comunità. Tutto il lavoro diplomatico di Sant’Egidio, che costeggia le diplomazie occidentali oltre a diversi capi di stato e a capi ribelli di paesi in conflitto, suppone due forti vincoli: il segreto e la discrezione, da una parte; dall’altra, l’interazione con la politica. Si tratta dunque di un’attività compromettente 22, suscettibile di ricevere la qualificazione di «impura» secondo un regime di convalida religiosa da un lato; mentre, dall’altro lato, il segreto e il nascosto si prestano al sospetto secondo un quadro di convalida democratica. Sulla scena interreligiosa pubblicizzata, accreditata da insigni rappresentanti religiosi, civili e politici, si produce allora per Sant’Egidio qualcosa di simile a una giustificazione in pubblico e per mezzo del pubblico. Si può parlare di un’epifania legittimante, in grado di «trattare» o di «purificare», tramite il rituale e la pubblicità, un’attività segreta e po-litica conferendole delle lettere di nobiltà. Anche la centralità dell’avve-nimento agli occhi della Comunità può essere letta – parzialmente – in questa luce.
Si potrebbe andare più lontano. Se, come suggerisce specialmente il manifesto sopra descritto – questa «discesa» della pace egidiana nella città terrestre –, la comunità romana si situa in una prospettiva escato-logica che consiste nell’ancorarsi saldamente alla Storia, ma sotto forma di una rottura, un Regno di pace che è «già là», allora la scena assume un rilievo particolare. Appare infatti come una condizione e allo stesso tempo un risultato di questo regime escatologico, costituendo il disposi-tivo per eccellenza di rivelazione e di esperienza della «pace-già-là» e del suo operatore, la Comunità di Sant’Egidio 23.
Avanzate queste ipotesi, possiamo ora seguire lo svolgimento della sessione e osservare le procedure grazie alle quali un dispositivo di ri-composizione tra i diversi mondi invitati viene messo in pratica. Per ri-spettare la nostra premessa, che era di identificare il tipo di cosmopo-litica attuato dall’incontro, porremo una domanda che è centrale per il nostro oggetto: si tratterà di esplicitare, tramite l’etnografia, quale sorte viene riservata al conflitto e alle conflittualità (vale a dire all’espres-sione tumultuosa delle singolarità) lungo tutta la sessione.
22 La nozione inglese di commitment, to commit oneself, rende con maggior preci-sione questa doppia qualità dell’impegno legato a compromessi.
23 Per dei lavori assai fruttuosi sul rapporto tra politica, escatologia e comunità, rimandiamo a Hervieu-Léger (1973) e a Séguy (1999).
MARIE BALAS
– 24 –
Dal politico al simbolico:l’architettura degli Incontri di Assisi
La sessione Hommes et Religions dura tre giorni e comincia una dome-nica, la prima o la seconda settimana di settembre. A Lione, per esem-pio, è cominciata un 11 settembre, occasione per gli organizzatori di ricordare gli attentati allo World Trade Center e di farsi portavoce del-l’urgenza di un dialogo tra civiltà.
L’evento si articola in quattro sequenze che sembrano avere cia-scuna una funzione, o almeno un senso, nell’economia dell’insieme. Le divideremo in un preludio, che raggruppa solo una porzione dei par-tecipanti, e in tre momenti che riuniscono la totalità dei partecipanti (ospiti e pubblico) fino alla conclusione.
Il preludio corrisponde alla celebrazione eucaristica della dome-nica. È celebrata dal vescovo, alla presenza dei rappresentanti delle al-tre confessioni cristiane, vestiti dei loro abiti liturgici e disposti nel coro tra gli officianti cattolici. Generalmente, la prima lettura della messa è affidata a uno di questi rappresentanti. Per il resto, si tratta di una messa solenne secondo il rito cattolico romano, che celebra i temi del-l’incontro: la pace come dono di Dio, il messaggio evangelico di frater-nità e dialogo, le responsabilità della Chiesa in merito.
La presenza delle altre confessioni cristiane a questa liturgia che precede un «incontro interreligioso» provoca ad alcuni membri dell’as-semblea un’incertezza sul framing: si tratta di una celebrazione ecume-nica? A Lione, all’uscita della messa, un piccolo gruppo di cattolici ve-nuti ad assistere alla sessione si stupisce del carattere ecclesiocentrico della celebrazione. Da etnografi, ci uniamo alla loro conversazione; ri-sulta che sono dei laici (francesi), praticanti regolari, impegnati in di-verse attività associative di tipo ecumenico e/o sociale. Si sono iscritti all’incontro molto per tempo, e a priori sono assai favorevoli alla sua proposta. Queste persone, che non hanno un’affiliazione istituzionale alla Chiesa cattolica, fanno dunque parte del pubblico dell’incontro, e più esattamente di un tipo di praticanti che intrattengono un rapporto a distanza con l’istituzione 24. Sul sagrato di Notre-Dame de Fourvière,
24 Siamo qui in presenza di una micro-sequenza etnografica: queste persone non rappresentano certo – nemmeno di lontano – tutti i fedeli della diocesi di Lione presenti all’eucaristia. Ma questo ha poca importanza se consideriamo la scena in una prospet-tiva semiotica, in cui l’attività critica di questi «testimoni» funzionerebbe come un segno o un segnale rilevante, per contrasto, di talune dinamiche della celebrazione. Se ripren-diamo i tipi di affiliazioni religiose proposti da Danièle Hervieu-Léger in Il pellegrino e il convertito (2003), l’atteggiamento religioso – e la teologia implicita – di questi parteci-panti rimanda a un registro «etico» (universalista), in tensione con un polo «comunita-rio» ecclesiocentrico. Parimenti, nei termini di Albert Piette (1999), il loro atteggiamento
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 25 –
un po’ in disparte rispetto ai membri che esprimono il loro entusiasmo dopo la celebrazione, questi fedeli reagiscono contro la «passività» dei rappresentanti delle altre confessioni: «fanno tappezzeria», «non capi-sco», «non partecipano», «non c’è stata nemmeno la versione del Padre nostro compatibile con la liturgia protestante», «era pomposo», ecce-tera. La presenza della critica mostra bene un’incertezza sulla qualifica di questa eucaristia: entrando in chiesa, questi laici si aspettavano che durante la celebrazione intervenissero dei gesti ecumenici; all’uscita, delusi nelle loro aspettative normative dai «fasti» e «pompe» di una li-turgia cattolica quant’altre mai, non sanno esattamente come adeguare le loro interpretazioni.
Questo iato sul sagrato, nello stesso luogo e allo stesso momento, tra la critica espressa da questi laici «esterni» e la soddisfazione mani-festata dai membri ci informa senza dubbio sulle differenze di gramma-tica 25 religiosa nell’uno e nell’altro gruppo 26.
Ma ci istruisce anche sulla possibile funzione del carattere eccle-siocentrico della celebrazione: di sicuro si tratta di riaffermare e rinfor-zare la cattolicità degli organizzatori 27 prima della cerimonia di inau-gurazione, situata in un registro politico e secolare (cfr. infra), e prima dell’immersione fra le altre religioni. L’ecumenismo troverà posto in un altro momento dell’incontro, in occasione della preghiera che precede la cerimonia conclusiva. Prima di tutto ciò, questa sequenza liturgica costituisce così a nostro avviso un’introduzione nella quale – oltre all’at-tività propriamente spirituale della celebrazione – si afferma l’identità religiosa dei mediatori: è una sorta di didascalia che preciserebbe agli
deriverebbe da un registro «sociopolitico» (egalitarista), per opposizione a un registro di «filiazione» (gerarchico). Per un osservatore francese ancorato in questo registro «etico» o «sociopolitico», il fatto che Sant’Egidio si mantenga in tensione tra queste due serie di opposti è un’esperienza spaesante.
25 Questo termine oggi molto diffuso (e discusso!) nelle scienze sociali francesi, designa nella sua accezione estesa un repertorio implicito di regole, norme e pratiche che orientano la condotta delle persone, sul modello della grammatica generativa di Chomsky. Sensibile alla storia e alla cultura, questo modello d’azione implicita può co-munque essere rifiutato, declinato o cambiato dagli attori nei momenti di riflessività o di critica. La grammatica può essere intesa come uno strumento descrittivo che in parte ri-prende il concetto di habitus, ma privo dell’aspetto determinista di quest’ultimo. Si veda Boltanski e Thévenot (1991) e soprattutto Lemieux (2000), pp. 107-124.
26 L’attività critica è parte integrante delle pratiche associate all’impegno religioso per tutta una fascia del cattolicesimo francese ordinario, e – ci sembra – per ragioni sto-riche e antropologiche legate in particolare al complesso rapporto con l’istituzione che ritroviamo in questo paese.
27 Sant’Egidio e diocesi ospitante; da notare che, nel caso di Lione, l’arcivescovo è un convinto fautore della nuova evangelizzazione.
MARIE BALAS
– 26 –
attori qual è il loro ruolo e la posizione scenografica prima che inizi il primo atto dell’incontro. La celebrazione anticipa il confronto con le al-tre religioni, un confronto con delle alterità potenzialmente alteranti.
A giudicare da questo primo segnale, la configurazione di partenza non sarebbe quindi affatto di tipo induttivo o costruttivista, con un’iden-tità concepita come il prodotto di un’interazione: l’identità al contrario è posta a priori, sotto forma di un’istituzione rinforzata. Questa sequenza afferma e manifesta una tradizione: è su questa base indistruttibile che si stabilisce una relazione con le altre tradizioni/istituzioni.
Il primo grande momento che riunisce l’insieme dei partecipanti è l’inaugurazione della sessione. Essa ha luogo la domenica sera, in una sala prestigiosa (per esempio l’Auditorium di Lione). Si tratta di una tavola rotonda, ugualmente solenne, che raccoglie diversi invitati di un certo rango istituzionale. Tra di essi, i responsabili politici locali e re-gionali, qualche religioso, alcuni intellettuali (spesso editorialisti della carta stampata), infine personalità politiche nazionali e internazionali. A Lione, la seduta inaugurale ha visto presenti il presidente del Mozam-bico, in rappresentanza dell’Africa, così come Nicolas Sarkozy, all’epoca ministro dei culti, Simone Veil, senatrice ed ex-ministro (di centro) e Gérard Coulomb, sindaco di Lione (del Partito socialista).
Il tema della seduta inaugurale è lo stesso dell’intera edizione: «Il coraggio di un umanesimo di pace». Il dibattito si focalizza sulla laicità e sulle risorse pacificatrici delle religioni negli ambiti politico, sociale e internazionale. Identifica gli scogli legati a queste problematiche e pone essenzialmente il principio di un contributo possibile e necessario delle religioni alla «coesistenza pacifica tra i popoli». Questo momento fa da pendant alla chiusura e la prepara. Costituisce la sequenza poli-tica: in essa ci si esprime soprattutto su un registro civico e culturale. È interessante, a questo proposito, notare come questa sequenza (non-ché la disposizione delle stesse personalità durante la cerimonia finale, cfr. infra) constati e manifesti la separazione tra politico e religioso. In tal senso, gli organizzatori si inscrivono in una prospettiva di mante-nimento della differenziazione tra le sfere; se la loro relazione rimane complessa (come dimostrano le costituzioni conciliari) 28, non siamo però affatto all’interno di un modello intransigente da un punto di vista religioso 29.
28 Su questo punto, rinviamo ai lavori dell’Istituto per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna sulle variazioni della cristianità nel pensiero ecclesiale contemporaneo: si veda per esempio Menozzi (1984).
29 Questa osservazione, di cui siamo debitori a Danièle Hervieu-Léger, è impor-tante soprattutto sullo sfondo degli attuali dibattiti politico-ecclesiali in Italia: pensiamo in particolare al coinvolgimento della C.E.I. in alcune controversie sociali.
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 27 –
Approcci del dialogo: divergenze
Il secondo momento della sessione consiste in un panel di tavole ro-tonde – in tutto una trentina – in cui gli invitati discutono e dibattono alla presenza del pubblico su problemi contemporanei o di attualità, politici o religiosi 30. Le tavole rotonde hanno luogo negli auditori o nelle sale di riunione della sede principale dell’incontro.
Questa sequenza è quella dello scambio di vedute e di saperi. È potenzialmente agonistica (nel senso di un confronto organizzato) ed è perciò che le tavole rotonde costituiscono, assieme alla cerimonia finale, un luogo cruciale di osservazione delle procedure di conciliazione. Que-sta la ragione per cui le abbiamo seguite con attenzione, scegliendo i temi più controversi allo scopo di comprendere in che modo la discus-sione veniva inquadrata – vale a dire, con quale tipo di spazio pubblico abbiamo a che fare. Ci soffermeremo ora su questo punto.
La tavola rotonda è un luogo potenzialmente agonistico perché in essa le singolarità religiose si vedono affidato uno spazio di espressione in quanto singolarità. Per comprendere la maniera in cui vengono mo-derati gli scambi, è interessante prestare attenzione all’atteggiamento dei presidenti della seduta. Si assiste ad alcune variazioni nel modo in cui regolano il confronto. Alcuni (ci vengono in mente due casi) invo-cano esplicitamente il dibattito. Ad esempio un cardinale che esordisce: «Dobbiamo cercare l’interferenza amicale»; o un metropolita che in-cita ad esplicitare i conflitti: «Vi chiedo di parlare di ciò che crea pro-blema».
In linea generale, i presidenti di seduta si sforzano di reindirizzare gli oratori nel momento in cui cadono manifestamente nell’autocelebra-zione istituzionale. Allo stesso modo, una tavola rotonda intitolata «Au-tocritica delle religioni» è spesso proposta nel corso dell’edizione. Ep-pure, ad eccezione dei due esempi ora citati, parrebbe che la consegna affidata ai moderatori sia di cercare innanzitutto una garanzia di ac-cordo o di consenso. In molti casi, questi moderatori pronunciano frasi come: «il punto di partenza dev’essere ciò che ci unisce», vale a dire la concordia. Assai rappresentativa al riguardo è l’indicazione di un pre-sidente, vescovo e membro di Sant’Egidio, in una tavola rotonda intito-lata «Cattolici-Ortodossi»: nel momento in cui la discussione comincia ad animarsi, egli invita all’intesa con queste parole: «Vorrei ritornare sugli aspetti positivi di questi rapporti tra cattolici e ortodossi».
Tra il pubblico, così come sul sagrato, le reazioni oscillano tra due poli. Da un lato, i membri della Comunità manifestano la loro ade-
30 Cfr. nota 10.
MARIE BALAS
– 28 –
sione alle discussioni così come sono inquadrate. Per questo pubblico egidiano, generalmente assai formato e informato sugli argomenti in questione, la posta in gioco è creare le condizioni per una esperienza di concordia fra attori abituati di solito a comunicare secondo le mo-dalità dell’opposizione, del pregiudizio o della disputa. Questo atteg-giamento deriva dalla pedagogia cui facevamo allusione più sopra. La lentezza delle discussioni, il loro carattere talvolta molto istituzionale, fanno parte del normale bilancio di perdite e guadagni della situazione; i membri vi accondiscendono con filosofia o con un distacco diver-tito, dato che l’importante è costituire tra gli oratori una esperienza di unità. È in questo modo – a quanto pare – che il dialogo è concepito e pensato. In questo senso, le tavole rotonde incentrate sulla «ricerca di ciò che unisce» 31 anticipano in qualche modo, rendendola presente, la manifestazione della «pace dono di Dio», vale a dire della pace-già-là.
Di fronte a questo dispositivo, il resto del pubblico si divide tra la soddisfazione per alcuni (senza dubbio la maggior parte) e un certo scetticismo per altri. All’uscita dalle conferenze, nei corridoi, abbiamo raccolto a caldo alcune impressioni di attori per i quali la situazione o l’attività, per diverse ragioni, presenta delle difficoltà. Anche qui, come nella sequenza micro-etnografica sul sagrato, questo tipo di reazioni è impossibile da quantificare, ma è assai probabile che sia minorita-rio. Non per questo è meno interessante, dal momento che mette alla prova i «va da sé» o le evidenze condivise dell’attività comune. Queste reazioni provengono stavolta non più dal semplice pubblico, ma da at-tori istituzionali o da specialisti dei temi affrontati. Per esempio il se-guente giudizio di una responsabile di ONG, all’uscita da una tavola rotonda: «Sono stata al dibattito sull’Africa, era talmente ingessato!»; oppure questo, di una giornalista di testata cattolica durante il dibat-tito sull’ecumenismo: «[sospirando] Non c’è fondamento!», «Non suc-cede niente!»; quest’altra nota del responsabile di una congregazione: «[sollevando le braccia] Non c’è nulla in questo dibattito! Ma bisogna parlare dell’oggi! Ci vuole del coraggio! Che cosa si fa oggi?». Un’altra invitata, fedelissima di questi incontri, dirà più tardi, a freddo: «Biso-gna sempre rimanere sul consenso; se la cosa inizia a scaldarsi, il mo-deratore chiude il dibattito».
Critiche di questo genere sono culturalmente situate: provengono da attori che sono essi stessi fortemente impegnati e che valorizzano una certa autonomia nei confronti delle istituzioni ecclesiali. In ogni caso, come all’uscita sul sagrato, queste reazioni di una parte del pub-
31 Si noti che l’espressione di Giovanni XXIII «bisogna cercare ciò che ci unisce più di ciò che ci divide» è spesso presentata dai fondatori della Comunità come un mo-tivo fondante dei loro metodi diplomatici.
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 29 –
blico manifestano aspettative normative divergenti rispetto a quelle de-gli organizzatori. È proprio la concezione del dialogo che sembra es-sere in causa. Per gli attori qui citati, è evidente che il dialogo non va concepito prima di tutto come un’esperienza, una pista o una prova di unità da immagazzinare in una memoria collettiva comune. Non si tratta di far sì che esso anticipi la realizzazione di una pace che, ai loro occhi, niente assicura sia ormai acquisita. Al contrario, secondo queste persone, bisogna parlare di ciò che crea conflitto: questo atteg-giamento valorizza un dialogo empirico, in cui le diverse singolarità e istituzioni si espongono al dibattito e si mettono in pericolo 32.
Il conflitto, ad ogni buon conto, non è assente dalle tavole ro-tonde: vi si trova allo stato latente e capita che, in determinate circo-stanze, debordi dall’inquadramento. Lo mostra in maniera ricorrente, per esempio, la tavola rotonda dedicata al Libano. A Lione si è visto il presidente di questa seduta uscirne come knocked-out, titubante, asciu-gandosi la fronte e ripetendo: «Si è scaldata... si è scaldata di brutto!». Tuttavia è giusto concludere che, in linea generale, la sequenza delle tavole rotonde presenta uno spazio preservato dal conflitto.
Un’ultima parola su queste tavole rotonde. Come si è detto, sono poste tra l’inaugurazione e la chiusura. Riuniscono per tre giorni, in uno stesso luogo, persone separate dalle loro istituzioni e dalle loro re-sponsabilità ordinarie per preparare la risposta a una crisi, vale a dire la minaccia di una discordia strutturale fra dei singoli. Vista in questi termini, abbiamo esattamente la struttura del social drama individuata da Victor Turner nel suo lavoro sui rituali politici 33. Social drama desi-gna l’incatenamento delle sequenze secondo il quale un gruppo percepi-sce una crisi (1. breach), i dispositivi destinati a risolverla falliscono (2.
32 Una simile concezione del dialogo da parte degli stessi attori presenta analo-gie con l’approccio pragmatico nelle scienze sociali al quale noi stessi aderiamo; que-sto approccio, ispirato alle filosofie pluraliste anglosassoni, insiste in effetti sul carattere aperto, plurale e negoziato dell’esperienza sociale e delle situazioni che la generano. Così, la concezione del dialogo suggerita dagli attori può avvicinarsi, per certi versi, alla nostra scelta «interazionista» e alla prospettiva normativa ad essa sottesa. Tale analogia rischia naturalmente di introdurre distorsioni nella descrizione, sottomessa agli stessi criteri di valutazione impiegati da questi attori. Siamo consapevoli di questo scoglio, che rimanda al classico problema della descrizione nelle scienze sociali. Una risposta imper-fetta potrebbe consistere nel considerare che, dato che il sociologo non è meno toccato da un ethos di quanto lo siano gli attori sociali, tanto vale segnalare in tutta franchezza i luoghi in cui la sua personale normatività rischia di affiorare. È nel dispiegare il suo oggetto, e nello sforzo di esplicitarne la ricchezza e la complessità, che potrà attenuare la portata dei suoi entusiasmi e dei suoi dubbi. In tal senso, per quanto concerne la normatività del sociologo, la descrizione è allo stesso tempo il luogo di un rischio e di un lavoro di pacificazione.
33 Si veda in particolare Turner (1992).
MARIE BALAS
– 30 –
crisis), fino a quando un rituale scenico (cerimonia, teatro o gioco) re-staura l’armonia minacciata (3. redressive action); i riti di passaggio ne fanno parte. Infine, il dramma sociale si conclude con la reintegrazione sociale o con la separazione (4. reintegration or schism).
Tra l’identificazione della crisi e l’azione rituale c’è uno spazio che Turner ha chiamato fase liminale, vale a dire un luogo e un tempo se-parati dal corso della vita, sottratti alla vita mondana ordinaria. È un momento esplorativo e sperimentale, un «caos fecondo» 34, caratteriz-zato dalla presenza di idee ambigue, di paradossi, di prove e di umilia-zioni, da una battaglia per nuove strutture eccetera 35.
Nelle nostre tavole rotonde, che sembrano formare l’equivalente di una sequenza liminale, questo caos è potenzialmente presente (lo testi-monia la sequenza sul Libano). Tuttavia non è istituito: si tratta piutto-sto di addomesticarlo. Per quanto concerne l’attività pubblica di questi incontri, e tralasciando per ora ciò che avviene dietro le quinte, si di-rebbe che il dispositivo degli incontri metta in atto le tappe del social drama senza però arrivare al punto di svolgere l’attività liminale – at-tività fragilizzante per le istituzioni e le persone e, nella prospettiva di Turner, eventualmente ristrutturante.
Gli oggetti e la loro disposizione, che spesso si annoverano tra i migliori informatori sul campo, sono là per esplicitare ciò che è in gioco: ricordiamo che in ogni sala, al di sopra degli oratori, è sospeso il telo con la colomba e il ramo d’olivo sormontati dallo slogan dell’in-contro. Esso è la prima cosa che il pubblico vede entrando nelle sale e domina la tavola dei conferenzieri. La colomba della pace si trova là come a priori e sembrerebbe di poterla leggere come un presupposto che afferma, allo stesso tempo in cui lo evoca, uno stato di pace. A mo’ di scenografia, l’uccello simbolico si vede forse attribuita una terza funzione, una funzione didattica: quella di congiungere il non ancora (il conflitto) e il già-là (la pace) e d’insegnare ai religiosi presenti che que-sta esperienza pacifica è possibile 36. Rivelare questo già presente, farne fare l’esperienza, conduce all’espulsione di un’antropologia empirica o costruttivista.
Di questa rivelazione sarà quindi incaricato il rituale: nel dialogo interreligioso al quale assistiamo qui, la prova avviene guardando. È la quarta sequenza della sessione, la sequenza simbolica.
34 Ibidem, p. 42.35 Ibidem. Vedere anche Turner (1977). 36 Non stiamo suggerendo che questi siano risultati coscienti o intenzionali dell’or-
ganizzazione: ci accontentiamo semplicemente di registrare, in una sorta di capriola che lascia in sospeso la questione dell’intenzione, che è così che la situazione si presenta.
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 31 –
La cerimonia conclusiva:quadro enunciativo e vincoli normativi
Lo schema della cerimonia conclusiva è lo stesso di anno in anno; de-scriveremo di nuovo, specificamente, l’incontro di Lione. Cominciamo con un quadro etnografico.
Al termine dell’ultimo pomeriggio di discussione, le diverse reli-gioni si ritrovano ciascuna in un luogo di preghiera preparato apposi-tamente per loro. La preghiera è la stessa per le confessioni cristiane e la sua tonalità ecumenica è pregnante, la parola e la responsabilità del rituale essendo ugualmente distribuite tra le varie confessioni rap-presentate. Dopo questo momento, le altre religioni convergono verso le confessioni cristiane, già riunite sul sagrato della basilica Fourvière.
Una processione si forma allora verso l’anfiteatro delle Gallie 37. Avanza in un’atmosfera distesa, gioiosa, circondata dal pubblico che applaude, da guardie del corpo e numerosi giornalisti. La testa della processione è costituita dai cinque o sei principali dignitari presenti, tra i quali il cardinale arcivescovo di Lione e il cardinale Kasper, presi-dente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani. Tutti i partecipanti alla processione sono vestiti dei loro abiti liturgici. La processione raggiunge l’anfiteatro e il pubblico prende posto sui gra-dini, mentre le personalità religiose si sistemano sui gradini di fronte, sul palco. Al microfono, sopra un allegro di musica classica, una voce esterna li presenta per nome man mano che entrano. La scena è sor-montata dal pannello con la colomba e lo slogan.
La scena è avvolta da un dispositivo di mediatizzazione e pubbli-cizzazione. Alcuni altoparlanti sono sistemati di fronte al pubblico, dove si trova anche una telecamera che filma l’evento e lo ritrasmette su grandi schermi a fianco degli altoparlanti. Possono aggiungersi al pub-blico telecamere televisive e giornalisti della stampa 38.
La processione è dunque l’albero motore della cerimonia conclu-siva, che culminerà nella firma dell’Appello di Pace, il quale sarà con-segnato agli ambasciatori presenti nell’assemblea, e nell’abbraccio tra i partecipanti sulla scena. Questa cerimonia è un condensato simbolico e metaforico di ciò che si gioca, in termini di messaggio, durante que-sta sessione. Per analizzarla, porremo due questioni: in primo luogo, si tratterà di esplicitare quali sono i ministri di questo rituale, vale a dire
37 Questo anfiteatro all’aperto, che data del primo secolo della nostra era, è un vestigio del santuario federale delle tre Gallie; è un luogo simbolico per la cristianità poiché è là che morirono i primi martiri cristiani delle Gallie.
38 A Lione ad esempio eravamo seduti accanto a una giornalista dell’AFP che met-teva in rete i suoi pezzi man mano che la cerimonia procedeva.
MARIE BALAS
– 32 –
quali sono i principali enunciatori di questo «dialogo interreligioso». In secondo luogo, dovremo osservare in che modo la pace è introdotta, come viene mantenuta e quale forma riceve.
La cerimonia conferma che l’attività interreligiosa di Assisi si svolge sotto gli auspici della Chiesa cattolica; essa ne è allo stesso tempo l’arbitro e l’enunciatore centrale. Per i partecipanti, si tratta di una convenzione tacita: in virtù della sua ampiezza e del suo centra-lismo, l’istituzione che ospita questi incontri è in grado di riunire una pluralità di singoli 39.
Ricapitoliamo: la sessione si tiene su invito di una diocesi e del suo vescovo; è lui che presiede la messa inaugurale e farà parte dei cinque o sei oratori della cerimonia conclusiva, assieme al cardinal Ka-sper e, sotto il precedente pontificato, a Giovanni Paolo II, il cui mes-saggio era letto pubblicamente 40. La processione, con i cardinali in te-sta, conferma questa gestione, così come la disposizione delle persone sul palco: a destra, le religioni della Bibbia; a sinistra i rappresentanti dell’islam, delle altre religioni e qualche attore del mondo laico; al cen-tro, i prelati cattolici. Le personalità politiche ufficiali sono fuori scena, ai primi ranghi del parterre. In questa disposizione a cerchi concentrici e dalla semiologia espressiva, la Chiesa cattolica forma il quadro enun-ciativo: attraverso i suoi rappresentanti, è essa che dichiara aperta la sessione, che distribuisce la parola, che redige, pronuncia e fa firmare l’appello di pace; è essa, globalmente, che prende la parola a nome dei partecipanti. Similmente, nella sequenza precedente, la grande maggio-
39 Vi si potrebbe vedere l’esteriorizzazione, nello spazio interreligioso, di una com-petenza interna al cattolicesimo italiano messa in luce da Diotallevi (2001) quando mo-stra come il monopolio cattolico renda possibile internamente una grande eterogeneità di espressioni ecclesiali.
40 Il sostegno del cardinal Ratzinger, poi Benedetto XVI, è stato per lungo tempo meno chiaro. A Lione nel settembre 2005, contrariamente ai messaggi precedenti di Giovanni Paolo II, il messaggio di Benedetto XVI è abbastanza breve, non fa menzione di Sant’Egidio e viene letto durante la preghiera interconfessionale. Sono note le riserve, più volte esplicitate all’inizio del suo pontificato, nei confronti di questo tipo di iniziative, sospette ai suoi occhi di «relativismo». Ma una svolta notevole sembra essersi verificata nel 2007, con la presenza del pontefice alla giornata d’inaugurazione degli Incontri di Assisi a Napoli (21 ottobre). Tale presenza, assai legittimante per la Comunità, sembra marcare un riposizionamento di Benedetto XVI in merito alle relazioni interreligiose: da una parte, essa attutisce la percezione da parte delle altre religioni di un’istituzione cat-tolica intransigente, alimentata soprattutto dall’affaire di Ratisbona. D’altra parte, con la condizione che il dialogo non sia teologico né rimetta in causa la dottrina cattolica della salvezza, l’incontro sembrerebbe, per Benedetto XVI, un’occasione per affermare l’esem-plarità del cattolicesimo nella ricerca della pace. Infine, la sua presenza a Napoli, dove ha potuto trattenersi con i vari rappresentanti religiosi, sembra tener conto del carattere ineludibile della rete di contatti nei rapporti inter-nazionali o inter-religiosi.
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 33 –
ranza dei presidenti di tavole rotonde sono personalità (laici o prelati) cattoliche.
Detto questo, in cosa questo inquadramento da parte della Chiesa cattolica istituzionale definisce una specifica grammatica interreligiosa? Si possono identificare tre vincoli:
– primo, il modello inclusivista del Concilio, secondo cui le altre re-ligioni possiedono dei «germi del Verbo» (Ad Gentes, 11), mentre il dialogo con il «mondo» è paragonato (nell’enciclica di Paolo VI Ecclesiam Suam, 65) alla sollecitudine del medico verso il suo pa-ziente;
– secondo, il rigetto, affermato da Giovanni Paolo II durante l’intero pontificato, della teoria dello scontro di civiltà;
– terzo, il concomitante rigetto, ribadito con forza nell’ultimo decen-nio dalla Congregazione per la dottrina della fede, di ciò che l’isti-tuzione considera come relativismo. Per rappresentarsi il quadro normativo soggiacente, ci si può riferire a un esempio di notifica-zione (vale a dire di sanzione argomentata) pronunciata contro il teologo dell’interreligiosità Jacques Dupuis 41:
È contrario alla fede cattolica considerare le varie religioni del mondo come vie complementari alla Chiesa in ordine alla salvezza (Congrega-zione per la dottrina della fede 2001a, 6).
In un contesto, come quello attuale, di una società che di fatto è sempre più multireligiosa e multiculturale, la Chiesa avverte con urgenza il biso-gno di manifestare con convinzione la sua identità dottrinale (Congrega-zione per la dottrina della fede, 2001b, 5).
Di modo che, se desidera esistere a questo livello di istituzionalità, la sessione di Sant’Egidio deve assicurare una certa ortodossia ecclesio-logica. In questo modo, il bene comune che emerge dall’incontro non toccherà proprietà dottrinali: il dialogo teologico è impossibile. Il bene comune procederà da un accordo etico (la pace) e spirituale, orientato verso una trascendenza (la pace dono di Dio/nome di Dio). È così che la pace entra in scena.
41 La notificazione è stata pronunciata dal cardinal Ratzinger nel 2001 dopo la pubblicazione di Verso una teologia del pluralismo religioso (Dupuis, 1997). L’opera di-fendeva una teologia della salvezza inclusivista nei confronti delle altre religioni.
MARIE BALAS
– 34 –
La pace annunciata, invocata, performata
Veniamo dunque al secondo punto del nostro studio sulle forme di com-posizione politica qui all’opera: in che modo, negli incontri di Assisi, la «pace, dono di Dio» viene introdotta e mantenuta come un bene co-mune superiore a tutti i partecipanti. Il seguito del quadro etnografico aiuterà a fare chiarezza su questo punto.
Una volta che la processione è terminata e le personalità hanno preso posto, sopraggiungono i discorsi di chiusura. L’arcivescovo, il fondatore di Sant’Egidio e diversi testimoni si succedono sul pulpito. A Lione, cinquant’anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, un monaco buddista pronuncia un discorso su Hiroshima, e un dignitario ebreo un altro su Auschwitz. L’orrore si innalza sulla scena, tematiz-zato nei due discorsi attraverso la metafora dell’inferno: «abbiamo pro-gressivamente sceso i gradini dell’inferno» (a proposito di Auschwitz); «è veramente una scena d’inferno» (a proposito di Hiroshima). Un mi-nuto di silenzio sarà proposto in memoria delle vittime della guerra. Tutte queste prove sono riprese nell’allocuzione dell’arcivescovo Barba-rin e in quella di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità: «Dio è più forte del male, delle nostre montagne di miserie; è per questo che noi crediamo che la pace sia possibile e che pace sia il nome del nostro futuro».
È interessante notare, attraverso questa sequenza di discorsi e te-stimonianze, che la scena non è il luogo di una u-topia astratta dalla storia (e certo non tutte le utopie lo sono). I traumi passati vengono evocati al centro stesso della celebrazione, senza indulgenza per le re-sponsabilità degli uomini. Come la colomba presa nel movimento di-scendente dell’arcobaleno, il «nome del futuro» – il topos del futuro – scende in un presente carico di prove difficili di cui prende atto.
Nell’Anfiteatro delle Gallie, decorato alla maniera di un teatro an-tico – colonne di stucco, edera e addobbi vegetali –, illuminato da nu-merosi proiettori mentre cade la sera, si succedono le sequenze. Tra l’una e l’altra, un coro di bambini opera la transizione; e saranno sem-pre i bambini a trasmettere l’appello di pace agli ambasciatori (infra). Vestiti di bianco, essi partecipano, con il canto, a questa prefigurazione della pace. Possiamo ritenere, a questo proposito, che facciano parte della catena semiologica incaricata di operare questa congiunzione di un futuro escatologico con il presente e il passato 42.
Dopo le allocuzioni e le testimonianze, il bene superiore è invocato direttamente. Un appello di pace viene letto in pubblico. Poi i dignitari
42 Siamo debitori di questa osservazione a Danièle Hervieu-Léger.
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 35 –
religiosi sono a loro volta interpellati l’uno dopo l’altro. Sull’aria del-l’adagio di Albinoni, assistiti da un membro della Comunità, si succe-dono a firmare il testo dell’appello sotto gli applausi dell’assemblea. In seguito ciascuno accende una candela e la sistema su un grande cande-labro piazzato al centro della scena. La notte accresce la visibilità del candelabro. Dopo questo percorso, tornati ai loro posti, i dignitari ri-mettono il testo dell’appello di pace (in piccoli rotoli) ai bambini, che vanno a consegnarli agli ambasciatori e responsabili politici. Questi ul-timi sono ben distinti dalla scena: la separazione delle sfere si applica anche al rituale. Infine, viene annunciato un segno di pace: sul palco e tra l’assemblea, le persone si scambiano un gesto amichevole. Sotto i proiettori e gli applausi del pubblico, imam e rabbini si abbracciano 43. L’intera sequenza è carica di emozione.
In cosa consiste il testo dell’appello di pace? Da un anno all’altro, si rifà ad uno schema ricorrente. È un testo semplice, percorso da me-tafore e parecchie ridondanze, che danno un effetto simile alla scan-sione ritmica. A grandi linee, eccone i motivi principali:
– uomini e donne di tradizioni differenti, siamo qui intervenuti per evocare la pace;
– abbiamo qui ascoltato le sofferenze e le ferite del mondo;– la pace è il nome di Dio. La pace è iscritta al cuore delle nostre
tradizioni religiose;– Dio è più forte delle nostre miserie;– il dialogo non nega le differenze, ci rinforza nelle nostre tradizioni
e ci apre all’alterità;– ci impegniamo e invitiamo il mondo a darsi da fare per la pace.
L’appello di pace è un testo polisemico: sembra comprendere quattro destinatari e mira a compiere altrettante funzioni 44. In primo luogo, si tratta di una preghiera. Fortemente diffuso dai media, è inoltre una di-mostrazione esemplare destinata al mondo civile; è poi un’ingiunzione rivolta al mondo politico, che è tra i destinatari dell’appello; infine è un impegno riflessivo, una promessa alla presenza di testimoni – in par-ticolare testimoni dei mondi associativo, civico e politico. Grazie all’ef-fetto combinato di questi quattro scopi, il testo e il suo con-testo alta-
43 Sottolineiamo l’ispirazione e la tonalità liturgica cristiane di questa cerimonia (fino all’equivalente del segno di pace).
44 È questa molteplicità di destinatari e di funzioni del messaggio che ne garanti-sce, ci sembra, la fruibilità da parte di un pubblico ampio e in parte laico.
MARIE BALAS
– 36 –
mente scenografico e pubblicizzato producono una invocazione (il ter-mine è impiegato dagli attori stessi).
La nostra ipotesi è che qui si giochi qualcosa di importante per chi partecipa: la scommessa della cerimonia è di dire la pace per farla. Si tratta, riferendoci al linguaggio del filosofo John Austin (1987), di rea-lizzare una performance. Tutti gli attori sono concentrati su questa atti-vità delicata che consiste nell’affermare la pace tra i diversi mondi rap-presentati, affinché essa si realizzi. Con il performativo, ci dice Austin, «la verità o falsità di un’affermazione dipende non soltanto dai signifi-cati delle parole ma da quale atto stavi eseguendo in quali circostanze» (ibidem, p. 106). Sono necessarie, affinché una performance vada a buon fine, delle circostanze appropriate, «felici». Si deve scongiurare il fallimento o fattori di vulnerabilità (the infelicities).
Nel nostro caso, allo scopo di consolidare la presupposta equiva-lenza tra la religione e la pace, il conflitto e la discordia non sono eli-minate dalla grande celebrazione finale, ma vi si trovano come rego-late, addomesticate. Nelle tavole rotonde, il loro carattere «caotico» pre-sentava un rischio di destabilizzazione per le istituzioni religiose pre-senti, ritardando così l’esperienza concreta della concordia. Il rituale, in compenso, è in grado di superare questa prova e – nella prospettiva degli organizzatori – trascenderne le difficoltà per giungere ad attualiz-zare la pace. È anche per questo che vi si afferma che le religioni sono ontologicamente pacifiche. Infine, anche l’impegno dei partecipanti alla cerimonia contribuisce alla felicity della performance: per quanto possa, prima o dopo l’incontro, assumere eventualmente una posizione critica, ciascuno vi esegue il ruolo previsto e compie l’azione adeguata (Théve-not, 1990).
L’emozione rende verosimile la performance. Essa proviene, da una parte, dal fatto che la scena lascia intendere (o vedere) una reversibi-lità delle situazioni: scambiandosi un abbraccio di pace e siglando l’ap-pello, i dignitari di religioni talvolta antagoniste fanno apparire la di-scordia come non irreversibile 45. Questa reversibilità per la quale il ri-tuale prefigura e fa sperimentare la pace futura, si appoggia d’altronde su una scenografia accuratamente predisposta.
45 Questo legame tra reversibilità ed emozione è messo in luce in Boltanski et al. (1995).
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 37 –
Prima conclusione:uno spazio pubblico non pluralista in senso agonistico
Tesa verso la pedagogia e l’epifania hic et nunc della pace, la Pre-ghiera Internazionale per la Pace propone un tipo particolare di con-ciliazione tra i diversi mondi. Le istituzioni religiose, fortemente mar-cate sulla scena e nelle tavole rotonde, vengono sostenute in quanto istituzioni che professano la pace. La loro conflittualità è neutralizzata, poiché sono ordinate attorno a un enunciatore centrale e ammettono un’istanza comune superiore e intemporale – la pace, di cui si afferma che sono depositarie. Si attiva dunque un racconto: per tre giorni si apre uno spazio per il confronto ragionevole e l’asserzione della con-cordia. Al termine dell’esperienza, il disordine delle singolarità è risi-stemato, così come i rischi di «contaminazione» tra una confessione e l’altra 46. La controversia appare addomesticata e le istituzioni si tro-vano riunite dalla Chiesa cattolica sotto la cupola civilizzatrice di una protesta di pace. Attraverso il rituale e le tavole rotonde deconflittua-lizzate, tali istituzioni lavorano a riattivare le proprietà «pacifiche» delle religioni e ad offrire al mondo una prova del fatto che la pace è possibile 47.
Questi incontri giocano, sotto diversi aspetti, un ruolo importante per le correnti religiose liberali o moderate messe in difficoltà dagli essenzialismi e dalle accuse di fondamentalismo. Il dispositivo rituale degli incontri di Assisi porta in pubblico attori desiderosi di istituzio-nalizzazione o di riconoscimento, provenienti in particolare dal giudai-smo, dal cristianesimo ortodosso e dall’islam. Questi incontri conferi-scono loro una «presentabilità» nelle società laiche democratiche. In tal senso si può sostenere che la performance evocata sopra funziona, in quanto istituisce pubblicamente dei portavoce di un messaggio pacifico offrendo loro – così come a un pubblico affamato di testimonianze di pace – un’esperienza concreta, corporea ed emozionale, di concordia. La comunità di Sant’Egidio vi figura come «rappresentante e collettore
46 È perciò che parliamo di «racconto», pensando alle proprietà di «messa in or-dine» della narrazione sottolineate in particolare da Ricoeur (1986-8).
47 Il vaticanista americano John Allen esprime molto bene ciò che appare come la prefigurazione escatologica dell’unità, quando nota, in un’intervista ad Andrea Riccardi: «Vari osservatori ecumenici ritengono che si debba riconsiderare ciò che intendiamo per “unità”, poiché se si intende “piena comunione strutturale”, sembrerebbe più simile a un obiettivo escatologico che a qualcosa suscettibile di prodursi qui e ora». Il fondatore di Sant’Egidio risponde: «Il punto è che non possiamo rinunciare all’obiettivo dell’unità. Dobbiamo renderci conto che l’unità non è né impossibile, né rivoluzionaria. [...] Sono convinto che l’unità non sia qualcosa che può essere tralasciato o ritardato. È un tra-guardo fondamentale per la chiesa» (Allen, 2004).
MARIE BALAS
– 38 –
del discorso globale sulla non-violenza» (Abbruzzese, 2006) e rivendica per ciò stesso una centralità della Chiesa cattolica nel campo (concor-renziale e in parte secolarizzato) degli imprenditori di riconciliazione.
In un contesto di globalizzazione scossa dai fondamentalismi, gli incontri di Assisi costituiscono inoltre una piazza ricercata da attori re-ligiosi, politici e civili. Vediamo qui come un principio superiore di na-tura etica (la pace) offra una presa alla quale ogni istituzione di senso, ogni mondo, può ricorrere per consegnare un messaggio comune. È perciò che i partecipanti di istituzioni diverse dalla Chiesa cattolica ac-cettano il gioco, spesso consapevoli dei compromessi a cui ciò li con-duce.
Con quale tipo di filosofia politica abbiamo qui a che fare? Proce-dendo per eliminazione, appare che ciò che è all’opera:
– non è evidentemente un paradigma relativista, nel quale le singo-larità sarebbero poste sullo stesso piano e fuse nell’equivalenza;
– non è neppure, com’è evidente, un modello di scontro di civiltà, con un conflitto dato come immanente alle rispettive tradizioni re-ligiose;
– ma poiché gli incontri di Assisi combattono quest’ultimo modello, è la pace che viene qui assolutizzata e intesa come immanente alle tradizioni, di cui assorbe la conflittualità. La grammatica in gioco ad Assisi sembra essere un addomesticamento delle controversie (da parte di un certo tipo di rituale e di simbolismo);
– questo modello, piuttosto che quello di una filosofia pluralista, sem-bra cogliere al meglio lo spirito della manifestazione. Il pluralismo implica un confronto organizzato, un momento agonistico caratte-rizzato dalla «simmetrizzazione» – anche se provvisoria – degli at-tori e dal loro consenso ad esporsi alle alterazioni dell’interazione. In questa grammatica, il conflitto – assecondato, riconosciuto, codi-ficato e provvisorio – e il dibattito che esso provoca, sono gli ele-menti federatori e dinamici 48. Il bene comune è allora quello che risulta dal confronto, piuttosto che ciò che lo precede.
Negli incontri di Assisi, quando la pace è invocata-convocata come principio già potenzialmente presente, l’attività agonistica è sospesa e, soprattutto, idealmente e metaforicamente risolta. Questo stato di cose pone l’interrogativo dell’efficacia – al di là di quella simbolica – del di-
48 Pensiamo ovviamente a Simmel e ai suoi lavori sulla socializzazione per mezzo del conflitto, ma soprattutto al commento, ispirato dalla filosofia dell’azione di Hannah Arendt, che si ritrova in Le bien public. Pour une cosmopolitique des conflits (Tassin, 2003).
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 39 –
spositivo pubblico di questi incontri, anche se – ed è questa, verosimil-mente, la scommessa di Sant’Egidio – non è possibile escludere a que-sto proposito che la performance lasci tracce nell’esperienza culturale di taluni invitati e nello «stock culturale» del pubblico. D’altra parte, in virtù degli elementi individuati nel corso di questo studio, non c’è alcun dubbio che una grammatica pluralista a questo livello di istituzionalità sarebbe, a rigore, irrealizzabile 49. Ci si può tuttavia domandare se una cosmopolitica oggi, una politica della pluralità dei mondi, non ha bi-sogno inoltre che siano affermate o suggerite pubblicamente le virtù agonistiche del dialogo. È ciò a cui s’impegnava il presidente di seduta menzionato sopra, nel momento in cui chiedeva ai convenuti di «par-lare di ciò che crea problema». In linea generale, per quanto concerne questo tipo di avvenimenti, la questione di un quadro di conciliazione tra i singoli rimane aperta.
Seconda conclusione: un’efficacia infra-istituzionale
La dimensione informale degli incontri di Assisi, quella che sfugge allo sguardo esterno, va messa in corrispondenza con il dispositivo pubblico della manifestazione. Per quanto possano avanzare riserve sull’adegua-tezza delle tavole rotonde o della cerimonia, i partecipanti ricordati in precedenza sono presenti ogni anno e persino, a quanto sembra, non mancherebbero per nessuna ragione.
Nel caso di questi attori, il contrasto tra la manifestazione in e l’ammirazione per l’organizzazione out, ci fornisce un indizio sullo spa-zio in cui ha luogo la conciliazione tra i mondi. Se l’incontro in è in qualche modo saturo di trascendenza, e di una pace che saremmo ten-tati di qualificare come estatica, lo spazio dietro le quinte è il luogo della rete di contatti e di una immanenza padroneggiata. In questo spa-zio difeso dal segreto, Sant’Egidio trasferisce la sua competenza diplo-matica.
Diversi partecipanti ci hanno descritto un’organizzazione «mor-bida», che facilita i contatti e gli incontri faccia a faccia tra gli in-vitati-conferenzieri. A ciascuno è assegnato durante tutto l’incontro un accompagnatore. Si tratta di membri confermati della Comunità, i quali hanno l’incarico di assistere i loro ospiti, di aiutarli a orientarsi nell’incontro o a risolvere i problemi materiali che si presenteranno. Questi accompagnatori hanno inoltre il compito, se è il caso, di creare occasioni d’incontro con altri conferenzieri, soprattutto in circostanze
49 Questa estrema fragilità del dibattito interreligioso istituzionalizzato, e le stra-tegie di evitamento e di elusione del conflitto, sono descritte con precisione in Lamine (2004).
MARIE BALAS
– 40 –
diplomatiche delicate, oppure di soddisfare le richieste di presa di contatti. Secondo i nostri intervistati, che sono pratici di grandi con-ferenze internazionali, tale dispositivo, qualificato come «originale», funziona molto bene ed è giudicato molto favorevolmente. Essi ci de-scrivono una semplicità, leggerezza e reattività che permettono pro-gressi significativi nelle deliberazioni e nei contatti informali, sia in ambito diplomatico che religioso. È là, senza ombra di dubbio, che si dispiega la vera forza di questi incontri.
È difficile, per definizione, svelare etnograficamente questo oggetto out 50. Di sicuro, comunque, esiste durante gli incontri di Assisi un ap-proccio pragmatico al dialogo e alla conciliazione. Esso si nasconde allo spazio pubblico: se vi è confronto, disaccordo o negoziazione, ciò ac-cade nell’infra-istituzionale. Questa opzione «infra» può probabilmente essere intesa in termini di vincoli normativi (ecclesiali), di cultura po-litica e – il che è cruciale – di efficacia diplomatica (nel senso più am-pio del termine). Gli incontri di Assisi costituiscono una sorta di piat-taforma in cui si stringono e si sciolgono contatti e vengono provocate delle occasioni che possono anche, se del caso, strutturarsi in attività specificamente diplomatiche (nel senso politico del termine) 51.
Così, quanto viene scartato dallo spazio pubblico dell’incontro è in qualche modo ridistribuito nella sfera confidenziale, privata o infor-male: è là che si dispiega l’attività liminale evocata più sopra. Senza dubbio siamo di fronte a un modo di stringere intese e di evocare con-troversie che ha mostrato storicamente la sua validità, specialmente dopo la fine della bipolarità e la ridefinizione delle linee di conflitto. In ragione dell’agilità e flessibilità proprie al segreto, quest’attività con-tinua di creazione di reti offre una risposta pragmatica, empirica, al problema della conciliazione tra i mondi. Per un’antropologia filosofica e politica del contemporaneo, sembra interessante soffermarsi oggi sui luoghi e le forme – agli incontri di Assisi e in qualunque altra mani-festazione – in cui potrebbe profilarsi uno spazio pubblico agonistico, una cosmopolitica in grado di confrontare tra loro i diversi pretendenti alla Veritas.
(Traduzione di Isacco Turina)
50 Si veda l’analisi di Colonomos (2000), che parla, a proposito degli incontri di Assisi, di «mesodiplomazia» o «diplomazia dal mezzo».
51 Cfr. Colonomos (2000); Borgomano-Loup (2006); Balas (2007); Dupuy (2007).
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 41 –
Riferimenti bibliografici
Abbruzzese, S.2006 Recensione a «J.-D. Durand, L’esprit d’Assise. Discours et messages de Jean-
Paul II à la Communauté de Sant’Egidio», in Archives de sciences sociales des religions, 134, p. 134.
Allen, J.L.2004 «Interview with Sant’Egidio Founder Andrea Riccardi», in National Catholic
Reporter, 23 luglio, http://ncronline.org/mainpage/specialdocuments/riccardi.htm, consultato il 26/10/2007.
Austin, J.L.1987 Come fare cose con le parole (1962), Genova, Marietti.
Balas, M.2007 «Sociologie d’une diplomatie: décrire l’internationalisation de la Communauté
Sant’Egidio», in B. Duriez, F. Mabille, K. Rousselet (a cura di), Les ONG confes-sionnelles. Religions et action internationale, Paris, L’Harmattan, pp. 185-199.
Boltanski, L., L. Thévenot1991 De la justification, Paris, NRF Gallimard.
Boltanski L., M.-N. Godet, D. Cartron1995 «Messages d’amour sur le téléphone du dimanche», in Politix, 31, pp. 30-76.
Borgomano-Loup, L.2006 «La médiation internationale religieuse: le cas de Sant’Egidio», in Agir, 24,
pp. 99-120.
Callon, M., P. Lascoumes, Y. Barthe2001 Agir dans un monde incertain: essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil.
Centemeri, L.2006 Ritorno a Seveso, Milano, Bruno Mondadori.
Claverie, E.2003 Les guerres de la Vierge, Paris, Gallimard.
Colonomos, A.2000 Églises en réseaux. Trajectoires politiques entre Europe et Amérique, Paris,
Presses de Sciences Po.
Comunità di Sant’Egidio1994 Il dialogo non finisce, Brescia, Morcelliana.
2006 Facciamo pace. Piccoli sguardi sulle guerre dei grandi, Roma.
Congregazione per la dottrina della fede2001a «Notificazione a proposito del libro del p. Jacques Dupuis, s.j., Verso una
teologia del pluralismo religioso», http://www.vatican.va/roman_curia/con-gregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010124_dupuis_it.html, con-sultato il 26/10/2007.
2001b «Articolo di commento della notificazione della Congregazione per la Dot-trina della Fede a proposito del libro di padre J. Dupuis Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso», http://www.vatican.va/roman_curia/con-gregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010312_dupuis-2_it.html, consultato il 26/10/2007.
Diotallevi, L.2001 Il rompicapo della secolarizzazione italiana: caso italiano, teorie americane e
revisione del paradigma della secolarizzazione, Soveria Mannelli, Rubbettino.
MARIE BALAS
– 42 –
Dupuis, J.1997 Verso una teologia del pluralismo religioso, Brescia, Queriniana.
Dupuy, E.2007 «Géopolitique de la médiation informelle: l’exemple de la Communauté de
Sant’Egidio», in Géostratégiques, 16, pp. 153-162.
Durand, J.-D.2003 L’Esprit d’Assise. Discours et messages de Jean-Paul II à la Communauté de
Sant’Egidio, Paris, Cerf.
Gagliardi, P., B. Latour (a cura di)2006 Les atmosphères de la politique, Paris, Seuil.
Gutwirth, S.2004 «Le cosmopolitique, le droit et les choses», in Cosmopolitiques, 8, pp. 77-88.
Hervieu-Léger, D.1973 De la mission à la protestation, Paris, Cerf.
2003 Il pellegrino e il convertito. La religione in movimento (1999), Bologna, Il Mulino.
Lamine, A.-S.2004 La cohabitation des dieux, Paris, PUF.
Latour, B.2002 War of the Worlds: What about Peace?, Chicago, Prickly Paradigm Press.
2006 Changer de société. Refaire de la sociologie, Paris, La Découverte.
Lemieux, C.2000 Mauvaise presse, Paris, Métailié.
Menozzi, D.1984 «La Chiesa e la storia. Una dimensione della cristianità da Leone XIII al Vati-
cano II», in Cristianesimo nella storia, 5, pp. 69-106.
Piette, A.1999 La religion de près, Paris, Métailié.
Riccardi, A.1997 Sant’Egidio, Roma e il mondo. Colloquio con Jean-Dominique Durand e Régis
Ladous, Cinisello Balsamo, San Paolo.
2004 La pace preventiva, Milano, San Paolo.
2006 Convivere, Bari, Laterza.
Ricoeur, P.1986-8 Tempo e racconto (1983-5), Milano, Jaca Book, 3 voll.
Séguy, J.1999 Conflit et utopie, ou reformer l’Église, Paris, Cerf.
Stengers, I.2005 Cosmopolitiche (1996-7), Roma, Sossella.
Tassin, E.2003 Le bien public. Pour une cosmopolitique des conflits, Paris, Ellipses.
Thévenot, L.1990 «L’action qui convient», in P. Pharo, L. Quéré (a cura di), Les formes de l’ac-
tion, Paris, Éditions de l’EHESS, pp. 36-69.
2006 L’action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement, Paris, La Décou-verte.
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO A SANT’EGIDIO
– 43 –
Tosi, S., T. Vitale2007 «Responsabilité directe. Hybridations croisées entre catholiques et laïcs dans
les mouvements pour la paix en Italie», in I. Sommier, O. Fillieule, E. Agri-kolianky (a cura di), La généalogie des mouvements antiglobalisation en Eu-rope, Paris, Karthala, pp. 187-206.
Turner, V.1977 «Variation on a Theme of Liminality», in S. Moore, B. Myerhoff (a cura di),
Secular Ritual, Assen e Amsterdam, Van Gorcum, pp. 36-52.
1992 «Dewey, Dilthey and Drama: an Essay in the Anthropology of Experience», in V. Turner, E.M. Bruner (a cura di), The Anthropology of Experience, Urbana, University of Illinois Press, pp. 33-44.