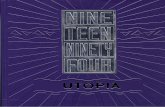La pace in Cusano. Tra ontologia e utopia
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La pace in Cusano. Tra ontologia e utopia
PENSARE LA PACEIL LEGAME IMPRENDIBILE
A cura diFrancesca Bonicalzi
Testi diMatteo Amori, Serenella Armellini, Gianni Bianchi,
Francesca Bonicalzi, Vincenzo Costa, Gianfranco Dalmasso,Silvano Facioni, Massimo Guidetti, Maria Teresa Maiocchi,
Sante Maletta, Saverio Matrangolo, Marco Maurizi,Fabrizio Palombi, Vincenzo Rizzo, Teresa Serra
V
Presentazione. Parole di pace, di Francesca Bonicalzi IX
Capitolo I LA PERSONA E I SUOI LEGAMI 1
La giustizia e il pudore, di Gianfranco Dalmasso 3Il patto e la città 3La pietà di Zeus 6Il possesso vicario 7Essere di confine 9Il senso del pudore 11La pace in-stabile 13
La pace fuori garanzia, di Francesca Bonicalzi 17Perché la guerra? 17Pace perpetua 20Pace e natura del legame 24L’audacia della pace 28
Pace nel nome, di Maria Teresa Maiocchi 33Domesticità senza pace 33Senza garanzia 37Guerre e paci 40
INDICE
Indice
VI
Crisi 44Generare, Se-parere, Riprodurre 47Fuori pista 51Pieni e vuoti 55Fare ed essere 58Non senza pace 62
“Šalom, šalom al lontano e al vicino” (Isaia 57,19): luoghi della pace, tempi dello šalom, di Silvano Facioni 65Orizzonti biblici 67Orizzonti rabbinici 73Il congedo dello šalom 80
Capitolo II RIDEFINIZIONI 85
Progetti e processi di pace da Teodorico a Paolo Diacono, di Massimo Guidetti 87Goti 89Longobardi 100Conclusione 114
“Ospite dal futuro”. La prospettiva del diritto per l’uomo, di Serenella Armellini 117
Ordine e mutamento nel rapporto tra culture, di Teresa Serra 145
Capitolo III L’ORDINE DEL GIUSTO 155
Platone: la legge al posto della pace, di Vincenzo Costa 157La legge e l’origine 157
Indice
VII
Volontà e autocoscienza 160Colpa 164Giustizia e godimento 166Legge e autocoscienza 167Ordinamento giuridico e coscienza di sé 168Legge, supplemento, scrittura 171Il movimento della giustizia e la legge 174Socrate e Callicle redivivi 175
Tra utopia e ontologia. La questione della pace in Cusano, di Marco Maurizi 177L’utopia religiosa del De pace fidei 177Una pace rischiosa 180La diversità necessaria 185Un’ontologia della pace 188Pensare in concordia 192
Una strada di uomini. Maurice Blondel e la costituzione della pace, di Gianni Bianchi 195Una questione antropologica 197Un uomo nuovo? 203Cosa significa la pace 210
La pace tra Genio della guerra e Ausgleich. Max Scheler tra due fuochi, di Matteo Amori 213Il “genio” della guerra e i pacifismi 216La realtà spirituale della guerra 217La radice personalistica del problema 222Pentimento e perdono 225Dalla pace all’Ausgleich 230
Immanentismo e teologizzazione del conflitto. A partire da Carl Schmitt, di Sante Maletta 239La decisione come mediazione 240Il caso Hobbes 242Neutralizzazione “attiva” e “passiva” 244La logica perversa del valore 246Incondizionalità e trascendenza 249
Indice
VIII
Una prospettiva impolitica contro l’ideologia del giorno. Jan Patocka e la ripresa del po vlemo~ eracliteo, di Saverio Alessandro Matrangolo 257
“La pace della sera”: considerazioni fenomenologiche sul terzo seminario di Lacan, di Fabrizio Palombi 279Un soggetto senza pace 280Soglie 283Metafisica freudiana 286Endofasie 289
Nella Pace del Nome: il Breve Racconto dell’Anticristo di Solov’ev, di Enzo Rizzo 293
Indice dei nomi 325
181
TRA UTOPIA E ONTOLOGIA. LA QUESTIONE DELLA PACE IN CUSANO
diMarco Maurizi
L’utopia religiosa del De pace fidei
All’indomani della caduta di Costantinopoli, di fronte all’inasprir-si dei rapporti tra cristianesimo e Islam, Nicola Cusano elaborò una proposta per realizzare una concordantia tra le diverse fedi che appa-re ancora oggi di straordinario interesse, sia per l’arditezza pragma-tica che per la profondità teorica dell’approccio sostenuto. L’opera, come noto, presenta al lettore una sorta di Concilio Religioso Univer-sale che si svolge in cielo al cospetto di Dio. La cornice celeste ci ri-manda a una visione che, come ci informa Cusano in apertura, avreb-be rapito un uomo molto pio, scosso dalle notizie che giungevano da Costantinopoli e che descrivevano atrocità e violenze commesse in nome della fede, mostrandogli l’unica via per poter realizzare una «pace perpetua»1 (perpetuam pacem) tra i popoli. Si tratta del tentati-vo di realizzare una religione universale in cui tutte le religioni possa-no trovare compimento in «una fede ortodossa»2 (unam fidem ortho-doxam) verace e pacificante.
Cusano ribadisce a più riprese che ciò che è in discussione è la pos-sibilità di fondare la pace «della fede», di celebrare finalmente una concordia «religiosa» e non, quindi, di realizzare una sorta di para-
1 N. Cusano, La pace nella fede, in Id., Opere religiose, a cura di P. Gaia, UTET, To-rino 1993, p. 619. 2 Ibid., p. 625 (trad. modificata).
Marco Maurizi
182
diso in Terra. Se il De pace fidei ha i caratteri dell’“utopia”, si tratta di un’utopia religiosa e non politica. Il progetto elaborato da Cusano non esclude, insomma, che l’umanità possa continuare a farsi violen-za. Ciò che Cusano vuole evitare, perché gli appare intollerabile e con-trario allo spirito stesso della religione, è che gli esseri umani si uccida-no in nome di Dio. Il De pace fidei, in sintesi, è una sorta di maestoso esperimento mentale che ha però tutta la serietà di una proposta ope-rativa di dialogo tra fedi diverse allo scopo di cercare una matrice co-mune in grado di armonizzare gli eccessivi contrasti politico-religio-si del tempo: non la caccia a un sincretismo privo di rigore, dunque, ma la ricerca di quella verità che attivamente struttura le diverse fedi dall’interno allo scopo, come diremo, di esaltarne e non di sopprimer-ne la diversità.
Il De pace fidei, da questo punto di vista, ha suscitato sempre rea-zioni contrastanti. Da un lato, lo si è inteso come una sorta di apologia del cristianesimo. Alla fine, potrebbe sembrare che Cusano monti una sorta di tribunale celeste in cui le varie religioni vengono razionalmen-te costrette a riconoscere la superiorità del cristianesimo. D’altro can-to, il De pace fidei non ha cessato di essere letto in chiave modernizzan-te, come anticipazione dell’indifferentismo religioso illuministico. Si tratta di un contrasto di non facile soluzione. È ovvio, infatti, che le in-terpretazioni «lessinghiane» dell’opera sono totalmente anti-storiche3. Tuttavia, per quanto inadeguate, esse non vanno completamente rifiu-tate. Il fatto che a condurre il colloquio siano figure centrali della reli-gione cristiana (i protagonisti dell’opera sono il Verbo, san Pietro e san Paolo che dialogano con alcuni sommi sapienti in rappresentanza delle diverse religioni) non deve trarre in inganno: la religione che realizze-rà la pace tra le fedi non è il cristianesimo, benché quest’ultimo sia ciò che più si avvicina alla vera religione universale. Si potrebbe dire che Cusano è interessato a definire i tratti di una religione trascendentale ri-spetto cui tutte le religioni storico-empiriche, compresa quindi la reli-gione cristiana, non possono che rimanere su un piano di inferiorità4.
3 Per una messa a punto del rapporto tra il pensiero cusaniano e la modernità cfr. M. Maurizi, La nostalgia del totalmente non altro. Cusano e la genesi della modernità, Rubbettino, Soveria Manelli 2007, cui rimandiamo per un’analisi più circostanziata della problematica politico-religiosa in questo autore. 4 Abbiamo affrontato tale questione in modo analitico in M. Maurizi, La nostalgia del totalmente non altro, cit., pp. 137ss.
Tra utopia e ontologia. La questione della pace in Cusano
183
La vera obiezione alle letture modernizzanti di Cusano dovrebbe inve-ce ribadire come esse manchino il colpo rispetto al nucleo teorico più vivo e sorprendente della riflessione del Cardinale. È alla delucidazio-ne di questo aspetto che intendiamo quindi rivolgerci.
È la comprensione di questo nucleo sfondo che permette di osser-vare dalla giusta angolatura il movente e l’esito dell’opera di Cusano, quali che possano essere state le preoccupazioni dottrinali del Cardi-nale. È senz’altro significativo che Cusano si sia deciso a inseguire la strada del dialogo e non quella delle armi, come pure sembrava esse-re nelle intenzioni di alcuni principi e addirittura del Papa. La salda convinzione che solo il dialogo, l’apertura all’altro, potesse sperare di realizzare quel cambiamento che la lotta politico-religiosa non sem-brava in grado di produrre, è sintomatico di uno spirito che concepi-sce la pace come causa piuttosto che come effetto, come forza unitiva che attraversa e trascende chi ne partecipa: essa non è, e non può es-sere, il prodotto di una volontà che si impone, né con la legge, né tan-tomeno con la spada.
Quel che ci interessa mettere a fuoco, in tal senso, è la fondazio-ne teorica del concetto di pace che occorre svincolare dalle sue ap-plicazioni e dalle ricadute sul piano della prassi politica e religiosa di un’epoca che non è più la nostra. È necessario quindi calibrare la que-stione della pace, collocandoci in qualche modo in una zona interme-dia tra la dimensione siderea della metafisica e l’urgenza infuocata del-le lotte religiose e politiche che assorbirono l’attenzione di Cusano.
Ora, come l’intera filosofia di Cusano testimonia, solo la pace è produttiva di pace. Questo assunto ha due lati: uno, in base al quale, la pace è un vero e proprio principio metodologico5; l’altro, che sostie-ne la verità del primo, è legato alla tesi ontologica (e storica)6 di una fondamentale «concordanza» tra gli esseri.
5 Per il concetto di pace come «metodo» cfr. J. Ries, Nicola Cusano e la pace come metodo, introduzione a N. Cusano, La pace della fede, Jaca Book, Milano 1991, rist. in J. Ries, Opera omnia, Jaca Book, Milano, pp. 157ss.6 Non è possibile qui nemmeno accennare al tema della «concordia» nel senso della prima opera di Cusano – il De concordantia catholica – dove si affronta in generale il problema dell’organizzazione sociale e del rapporto tra potere politico e ordine della salvezza. Tale esclusione trova comunque anche una motivazione teorica nel fatto che in quest’opera non sono stati ancora sviluppati i temi classici della speculazione cusa-niana. Cfr. però M. Maurizi, La nostalgia del totalmente non altro, cit., pp. 35-143.
Marco Maurizi
184
Per quanto riguarda il primo punto, possiamo notare come, a mon-te del contenuto del De pace fidei, il «messaggio di pace» si dispie-ghi già nel modo originale di organizzazione dell’opera. L’andamento del colloquio è tripartito e condotto secondo una logica scrupolosa: il Verbo è infatti invitato a parlare di Dio, san Pietro dell’Incarnazione del Verbo, san Paolo del rito nella sua forma universale. Si tratta di un andamento discendente che ha una chiara derivazione neoplatonica e che, tuttavia, qui sembra avere maggiormente a che fare con il nucleo speculativo dello scritto e il fondamento stesso di una pace possibi-le: si tratta del principio secondo cui la verità è sempre detta dall’al-tro. Non è Dio infatti a parlare di sé, ma lascia che sia il Figlio a far-lo. E non è il Verbo a parlare della propria incarnazione ma lascia che sia il suo rappresentante in Terra a farlo. E così non è Pietro a parlare di un rito, cui egli presiede e che si pone come il più vicino alla purez-za della religione universale cui tutti i popoli tendono, ma Paolo. Infi-ne, non sfuggirà come la stessa finzione letteraria che apre l’opera e in cui si racconta di una visione che ha come protagonista un terzo e non l’autore materiale del dialogo possa rientrare in questo meccanismo di smarcamento da una verità intesa come possesso.
La verità che, a livello antropologico, si mostra nell’apertura al dia-logo si fonda però su una più ampia visione ontologica, secondo cui la verità è un fare spazio all’alterità, lasciar-essere l’altro-da-sé. In tal sen-so, come cercheremo di evidenziare, l’amore che lega le creature tra di loro nel rispetto reciproco è fatto della stessa pasta dell’amore che lega la creatura al creatore.
Una pace rischiosa
La supplica che gli uomini e le potenze celesti rivolgono a Dio nel De pace fidei per il raggiungimento di una concordia tra le diverse fedi, ipotizza la possibilità che la diversità delle religioni e dei culti possa essere essa stessa intesa ad majorem dei gloriam:
Se ti degnerai di ascoltarci, cesserà la spada, il livore dell’odio e qualun-que altro male, e tutti sapranno che non c’è che una che sola religione nella varietà dei riti. Se poi non fosse possibile eliminare questa differen-za di riti, oppure non fosse conveniente, in quanto la loro stessa varietà costituisce un incremento della devozione, poiché ogni paese cercherà di
Tra utopia e ontologia. La questione della pace in Cusano
185
celebrare con più zelo le proprie cerimonie credendole più gradite alla tua Maestà, che almeno possa esservi una sola religione ed un solo culto di latria, come unico sei Tu stesso7.
Cade in questo passaggio la nota la formula con cui Cusano definisce la possibilità di una convivenza pacifica tra le fedi: una religio in rituum varietate. Ora, è significativo che tale espressione venga usata da Cu-sano ben prima della stesura del De pace fidei: si trova infatti già nel-la prima opera sistematica del Cardinale, il De concordantia catholica8. Nel De pace fidei, Cusano tenta però più esplicitamente di considerare in modo specifico in che senso la molteplicità delle fedi risulti in un’ar-monia. Attraverso il concetto di presupositio fidei (presupposizione di articoli di fede inespressi nelle altre religioni in base a un ragionamen-to logico che muove dai presupposti di quelle) Cusano teorizza una im-perscrutabile coincidenza delle religioni nella religione universale. Che non si tratti né di sincretismo, né di indifferentismo è mostrato dal fatto che quell’accordo tra le diverse fedi che determina in controluce il con-tenuto della religione universale, necessita a sua volta dell’idea stessa di questa religione per determinare la natura e l’ampiezza di quest’accor-do. Non si tratta, cioè, di compiere una media o una sintesi empirica tra le diverse dottrine, quanto di delineare l’unità originaria di esse, ciò che le unisce nella diversità. È incontestabile che il cristianesimo giochi per Cusano un ruolo di primo piano nella ricerca di questa concordan-za delle fedi. E tuttavia è importante sottolineare come il cristianesimo non sia sic et simpliciter questa stessa religione universale9.
7 N. Cusano, La pace nella fede, cit., pp. 622-623. 8 «È sempre un’unica e identica religione che viene venerata e professata, ora con certi usi e riti, ora con altri, dapprima in modo più oscuro e poi più chiaro, prima da pochi uomini, poi da molti, N. Cusano, La concordanza universale, in Id., Op. religio-se, cit., p. 142. 9 «Naturalmente», scrive invece Vasoli, «il Cardinale di S. Pietro in Vincoli concepi-va la pax fidei dal punto di vista della rivelazione cristiana». C. Vasoli, L’ecumenismo di Niccòlò da Cusa, in C. Vasoli (e altri), Cusano e Galileo, Archivio di Filosofia, III, CE-DAM, Padova 1964, p. 17. Ma come si esprime meglio Flasch, il tentativo messo in atto da Cusano nel De pace fidei è quello di «guardare il modo di pensare cristiano con gli occhi degli altri», K. Flasch, Geschichte einer Entwicklung Vorlesungen zur Ein-fuhrung in seine Philosophie, Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M. 1998, p. 379. Cfr. anche W.A. Euler, Nikolaus von Kues als Wegbereiter des interreligiosen Dialogs und der Theologie der Religionen, in Nikolaus von Kues 1401-2001. Akten des Symposiums
Marco Maurizi
186
È chiaro che l’obiettivo principale di Cusano – e l’ostacolo maggio-re da superare – è la pace con l’Islam, obiettivo al quale la pace con le altre religioni è qui subordinato. Cusano affronta tutti i motivi di dissi-dio teologici tra cristianesimo e Islam mosso da due presupposti con-trastanti e forse un po’ troppo impegnativi: 1) le due fedi devono ne-cessariamente essere concordi tra loro, anche se apparentemente non lo sono; 2) tale armonia, una volta esplicitate quelle nozioni implicite che ne mostrano l’effettiva concordia, non ne sacrifica la specificità.
Il problema della concordanza tra la dottrina trinitaria e il rigido monoteismo dell’Islam viene risolto tramite il ricorso alla teologia ne-gativa, secondo cui Dio «come infinito, non è né trino né uno»10. È in-fatti, precisa Cusano, solo nel suo ruolo di creatore (ut creator) che Dio agisce come trino. E la dimostrazione di questo assunto teologico è ov-viamente un compendio delle posizioni ribadite dallo stesso Cusano più volte nei suoi scritti. Più difficile è far accettare l’idea che Cristo sia il mediatore e che il riconoscimento della sua divinità sia conditio sine qua non della salvezza. Su questo punto Cusano si impegna maggior-mente che su altri, non solo perché si tratta di una questione irrinun-ciabile per il cristianesimo ma soprattutto perché è convinto che solo l’accettazione di questo punto da parte delle altre fedi potrebbe aprire la strada a una conciliazione reale delle diverse religioni.
In un passaggio cruciale del dialogo, Cusano stabilisce anzitutto la piena “umanità” di Cristo; in base a questa considerazione, Cristo non è ancora riconoscibile come Verbo, e anzi si può tranquillamente dire, e lo si deve, che in quanto uomo egli non è affatto Dio: «in Cristo la natura umana era perfettissima, e per essa egli era vero uomo e morta-le come tutti gli altri uomini e quindi, secondo questa natura, egli non era Verbo di Dio»11. Dio ha posto il suo Verbo in Cristo così come lo ha posto in tutti i suoi profeti sebbene, come Pietro fa abilmente af-fermare al persiano: «Cristo è il più grande di tutti i profeti»12. La stra-tegia di Cusano è quella di mostrare come il semplice affermare che Cristo sia perfezione dell’uomo costringa ad ammetterne la divinità e il punto di partenza è, appunto, il riconoscimento, comune anche
in Bernkastel-Kues vom 23. bis 26. Mai 2001, Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus, 28, Paulinus, Trier 2003, pp. 211-231.10 N. Cusano, La pace nella fede, cit., p. 634. 11 Ibid., p. 645. 12 Ibidem.
Tra utopia e ontologia. La questione della pace in Cusano
187
all’Islam, della saggezza di Cristo. Se è vero, argomenta Cusano, che la saggezza di Cristo fu umana, essa fu, tuttavia, anche la massima sag-gezza possibile, di fronte a cui non ce ne può essere una maggiore. In base a questa sola considerazione è possibile per Cusano dedurre la piena divinità dell’uomo Cristo:
Ammettiamo ora che l’intelletto di qualche uomo possegga un magistero ed una sapienza tale da non poterne conseguire una maggiore; in tal caso l’intelletto di quest’uomo sarebbe unito in massimo grado alla Sapienza in sé o al Magistero in sé, tanto che questa unione non potrebbe essere mag-giore. In tal caso quest’intelletto, in virtù della massima Sapienza e del massimo Magistero ai quali è unito, non avrebbe conseguito la potenza divina? [...] Quando l’unione della natura umana inferiore con la natura divina fosse tanto grande da non poter essere maggiore, allora la natura umana sarebbe unita alla divina anche in un’unione personale. Infatti, fino a che una natura inferiore non sia elevata all’unione personale e ipo-statica con la natura superiore, essa può ancora essere aumentare13.
Se la saggezza profetica implica una forma di “unione” col divino, l’unio-ne che si realizza in Cristo è quella massima possibile per un essere uma-no. L’unificazione con Dio non può perciò essere più intesa per mez-zo della semplice grazia, essa è personale e unica, poiché quando non c’è alcun “più o meno” la creatura coincide con Dio, massimo assoluto.
Per superare, infine, il problema che alcune religioni non ricono-scono né Cristo né la sua saggezza superiore, Cusano teorizza la ne-cessità per ogni religione di pensare la figura del Redentore. L’uomo, infatti, cerca la perfezione della propria essenza. Questa non deve es-sere impossibile ma essere concreata in un uomo come massima rea-lizzazione cui nulla di più perfetto può seguire. Tale massimo è, ap-punto, Cristo14.
13 Ibid., p. 469. 14 Ma in questo caso il Quod Erat Demonstrandum non appare tanto convincente. Il problema non è solo che non è affatto agevole dimostrare la necessità di quel massimo a partire da un anelito di perfezione proprio della specie. Il problema è dimostrare la necessità che quel massimo sia già stato, cioè che la figura del Redentore si sia già manifestata nel tempo e non sia invece di là da venire. Tale convinzione, centrale per il cristianesimo, appare inconciliabile con la fede ebraica e incrina dall’interno il sogno ecumenico di Cusano. Contro gli ebrei, infatti, che un tale massimo ancora aspettano, l’argomento non tiene. E ciò spiega forse la violenza e l’intolleranza di Cusano nei loro confronti: «tutte quelle verità su Cristo gli Ebrei le hanno nelle loro Scritture,
Marco Maurizi
188
È da notare come, nonostante l’acume teologico, persino l’astuzia, con cui Cusano porta avanti il suo discorso sulla una religio, il De pace fidei non è una specie di trappola in cui ingabbiare le religioni del mon-do per convertirle al cristianesimo. Gli sforzi ecumenici di Cusano sono sinceri, le concessioni all’idea di religione universale sono parecchie e rilevanti: oltre ad aver in certo qual modo subordinato la trinità di Dio all’unità e aver razionalizzato il mistero di Cristo e il suo ruolo di reden-tore ponendolo come “perfezione” dell’uomo, nel De pace fidei Cusano è costretto a una certa svalutazione delle opere15 e all’ammissione che l’eucarestia non è necessaria alla salvezza16. Si potrebbe anche pensare che gli sforzi cusaniani avrebbero potuto mettere a repentaglio l’unità cristiana piuttosto che favorire il dialogo con le altre fedi.
La pace della fede di Cusano vuole infatti essere una vittoria del cristianesimo senza sconfitta delle altre religioni. Il suo progetto è am-bizioso: mostrare che il cristianesimo, ricondotto pienamente a se stes-so, si fa portavoce di una religione universale che concilia tra loro tut-te le fedi. Ma questa conciliazione è un trionfo del cristianesimo che coincide con la sua dissoluzione nell’annuncio di un superiore ecu-menismo e tanto più il cristianesimo come tale si avvicina alla purez-za della religione universale che prefigura, tanto più doloroso appa-re il suo auto-sacrificio in nome della pace. Poiché il fattore distintivo della fede cristiana è proprio la convinzione di portare un messaggio già universale, quella “pace perpetua”17 che sarebbe stata impensabi-le senza Cristo18, assomiglia anche, inevitabilmente, a una ritirata. Ma è possibile pensare una tale ritirata che abbia la forma del trionfo, un
ma non vogliono comprenderle, essendo asserviti al senso letterale. Tuttavia, questa resistenza dei Giudei, non impedirà la concordia. Poiché essi sono poco numerosi e non potranno turbare con le armi tutto il mondo». Ibid., p. 652.15 «La salvezza dell’anima si ottiene non in forza delle opere ma in forza della fede [non ex operibus sed ex fide]», ibid., p. 663.16 Facendo intervenire il Boemo nel dialogo Cusano gli concede di definire in questi termini l’eucarestia: «capisco in che modo in questo sacramento è il cibarsi della vita eterna... e capisco in che modo in questo sacramento dell’eucarestia è la similitudine di ciò». Ibid., p. 671 (trad. mod.). 17 Ibid., p 673. 18 In questo senso ristretto è allora vero che nel De pace fidei il cristianesimo ha un “privilegio” rispetto alle altre religioni. Cfr. M. Watanabe, Nicholas of Cusa and the Idea of Tolerance, in Nicolò Cusano agli inizi del mondo moderno, Atti del convegno internazionale di Bressanone (6-10 settembre 1964), Sansoni, Firenze 1970, p. 415.
Tra utopia e ontologia. La questione della pace in Cusano
189
aprirsi radicale all’altro che non esprima una dissoluzione bensì la pie-nezza di sé, una rinuncia che abbia la forma radicale del sì? È chia-ro che gli sforzi ecumenici di Cusano esprimo il rischio di una scom-messa: la scommessa che questa apertura radicale all’altro sia l’essenza stessa del cristianesimo.
La diversità necessaria
In che modo è da intendersi quest’essenza? Per rispondere a tale do-manda occorre allargare la prospettiva sull’intera produzione filosofi-ca di Cusano. Per quanto il testo del De pace fidei presenti alcune spe-cificità che lo rendono, in certo modo, un unicum nel complesso dei testi cusaniani19, il concetto di pace può infatti essere considerato una sorta di architrave del suo intero percorso speculativo.
Come noto, la riflessione filosofica e teologica di Cusano è forte-mente debitrice della tradizione neoplatonica, in particolare della Teo-logia mistica dello Ps.-Dionigi Areopagita, della Scuola di Chartres, de-gli scritti di Ermete Trismegisto e, man mano che le nuove traduzioni venivano approntate, anche delle opere di Proclo. Ciò che Cusano tro-va in questa tradizione di pensiero è un modo di impostare il rapporto tra l’Uno e il Molteplice che gli appare poter aggirare e superare alcu-ni stalli della tarda scolastica. Ciò implica, da un lato, un’ontologia (o henologia) che rinviene nella realtà una forza unitiva, un’energia atti-va, rispetto cui la molteplicità e il divenire si costituiscono come effetto di ritorno, realtà identiche a sé solo in quanto partecipi dell’Uno, come un’eco indebolita dell’unità infinita. D’altro canto, questa stessa strut-tura incessantemente in azione non può essere compresa dall’esterno, «rappresentata» e «oggettivata» su un piano di immanenza. Se l’Uno è ciò che attivamente tiene insieme la realtà, esso non potrà essere fatto oggetto del discorso, poiché sarà ciò che tiene insieme questo stesso di-scorso, ciò che identifica i suoi concetti, organizza le sue parole, com-pleta il suo senso. Ciò che nascostamente sostiene il discorso non può dunque venire detto che nella forma di un’assenza che è generativa, di
19 Cfr. T. McTyghe, Nicholas of Cusa’s Unity-Methaphysics and the Formula religio una in rituum varietate, in G. Christianson, T.M. Izbicki (a cura di), Nicholas of Cusa in Search of God and Wisdom: Essays in Honor of Morimichi Watanabe by the Ameri-can Cusanus Society, Brill, Leiden 1991, pp. 161-172.
Marco Maurizi
190
un vuoto di cui il logos si accerta come del proprio punto di consisten-za nell’atto stesso in cui si volge verso un’origine che si trova sempre alle sue spalle. Da qui la necessità di una teologia apofatica, di un sape-re negativo su tale origine, che sceglie la strada della negazione per la-sciar tralucere ciò che, nella positività accecante di una generazione in-finita, sfugge a ogni determinazione positiva.
Tutto ciò non rappresenta ovviamente una novità e, sottolineando questi aspetti, Cusano non fa altro che ripetere, talvolta quasi alla let-tera20, i luoghi più visitati della teologia negativa. In cosa consiste, al-lora, il contributo di Cusano a questa tradizione e perché esso deve necessariamente intrecciarsi con il tema della pace? Questa domanda ci porta al cuore del vero contributo che Cusano ha portato alla tradi-zione teologico-negativa: il concetto di congettura. Come noto, dopo la grande sintesi della Dotta ignoranza, Cusano scrive un trattato che non si lascia facilmente accordare con il precedente, sia per la natu-ra dell’argomento che per il linguaggio utilizzato21. Tradizionalmen-te, il De conjecturis viene inteso come un complemento al trattato teo-logico-negativo sulla docta ignorantia: quest’ultimo, infatti, dopo aver descritto il processo di ascensione all’Unità ineffabile e infinita, trae la conseguenza che ogni asserzione sul mondo è destinata a rimanere nell’ambito del congetturale, poiché la conoscenza procede per pro-porzione e tra finito e infinito non può esserci proporzione. L’opera Le congetture, quindi, tratta del modo in cui la mente umana può co-struire un sapere congetturale su Dio, sul Mondo e su se stessa, muo-vendo appunto dall’assunto dell’impossibilità di stabilire un rapporto
20 Cfr. però l’analisi derridiana del linguaggio della teologia negativa, laddove con-stata che essa appare «tanto più meccanizzabile e facilmente riproducibile, falsifi-cabile, esposta alla contraffazione ed alla moneta falsa, in quanto l’enunciato della teologia negativa si svuota per definizione, per vocazione, da ogni pienezza intuitiva. Chenosi del discorso. Se si segue una regola di tipo fenomenologico per distinguere fra un’intuizione vuota o simbolica, dimentica della percezione originaria che la so-stiene, allora gli apofatici sono, devono essere dalla parte del vuoto e dunque della ripetizione meccanica ossia puramente verbale di frasi senza voler-dire intenzionale attuale o pieno». J. Derrida, Salvo il nome (post-scriptum), in Id., Il segreto del nome, Jaca Book, Milano 1997, p. 144.21 Ci sono, tuttavia, buoni argomenti per ritenere le due opere coeve, pensate, se non addirittura scritte, di concerto. Cfr. J. Koch, Die Ars coniecturalis des Nikolaus von Kues, Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, n. 16, Westdeutscher Verlag, Köln 1956.
Tra utopia e ontologia. La questione della pace in Cusano
191
certo, univoco e definito tra questo sapere e l’ens realissimum che ne costituisce l’oggetto strutturalmente elusivo.
Il mondo si manifesta quindi come il luogo «del più e del meno», in cui ogni messa-in-forma è il prodotto dell’azione dell’Uno che è an-che assoluta precisione. Nulla può essere detto di così preciso da non poter essere superato da una precisione più grande e così via all’infi-nito. Ogni sapere è congettura, prospettiva sull’unità che mantiene una propria progressione scalare nei confronti delle altre congetture e prospettive e, tuttavia, nei confronti di quel vero che l’attraversa e la forma dall’interno, ogni congettura rimane infinitamente distante. Si tratta di uno scetticismo radicale che relativizza e rende impossibile ogni accertamento della verità? Niente affatto. Cusano ribadisce, in-fatti, come la congettura, pur essendo infinitamente distante dal vero, sia sempre «più o meno» vera di un’altra: dunque non c’è alcun indif-ferentismo, le congetture non sono affatto tutte uguali, ma partecipa-no tutte, seppure in modo diverso, della medesima verità.
Ancora più rilevante per il tema che stiamo affrontando è la se-conda caratteristica del mondo congetturale: le congetture sono tut-te necessarie all’esplicazione della potenza formatrice dell’Uno. Pro-prio perché l’Unità è potenza infinita il suo effetto non può che rivelare i tratti dell’infinità: ma l’unico modo in cui l’infinito semplice può ri-prodursi è uscendo da sé, dunque abbandonando la propria semplicità intensiva e puntuale e istituendo un’infinità di tipo estensivo. Il Mon-do sensibile è questo infinito non al modo dell’Assoluto, cioè ripiega-to su se stesso (complicatio), bensì sviluppato, dispiegato nella «cattiva infinità» del tempo e dello spazio (explicatio). Se questo schema onto-logico può ancora configurare una soluzione abbastanza tipica per la teologia negativa, Cusano imprime qui una torsione vertiginosa al di-scorso laddove introduce il sapere stesso in questo processo di esplica-zione mondana dell’infinito. Se il Mondo è il dispiegamento dell’Asso-luto che mima, per così dire, l’infinità di quest’ultimo, riproducendone su un piano di sequenze ascendenti e discendenti l’infinità generativa, dove dovremmo collocare il discorso, il logos che descrive questo Mon-do e il suo rapporto con l’origine? La questione troverà in Cusano so-luzioni raffinatissime e che qui non è possibile seguire nel dettaglio22;
22 Rimandiamo, però, alla trattazione che ne abbiamo proposto in M. Maurizi, La nostalgia del totalmente non altro, cit., pp. 257ss.
Marco Maurizi
192
dobbiamo dunque limitarci a registrare il passo inaugurale della rifles-sione cusaniana sulla mens.
Cusano sottolinea, infatti, come il discorso non possa che mostra-re esso stesso il carattere proprio di questo «infinito mimetico» che è il mondo, la sua infinita deriva che non è assenza di unità, ma il modo stesso in cui l’unità si dà a livello della sua produttività. L’unità è ciò che «fa uno», espressione che va intesa nel duplice senso di ciò che fa sì che ogni singola entità sia se stessa e che tiene insieme gli enti, dan-do ad essi un ordine e un senso in vista dei rapporti che essi instau-rano tra di loro e con l’unità che incessantemente li genera. Ed ecco che questa infinità di secondo grado si mostra intessuta attorno a un centro che è posto però su un piano diverso, indefinibile nei termini delle relazioni tra gli enti della trama stessa. Il punto prospettico che produce ordine e direzione nella realtà sensibile, sottraendosi al suo piano di immanenza, è anche la direzione verso cui le singole prospet-tive degli enti guardano come alla propria verità. Rispetto a un uni-verso così prospetticamente costituito è chiaro che il sapere stesso deve assumere un andamento e una struttura prospettiche. E non si tratterà, come si è detto, di una molteplicità di cui il sapere dovrebbe liberarsi per accedere alla verità: la molteplicità è invece il modo stesso in cui la verità si offre nella forma del discorso.
Un’ontologia della pace
È solo da questo punto di vista che è possibile comprendere la trian-golazione tra unità, molteplicità e sapere congetturale proposta da Cusano e che si può dare il giusto risalto a quella sorta di «inno» alla differenza che sigilla il I capitolo del III libro della Docta ignorantia in cui troviamo un’altra anticipazione della visione cosmica su cui è co-struita la tensione ecumenica del De pace fidei:
In nessun individuo i principi individuanti possono incontrarsi tra di loro con lo stesso accordo e proporzione che hanno in un altro individuo, per cui ognuno è per sé uno e perfetto nel modo in cui gli è possibile. E, sebbene in ciascuna specie, per esempio l’umana, siano esistiti in un determinato tempo alcuni individui che sono stati stimati più perfetti e nobili di altri per certe loro qualità, [...], tuttavia, la diversità delle opi-nioni a seconda della diversità delle religioni, delle sètte e dei paesi, rende
Tra utopia e ontologia. La questione della pace in Cusano
193
diversi i giudizi di paragone. Per questo ciò che è lodevole secondo un opinione è biasimevole secondo un’altra. Inoltre esistono molti indivi-dui sparsi nell’universo che noi non conosciamo. Pertanto non sappiamo quale uomo nel mondo sia più eccellente degli altri, perché non siamo capaci di conoscerne perfettamente neppure uno fra tutti. Ora, Dio ha fatto tutto questo perché ciascuno, pur ammirando gli altri, si contenti di se stesso e della propria terra, sicché il paese natale gli sembri tra i più dolci, per i costumi qui praticati e per la lingua. Ci sia così unità e pace senza odio, quanto più è possibile, perché la pace e l’unità sono possibili solo agli uomini che regnano con lui che è la nostra pace ed è superiore a ogni nostra percezione23.
In questo passo risuona tutta la profondità ontologica del concetto di concordantia, con il quale Cusano intende non uno stato di pacifica-zione, quanto l’attività che è nelle cose e che attraverso le cose si com-pie nell’umano come ripercorrimento della propria genesi («la pace e l’unità sono possibili solo agli uomini che regnano con lui che è la nostra pace»). Esso indica quindi uno schema dinamico in cui l’unità non è ciò che, come dall’esterno, sussume e costringe la molteplicità, bensì ne è il principio intimo di costituzione. L’armonia tra i diversi è qualcosa che agisce dal loro interno in un senso che potremmo defini-re «monadologico» in senso leibniziano.
Non si tratta però di un’algida costruzione intellettualistica che priverebbe i concetti di armonia e di pace di tutti gli armonici emo-tivi con cui noi oggi tendiamo a interpretarli (con una unilateralità, per altro, che non è minore del suo opposto teoreticistico). Il dar-si del molteplice, il più e meno delle prospettive infinite, è infatti il modo con cui l’universo ripete quell’atto d’amore che ne sancisce la nascita: atto d’amore che è un fare spazio, un lasciar-essere, un chia-mare all’esistenza ciò che non è. L’Uno neoplatonico viene qui a me-scolarsi, evidentemente, con la concezione giudaico-cristiana della creazione ex nihilo, benché il problema del loro rapporto non risul-ti in Cusano mai pienamente risolto. Il punto veramente interessan-te è però che questo amore chiama amore, invita la stessa creatura a farsi da parte per lasciar apparire l’Assoluto da cui è sorta. Ciò, tut-tavia, non accade in Cusano attraverso la via mistica della rinuncia
23 N. Cusano, La dotta ignoranza, trad. di G. Federici Vescovini, Città nuova, Roma 1991, pp. 162-163.
Marco Maurizi
194
di sé e dell’ascesi ultramondana o, meglio, non avviene solo per que-sta strada.
Parallelamente a quanto abbiamo visto sul piano gnoseologico, in-fatti, anche su quello ontologico il rapporto sproporzionale tra finito e infinito diviene centro propulsivo di diversità, variazione incessante, creazione di prospettive sempre nuove. Ciò significa però al contem-po che la variazione assume la forma del compito e, per dirla tutta, del compito impossibile. La corresponsione con l’Uno accade, infatti, lad-dove la singolarità diviene norma a se stessa e si approfondisce in quan-to singolarità. Una volta che si sia inteso il senso di questo compito, se ne coglierà anche l’impossibilità radicale. La singolarità appare infatti come duplice problema: da un lato, si tratta dell’atto con cui ogni ente si fa identico a sé; dall’altro, dell’atto con cui esso si rende differente dall’altro. Identità e differenza, dunque, si trovano ad agire nell’ente come due facce della stessa medaglia, eppure non sono affatto la stes-sa cosa. E non sono la stessa cosa per il semplice motivo che a livello dell’ente tanto l’identificazione quanto la differenziazione non possono costituirsi che come approssimazione all’identità e alla differenza assolu-te, ovvero all’essere di Dio. Solo l’Unità, infatti, si pone come essenzial-mente identico e differente, luogo in cui l’uguaglianza con sé e l’alterità si trovano conciliate. Rispetto alla massima realizzazione dell’identifi-cazione e della differenziazione, cioè a quella realizzazione che «non potrebbe essere maggiore» (come suona la nota formula che Cusano ri-prende da Anselmo approfondendola), l’identità e la differenza dell’en-te non possono che apparire come imitazioni, pallidi riflessi, quasi-ir-realtà. Ciò definisce dunque l’ambito di un compito che traduce su un piano morale-estetico una più profonda necessità di tipo ontologico: essere quanto più possibile uguali a se stessi e diversi dall’altro.
Non si può certo tacere qui la complicazione teorica che sorge nel porre, a livello dell’essere divino, la questione dell’alterità. Se, infatti, è relativamente facile pensare l’identità come tratto essenziale dell’Uno, non sembra possibile porvi un’alterità in azione se non a costo di con-traddire la prima determinazione. L’Uno dovrebbe cioè essere identico e non-identico nello stesso tempo e sotto il medesimo rispetto. Da qui la necessità di attrezzarsi di una logica sui generis quando si intende af-frontare l’abissale problema dell’essenza divina: logica che in Cusano, sulla scia tanto della teologia mistica dionisiana, quanto della trinitolo-gia patristica, assume tratti «dialettici» non conciliabili con l’organon aristotelico. È il noto concetto di coincidentia oppositorum, in base al
Tra utopia e ontologia. La questione della pace in Cusano
195
quale il passaggio dal piano del mondo sensibile a quello dell’intelligi-bile semplicità divina impone al pensiero l’abbandono delle distinzioni con cui si descrivono le realtà molteplici, poiché nell’Uno le determi-nazioni opposte vengono in qualche modo assorbite da una pienezza d’essere che è potenza assoluta (nel senso di una singolarità in cui sono accolte e custodite tutte le possibilità d’essere del mondo creaturale)24.
L’alterità divina viene poi definita in due direzioni opposte ma complementari: ad intra e ad extra. Nel primo caso, l’alterità come ciò che si trova in Dio, è centrale l’aspetto trinitario, ovvero relazio-nale, che Cusano affronta non solo teologicamente – in osservanza alla dogmatica ecclesiastica – ma anche filosoficamente, riformulando il rapporto tra le persone della Trinità secondo modalità congettura-li sempre diverse, di cui resta però paradigmatica la triade unitas – ae-qualitas – conexio: unità-in-sé, uguaglianza-a-sé e rapporto della prima con la seconda. Nel secondo caso, l’alterità viene intesa come rappor-to tra Dio e il mondo creaturale, ciò che, più precisamente, si potreb-be definire un non-rapporto o, forse, un rapporto disgiuntivo. L’Iden-tità divina viene così spezzata all’interno dal rapporto intratrinitario e produce la Differenza come non-rapporto a sé (nel senso dell’ab-solu-tus, cioè sciolto da legami). Identità e Differenza sorgono insieme ma il loro nesso rimane indiretto: ciò che è altro dall’identico non è identi-co e, per questo, si definisce negativamente come differente. Il diverso è così colto come effetto ontologico di un’identità che funziona a par-tire dal movimento di sdoppiamento della propria non-identità (alte-rità-intratrinitaria, alterità-extradivina)25.
24 Si potrebbe sostenere che gli attributi contraddittori non riguardano l’Uno «nel-lo stesso tempo e sotto il medesimo rispetto», rendendo quindi conciliabile la spe-culazione cusaniana e la logica aristotelica. Cfr. ad esempio, E. Berti, Coincidentia oppositorum e contraddizione nel De docta ignorantia I, 1-6, in G. Piaia (a cura di), Concordia discors Studi su Niccolò Cusano e l’umanesimo europeo offerti a Giovanni Santinello, Padova 1993, p. 115. Ci pare tuttavia che questa soluzione non possa esse-re accettata. Non solo per l’esplicito riferimento di Cusano a un necessario abbando-no – limitatamente alla trattazione dell’essenza di Dio – della logica di Aristotele ma, ancor più radicalmente, perché ci pare che in un’essenza come quella divina che si pone al di là della temporalità e che nella sua semplicità rifiuta di lasciarsi esplicitare in Abschattungen, la formulazione aristotelica evidentemente non possa avere corso. 25 Il rapporto tra questi due momenti è stato ben delineato da Santinello: «La Trinità divina, in quanto istituisce una relazione in Dio, è il principio esplicativo, formale-esemplare ed efficiente, di quella molteplicità di relazioni in cui consiste il
Marco Maurizi
196
Pensare in concordia
Ma cosa implica questo assunto ontologico per il tema della pace? Ci sembra che una risposta plausibile all’interrogativo che qui ci preoc-cupa possa essere impostata solo evidenziando il paradosso che sta al cuore dell’Infinito e del suo (non)rapporto con il Finito: la singola-rità è chiamata a se stessa dall’invocazione di un Altro che è, al tem-po stesso, assoluta Identità e assoluta Differenza. Si tratta di un pa-radosso che trova la propria soluzione solo su un piano performativo. Non si intenda tale termine nel senso di un pragmatismo che dovreb-be saldare e sanare a livello dell’azione ciò che il concetto non riusci-rebbe a tenere unito. La singolarità è qui piuttosto chiamata a rispon-dere di qualcosa muovendosi nel senso di un ripercorrimento della genesi e solo nella consapevolezza di tale ripercorrimento il proble-ma dell’aporia in cui si incaglia il pensiero dell’Identità/Differenza può sciogliersi. Quadro che, per quanto già notevolmente complesso, non sarebbe tuttavia completo se non vi aggiungessimo quella postil-la di straordinario fascino che rappresenta, come si è visto, l’origina-le modo in cui Cusano declina il programma della teologia negativa: la consapevolezza che opera il ripercorrimento in direzione dell’ori-gine non può infatti mai offrirsi nel senso di una formulazione teorica invariabile, ma essa stessa slitta assieme al suo oggetto e non conosce stabilità se non nell’eterno differire il proprio compimento. Il senso propriamente speculativo della congettura in Cusano si situa a que-sto livello.
Perché Cusano giunge a concepire come compito la realizzazio-ne d’essere della singolarità e perché tale compito gli appare in forma congetturale? Cerchiamo di sciogliere questo nodo fondamentale ag-ganciandolo al punto di arrivo della riflessione cusaniana sulla pace che è anche il motivo da cui abbiamo preso le mosse in questo artico-lo. Proviamo cioè a guardare il problema dal punto di vista “pratico” della religione considerando però quest’ultima, analogamente a quan-
creato: soprattutto dei caratteri di molteplicità, alterità e similitudine [...]. La Trinità, in quanto manifestazione di Dio a se stesso, ad intra, è il principio anche di quella manifestazione di Dio ad extra che è il mondo; il mondo potrà dirsi manifestazione di Dio in altro da sé, in quanto ha il suo principio in Dio che è, prima di tutto, per sua essenza, manifestazione di sé a sé». Cfr. G. Santinello, Il pensiero di Nicolò Cusano nella sua prospettiva estetica, Liviana, Padova 1958, p. 131.
Tra utopia e ontologia. La questione della pace in Cusano
197
to accade nell’orizzonte dell’essere finito-mondano, come un modo di atteggiarsi della diversità. Nelle prime battute del De pace fidei, un ar-cangelo si rivolge a Dio con la seguente supplica:
Tu, o Signore, sai che una grande moltitudine di uomini non può esistere senza grandi differenze, e che quasi tutti sono costretti a condurre una vita travagliata, piena di preoccupazioni e di miseria, ed a sottostare con soggezione servile ai re che li dominano. Perciò soltanto pochi fra di essi hanno tempo e agio sufficiente per giungere a conoscerti interiormente, usando della propria libertà. Essi infatti vengono distratti da molte preoc-cupazioni e dagli affari materiali, per cui non possono ricercare Te che sei un Dio nascosto. Perciò Tu hai posto come capi del tuo popolo diversi re e veggenti, detti profeti, molti dei quali, esercitando la funzione loro affidata, istituirono, a nome tuo, il culto e le leggi ed istruirono il popolo incolto. E gli uomini accettarono quelle leggi come se Tu stesso, Re dei re, gli avessi parlato di persona, convinti di ascoltare non loro (i profeti) ma Te in loro. Alle diverse nazioni inoltre hai inviato profeti e maestri diversi, alcuni in un’epoca, altri in un’altra epoca. Senza aggiungere poi che è proprio della natura umana sulla terra difendere come verità una consue-tudine inveterata che, come si crede, è diventata parte della natura stessa. Per tutti questi motivi sorgono non pochi dissensi di vedute quando ogni popolo preferisce la propria fede a quella degli altri26.
La diversità storico-culturale delle fedi è dunque effetto del modo in cui l’umano partecipa del divino, attraverso l’azione della rivelazione, dei libri sacri e dei profeti. Come mostra successivamente nel collo-quio l’intercessione di Cristo presso il Padre – che lamenta, per così dire, la «dura cervice» di un’umanità sorda al suo messaggio di pa-ce27 – è la natura stessa dell’uomo a motivare un costante intervento divino, una visitatione frequente28, per correggere gli errori che l’uma-na condizione ontologica inevitabilmente produce. Cusano ricorda così che anche la parola divina si presta a un uso contrario al suo sen-so laddove il messaggio religioso tende a sfuggire alla dialettica ori-
26 Ibid., pp. 621-622.27 Ibid., p. 624.28 «Poiché nel mondo sensibile niente resta immutabile, e le opinioni e le congetture cambiano col tempo, come anche le lingue e le interpretazioni, per questo motivo la natura umana ha bisogno di una frequente visitazione al fine di estirpare i numerosi errori che riguardano il tuo Verbo, di modo che la verità brilli in eterno», ibidem (trad. modificata).
Marco Maurizi
198
ginaria di Identità/Differenza per farsi meramente “identitario”. Ed è sintomatico che sia il Verbo a sostenere la necessità di un incessan-te ri-pensamento del Verbo. La parola di Dio è tale solo in un costan-te riattraversamento che ne faccia salvo lo spirito e non renda l’uomo schiavo della lettera.
La questione ecumenica posta da Cusano va perciò letta nella dia-lettica tra una diversità che non è di per sé “errore” ma modo d’esse-re della molteplicità e un’unità che, a sua volta, necessita del peren-ne sforzo di superare la limitatezza del proprio sguardo per avverarsi. Non si tratta quindi di abbandonare, ma di approfondire la dimensio-ne della singolarità in cui tale sguardo è costitutivamente centrato. Si tratta, in altri termini, di comprendere il significato e la funzione on-tologica del finito nella dialettica tra Identità e Differenza che abbia-mo analizzato in precedenza. Si mostra così come la diversità debba mantenere desto il suo rapporto genetico con l’origine – nel suo du-plice potere identificante e differenziante – se non vuole scadere a ha-bitus, ripetizione priva di spirito. Ciò implica a livello individuale la necessità di re-inventare ogni volta il tentativo di dire l’origine, di sal-vare ogni volta lo slancio di una congettura che apre e mobilita lo spa-zio saturato da un sapere «reificato».
Ci sembra così che la posizione politico-religiosa cusaniana, collo-cata sullo sfondo ontologico che gli è proprio, vada al di là dell’idea secondo cui la pace è qualcosa che possa realizzarsi come “proget-to”, poiché prima ancora che esito di un azione, Cusano ci ricorda che essa è il frutto di un pensiero del rapporto: rapporto che è all’origi-ne dell’identità di sé e dell’altro, dei loro rapporti reciproci e del rap-porto impensabile, perché privo di proporzione, tra la sfera delle fini-tudini e l’infinito. Saper abitare la vertigine di questa moltiplicazione dei piani del rapporto è l’unica possibilità che l’umanità ha di salvare la pace come possibilità della propria stessa umanità, a fronte di una sempre possibile auto-divinizzazione o della regressione nella dispe-rante chiusura del non-senso. Sfrondata di ogni risonanza teoreticista, la posizione di Cusano potrebbe allora forse sintetizzarsi nella tesi se-condo cui l’agire nel senso della pace è possibile solo sullo sfondo di un pensare in concordia.