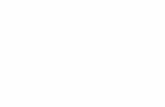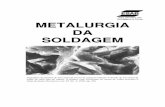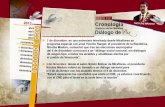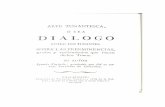Le citazioni reciproche tra la Corte europea e la Corte interamericana dei diritti dell’uomo:...
Transcript of Le citazioni reciproche tra la Corte europea e la Corte interamericana dei diritti dell’uomo:...
federalismi.it n. 19/2013
LE CITAZIONI RECIPROCHE TRA LA CORTE EUROPEA E LA CORTE
INTERAMERICANA DEI DIRITTI DELL’UOMO: DALL’INFLUENZA AL DIALOGO?*
di
Tania Groppi
(Professore ordinario di Diritto pubblico
Università di Siena)
e
Anna Maria Lecis Cocco-Ortu
(Dottoranda in Diritto pubblico comparato
Università di Siena e di Aix-Marseille)
25 settembre 2013
Sommario: 1. Presentazione della ricerca. 2. Analogie e differenze tra il sistema europeo e
quello interamericano di protezione dei diritti. 3. La ricerca empirica: le citazioni esplicite nel
periodo 1987-2012. 3.1. Premesse metodologiche. 3.2. Analisi quantitativa. 3.2.1.
Considerazioni generali. 3.2.2. La prospettiva diacronica. 3.3. Analisi qualitativa. 3.3.1.
Analisi formale. 3.3.2. Analisi sostanziale . 4. In conclusione: le Corti regionali tra
universalismo e particolarismo dei diritti umani
* In corso di pubblicazione in Studi in onore di Giuseppe De Vergottini. Il contributo è il risultato del lavoro
congiunto delle due autrici. Tuttavia, in fase di redazione, i paragrafi 1 e 4 sono stati realizzati da entrambe le
autrici, il paragrafo 2 da Tania Groppi e il paragrafo 3 da Anna Maria Lecis Cocco-Ortu.
Esso è stato presentato nella Tavola rotonda dell’IACL, “Key Developments in Constitutionalism and
Constitutional Law”, tenutasi a Belgrado, il 4 e 5 maggio 2012, associazione della quale il professor De
Vergottini è stato tra i fondatori ed è Presidente onorario. Ci è particolarmente gradito dedicarglielo,
ringraziandolo per la sua pionieristica presenza sulla scena globale.
www.federalismi.it 2
1. Presentazione della ricerca
La comparazione tra i due principali sistemi regionali di tutela dei diritti umani, e in
particolare tra le due Corti preposte alla garanzia dei diritti, la Corte europea dei diritti
dell’uomo (Corte EDU) e la Corte interamericana dei diritti dell’uomo (Corte IDU), ha
destato da tempo l’attenzione della dottrina, interessata dall’indubbia somiglianza tra i due
sistemi, nonché dall’ispirazione che la Corte interamericana ha tradizionalmente trovato nella
giurisprudenza di Strasburgo1.
Il presente lavoro non si pone pertanto l’obiettivo di analizzare globalmente le affinità e le
differenze tra i due sistemi, che sono state oggetto di numerosi e attenti studi, bensì, più
modestamente, di mettere in luce i risultati di una ricerca empirica sulle citazioni reciproche
delle due Corti, riscontrabili nelle motivazioni delle loro decisioni.
Gli studi sulla globalizzazione del diritto e sulla circolazione delle giurisprudenze hanno
mostrato a più riprese che la citazione di fonti “extra-sistemiche”, ovvero esterne al contesto
giuridico di riferimento, non è più un fenomeno circoscritto ai soli tribunali nazionali, ma
interessa oramai anche le corti internazionali2.
1 Si segnala in particolare la recente opera collettanea dedicata proprio al dialogo e alle convergenze tra i sistemi
europeo e americano, a cura di J. GARCÍA ROCA, P. A. FERNÁNDEZ, P. SANTOLAYA, R. CANOSA, El Diálogo entre
los Sistemas Europeo y Americano de derechos Humanos, Navarra, 2012. Si vedano inoltre: L. CAPPUCCIO, A.
LOLLINI, P. TANZARELLA, Le corti regionali tra Stati e diritti. I sistemi di protezione dei diritti fondamentali
europeo, americano e africano a confronto, Napoli, 2012; N. P. SAGUÉS, El ‘control de convencionalidad’ en el
sistema interamericano, y sus anticipos en el àmbito de los derechos econòmicos-sociales. Concordancias y
diferencias con el sistema europeo, in A. VON BOGDANDY, H. FIX-FIERRO, M. MORALES ANTONIAZZI, E.
FERRER MAC-GREGOR (a cura di), Construcciòn y papel de los derecos sociales fundamentales, Mexico, 2011,
381 ss.; A. A. CANÇADO TRINDADE, Approximations and Convergences in the Case-Law of the European and
Inter-American Courts of Human Rights, in G. COHEN-JONATHAN, J. F. FLAUSS, (a cura di), Le rayonnement
international de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Bruxelles, 2005, 101-138; A. A.
CANÇADO TRINDADE, L CAFLISCH, Les Conventions Américaine et Européenne des Droits de l’Homme et le
Droit International Général, RGDIP, 2004, 5. 2 Si veda il volume che raccoglie gli Atti del convegno tenutosi il 28 aprile 2006 all’Università di Bruxelles Le
Dialogue des juges, Bruxelles, 2007 e, in particolare, il contributo di L. HENNEBEL, Les références croisées entre
les juridictions internationales des droits de l’homme, 31; si segnalano inoltre L. BURGORGUE-LARSEN, De
l’internationalisation du dialogue des juges. Missive doctrinale à l’attention de Bruno Genevois, in AA. VV., Le
dialogue des juges. Mélanges en l'honneur du président Bruno Genevois, Paris, 2009, 95-130, in particolare 119
ss.; G. COHEN-JONATHAN, J. F. FLAUSS, (a cura di), Le rayonnement international de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, cit. supra nota 1, in particolare il saggio conclusivo di J. F. FLAUSS, Diffusion
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et interactions normatives dans le domaine de
la protection des droits de l’homme, 265; l’opera contiene diversi contributi sull’influenza della giurisprudenza
della Corte EDU da parte: delle giurisdizioni penali internazionali (di A. CASSESE, 11), del Comitato dei diritti
dell’uomo delle Nazioni Unite (di M. BOSSUYT, 29), della Corte interamericana (di A. A. CANÇADO-TRINDADE,
83), della Commissione africana dei diritti dell’uomo (di E. LAMBERT-ABDELGAWAD, 101), della Corte di
giustizia dell’Unione europea (di O. DE SCHUTTER, 189), delle giurisdizioni internazionali specializzate (di J. F.
FLAUSS, 243); si vedano anche: N. MILLER, An International Jurisprudence? The Operation of “Precedent”
Across International Courts and Tribunals, LJIL, 2002, 499; F. G. JACOBS, Judicial Dialogue and the Cross-
fertilization of Legal Systems: The European Court of Justice, Tex. Int’l. L.J., 2003, 547; G. L. NEUMAN, The
External Reception of Inter-American Human Rights Law, Quebec Journal of International Law (RQDI), 2011,
99.
www.federalismi.it 3
Spesso tali studi, tanto quelli aventi ad oggetto la giurisprudenza di organi giurisdizionali
nazionali che quelli incentrati sulla giurisprudenza internazionale, mancano però di una base
documentale adeguata, che dimostri l’effettività della circolazione giurisprudenziale: dalle
ricerche empiriche più complete e meglio documentate emerge che, se si passa dalla teoria
alla pratica, il contesto cambia sensibilmente e il fenomeno della circolazione delle
giurisprudenze ne esce notevolmente ridimensionato, sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo3.
Per questo motivo, con il presente studio, si sono volute verificare, in maniera completa e
sistematica, alcune delle considerazioni spesso avanzate dalla dottrina sulle relazioni tra due
corti regionali che presentano spiccate somiglianze e tra le quali intercorrono frequenti
contatti e scambi reciproci (come visite, convegni, ecc.), oltre che una certa circolazione
giurisprudenziale già da tempo documentata.
Nell’analisi delle relazioni tra le due Corti è stata impiegata la stessa metodologia già
utilizzata in alcune ricerche empiriche relative al ricorso ai precedenti stranieri da parte di
corti costituzionali, che si sono limitate a prendere in considerazione le sole citazioni esplicite
della giurisprudenza straniera4. La scelta di limitare l’analisi alle citazioni esplicite non è
dovuta a un sottovalutazione della effettiva esistenza e della importanza di influenze implicite
– che non si traducano, cioè, in citazioni espresse della giurisprudenza extra-sistemica nella
motivazione delle decisioni -, ma piuttosto alla consapevolezza che una ricerca che tocchi
anche le citazioni implicite richiederebbe l’impiego di strumenti di indagine assai complessi,
come questionari o interviste, nonché una lettura approfondita di tutta la giurisprudenza
rilevante5. D’altra parte, pur coscienti dei limiti di uno studio circoscritto alle sole citazioni
3 Sul fenomeno della circolazione giurisprudenziale tra corti nazionali, si vedano i risultati delle ricerche
empiriche raccolte in T. GROPPI, M. C. PONTHOREAU, The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges,
Oxford, 2013; per quanto riguarda invece le corti internazionali oggetto del presente contributo, la più completa
ricerca empirica ad oggi risulta essere quella riportata in J. GARCÍA ROCA, P. A. FERNÁNDEZ, P. SANTOLAYA, R.
CANOSA (a cura di), El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de derechos Humanos, cit. supra nota
1; si veda anche L. HENNEBEL, Les références croisées entre les juridictions internationales des droits de
l’homme, cit. supra nota 1. 4 T. GROPPI, A User-friendly Court. The Influence of Supreme Court of Canada Decisions since 1982 on Court
Decisions in Other Liberal Democracies, Supreme Court Law Review, 2007, 337; D. S. LAW, W. C. CHANG, The
Limits of Global Judicial Dialogue, Washington Law Review, 2011, 523; C. RAUTENBACH, L. DU PLESSIS, In the
Name of Comparative Constitutional Jurisprudence: the Consideration of German Precedents by South African
Constitutional Judges, di prossima pubblicazione in German Law Journal; T. GROPPI, M. C. PONTHOREAU, The
Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges, cit. supra nota 3.
5 A nostra conoscenza, solo uno studio monografico di questo tipo risulta pubblicato: il contributo di Catherine
Dupré sull’influenza delle decisioni della Corte costituzionale tedesca in materia di dignità umana sulla
giurisprudenza della Corte costituzionale ungherese, influenza assolutamente implicita. Si veda C. DUPRÉ,
Importing Law in Post-Communist Transitions, Oxford, 2003. Di recente, la questione delle citazioni implicite
ha fatto l’oggetto anche di alcuni articoli fondati su interviste a giudici: U. BENTELE, Mining for Gold: the
Constitutional Court of South Africa’s Experience with Comparative Constitutional Law, Georgia J. Int.
Comp. Law, 2009, 219; B. FLANAGAN, S. AHERN, Judicial Decision-Making and Transnational Law: A Survey of
www.federalismi.it 4
esplicite, esso non sembra del tutto ininfluente, contribuendo a nostro avviso a fornire
ulteriori elementi di analisi che possano illuminare un fenomeno diffuso e articolato quale la
circolazione giurisprudenziale.
La trattazione del fenomeno della circolazione delle giurisprudenze tra due corti regionali
richiede innanzi tutto di prendere in considerazione le numerose differenze esistenti tra queste
e le corti costituzionali nazionali: differenze che vanno dal tipo di testi normativi alla cui
tutela sono preposte (rispettivamente, le carte internazionali dei diritti e le costituzioni
nazionali), all’oggetto del giudizio (che non sempre di fronte alle corti costituzionali è
rappresentato dalla violazione di un diritto, concretandosi nella maggior parte dei casi nella
incostituzionalità di una legge), dalla composizione dell’organo giurisdizionale (in particolare
per quel che riguarda il procedimento di nomina e le caratteristiche individuali dei singoli
giudici) al funzionamento della Corte, fino ad investirei soggetti destinatari della decisione
(che per le corti costituzionali nazionali sono sovente i legislatori).
Ai fini della presente ricerca, almeno tre profili di peculiarità delle corti regionali vanno tenuti
in considerazione.
Innanzitutto, è pacifico che una certa inclinazione a guardare alla giurisprudenza di altri
sistemi giuridici è propria della natura stessa delle corti internazionali, le quali sono chiamate
a rapportarsi ai differenti ordinamenti degli Stati membri e devono, pertanto, confrontarsi con
contesti giuridici e culturali variegati. Potremmo perciò dire che, in qualche modo, esse sono
per natura comparatiste6.
Inoltre, bisogna considerare la diversa composizione delle corti internazionali, rispetto alle
corti costituzionali. Le corti internazionali sono infatti formate da giuristi provenienti da Paesi
differenti, il cui bagaglio di tradizioni giuridiche e culturali può avere un impatto notevole
sulla propensione alla citazione di decisioni extra-sistemiche, con effetti ben più complessi di
Common Law Supreme Court Judges, ICLQ, 2011, 1; E. MAK, Why Do Dutch and UK Judges Cite Foreign
Law?, CLJ , 2011, 420; D. S. LAW, W. C. CHANG, The Limits of Global Judicial Dialogue, cit. supra nota 4. 6 G. DEVERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le corti. Giudici, diritto straniero, comparazione, Bologna, 2010, 11;
ID., Tribunales constitucionales y comparacion en la exstension de las declaraciones de derechos, in La ciencia
del derecho procesal constitucional. Estudio en homenaje a Héctor Fix-Zamudio, Volume II, Mexico, 2008,
637-650, spec. 641. Sull’attitudine “comparatista” della Corte EDU, si veda anche C. ROZAKIS, The European
Judge as Comparatist, Tulane L.Rev., 2005, 273; J. P. COSTA, Concepts juridiques dans la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme: de l'influence de différentes traditions nationales, RTDH, 2004, 101; P.
WIDMER, Le rôle du droit comparé dans la formation du droit européen, Zurich, 2002; P. G. CAROZZA, Uses
and Misuses of Comparative Law in International Human Rights: Some Reflections on the Jurisprudence of the
European Court of Human Rights, Notre Dame L. Rev., 1998, 1217; G. REPETTO, Argomenti comparativi e
diritti fondamentali in Europa. Teorie dell’interpretazione e giurisprudenza sovranazionale, Napoli 2011; sia
consentito rinviare anche a A.M. LECIS COCCO ORTU, La comparaison en tant que méthode de détermination du
standard de protection des droits dans le système CEDH, Rivista AIC, 2011.
www.federalismi.it 5
quelli che si sono potuti osservare al livello delle corti costituzionali nazionali, dove peraltro
l’influenza della personalità dei singoli giudici sull’inclinazione alla citazione è già rilevante7.
Infine, si deve tenere conto della diversa natura dei destinatari cui si rivolgono le corti
costituzionali e le corti internazionali. Infatti, mentre le decisioni delle prime sono destinate
ad una platea composta essenzialmente dalle istituzioni e dall’opinione pubblica nazionale, le
decisioni delle corti internazionali sono invece rivolte agli Stati e, in particolare, ai giudici
nazionali8.
Poiché la motivazione delle decisioni giudiziarie ha come obiettivo principale quello di
renderle persuasive e meglio accette agli occhi dei loro destinatari, la selezione degli
argomenti operata dalle corti è fortemente influenzata dalla percezione che hanno della
sensibilità e delle preferenze della loro platea di riferimento. Per quanto riguarda
specificamente le corti internazionali, pertanto, assume un’importanza cruciale la percezione
che esse hanno, in termini di cultura giuridica e di preferenze geopolitiche, dei giudici
nazionali, quali destinatari privilegiati delle loro decisioni.
Queste considerazioni implicano differenziazioni non solo tra corti costituzionali nazionali e
corti internazionali, ma anche tra diverse corti internazionali.
Fatte queste premesse, si può anticipare che, dalla ricerca, emerge come sia ancora difficile
inquadrare le relazioni tra le due Corti qui considerate nell’ottica del “dialogo”9 (e non solo
perché si tratta di un termine del quale spesso si abusa10
), nonostante una crescente tendenza
delle due Corti a osservarsi, a citarsi e, infine, ad adottare soluzioni convergenti in diversi
ambiti11
. Per molti anni, il rapporto è stato esclusivamente “a senso unico”, dal momento che
soltanto la Corte IDU, in quanto giurisdizione di nuova costituzione, guardava alla più antica
e influente Corte EDU. Si poteva allora parlare di “influenza” di una corte sull’altra, più che
di “dialogo”.
7 D. S. LAW, W. C. CHANG, The Limits of Global Judicial Dialogue, cit. supra nota 4, 523; C. RAUTENBACH, L.
DU PLESSIS, In the Name of Comparative Constitutional Jurisprudence: the Consideration of German
Precedents by South African Constitutional Judges, cit. supra nota 4. 8 L. BURGORGUE-LARSEN, Les standards : normes imposées ou consenties ?, in M. FATIN-ROUGE STEFANINI, G.
SCOFFONI (a cura di), Existe-t-il une exception française en matière de droits fondamentaux?, Aix-en-Provence,
2013, 15-30. 9 Di parere contrario invece J. GARCÍA ROCA, H. NOGUEIRA ALCALÀ, R. BUSTOS GISBERT, La comunicación
entre ambos sistemas y las características del diálogo, in J. GARCÍA ROCA, P. A. FERNÁNDEZ, P. SANTOLAYA, R.
CANOSA (a cura di), El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de derechos Humanos, cit. supra nota
1, che qualificano le comunicazioni transgiudiziali tra le due Corti come forme di un vero e proprio dialogo,
seppur “debole” e “asimmetrico”: si vedano in particolare 89 ss. 10
Come ci ha spiegato efficacemente il professor De Vergottini in G. DEVERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le
corti, cit. supra nota 6. 11
Dando così luogo a quella convergenza di soluzioni giurisprudenziali che A. M. Slaughter ha definito
“emerging global jurisprudence”: A. M. SLAUGHTER, A Global Community of Courts, HarvInt’l L J, 2003, 202.
www.federalismi.it 6
È a partire dagli anni Duemila che anche la Corte EDU comincia a citare la sua omologa
americana in un numero di decisioni che, benché esiguo, appare tutt’altro che irrilevante dal
punto di vista qualitativo, come vedremo nel prosieguo.
Dal canto suo la Corte IDU non sembra accennare a ridurre le citazioni della giurisprudenza
europea, come mostra, ad esempio, la sentenza Atala Riffo e figli c. Cile (del 24 febbraio
2012)12
, nella quale i giudici interamericani hanno ritenuto che la convivenza di un genitore
con una persona dello stesso sesso non ledesse l’interesse superiore del figlio con essi
coabitante. Le numerose citazioni della giurisprudenza europea sono utilizzate dalla Corte per
molteplici finalità. Esse servono a dare un’interpretazione estensiva del concetto di
discriminazione, che contempli la categoria dell’“orientamento sessuale” tra le categorie
protette; ad affermare che l’orientamento sessuale è una componente essenziale dell’identità
della persona; a sostenere che, secondo la Convenzione americana dei diritti dell’uomo
(CADU) non esiste una concezione chiusa di “famiglia”. Nella medesima linea si colloca la
sentenza Artavia Murillo e altri c. Costa Rica del 28 novembre 2012, dove compaiono
numerose citazioni della giurisprudenza europea, benché esse siano prevalentemente
finalizzate a dimostrare «che le tendenze della regolamentazione nel diritto internazionale non
portano alla conclusione che l’embrione debba essere trattato alla stregua di una persona o che
sia titolare di un diritto alla vita»13
.
Il presente contributo è suddiviso in tre parti. In una prima parte, verranno avanzate alcune
considerazioni generali sulle differenze e le somiglianze tra i due sistemi considerati. Nella
seconda verranno evidenziati e commentati alcuni dati rinvenuti attraverso la ricerca empirica.
In chiusura, saranno individuati alcuni spunti di riflessione e tratte alcune conclusioni
preliminari, soprattutto in vista di potenziali sviluppi futuri nelle relazioni tra le due Corti.
2. Analogie e differenze tra il sistema europeo e quello interamericano di protezione dei
diritti
Prima di procedere all’analisi delle decisioni che contengono riferimenti reciproci, è
opportuno richiamare, in breve, i caratteri comuni alle due Corti e quelli, invece, distintivi di
ciascuna di esse, che possono influenzare la loro propensione alla citazione esplicita14
.
12
Su cui si veda l’analisi di L. Cappuccio in L. CAPPUCCIO, A. LOLLINI, P. TANZARELLA, Le corti regionali tra
Stati e diritti, cit. supra nota 1, 193. 13
Artavia Murillo e altri c. Costa Rica del 28 novembre 2012, par. 253. Questa sentenza esula dall’arco
temporale oggetto della ricerca, che come si dirà meglio più avanti, si chiude al 31 agosto 2012. 14
Per un quadro più esaustivo, si vedano J. GARCÍA ROCA, H. NOGUEIRA ALCALÀ, R. BUSTOS GISBERT, La
comunicación entre ambos sistemas y las características del diálogo, in J. GARCÍA ROCA, P. A. FERNÁNDEZ, P.
SANTOLAYA, R. CANOSA (a cura di), El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de derechos Humanos ,
www.federalismi.it 7
Partendo dai tratti comuni, essi rappresentano il fondamento della presente ricerca: i due
sistemi per la salvaguardia dei diritti umani sono infatti molto simili, sia sotto il profilo
sostanziale, ovvero dei diritti sanciti dalle rispettive carte, sia sotto il profilo procedurale, cioè
delle garanzie giurisdizionali previste.
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha indubbiamente costituito il
principale modello per la redazione della Convenzione americana dei diritti dell’uomo, nel
196915
: si tratta di due cataloghi fondati sui diritti civili e politici, che pongono norme di
principio più che vere e proprie regole, e che hanno lo scopo di proteggere il contenuto
essenziale dei diritti tutelati, in ragione del proprio carattere sussidiario rispetto agli strumenti
nazionali di tutela. Entrambe le carte consentono che la legge possa porre delle limitazioni ai
diritti garantiti, nel rispetto di alcune condizioni previste dai due documenti con formulazioni
analoghe, che fanno riferimento alle misure necessarie, in una società democratica, alla
protezione della sicurezza nazionale o di altri valori (quali l’integrità territoriale, la sicurezza
pubblica, la difesa dell’ordine pubblico, la prevenzione del crimine, la protezione della salute
e dell’igiene pubblica, della morale, dei diritti e delle libertà altrui, etc.).
Analoghe considerazioni possono essere avanzate per quanto riguarda le garanzie
giurisdizionali: il sistema europeo ha infatti influenzato quello americano, al quale tuttavia
sono state apportate alcune correzioni, alla luce dell’esperienza europea16
.
Entrambe le Corti sono dunque organi giurisdizionali autonomi, il cui obiettivo è quello di
applicare le rispettive Convenzioni valutando, nelle questioni rimesse alla loro giurisdizione,
con funzione sussidiaria rispetto alle giurisdizioni nazionali, se uno Stato ha violato un diritto
garantito dalla Convenzione e, in tal caso, ordinando le misure necessarie per riparare alle
conseguenze derivate dalla violazione.
cit. supra nota 1, 79 ss.; L. CAPPUCCIO, A. LOLLINI, P. TANZARELLA, Le corti regionali tra Stati e diritti, cit.
supra nota 1, 1; F. PIOVESAN, Proteção dos direitos humanos : uma anàlise comparativa dos sistemas regionais
europeu e interamericano, in A. VON BOGDANDY, F. PIOVESAN, M. MORALES ANTONIAZZI (a cura di), Direitos
Humanos, Democracia e Integração Jurídica na América do Sul, Rio de Janeiro, 2010, 625 ss. 15
P. G. Carozza ha sottolineato come l’influenza del sistema europeo si sia manifestata anche attraverso il
contributo offerto da alcune singole personalità, che erano state protagoniste nella costruzione del prototipo
europeo: «Il est intéressant de noter que l’un des acteurs majeurs de la conférence spéciale interaméricaine
chargée de rédiger le projet de convention était René Cassin, qui était présent en qualité d’expert invité (et
travailla de concert avec d’autres personnes qui connaissaient le système européen de protection des droits de
l’homme). Cassin intervint à plusieurs reprises afin de comparer les propositions avec le système européen et de
suggérer des solutions parallèles, bien qu’il vît aussi dans ces travaux l’occasion de corriger ou éviter certaines
des difficultés mineures qui étaient apparues en Europe et qu’il proposât de ce fait des axes de recherche
différents» : P. G. CAROZZA, Le cinquantenaire de la Cour européenne des droits de l’homme vu par les autres
juridictions internationales, Strasbourg, 30 gennaio 2009, disponibile all’indirizzo
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A60E9D1E-B58C-48AE-A7E0-
166BD35DDBD0/0/30012009PresidentCarozza Seminaire_fr_.pdf 16
Ibidem.
www.federalismi.it 8
Al di là di quest’impianto comune ai due sistemi, vi sono alcune differenze salienti che
potrebbero incidere sul tema dell’utilizzo, nella motivazione delle decisioni, di citazioni
reciproche: a) l’origine e l’evoluzione storica; b) il contesto di riferimento e il livello di
legittimazione e di accettazione delle decisioni della Corte; c) l’estensione della competenza
ratione materiae; d) il funzionamento e il carico di lavoro della Corte.
a) Sotto il profilo dell’origine e dell’evoluzione storica innanzitutto17
, è opportuno
sottolineare che, sebbene entrambi i sistemi abbiano posto le loro radici all’indomani della
seconda guerra mondiale, il loro sviluppo e la loro piena attuazione hanno avuto luogo in
tempi diversi. L’evoluzione del sistema europeo è stata di gran lunga più rapida, in quanto ha
portato già nel 1959 all’istituzione della Corte, malgrado, fino alla riforma attuata con il
Protocollo XI, entrato in vigore nel 1998, questa non potesse essere adita senza la previa
attività di filtro della Commissione. Il diritto di ricorso individuale (alla Commissione), che
fino al 1998 era soltanto un’opzione che gli Stati membri erano liberi di accettare o meno, nel
1990 era stato sottoscritto da tutti gli Stati membri (allora nel numero di ventidue) e fu in
seguito accettato da tutti gli Stati dell’Europa centrale e orientale, entrati a far parte del
Consiglio d’Europa e della Convenzione dopo tale data.
Nel corso degli anni Novanta ci fu un eccezionale allargamento del numero degli Stati
membri, che ha portato rapidamente all’attuale numero di 47 membri, all’interno dei quali
sono ricomprese realtà molto differenti tra loro, in particolare quanto al livello di
democratizzazione e alla natura delle violazioni di diritti e libertà perpetrate18
.
Dall’altro lato dell’oceano, il sistema interamericano ha invece conosciuto uno sviluppo più
lento e complesso, in seno all’Organizzazione degli Stati americani (OSA)19
. Uno strumento
di garanzia giurisdizionale fu previsto solo in conseguenza dell’emanazione della CADU, nel
17
Sull’evoluzione dei due sistemi, nonché di altri sistemi internazionali di protezione dei diritti umani, si veda T.
BUERGENTHAL, Centennial Essay: The Evolving International Human Rights System, Am.journ.intern.Law,
2006, 703. 18
Ciò ha avuto peraltro un’incidenza sul numero dei casi: nel 2011, la maggior parte delle sentenze aveva come
Stati convenuti principali la Turchia (174), la Russia (133), l’Ucraina (105), la Grecia (73), la Polonia (71), la
Romania (68) e la Bulgaria (62). I contenziosi relativi a questi sette Paesi rappresentavano il 59% delle sentenze
emanate nel corso dell’anno. Si veda il rapporto annuale della Corte EDU per l’anno 2011, on line all’indirizzo
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/001F2457-5173-44B0-ADC8-
B6E0DEC0B134/0/2011_Rapport_Annuel_FR.pdf, 14. 19
Sulla lenta creazione del sistema interamericano, si vedano S. GARCÌA RAMIREZ, The Interamerican Human
Rights Jurisdiction: A Long Journey, introduzione all’opera di L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE TORRES,
The Inter-American Court of Human Rights, Case-Law and Commentary, Oxford, 2011, xvii; T. BUERGENTHAL,
Human Rights in the Americas: View from the Inter-American Court, Conn. J. Int'l L., 1987, 303; D. SHELTON,
The Jurisprudence of the Inter American Court of Human Rights, Am.U.J.Int’l L.&Pol., 1994, 33; L. HENNEBEL,
La Convention américaine des droits de l’homme. Mécanismes de protection et étendue des droits et libertés,
Bruxelles, 2007, 15 ss.
www.federalismi.it 9
1969, e la Corte, istituita nel 1978, ha reso la sua prima decisione in sede giurisdizionale nel
1987.
Non vi è poi, nel sistema interamericano, la stessa corrispondenza riscontrabile in Europa tra
Stati parte della Convenzione e Stati membri dell’organizzazione internazionale in seno alla
quale la stessa è stata emanata: dei 35 Stati membri dell’OSA, infatti, solo 25 hanno ratificato
la CADU20
, e soltanto 21 di essi hanno accettato la giurisdizione della Corte21
. Si tratta di
Paesi dell’America latina, che denotano una spiccata omogeneità culturale e una certa
somiglianza nel livello di democratizzazione e che, avendo attraversato dei processi di
transizione nel corso degli anni Novanta, possono per la maggior parte essere catalogati tra le
“nuove democrazie”22
.
b) Il differente percorso storico delle due Corti aiuta a comprendere il diverso livello di
accettazione delle loro decisioni, che si ripercuote sulle tecniche di motivazione delle stesse.
La Corte EDU gode infatti di un consenso molto più ampio di quello riscontrato dalla Corte
IDU: le resistenze esercitate contro le decisioni della Corte di Costa Rica sono state più
frequenti23
e, sebbene il rifiuto delle condanne ad hoc sembri limitato al caso del Venezuela24
,
l’influenza sistematica della giurisprudenza della Corte IDU è contestata anche in altri Paesi,
come il Brasile. Tali circostanze impongono alla Corte IDU di impegnarsi scrupolosamente a
20
Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa
Rica, Cile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Giamaica, Messico,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay e
Venezuela. Trinidad e Tobago ha denunciato la Convenzione mediante comunicazione al Segretario generale de
l’OSA il 26 maggio 1998. 21
Gli Stati che hanno ammesso la competenza contenziosa della Corte sono i seguenti: Argentina, Barbados,
Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Suriname, Uruguay e Venezuela. 22
L. MEZZETTI, Transizioni costituzionali e consolidamento democratico in America latina agli albori del XXI
secolo, DPCE, 2000, 29; L. MEZZETTI, Le democrazie incerte. Transizioni costituzionali e consolidamento della
democrazia in Europa orientale, Africa, America latina, Asia, Torino, 2000; R. HERNÁNDEZ VALLE, P. PÉREZ
Tremps (a cura di), La justicia constitucional como elemento de consolidación de la democracia en
Centroamérica, Valenzia, 2000; G. O’DONNELL, P. C. SCHMITTER, L. WHITEHEAD (a cura di), Transitions from
authoritarian rule: Latin America, Baltimora, 1986. 23
Su tali resistenze, si veda ad es. C. BINDER, Hacia una Corte constitucional de America latina? La
jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos con enfoque especial sobre aministias, in A.
VON BOGDANDY, E. FERRER-MAC GREGOR, M. MORALES ANTONIAZZI, (a cura di) La justicia constitucional y su
internazionalizaciòn, vol. II, Mexico, 2010, 159 ss., spec. 187; N. P. SAGUÉS, El ‘control de convencionalidad’
como instrumento para la elaboraciòn de un ius commune interamericano, ibidem, 449 ss.; A. R. BREWER-
CARIAS, La interrelaciòn entre los tribunales constitucionales de America latina la Corte interamericana de
derechos humanos, y la cuestiòn de la inejecutabilidad de sus decisiones en Venezuela, in A. VON BOGDANDY, F.
PIOVESAN, M. MORALES ANTONIAZZI (a cura di), Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na
América do Sul, cit. supra nota 14, 661 ss.; M. TAN, Member State compliance with the judgements of the
Interamerican Court of Human Rights, Int’l Journal of legal information, 2005, 319 ss. 24
Sul punto, si veda A. R. BREWER-CARIAS, La interrelación entre los tribunales constitucionales de America
Latina y la Corte interamericana de derechos humanos, y la cuestión de la inejecutabilidad de sus decisiones en
Venezuela, Anuario Iberoamericano de Justicia constitutional, 2009, 89.
www.federalismi.it 10
rendere le proprie decisioni persuasive e incontestabili. La Corte è infatti investita di
importanti poteri decisionali, che esercita con una giurisprudenza audace25
, ma allo stesso
tempo attenta a far sì che le proprie decisioni siano accettate dalle giurisdizioni nazionali,
soprattutto qualora esse impongano degli standard generali, che trovino fondamento in una
giurisprudenza che non coinvolgeva direttamente lo Stato in questione26
.
c) Se è vero, come si è detto, che il sistema europeo è stato il principale modello per la
redazione della CADU, la volontà del sistema americano di differenziarsi per rispondere alle
esigenze specifiche del continente di riferimento fu evidente sin dal principio, il che ha fatto sì
che la Convenzione americana disciplini un numero più vasto di diritti e che alcuni di essi
siano più dettagliati. Per rendere l’idea, il catalogo dei diritti sanciti dalla CEDU comprende
gli articoli da 2 a 13, mentre nella CADU l’elenco dei diritti si estende dall’articolo 3 al 25.
La Convenzione americana prevede già nella sua redazione originaria non solo i diritti civili
tradizionali, ma anche il diritto di proprietà (art. 21 della CADU, introdotto nel sistema
europeo mediante il Protocollo addizionale) e i diritti politici a elezioni libere e all’accesso
alle funzioni pubbliche (art. 23 della CADU, introdotti nel sistema CEDU con il Protocollo n.
3). Inoltre, la lista dei diritti civili è più ricca e articolata. In particolare, la Convenzione
americana sancisce il diritto ad essere riconosciuto in quanto persona (art. 3), il diritto al
nome (art. 18), i diritti del fanciullo (art. 19) e il diritto alla nazionalità (art. 20), oltre che il
“diritto di risposta” a calunnie e diffamazioni (art. 14).
Anche quei diritti che trovano il loro corrispondente nella CEDU, poi, appaiono più dettagliati
nel testo americano: è il caso, ad esempio, del diritto alla vita (art. 4, che comprende dei limiti
espressi alla pena di morte), del divieto di trattamenti inumani (art. 5, che include alcuni diritti
dei detenuti) e ancora del divieto di schiavitù (art. 6), del diritto alla libertà personale (art. 7) e
alla libertà d’espressione (art. 13).
Ancora, la Convenzione americana comprende anche un capitolo dedicato ai diritti sociali e
economici, benché sia composto da un solo articolo (art. 26) dal contenuto programmatico, le
25
Sia per il carattere progressista delle sue decisioni dal punto di vista sostanziale, sia per la fermezza con la
quale ha sancito la natura obbligatoria del controllo di conformità alla Convenzione. In questo senso L.
BURGORGUE LARSEN, El sistema Interamericano de protecciòn de los derechos humanos: entre clasicismo y
creatividad, in A. VON BOGDANDY, C. LANDA RROYO, M. MORALES ANTONIAZZI, (a cura di), Integraciòn
suramericana a travès del derecho? Madrid, 2009, 287 ss. 26
Per una panoramica delle diverse posizioni delle giurisdizioni nazionali in materia di standard dettati dalla
giurisprudenza interamericana, si vedano: M. E. GÒNGORA MERA, Inter-American Judicial Constitucionalism,
San Josè, 2011, 214 ss. (che mostra come talune corti nazionali non facciano ricorso di frequente alla
giurisprudenza della Corte interamericana); J. P. SAGUÉS, Las relaciones entre los tribunales internazionales y
los tribunales nacionales en materia de Derechos Humanos. Experencias recentes, Ius et Praxis, 2003, 205.
www.federalismi.it 11
cui disposizioni sono poi completate da un Protocollo addizionale (il Protocollo di San
Salvador, ad oggi ratificato da 16 Stati membri).
Inoltre, la Corte IDU in sede giurisdizionale è competente a conoscere anche di violazioni di
altri documenti oltre alla CADU, in particolare di strumenti giuridici applicabili negli Stati
dell’OSA.
Infatti, benché la Corte, alla luce dell’art. 62 della CADU e dell’art. 1 del suo Statuto, sia
investita della sola competenza a conoscere, in sede contenziosa27
, i ricorsi concernenti la
CADU28
, altri trattati le hanno in seguito accordato, ora in maniera esplicita ora implicita29
, la
competenza contenziosa per le violazioni delle loro disposizioni30
.
d) Infine, i due sistemi divergono significativamente quanto alle regole di funzionamento e al
carico di lavoro di cui sono investite le rispettive Corti.
Nell’evoluzione del sistema CEDU, il Protocollo n. 11 ha segnato un vero punto di svolta
laddove ha imposto a tutti gli Stati parti la giurisdizione della Corte e, soprattutto, laddove ha
eliminato il filtro da parte della Commissione e ha introdotto la possibilità di ricorso
individuale alla Corte. Tale riforma, insieme con l’allargamento geografico, ha comportato
una moltiplicazione dei ricorsi, che ha condotto all’attuale e ben nota situazione di
sovraccarico di lavoro31
.
Allo stesso tempo, la Corte è diventata permanente: è composta da 47 giudici, uno per ogni
Stato membro, che provengono dunque da contesti giuridici e culturali molto diversi tra loro.
27
Nell’esercizio della funzione consultiva, invece, può rendere dei pareri sull’interpretazione «di altri trattati
concernenti la protezione dei diritti umani negli Stati americani»: art. 64 CADU e art. 71 delle Regole di
procedura della CorteIDU. 28
A differenza della Commissione interamericana per i diritti dell’uomo che, ai sensi del proprio regolamento, è
abilitata a conoscere delle violazioni dei diritti riconosciuti non solo dalla Convenzione, ma anche da tutti i
documenti applicabili agli stati membri dell’OSA: art. 23 Regolamento della Commissione. 29
Sulla competenza ratione materiae della Corte e per alcuni esempi giurisprudenziali nei quali la Corte ha
ammesso l’estensione della propria competenza, si vedano L. HENNEBEL, La Convention américaine des droits
de l’homme, cit. supra nota 19, 115 ss.; H. TIGROUDJA, I. K. PANOUSSIS, La Cour interaméricaine des droits de
l’homme. Analyse de la jurisprudence consultative et contentieuse, Bruxelles, 2003, 76 ss. 30
Si vedano, ad esempio, l’art. 8 de la Convenzione interamericana per la prevenzione e la repressione della
tortura e l’art. 13 della Convenzione interamericana sulle sparizioni forzate. 31
Alla fine del 2011, oltre 151 600 ricorsi erano pendenti dinanzi alla Corte EDU. Mentre la “vecchia” Corte,
nell’organizzazione precedente alla riforma introdotta dal Protocollo n. 11, aveva reso meno di 1 000 sentenze, la
nuova Corte ne aveva già pronunciate più di 14 000 prima della fine del 2011: si veda il rapporto annuale della
CorteEDU per l’anno 2011, all’indirizzo http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/001F2457-5173-44B0-ADC8-
B6E0DEC0B134/0/2011_Rapport_Annuel_FR.pdf, 14 e 155.
Per permettere alla Corte di gestire l’ingente carico di lavoro dato dalla nuova procedura, sono stati apportati dei
cambiamenti strutturali importanti all’organizzazione della cancelleria: in particolare, è stata creata una sezione
di filtraggio, appositamente dedicata a esaminare i ricorsi presentati contro i cinque Stati che rappresentano i
convenuti nella maggior parte dei casi dinanzi alla Corte (Ibidem, 20).
www.federalismi.it 12
Nel sistema americano, il filtro da parte della Commissione esiste ancora: i ricorsi individuali
(che, a differenza di quanto avviene nel sistema europeo, possono essere sottomessi non solo
dalla vittima della violazione, ma da tutti coloro che dimostrino un interesse concreto,
compresi i suoi familiari, nonché le ONG32
) non possono essere indirizzati direttamente alla
Corte, ma devono passare per il vaglio della Commissione, la quale ha il compito di adire
eventualmente la Corte (anche se la modifica del regolamento della Commissione intervenuta
nel 2000 stabilisce cha questa debba adire la Corte, salvo in caso di decisione contraria
adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri33
). Benché non possano agire direttamente
dinanzi alla Corte, tuttavia, le vittime presunte, i loro parenti o i loro rappresentanti possono
oramai, a seguito di un’evoluzione per tappe della procedura34
, presentare argomenti e prove
alla Corte, nonché prendere parte alle udienze.
Oltre alla competenza in sede contenziosa, la Corte IDU è dotata di altre competenze, come
quella consultiva, per mezzo della quale essa risponde a quesiti formulati dagli Stati membri
dell’OSA o da organi istituzionali della medesima, relativi all’interpretazione della
Convenzione americana o di altri trattati aventi ad oggetto la tutela dei diritti umani negli Stati
americani. Inoltre, sulla base di tale competenza, la Corte può, su richiesta di uno Stato
membro dell’OSA, emanare un parere sulla compatibilità di norme interne con gli strumenti
del sistema interamericano35
.
La Corte IDU non è un organo permanente, ma siede in sessione36
ed è composta da soli 7
giudici provenienti da Stati membri dell’OSA (che abbiano ratificato la Convenzione ma non
necessariamente che abbiano accettato la giurisdizione della Corte)37
, i quali, fatta eccezione
per l’eventuale presenza di giuristi anglosassoni38
, provengono di norma dal contesto
32
Art. 44 CADH. Sul ruolo di primo piano ricoperto dalle ONG nello sviluppo del sistema interamericano di
tutela dei diritti, si veda: M. PINTO, Ngos and the Inter-American Court of Human Rights in T. TREVES, M.
FRIGESSI DI RATTALMA, A. TANZI, A. FODELLA, C. PITEA, C. RAGNI (a cura di), Civil Society, International
Courts and Compliance Bodies, La Haye, 2005, 47. 33
Art. 45 co. 1 del Regolamento della Commissione interamericana dei diritti dell’uomo. 34
Su tale evoluzione si veda R. E. GIALDINO, Le nouveau règlement de la Cour interaméricaine des droits de
l’homme, RTDH, 2005, 979. 35
Per una sintesi delle competenze della Corte IDU, si veda C. M. PELAYO MOLLER, Introducciòn al sistema
interamericano de derechos humanos, Mexico, 2011. 36
Il progetto di Statuto redatto dalla Corte prevedeva una corte permanente composta da giudici nominati a
tempo pieno, ma l’assemblea generale dell’OSA aveva ritenuto tale proposta troppo onerosa: così ricorda T.
BUERGENTHAL, The Inter-american Court of Human Rights, Am.journ.intern.Law, 1982, 231. I giudici possono
essere convocati per delle sessioni straordinarie ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ma tale
opzione, sebbene talvolta utilizzata, ha dovuto altresì essere spesso scartata per ragioni di bilancio. 37
La Corte siede e rende decisioni soltanto in sessione plenaria. Inoltre, la Convenzione prevede che la Corte
possa essere integrata da dei giudici ad hoc, qualora nessuno dei giudici eletti provenga dallo Stato parte di un
giudizio: in tal caso, è proprio lo Stato in questione a nominare un giudice ad hoc. 38
Fu il caso, ad esempio, del giudice Thomas Buergenthal, che ha svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo
della CorteIDU tra il 1979 e il 1991.
www.federalismi.it 13
giuridico e culturale sudamericano. Tale circostanza è tutt’altro che priva di conseguenze
quanto al soggetto in esame, se si considera la propensione di molte giurisdizioni
sudamericane a citare fonti extra-sistemiche, ivi compresi precedenti stranieri39
.
In un sistema giurisdizionale che non preveda una corte permanente, un ruolo essenziale è
ovviamente giocato dal personale dipendente e, in particolare, dalla cancelleria40
. Tuttavia, la
Corte IDU può contare su un numero piuttosto esiguo di funzionari: il budget limitato di cui
dispone non le consente di assumere più di una trentina di persone41
, a fronte dei circa 600
dipendenti della Corte EDU42
.
Anche per quanto concerne il carico di lavoro le due Corti divergono significativamente: il
numero dei ricorsi rimessi alla Corte IDU in sede contenziosa rimane circoscritto (per dare
un’idea, 23 nel 201143
), e ancora meno numerose sono le richieste presentate in sede
consultiva (nella quale la Corte ha emanato 20 pareri dall’inizio della sua attività)44
. La Corte
interamericana è inoltre competente a controllare l’esecuzione delle sue decisioni; una
competenza, questa, guardata con sempre maggiore interesse dal punto di vista europeo. Il
minor carico di lavoro di cui è gravata la Corte IDU implica, per quanto riguarda l’oggetto del
presente studio, che essa è in grado di dedicare una maggiore attenzione ad ogni singolo caso,
potendo così sviluppare studi e argomentazioni estesi e approfonditi.
39 Si veda M. J. GARCIA-MANSILLA, La Corte Suprema de los Estados Unidos y su debil influencia en
Iberoamerica in P. MANILI (a cura di), Tratado de derecho procesal constitucional, III, Buenos Aires, 2010,
109; V. A. DA SILVA, Integração e Diálogo Constitucional na América do Sul, in A. VON BOGDANDY, F.
PIOVESAN, M. MORALES ANTONIAZZI (a cura di), Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na
América do Sul, cit. supra nota 14, 530; M. NEVES, Breves Considerações com Especial Referência à
Experiênica Latino-Americana, ibidem, 255. 40
Al contrario della Corte, infatti, la cancelleria svolge la propria funzione a tempo pieno presso la sede di Costa
Rica. Il cancelliere, nominato dalla Corte per un mandato di cinque anni rinnovabile, organizza la cancelleria. 41
L. HENNEBEL, La Convention américaine des droits de l’homme. Mécanismes de protection et étendue des
droits et libertés, cit. supra nota 19, 74 ss. 42
Secondo il rapporto annuale della Corte EDU per l’anno 2011, la cancelleria nel 2011 poteva contare su 658
agenti, di cui circa la metà assunti con contratti a tempo indeterminato (si veda il rapporto annuale 2011
all’indirizzo http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/001F2457-5173-44B0-ADC8-
B6E0DEC0B134/0/2011_Rapport_Annuel_FR.pdf, 20. 43
Per un totale di 174 ricorsi in sede contenziosa dal 1986 alla fine del 2011 (si consideri che ogni ricorso può
dare luogo a più di una decisione, qualora la Corte non decida al contempo sulle eccezioni preliminari, il merito
e la riparazione e le spese): si veda il rapporto sull’attività della Corte per l’anno 2011, all’indirizzo
http://www.scm.oas.org/pdfs/2012/CP28109.pdf. 44
I pareri emanati dalla CorteIDU in sede consultiva sono reperibili sul sito della Corte, nella sezione
“Jurisprudence – Advisory opinions”.
www.federalismi.it 14
3. La ricerca empirica: le citazioni esplicite nel periodo 1987-2012
3.1. Premesse metodologiche
L’analisi empirica qui presentata ha ad oggetto tutte le sentenze emanate dalle due Corti
nell’esercizio della loro funzione contenziosa45
a partire dal 1987, anno nel quale la Corte
interamericana ha reso la sua prima sentenza46
, fino al 31 agosto 2012.
In tale universo, sono state selezionate le pronunce che contengono almeno una citazione
della giurisprudenza dell’altra Corte o della Commissione dell’altro sistema regionale.
Le decisioni esaminate sono state selezionate in un primo momento mediante i sistemi di
ricerca forniti dai siti web delle due Corti, attraverso una ricerca per parole-chiave47
nelle loro
banche-dati.
Dato il numero esiguo di decisioni emanate dalla Corte interamericana, in un secondo
momento si è voluta verificare l’attendibilità dei dati così ottenuti, ripetendo la ricerca per
parole-chiave su ogni singola decisione. Tale verifica ha fornito dei risultati molto diversi
rispetto a quelli ottenuti mediante la prima ricerca, il che ci costringe ad accettare un certo
margine di errore per quel che riguarda la Corte europea, per la quale, a causa del numero
elevato di pronunce, non è stato possibile effettuare una ricerca per parole chiave decisione
per decisione.
Una volta individuate le pronunce che contengono riferimenti all’altro sistema regionale di
tutela dei diritti, si è proceduto alla loro analisi da una prospettiva quantitativa e qualitativa.
Mediante l’analisi quantitativa, sono state tenute in conto le pronunce contenenti almeno una
citazione della giurisprudenza dell’altra Corte o della Commissione dell’altro sistema
regionale, mettendo in evidenza il rapporto tra il numero di decisioni che presentino almeno
una citazione e il numero totale delle pronunce emanate (Fig. 1), nonché la tendenza alla
citazione in prospettiva diacronica in numero assoluto (Fig. 2) e in percentuale (Fig. 3).
Dal punto di vista qualitativo, si è cercato quindi di valutare la rilevanza delle citazioni
individuate, in un primo momento per mezzo di indicatori formali, quali il “luogo” della
decisione nella quale è situata la citazione (considerazioni in fatto o in diritto; opinione di
45
Non abbiamo preso in considerazione, ai fini del presente lavoro, le altre competenze della Corte IDU, in
particolare la funzione consultiva e la competenza nell’adozione di misure provvisorie. 46
Si trattava di una pronuncia sulle sole eccezioni preliminari, mentre la prima decisione sul merito è stata resa
soltanto nel 1988. 47
La ricerca è stata realizzata, per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte EDU, sulle banche dati in
Inglese e in Francese, utilizzando le parole-chiave “interamerican”, “inter-american” (in considerazione della
doppia grafia impiegata per l’aggettivo in questione), “interaméricaine”, “interam” e “inter-am” (queste ultime,
in considerazione del fatto che le citazioni in nota sono spessso abbreviate); con riferiemento, invece, alla
giurisprudenza della CorteIDU, la ricerca è stata condotta sulle banche dati in Inglese e in Spagnolo, con le
parole-chiave “european”, “europeo”, “europea” e “eur”.
www.federalismi.it 15
maggioranza o opinione separata) (Fig. 4 e 5), il soggetto che ha introdotto la citazione
(rectius, il soggetto cui sembra riconducibile l’introduzione della citazione, alla luce di quanto
riportato nella motivazione) (Fig. 6), la compresenza di altri riferimenti extra-sistemici (Fig.
7).
In un secondo momento, sono stati impiegati indicatori sostanziali, finalizzati a valutare
l’influenza della citazione sulla decisione (cercando, per ogni citazione, di verificare se si
tratti di un argomento utilizzato nella fase cognitiva o in quella decisionale, o ancora se si
tratti di un argomento utilizzato “a contrario”48
.
Tale disamina permette di offrire una prima descrizione, seppur non esaustiva, della
circolazione esplicita della giurisprudenza tra le due Corti.
3.2. Analisi quantitativa
3.2.1. Considerazioni generali
Già da una prima osservazione del numero di citazioni reciproche, in rapporto al numero di
decisioni emanate in sede contenziosa, emerge nettamente l’importante distanza numerica tra
i dati delle due Corti.
Tra il 1987 e il 2012 (fino al 31 agosto) la Corte IDU ha emanato 246 decisioni in sede
contenziosa, nel 59,8% delle quali è riscontrabile una qualche citazione della giurisprudenza
della Corte EDU o della Commissione, per un totale di 147 decisioni.
La Corte EDU, nello stesso lasso di tempo, ha reso invece 15 778 decisioni, ma soltanto in 48
di esse, pari allo 0,3% del totale, si ritrova qualche riferimento a pronunce della Corte o della
Commissione interamericana.
48
Per questa classificazione, T. GROPPI, M. C. PONTHOREAU, How to Assess the Reality of Trans-judicial
Communication? in T. GROPPI, M. C. PONTHOREAU, The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges,
cit. supra nota 3.
www.federalismi.it 16
Fig. 1. Le decisioni che contengono citazioni della giurisprudenza dell’altro sistema
La differenza tra i due dati numerici è indubbiamente notevole.
Si possono avanzare diverse ipotesi per tentare di comprendere il fenomeno, legate in
particolare alle differenze tra i due sistemi che sono state richiamate.
a) Innanzitutto, si può tentare di spiegare il dato alla luce della più recente creazione della
Corte IDU che, in qualità di giurisdizione di nuova formazione, sarebbe maggiormente incline
all’apertura nei confronti della giurisprudenza proveniente da una corte più antica e influente,
59,8%
40,2%
Corte interamericana dei diritti dell'uomo
con citaz.
senza citaz.
0,3%
99,7%
Corte europea dei diritti dell'uomo
con citaz.
senza citaz.
www.federalismi.it 17
secondo una prassi diffusa tra le corti costituzionali, dove tale atteggiamento è stato
frequentemente riscontrato. L’analisi della giurisprudenza delle corti nazionali ha mostrato
infatti che, quando una corte inizia a dotarsi di un cospicuo patrimonio di precedenti propri,
diminuisce il ricorso alla citazione di decisioni straniere49
. Per verificare tale ipotesi, è
necessario esaminare il dato in prospettiva diacronica.
b) Ancora, si potrebbero avanzare altre ipotesi, legate al differente contesto nel quale le due
Corti si trovano ad operare e al grado di legittimazione del quale dispongono. Il fatto che la
Corte IDU incontri una maggiore resistenza e goda, in definitiva, di un minore
riconoscimento all’interno del proprio sistema di riferimento, la porterebbe a dover motivare
le proprie decisioni in maniera particolarmente ricca e articolata, per tentare di favorirne una
maggiore accettazione. Il fatto, poi, che il contesto nel quale opera sia stato a lungo
caratterizzato da ordinamenti non democratici, avrebbe generato l’esigenza di rivolgersi al di
là dei confini regionali per l’individuazione degli standard di tutela. Il ricorso a fonti extra-
sistemiche, quali la giurisprudenza della Corte EDU, sarebbe perciò la conseguenza, da un
lato, della scelta consapevole di interpretare il proprio ruolo di corte internazionale dei diritti
umani secondo una prospettiva universalista e, dall’altro, di un’esigenza pratica di effettività
della tutela dei diritti e di legittimazione del proprio operato, dato che guardare all’interno dei
confini degli Stati membri del proprio sistema regionale sarebbe stato poco proficuo e, in
definitiva, tutt’altro che persuasivo, sia per le difficoltà incontrate da molti Stati nella garanzia
dei diritti e delle libertà, sia per l’assenza di una circolazione orizzontale o di una convergenza
ben stabilita tra le giurisdizioni degli Stati membri, che renda riscontrabile un consenso
giurisprudenziale intorno a certi standard.
L’atteggiamento della Corte EDU, nei confronti dell’utilizzo della giurisprudenza della sua
omologa americana, potrebbe invece essere spiegato alla luce della sua prospettiva più
regionalista, che si fonda sull’individuazione del contenuto dei diritti a partire dalle
concezioni riscontrabili negli ordinamenti degli Stati membri, grazie alla quale la Corte ha
accresciuto la propria legittimazione. Questa tendenza a ricercare il consenso regionale per la
determinazione degli standard comporterebbe per la Corte EDU una minore propensione a
guardare al di là dei confini europei50
.
49 M. C. PONTHOREAU, Le recours à l’argument de droit comparé par le juge constitutionnel. Quelques
problèmes théorique et techniques, in F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN (a cura di), L’interprétation constitutionnelle,
Paris, 2005, 168. 50
Una Corte dove la prospettiva del “looking down” - alle soluzioni e prassi degli Stati membri - la importa sulla
prospettiva del “looking up” - alla dimensione internazionale della tutela dei diritti. Così L. GARLICKI,
www.federalismi.it 18
Per verificare tali ipotesi, bisognerà appurare, mediante un’analisi qualitativa, la compresenza
e l’incidenza, nelle motivazioni delle due Corti, di altri argomenti extra-sistemici, quali la
citazione di documenti delle Nazioni Unite, di decisioni di altre corti internazionali o di
pronunce di corti nazionali di Paesi estranei alla loro giurisdizione.
L’analisi che segue, che si sviluppa come anticipato sul piano quantitativo e qualitativo,
cercherà di verificare tali ipotesi, anche se occorre tenere presente altresì l’influenza esercitata
dalle modalità di funzionamento e dal diverso carico di lavoro delle due Corti sul ricorso a
decisioni extra-sistemiche. L’organizzazione di ciascuna corte può infatti avere una certa
rilevanza quanto al ruolo svolto dalla struttura amministrativa nella redazione delle decisioni,
all’incidenza della formazione personale dei giudici, al margine di manovra lasciato al
contributo delle parti o di altri soggetti nell’introduzione degli argomenti, ecc. Tutti aspetti
rilevanti e significativi, che però sfuggono allo scopo di questo lavoro, che resta circoscritto
all’analisi giurisprudenziale.
Conferencia introductoria: Universalism v. Regionalism? The role of the supranational judicial dialog, in J.
GARCÍA ROCA, P. A. FERNÁNDEZ, P. SANTOLAYA, R. CANOSA (a cura di), El Diálogo entre los Sistemas Europeo
y Americano de derechos Humanos, cit. supra nota 1, 27, spec. 36. Su questa tendenza dela Corte EDU a
ricercare il consenso regionale attraverso la comparazione tra gli ordinamenti degli Stati membri si vedano i
contributi indicati supra nota 6.
www.federalismi.it 19
3.2.2. La prospettiva diacronica
Fig.2. Le citazioni in una prospettiva diacronica (numero assoluto)
Se si esaminano le citazioni in una prospettiva diacronica, è facile verificare, come avanzato
nelle ipotesi, che la Corte IDU ha cominciato a citare la giurisprudenza europea sin dagli
esordi.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Corte interamericana dei diritti dell'uomo
0
1
2
3
4
5
6
7
Corte europea dei diritti dell'uomo
www.federalismi.it 20
Si noti, inoltre, che già prima di iniziare ad esercitare la propria funzione in sede contenziosa,
la stessa aveva già sviluppato tale prassi nella funzione consultiva (che non è oggetto della
presente analisi): tra il 1982 e il 1987, la Corte IDU aveva adottato 7 opinioni consultive,
ciascuna delle quali conteneva almeno un riferimento al sistema europeo e 5 di esse una
citazione della giurisprudenza europea.
Una ricerca empirica sulle opinioni consultive realizzata nel 200851
ha mostrato che tale prassi
è rimasta immutata nel tempo e che, sulle 19 opinioni consultive emanate alla data dello
studio, 8 contenevano citazioni della giurisprudenza della Corte EDU52
. In un’opinione in
materia di diritti del fanciullo, emanata nel 2002, erano citate addirittura 25 sentenze della
Corte EDU53
.
Anche in sede contenziosa, al contrario di quanto ci si sarebbe potuti aspettare, tale tendenza
non ha mostrato alcuna flessione nel tempo, sia se si considera il numero assoluto di decisioni
che citano la giurisprudenza europea, sia se si considera il dato percentuale: ciò significa che
non sembra trattarsi di un fenomeno transitorio, destinato ad arrestarsi una volta che la Corte
IDU abbia acquisito una maggiore influenza e legittimazione.
Venendo invece all’analisi della giurisprudenza della Corte EDU, il numero di citazioni
dell’altra Corte rinvenute è alquanto ridotto e, se si guarda al dato percentuale sul numero
totale di decisioni, quasi irrilevante.
Venendo invece all’analisi della giurisprudenza della Corte EDU, il numero di citazioni
dell’altra Corte rinvenute (mediante la ricerca per parole-chiave sulla banca dati del sito della
Corte) è alquanto ridotto e, se si guarda al dato percentuale sul numero totale di decisioni,
quasi irrilevante.
51
A. GARRO, La influencia del TEDH en el ejercicio de la funcion consutiva de la CourIDH, Cuestiones
constitucionales, 2009, 191 ss. 52
Nel 2009 la Corte IDU ha emanato la sua ventesima opinione consultiva, nella quale non fa riferimento alla
giurisprudenza della Corte europea. 53
Corte IDU, Opinion consultiva Condiciòn juridica y derechos del nino, OC-17/02, 28 agosto 2002.
www.federalismi.it 21
Fig.3 Le citazioni in una prospettiva diacronica (percentuale sul totale delle decisioni per
anno)
Ciononostante, il leggero aumento del numero delle citazioni – in valore assoluto – nel corso
degli anni Duemila merita qualche riflessione.
Una prima spiegazione del fenomeno riposa sull’entrata vigore del Protocollo n. 11 e sul
conseguente aumento delle decisioni, che implicherebbe una maggiore probabilità di
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Corte europea dei diritti dell'uomo
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
19
80
-87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Corte interamericana dei diritti dell'uomo
www.federalismi.it 22
citazione. In effetti, il dato percentuale, a conforto di questa tesi, mostra che mentre il numero
assoluto di decisioni contenenti citazioni aumenta, la percentuale diminuisce.
Una spiegazione meno immediata, ma forse più interessante, fa riferimento al fatto che in
quegli anni, mentre da un lato la Corte IDU sviluppava una propria giurisprudenza, la Corte
EDU si trovava sempre più spesso a conoscere questioni aventi ad oggetto gravi violazioni dei
diritti, sulle quali la giurisprudenza interamericana si rivelava più ricca e avanzata. Pertanto,
la Corte EDU aveva delle nuove motivazioni per interessarsi all’attività della più giovane
Corte interamericana54
.
A questo punto, solo un’analisi qualitativa, che esamini in dettaglio ogni singola decisione
contenente citazioni, può aiutare a chiarire tali questioni.
3.3. Analisi qualitativa
3.3.1. Analisi formale
L’analisi qualitativa delle 48 decisioni della Corte EDU contenenti almeno una citazione della
giurisprudenza del sistema interamericano (ivi comprese dunque sia le pronunce della Corte
che della Commissione) conduce ad un’ulteriore riduzione della loro rilevanza per l’oggetto
della ricerca: in 16 casi, infatti, sono solo le parti55
o i soggetti intervenienti56
a citare la
54
Sul punto, si veda M. PHILIP-GAY, La poursuite des auteurs de graves violations de droits de l’homme : une
influence de la jurisprudence interaméricaine sur le système européen ?’ in E. LAMBERT ABDELGAWAD, K.
MARTIN-CHENUT (a cura di), Réparer les violations graves et massives des droits de l'homme : la cour
interaméricaine, pionnière et modèle?, Paris, 2010, 263 ss. 55
La citazione è fatta solo dalle parti in: Akkum e altri c. Turchia, Ric. n. 21894/93, 24 marzo 2005; Ergi c.
Turchia, Ric. n. 66/1997/850/1057, 28 luglio 1998; Ertak c. Turchia, Ric. n. 20764/92, 9 maggio 2000; Sarli c.
Turchia, Ric. n. 24490/94, 22 maggio 2001; Bersunkayeva c. Russia, Ric. n. 27233/03, 4 dicembre 2008;
Janowiec e altri c. Russia, Ric. n. 55508/07 e 29520/09, 16 aprile 2012. In nessuna di queste decisioni la
citazione è poi ripresa dalla Corte nelle sue considerazioni; la Corte riprende invece la citazione effettuata dalle
parti nel caso Kurt c. Turchia. 56
La citazione si deve: a Amnesty international in Aydin c. Turchia, Ric. n. 57/1996/676/866, 25 settembre
1997; al Center for Justice and International Law in Timurtas c. Turchia, Ric. n. 23531/94, 13 giugno 2000; alla
Northern Ireland Human Rights Commission in: Hugh Jordan c. Regno Unito, Ric. n. 24746/94, 4 maggio 2001,
McKerr c. Regno Unito, Ric. n. 28883/95, 4 maggio 2001, Shanaghan c. Regno Unito, Ric. n. 37715/97, 4
maggio 2001 e Kelly e altri c. Regno Unito, Ric. n. 30054/96, 4 maggio 2001; all’associazione Centre des droits
génésiques (Center for Reproductive Rights) dans Vo c. Francia, Ric. n. 53924/00, 8 luglio 2004;
all’associazione Liberty and Justice in A. c. Paesi Bassi, Ric. n. 4900/06, 20 luglio 2010; a due ONG, Article
19 e Open Society Justice Initiative, in Kasabova c. Bulgaria, Ric. n. 22385/03, 19 aprile 2011; all’ONG
intervenuta in Hirsi Jamaa e altri c. Italia, Ric. n. 27765/09, 23 febbraio 2012. In nessuna di queste decisioni la
citazione è poi ripresa espressamente dalla Corte nelle sue considerazioni; tuttavia, nel caso Hirsi Jamaa, la
citazione dei terzi intervenuti è poi ripresa dal giudice autore di un’opinione dissenziente. In altre 5 decisioni,
invece, la Corte cita espressamente la giurisprudenza interamericana richiamata dai terzi intervenuti.
www.federalismi.it 23
giurisprudenza interamericana e in 4 casi la citazione è contenuta soltanto in opinioni
separate57
(Fig. 4).
All’interno delle pronunce nelle quali è la Corte a farvi espressamente riferimento, poi,
soltanto in 17 casi le citazioni sono contenute nella parte “in diritto” della motivazione,
mentre nelle restanti 1158
le citazioni sono contenute solo nella parte “in fatto”, e in
particolare nella parte dedicata all’analisi del diritto internazionale rilevante, senza essere
riprese nella parte in diritto59
.
Dall’esame delle 147 decisioni della Corte interamericana che fanno riferimento alla
giurisprudenza europea, emerge che in 17 di esse le citazioni sono situate esclusivamente in
opinioni separate60
, in 5 tra gli argomenti avanzati dalla Commissione61
o dagli Stati costituiti
in giudizio62
, riportati dalla Corte nella motivazione, mentre la citazione è contenuta
all’interno delle considerazione della Corte, e dunque nella motivazione giuridica della
decisione, in 125 decisioni (da notare che nelle motivazioni delle pronunce della Corte
interamericana non vi è la ripartizione esplicita tra “fatto” e “diritto” che si trova invece nella
giurisprudenza della Corte EDU).
57
Anguelova c. Bulgaria, Ric. n. 38361/97, 13 giugno 2002; Cicek c. Turchia, Ric. n. 25704/94, 27 febbraio
2001; Hasan Ilhan c. Turchia, Ric. n. 22494/93, 9 novembre 2004; Konstantin Markin c. Russia, Ric. n.
30078/06, 22 marzo 2012. In altre 3 decisioni, poi, le opinioni separate contengono delle citazioni, laddove
l’opinione di maggioranza fa anch’essa riferimento alla giurisprudenza interamericana. Si tratta dei casi: Kurt c.
Turchia, Ric. n. 24276/94, 25 maggio 1998; Palomo Sanchez e altri c. Spagna, Ric. n. 28955/06, 28957/06,
28959/06 e 28964/06 12 settembre 2011 e Hirsi Jamaa e altri c. Italia, Ric. n. 27765/09, 23 febbraio 2012 (in
quest’ultima, la Corte non riprende la citazione nelle proprie considerazioni in diritto, ma la menziona nella parte
dedicata alle osservazioni dei terzi intervenuti). 58
In 4 di esse la Corte cita dei rapporti della Commissione: G.B. c. Bulgaria, Ric. n. 42346/98, 17 marzo 2004;
Iorgov c. Bulgaria, Ric. n.40653/98, 11 marzo 2004; Bayatyan c. Armenia, Ric. n. 23459/03, 7 luglio 2011;
Sitaropoulos e Giakoumopoulos c. Grecia, Ric. n. 42202/07, 15 marzo 2012; nelle 7 rimanenti, è la
giurisprudenza della Corte ad essere citata: Kurt c. Turchia, Ric. n. 24276/94, 25 maggio 1998; Bevacqua e S. c.
Bulgaria, Ric. n. 71127/01, 12 giugno 2008; Lexa c. Slovacchia, Ric. n. 54334/00, 23 settembre 2008; Gafgen c.
Germania, GC, Ric. n. 22978/05, 1 juin 2010; Al-skeini e al. c. Regno Unito, GC, Ric. n. 55721/07, 7 luglio
2011; Portmann c. Svizzera, Ric. n. 38455/06, 11 ottobre 2011; Babar Ahmad e al. c. Regno Unito, Ric. n.
24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09, 10 aprile 2012.
59
Tra queste sentenze nelle quali la Corte stessa fa riferimento alla giurisprudenza interamericana, in 5 sono
citati soltanto dei rapporti della Commissione. Si tratta dei casi G.B. c. Bulgaria, Ric. n. 42346/98, 17 marzo
2004; Iorgov c. Bulgaria, Ric. n.40653/98, 11 marzo 2004; Sitaropoulos e Giakoumopoulos c. Grecia, Ric. n.
42202/07, 15 marzo 2012; Bayatyan c. Armenia, Ric. n. 23459/03, 7 luglio 2011; nel primo di questi, il principio
giurisprudenziale citato figura tra gli argomenti della Corte come principio di diritto internazionale applicabile,
mentre negli altri casi si tratta di mere considerazioni dif atto sul diritto internazionale esistente. 60
Oltre a queste, vi sono altresì 34 decisioni delle quali la citazione è contenuta in un’opinione separata, ma là
dove l’opinione di maggioranza fa anch’essa riferimento alla giurisprudenza europea. 61
La Corte richiama le citazioni della giurisprudenza europea ad opera della Commissione nelle seguenti
sentenze: Caballero-Delgado e Santana c. Colombia, 21 gennaio 1994 (Eccezioni preliminari); Gangaram-
Panday c. Suriname, 21 gennaio 1994 (Merito, riparazione e spese); Loayza-Tamayo c. Perù, 17 settembre 1997
(Merito); Las Palmeras c. Colombia, 6 dicembre 2001 (Merito). In altre 7 decisioni, invece, la Corte riprende
espressamente e fa proprie nelle sue considerazioni le citazioni introdotte dalla Commissione. 62
In una di queste decisioni, le citazioni sono introdotte dallo Stato e richiamate dalla Corte nella parte in cui
riporta le osservazioni delle parti (Grande c. Argentina, 31 agosto 2011 - Eccezioni preliminari e merito); in un
altro caso, invece, la Corte fa esplicitamente riferimento alle citazioni dello Stato all’interno delle proprie
considerazioni (El Amparo c. Venezuela, 14 settembre 1996 – Riparazione e spese).
www.federalismi.it 24
Fig.4 Il “luogo” delle citazioni, sul totale delle decisioni che contengono citazioni
Confrontando i dati delle due corti quanto al luogo in cui è situata la citazione della
giurisprudenza dell’altro sistema, si può notare che in entrambi i casi le citazioni sono
contenute principalmente nell’opinione della Corte, e non in opinioni separate, anche se, per
quanto riguarda la giurisprudenza interamericana, si può osservare una più spiccata tendenza
dei singoli giudici a citare la giurisprudenza europea nelle loro opinioni separate (Fig. 5).
48%
33%
8%
11%
Corte europea dei diritti dell'uomo (percentuale sul totale delle decisioni)
Solo consid. Corte
Solo oss. parti/terzi
Solo op. sep.
Diversi "luoghi" delle citaz.
61%
3%
12%
24%
Corte interamericana dei diritti dell'uomo (percentuale sul totale delle decisioni)
Solo consid. Corte
Solo oss. Parti/Comm.
Solo op. sep.
Diversi "luoghi" delle citaz.
www.federalismi.it 25
Fig. 5. Il luogo delle citazioni, sul totale delle citazioni
L’analisi condotta non consente di verificare, per ogni citazione, il soggetto che ha introdotto
l’argomento di diritto comparato nel giudizio, tranne nel caso in cui sia la Corte a farne
menzione nella motivazione (Fig. 6)63
.
63
In questo modo abbiamo potuto verificare che, per quanto riguarda la CorteIDU, su un totale di 181 citazioni
(ivi comprendendo non solo le 147 decisioni nelle quali figura almeno una citazione, ma anche le citazioni
contenute in un’opinione separata nei casi in cui altre citazioni sono presenti nell’opinione della Corte), in
relazione a 122 di esse la Corte non esplicita chi è il soggetto che ha introdotto la citazione, così che si potrebbe
pensare che essa l’abbia introdotta d’ufficio; viceversa, in 11 occasioni sappiamo che è la Commissione che ha
introdotto le citazioni, in 2 lo Stato, in altre un esperto sentito dalla Corte. Con riferimento alle opinioni
dissenzienti, nella maggioranza dei casi è il giudice autore dell’opinione che introduce le citazioni, per un totale
di 44 casi su 51. Per quanto concerne, invece, la CorteEDU, su un totale di 51 citazioni (contate secondo lo
50%
37%
13%
Corte europea dei diritti dell'uomo (percentuale sul totale delle citazioni*)
*si tiene conto qui anche di diverse citazioni nella stessa decisione
Op. Corte
Oss. parti/terzi
Op. sep.
65% 8%
27%
Corte interamericana dei diritti dell'uomo (percentuale sul totale delle citazioni*)
*si tiene conto qui anche di diverse citazioni nella stessa decisione
Op. Corte
Oss. Parti/Comm./esperti
Op. sep.
www.federalismi.it 26
Nonostante l’incompletezza dei dati a disposizione sull’introduzione dell’argomento extra-
sistemico, può essere interessante notare come emerga che la Corte EDU ignori spesso nella
propria motivazione gli argomenti delle parti, o degli intervenienti, che citano la
giurisprudenza interamericana, mentre nella giurisprudenza della Corte IDU non è
riscontrabile tale discordanza.
Fig. 6. Chi introduce le citazioni (da ciò che emerge nella motivazione)
Per quanto riguarda la rilevanza delle singole citazioni e il loro impatto effettivo sulla
decisione, dal punto di vista formale si può rilevare che la Corte EDU, nelle 17 decisioni
stesso criterio), 26 di esse sembrano attribuibili alla Corte d’ufficio, 5 al o ai giudici autori dell’opinione separata
e 20 alle parti o ai terzi intervenuti.
51%
10%
39%
Chi introduce le citazioni davanti alla Corte europea
(sul totale delle citazioni riprese nelle considerazioni della Corte o in opinioni separate)
Corte
Giud. autore op. sep.
Parti/terzi
68%
24%
8%
Chi introduce le citazioni davanti alla Corte interamericana
(sul totale delle citazioni riprese nelle considerazioni della Corte o in opinioni separate)
Corte
Giud. autore op. sep.
Parti/Comm./altri
www.federalismi.it 27
contenenti le citazioni nella parte “in diritto”, procede a citazioni puntuali e dettagliate, spesso
riportando interi passaggi delle pronunce richiamate. Le citazioni della giurisprudenza
interamericana sono quasi sempre accompagnate da richiami ad altri materiali provenienti da
organi giurisdizionali o quasi-giurisdizionali internazionali, quali la Corte internazionale di
giustizia o il Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite. Di rado, come si vedrà in
seguito, la citazione della giurisprudenza interamericana rappresenta l’unico riferimento
extra-sistemico per la Corte EDU (Fig. 7), una Corte, è opportuno ricordarlo, che non
dimostra una straordinaria propensione a riferirsi a fonti e materiali extra-europei64
,
preferendo di gran lunga trarre ispirazione dalle tradizioni giuridiche degli Stati membri65
.
Le numerose citazioni della giurisprudenza europea effettuate dalla Corte IDU, invece, sono
più variegate: si va dalla citazione precisa e dettagliata, con plurimi riferimenti a singole
decisioni e la riproduzione di interi paragrafi66
, alla citazione generica alla giurisprudenza
europea, senza l’indicazione degli estremi di alcuna decisione specifica o con riferimenti
puntuali solo nelle note a pie’ di pagina67
. Tali citazioni sono spesso accompagnate,
anch’esse, da riferimenti ad altre fonti extra-sistemiche, come ad esempio pronunce di altri
organi giurisdizionali e quasi-giurisdizionali internazionali, ma anche di giurisdizioni
nazionali: la Corte IDU mostra infatti una straordinaria inclinazione a guardare al di là delle
proprie frontiere regionali68
e, di conseguenza, a citare perfino le corti costituzionali o
supreme di Stati terzi rispetto al proprio sistema di riferimento.
64
Si è osservato che la CEDU è «un instrument davantage tournée vers l’exportation que vers l’importation» : J.
F. FLAUSS, Variations autour de l’influence extra-muros de la Convention européenne des droits de l’homme, in
J. F. FLAUSS (a cura di), L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur les Etats tiers,
Bruxelles, 2002, 129. Sull’attitudine della Corte EDU a citare fonti extra-sistemiche, v. J. F. FLAUSS, Du droit
internationale comparé dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, in P. WIDMER (a
cura di), Le rôle du droit comparé dans la formation du droit européen, cit. supra nota 6, 159. 65
P. Carozza, con riferimento al ricorso al diritto “comparato” da parte della CorteEDU, utilizza l’espressione
“comparazione interstatale”, sottolineando come si tratti di un riferimento alle legislazioni e pratiche degli Stati
membri più che di una vera e propria comparazione funzionale all’individuazione di un principio di diritto
applicabile: P. G. CAROZZA, Uses and Misuses of Comparative Law in International Human Rights: Some
Reflections on the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, cit. supra nota 6, 1218-1219; oltre
agli altri contributi indicati alla nota 6, si veda N. MILLER, An International Jurisprudence? The Operation of
“Precedents” Across Internationl Tribunals, cit. supra nota 2, il quale sottolinea il diverso approccio della
CorteEDU e della CorteIDU a questo proposito, 499. 66
Ad es. in Herrera-Ulloa c. Costa Rica, 2 luglio 2004, Ricardo Canese c. Paraguay, 31 agosto 2004, Valle
Jaramillo e al. c. Colombia, 27 novembre 2008, Cabrera Garcia e Montiel Flores c. Messico, 26 novembre 2010,
Atala Riffo e figlie c. Cile, 24 febbraio 2012. 67
La giurisprudenza europea è citata in maniera generica nel testo, con l’indicazione solo nelle note a pie’ di
pagina dei riferimenti puntuali alle decisioni interessate, in: La Cantuta c. Perù, 29 novembre 2006, Baldeón -
García c. Perù, 6 aprile 2006, Anzualdo Castro c. Perù, 22 settembre 2009, Tristán Donoso c. Panama, 27
gennaio 2009. 68
H. TIGROUDJA, L’autonomie du droit applicable par la Cour interaméricaine des droits de l’homme: en marge
d’arrêts et d’avis consultatifs récents, RTDH, 2002, 69; L. HENNEBEL, La Convention américaine des droits de
l’homme. Mécanismes de protection et étendue des droits et libertés, cit. supra nota 19, 82 ss.
www.federalismi.it 28
Tuttavia, la giurisprudenza della Corte europea gode indubbiamente di una posizione
privilegiata rispetto ad altre fonti esterne69
(Fig. 7), come testimoniato dal numero e dalla
qualità delle citazioni70
.
Fig. 7. Le citazioni dell’altra Corte con o senza altre citazioni extra-sistemiche
69
Lo sottolinea G. L. NEUMAN, Import, Export, and Regional Consent in the Inter-American Court of Human
Rights, EJIL, 2008, 101, sul punto 109. 70
Per dare solo un’idea, nella decisione Atala Riffo e figlie c. Cile, del febbraio 2012, la Corte cita altresì alcune
decisioni emanate da giurisdizioni di Paesi membri nonché di Stati terzi quali l’Australia, le Filippine, il
Sudafrica, il Canada e gli Stati Uniti, ma fonda poi il suo intero ragionamento sulla giurisprudenza della Corte
europea, presente con oltre 40 citazioni, e sulle osservazioni del Comitato dei diritti umani dell’Onu e di altri
organi delle Nazioni Unite.
9%
91%
Corte europea dei diritti dell'uomo (percentuale sul totale delle citazioni*)
*si tiene conto qui anche di diverse citazioni nella stessa decisione
Solo giurisprudenza interamericana
Giurisprudenza interamericana con altre fonti internazionali
56%
44%
Corte interamericana dei diritti dell'uomo (percentuale sul totale delle citazioni*)
*si tiene conto qui anche di diverse citazioni nella stessa decisione
Solo giurisprudenza europea
Giurisprudenza europea con altre fonti internazionali
www.federalismi.it 29
3.3.2. Analisi sostanziale
Innanzitutto, è possibile avanzare una considerazione preliminare: nelle decisioni esaminate,
le citazioni della giurisprudenza dell’altro sistema non sono quasi mai utilizzate “a contrario”
71, cioè per rendere noto che si prende atto di altre possibilità interpretative ma che le si scarta
scientemente, in ragione delle differenze tra il proprio ordinamento e quello di provenienza
della citazione: una pratica, questa, diffusa tra corti nazionali ma che altri studi hanno già
mostrato essere assente a livello di giurisdizioni internazionali72
.
Le citazioni risultano essere utilizzate prevalentemente nel momento iniziale dell’attività
interpretativa, in quella che può essere definitiva la fase cognitiva dell’interpretazione73
, per
orientare la stessa (in tal caso, si comincia con una sorta di lista di decisioni di altre
giurisdizioni, di Paesi membri e non, per mostrare le diverse scelte interpretative possibili74
),
oppure risultano impiegate con la funzione di “comparazione confortativa” o “probatoria”,
mediante la quale si intende mostrare come una decisione che la Corte si appresta ad adottare
sulla base della Convenzione è stata presa anche da altre corti, internazionali o nazionali75
.
Quest’ultima categoria, che comprende le decisioni nelle quali l’argomento extra-sistemico
contribuisce effettivamente alla formazione della decisione, sarà l’oggetto dell’analisi
qualitativa di cui si darà atto di seguito, nella quale saranno esaminate più in dettaglio alcune
delle decisioni segnalate, aventi ad oggetto le materie nelle quali è riscontrabile una certa
reciprocità delle citazioni. Per fornire qualche esempio significativo, si è scelto infatti di
trattare gli ambiti nei quali le citazioni reciproche sono più ricorrenti, quali il processo equo,
71
Vi sono tuttavia delle eccezioni, nelle quali la Corte interamericana, dopo aver citato la giurisprudenza
europea in materia di riparazione, secondo la quale una sentenza di condanna costituisce per se una riparazione
sufficiente dei danni morali patiti, ha affermato che tale soluzione non può ritenersi soddisfacente in presenza di
danni morali di grave entità. Si vedano, tra le altre, Neira-Alegría e al. c. Perù, 19 settembre 1996; Blake c.
Guatemala, 22 gennaio 1999; Paniagua-Morales e al. c. Guatemala (caso «White Van»), 25 maggio 2001;
Bámaca-Velásquez c. Guatemala, 22 febbraio 2002. 72
N. MILLER, An International Jurisprudence? The Operation of “Precedents” Across Internationl Tribunals,
cit. supra nota 2, 499. 73
In quello che è stato definito il “window-dressing approach”, secondo il quale la Corte fa ampi riferimenti a
fonti extra-sistemiche solo per dimostrare l’ampiezza della sua conoscenza del diritto comparato e internazionale
(così, L. GARLICKI, Conferencia introductoria: Universalism v. Regionalism? The role of the supranational
judicial dialog, cit. supra nota 50, 56), ma si tratta appunto di un uso della comprazione nella fase cognitiva
dell’interpretazione, che non entra nella fase decisoria: O. PFERSMANN, Le sophisme onomastique: changer au
lieu de connaitre. L’interprétation de la constitution, in F. Mélin-Soucramanien (a cura di), L’interprétation
constitutionnelle, cit. supra nota 49, 146. 74
Talvolta, peraltro, dando luogo a rassegne conoscitive comprendenti ordinamenti tanto variegati che la loro
utilità «resta del tutto incomprensibile», come osserva G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, VIII
ed., Padova, 2011, 67. 75
Quest’utilizzo “confortativo” della citazione dei precedenti dell’altra Corte può essere definito come una
forma di comunicazione giudiziale fondata sull’“empatia”, laddove il ricorso al precedente extra-sistemico non
rappresenti un mero esempio di diritto comparato, ma un riferimento interpretativo dotato di grande efficacia
persuasiva grazie alla convinzione che esiste un common ground tra l’ordinamento in cui è stata adottata la
decisione e l’ordinamento in cui essa è citata. Su tale classificazione, N. WALKER, Beyond Boundaries Disputes
and Basic Gride: Mapping the Global Disorders of Normative Orders, in Int’l J. Const. L, 2008, 373.
www.federalismi.it 30
la definizione dei trattamenti inumani e degradanti e di gravi violazioni (in particolare legate
al fenomeno delle sparizioni forzate), la libertà di espressione.
In molti altri ambiti, si ritrova più che altro un’influenza “a senso unico” della Corte europea
sulla Corte interamericana. Questo è avvenuto, ad esempio, in materia di criteri
interpretativi76
, dove l’influenza della Corte EDU sulla sua omologa interamericana ha dato
luogo allo sviluppo di criteri interpretativi specifici propri del diritti dei diritti umani, i quali si
distanziano parzialmente dai criteri codificati nella Convenzione di Vienna sul diritto dei
Trattati77
.
In tema di processo equo, la Corte IDU ha sin dagli esordi ispirato la propria giurisprudenza a
quella europea78
, soprattutto in riferimento alla ragionevole durata del processo79
, ma anche
all’imparzialità dei giudici garantita mediante opportune procedure di nomina80
e al diritto di
conoscere i fatti a carico81
.
Tuttavia, la Corte interamericana ha in seguito sviluppato ulteriormente l’interpretazione di
tali garanzie processuali, affermando ad esempio che il loro rispetto è tanto più essenziale
quando la procedura prevede la possibilità di applicazione della pena di morte e quindi è in
76
Si possono ricordare, ad esempio, la dottrina dell’effetto utile, richiamata nella sentenza Ivcher-Bronstein c.
Perù, 24 settembre 1999, par. 45 che cita Soering c. Regno Unito, 26 gennaio 1989, par. 87; o quella
dell’interpretazione evolutiva della Convenzione, richiamata in “Mapiripán Massacre” c. Colombia, 15
settembre 2005, par. 106, che cita Tyrer c. Regno Unito, 25 aprile 1978, par. 31. La Commissione interamericana
non ha mai fatto propria, invece, la dottrina del margine di apprezzamento (che ha rifiutato, da ultimo, in Atala
Riffo e figlie c. Cile, 24 febbraio 2012, par. 34-35 e in Artavia Murillo e altri c. Costa Rica del 28 novembre
2012, par. 316), salvo ammettere un certo livello di discrezionalità statale per quanto riguarda la disciplina
dell’elettorato attivo e passivo, «alla luce dell’evoluzione politica dello Stato in questione» (si v. Castañeda
Gutman c. Messico, 6 agosto 2008, par. 165). Si vedano anche F. NI AOLAIN, The Emergence Of Diversity:
Differences in Human Rights Jurisprudence, Fordham Int’lLJ, 1995, 126 ss. e M. A. BENAVIDES CASALS, El
consenso y el margine de apreciaciòn en la protecciòn de los derechos humanos, Ius et Praxis, 2009, 295. 77
A. A. CANÇADO TRINDADE, La interpretation des tratados en el derecho internacional y la especifidad de los
tratados de derechos humanos, in Z. DRNAS DE CLÉMENT (a cura di), Estudios de derecho internacional en
homenaje al Prof. E. J. Rey Caro, Cordiba, 2003, 747; M. KILLANDER, Interpreting Regional Human Rights
Treaties, International journal of human rights, 2010, 145. Si veda, infine, A. A. CANÇADO TRINDADE, L
CAFLISCH, Les Conventions Américaine et Européenne des Droits de l’Homme et le Droit International Général,
cit. supra nota 1, dove gli A. sottolineano come i diversi criteri di interpretazione propri del diritto dei diritti
umani trovino comunque un qualche fondamento nella Convenzione di Vienna. 78
Si vedano, tra le altre, le decisioni Suárez-Rosero c. Ecuador, 12 novembre 1997; Villagran-Morales e al. c.
Guatemala (caso “Street Children”), 19 novembre 1999; Corte costituzionale c. Perù, 31 gennaio 2001; Lori
Berenson-Mejía c. Perù, 25 novembre 2004; Fermín Ramírez c. Guatemala, 20 giugno 2005; Cabrera Garcia e
Montiel Flores c. Messico, 26 novembre 2010; Palamara-Iribarne c. Cile, 22 novembre 2005; “Pueblo Bello
Massacre” c. Colombia, 31 gennaio 2006; La Cantuta c. Perù, 29 novembre 2006; Acevedo Buendía e al. c. Perù
(caso “Discharged and Retired Employees of the Comptroller”), 1 luglio 2009; Barbani Duarte e al. c. Uruguay,
13 ottobre 2011. 79
A partire dalla decisione Genie-Lacayo c. Nicaragua, 29 gennaio 1997. 80
Corte costituzionale c. Perù, 31 gennaio 2001. 81
Fermín Ramírez c. Guatemala, 20 giugno 2005.
www.federalismi.it 31
gioco la stessa vita umana82
. Ciò ha fatto sì che anche la Corte europea abbia più di recente
citato questa giurisprudenza sull’assoluta inderogabilità delle regole del giusto processo
quando sia prevista la comminabilità della pena capitale. Ad esempio, nella prima sentenza
sul caso Ocalan, emanata nel 2003, la Corte ha affermato l’essenzialità delle garanzie del
processo equo, specie in quanto «essendo irreversibile l’esecuzione della pena capitale, solo
mediante l’applicazione di tale norme è possibile evitare una morte arbitraria e illegale» 83
. La
Corte rinvia, per l’enucleazione di tale principio, ad una risoluzione del Comitato dei diritti
dell’uomo delle Nazioni Unite, oltre che all’Opinione consultiva OC-16/99 della Corte
interamericana e alla sentenza Hilaire, Constantine e Benjamin e altri c. Trinidad e Tobago.
La stessa argomentazione, così come le medesime citazioni, sono state riprese dalla Grande
Camera nella sua sentenza del 200584
.
La giurisprudenza interamericana è stata poi citata dalla Corte europea in materia di
imparzialità dei tribunali militari. Nel caso Ergin c. Turchia la Corte, statuendo sulla
violazione del diritto al giusto processo di un civile giudicato da un tribunale militare, ha
citato le considerazioni del Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite sul diritto
comparato sul punto, nonché la «giurisprudenza costante [della Corte interamericana] che
esclude i civili dalla giurisdizione dei tribunali militari», giungendo alla conclusione che
«sulla base […] in particolare della situazione a livello internazionale che è stata richiamata
[…] si può ritenere che fossero oggettivamente fondati i dubbi nutriti dal ricorrente circa
l’indipendenza e l’imparzialità di questa giurisdizione»85
.
Un’altra materia di influenza reciproca si è rivelata quella della definizione di “trattamenti
inumani e degradanti”.
Dapprima è stata, anche qui, la Corte europea a influenzare la giurisprudenza interamericana
che, nel caso Loayza-Tamayo c. Perù del 1997, ha mutuato la lettura interpretativa secondo la
quale le violenze psicologiche esercitate nei confronti di una persona sottoposta ad
82
Con riferimento all’importanza delle garanzie del giusto processo e del ricorso effettivo nelle procedure che
prevedono la condanna a morte, nella decisione Hilaire, Constantine e Benjamin e al. c. Trinidad e Tobago la
Corte interamericana ha osservato che «in considerazione della natura eccezionalmente grave e irreparabile della
pena capitale, l’ooservanza delle regole del processo equo, con il suo bagaglio di diritti e garanzie, diviene
ancora più importante, dal momento che la vita umana è in gioco» (Hilaire, Constantine e Benjamin e al. c.
Trinidad et Tobago, 21 giugno 2002, par. 148). 83
Ocalan c. Turchia, 12 marzo 2003, par. 203. 84
Ocalan c. Turchia, GC,12 maggio 2005. 85
Ergin c. Turchia, 4 maggio 2006, par. 25 e 54.
www.federalismi.it 32
interrogatorio possono integrare la nozione di trattamento inumano e degradante,
particolarmente grave qualora la vittima sia detenuta arbitrariamente86
.
In una decisione successiva, ancora contro il Perù, la Corte interamericana ha poi affermato
che il divieto di tortura non può mai essere derogato, qualunque sia il pericolo che minaccia la
nazione87
, riferendosi in particolare alla decisione Irlanda c. Regno Unito, già citata nel caso
Loayza-Tamayo.
Anche la Corte europea comincia a sua volta a guardare alla giurisprudenza interamericana in
materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti e di altra gravi violazioni quando, a
partire dagli anni Novanta, si trova a far fronte con sempre maggiore frequenza a ricorsi
aventi ad oggetto violazioni sistematiche quali detenzioni arbitrarie, esecuzioni illegali e
sparizioni forzate.
L’influenza della giurisprudenza interamericana su quella europea in quest’ambito sembra,
tuttavia, dal punto di vista numerico, meno rilevante di quanto ci si sarebbe potuti aspettare.
Si noti, ad esempio, che non sono mai state citate le note decisioni della Corte IDU che
affermano il diritto delle vittime a vedere i colpevoli sanzionati88
, né quelle che stabiliscono
che la garanzia del “diritto alla verità” rappresenta un’importante forma di riparazione89
.
Pur in assenza di una cospicua mole di citazioni reciproche, le due Corti hanno mostrato nel
corso degli anni una crescente convergenza nell’approccio a tali violazioni, spesso senza che
la Corte EDU faccia espressamente menzione alle decisioni della Corte IDU90
.
Il primo caso nel quale la Corte europea si occupa di sparizioni forzate è Kurt c. Turchia91
.
Nella sua motivazione, la Corte richiama soltanto nelle proprie considerazioni in fatto la
giurisprudenza interamericana in materia - rappresentata specialmente dal leading case sulla
qualificazione delle sparizioni forzate, che è Velasquez Rodríguez c. Honduras –, ma non vi
fa alcun riferimento espresso nelle proprie argomentazioni in diritto, concludendo nel senso
che la violazione allegata costituisce una violazione della libertà personale, senza applicare la
presunzione della morte della persona scomparsa, che era invece stata introdotta nella
giurisprudenza interamericana.
86
Loayza-Tamayo c. Perù, 17 settembre 1997, par. 57. In particolare, sono citate le sentenze Irlanda c. Regno
Unito, 18 gennaio 1978, e Ribitsch c. Austria, 4 dicembre 1995. 87
Cantoral-Benavides c. Perù, 18 agosto 2000, par. 89. 88
Quali, ad esempio, Bamaca Velasquez, del 21 luglio 1989, o Durand e Ugarte, del 3 dicembre 2001. Si veda
M. PHILIP-GAY, La poursuite des auteurs de graves violations de droits de l’homme : une influence de la
jurisprudence interaméricaine sur le système européen?, cit. supra nota 54, 267. 89
Quale, ad esempio, Carpio Nicole c. Guatemala, del 22 novembre 2004. 90
E. FERNÀNDEZ, Nuevos retos para el Tribunal europeo de derechos humanos: la jurisprudencia sobre
desapariciones forzadas, Persona y derecho, 2009, 195. 91
Kurt c. Turchia, Ric. n. 24276/94, 25 maggio 1998.
www.federalismi.it 33
In seguito, la giurisprudenza europea si avvicina sempre più agli standard dettati da quella
americana quanto alla qualificazione delle sparizioni forzate quali violazioni continuate e
complesse, che comportano la violazione di molteplici diritti umani, sebbene i riferimenti
espliciti alle decisioni della Corte interamericana rimangano rari92
.
Ad esempio, nel caso Timurtas c. Turchia93
, la Corte europea accoglie la presunzione di
morte in detenzione della persona scomparse, in considerazione de[l] «la situazione generale
regnante nel Sud-est della Turchia nel 1993», con un ragionamento simile a quello sviluppato
nella giurisprudenza interamericana, che è tuttavia richiamata soltanto nelle osservazioni di
una ONG interveniente94
.
Questa convergenza, rilevabile soprattutto nella qualificazione delle sparizioni forzate come
violazioni continuate e nelle conseguenze che ne derivano in termini di giustiziabilità, emerge
in seguito nettamente in Varnava e altri c. Turchia95
. In questa decisione la Corte europea,
dopo aver richiamato la giurisprudenza interamericana sul punto, con citazioni puntuali e
approfondite, afferma la propria competenza a statuire sulla violazione dell’obbligo di
indagare sulle violazioni del diritto alla vita, che costituisce un’obbligazione autonoma e
continuata96
, anche per fatti di sparizione prodottisi prima dell’accettazione della giurisdizione
della Corte da parte dello Stato97
.
La Corte prende quindi in considerazione, sulla scorta della Corte interamericana e del
Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite ai quali fa riferimento, la natura complessa
e continuata delle violazioni dei diritti umani derivanti dalle sparizioni forzate98
.
La convergenza tra le diverse giurisprudenze internazionali sul punto è in seguito messa in
evidenza dalla Corte interamericana in Anzualdo Castro c. Perù, laddove la Corte, dopo aver
ricordato la qualificazione di tali violazioni invalsa nelle proprie decisioni, osserva che «anche
la giurisprudenza degli organi delle Nazioni Unite e quella della Corte europea dei diritti
92
Per es. nel caso Ertak c. Turchia, Ric. n. 20764/92, 9 maggio 2000, la giurisprudenza della Corte
interamericana è citatta dai ricorrenti; in Cicek c. Turchia, Ric. n. 25704/94, 27 febbraio 2001 la citazione è
contenuta tra le osservazioni degli intervenienti e in un’opinione concorrente. 93
Timurtas c. Turchia, Ric. n. 23531/94, 13 giugno 2000. 94
Si tratta del Center for Justice and International Law (CEJIL). 95
Varnava e al. c. Turchia, Ric. n. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90,
16072/90 e 16073/90, 18 settembre 2009. 96
Come aveva già avuto modo di dire, anche allora citandi la giurisprudenza interamericana in materia di
sparizioni forzate, in un caso concernente la morte di una persona in conseguenza di una negligenza medica:
Silih c. Slovenia, Ric. n. 71463/01, 9 aprile 2009. 97
I giudici fanno altresì riferimento a diverse decisione nelle quali la Commissione interamericana aveva
riconosciuto la propria competenza a conoscere di violazioni perpetuatesi precedentemente all’accettazione da
parte dello Stato della giurisdizione della Corte stessa: Velásquez Rodríguez c. Honduras, 29 luglio 1988,
Godínez Cruz c. Honduras, 20 gennaio 1989, Sorelle Serrano Cruz c. El Salvador, 23 novembre 2004, Comunità
di Moiwana c. Suriname, 15 giugno 2005. 98
Varnava e al. c. Turchia, Ric. n. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90,
16072/90 and 16073/90, 18 settembre 2009.
www.federalismi.it 34
dell’uomo condividono questa impostazione, così come molte corti costituzionali degli Stati
americani»99
.
Più di recente, la Corte europea ha citato la giurisprudenza interamericana anche in materia di
classificazione di taluni trattamenti sui detenuti alla stregua di trattamenti inumani e
degradanti contrari alla Convenzione. Ciò si è verificato nella sentenza Zontul c. Grecia100
,
nella quale la Corte ha affermato che una certa condotta subita dal ricorrente costituisse un
atto di tortura, citando, tra le altre, la giurisprudenza della Corte interamericana e in
particolare la sentenza Penal Miguel Castro Castro c. Perù101
.
Una certa interazione tra le due Corti ha interessato perfino - e ciò potrà destare una certa
sorpresa - la libertà d’espressione, ambito nel quale la Corte europea, a partire dalla sentenza
Sunday Times c. Regno Unito, ha tradizionalmente riconosciuto un ampio margine di
apprezzamento agli Stati, adottando un approccio fortemente regionalistico nella
determinazione degli standard di protezione.
Ciononostante, mentre la Corte interamericana ha fatto ampio ricorso alla giurisprudenza
europea sull’interpretazione delle restrizioni alla libertà d’espressione ammissibili in una
società democratica – tra il 1985 e il 1986 in opinioni consultive e, a partire dal 2001, anche
in casi giurisdizionali102
-, anche la Corte europea ha di recente citato due volte la
giurisprudenza interamericana in materia di libertà d’espressione.
Nel caso Stoll c. Svizzera, la Corte cita all’interno delle proprie considerazioni in fatto le
argomentazioni avanzate dalla Commissione e dalla Corte interamericana in Claude Reyes e
altri c. Cile103
, oltre che le osservazioni del Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite
su una legge del Regno Unito sulla responsabilità dei giornalisti, applicando poi al caso
concreto i principi desunti da tali fonti.
La Corte, dopo aver sottolineato che «la libertà di stampa diviene ancora più importante in
circostanze nelle quali le attività e le decisioni dello Stato, in ragione della loro natura
confidenziale o segreta, sfuggono al controllo democratico o giudiziario» e che «la condanna
99
Anzualdo Castro c. Perù, 22 settembre 2009, par. 61. Si vedano altresì Gomes Lund e al. c. Brésil (caso
“Guerrilha Do Araguaia”), 24 novembre 2010 e Ibsen Cárdenas And Ibsen Peña c. Bolivie, 1 Settembre 2010. 100
Zontul c. Grecia, Ric. n. 12294/07, 17 gennaio 2012. 101
Penal Miguel Castro Castro c. Perù, 25 novembre 2006. Già in precedenza, peraltro, la Corte aveva citato la
giurisprudenza interamericana sulla qualificazione di taluni trattamenti sui prigionieri come tortura, ma solo
nelle considerazioni in fatto: si vedano Gäfgen c. Germania, Ric. n. 22978/05, GC, 1° giugno 2010; Portmann c.
Svizzera, Ric. n. 38455/06, 11 ottobre 2011. 102
Olmedo-Bustos e al. c. Cile (caso “The Last Temptation of Christ”), 5 febbraio 2001; Ivcher-Bronstein c.
Perù, 6 febbraio 2001; Herrera-Ulloa c. Costa Rica, 2 luglio 2004; Ricardo Canese c. Paraguay, 31 agosto 2004;
Kimel c. Argentina, 2 maggio 2008; Fontevecchia et D’amico c. Argentina, 29 novembre 2011; Usón Ramírez c.
Venezuela, 20 novembre 2009. 103
Claude Reyes e al. c. Cile, 19 settembre 2006.
www.federalismi.it 35
di un giornalista per la divulgazione di informazioni classificate confidenziali o segrete rischia
di dissuadere i professionisti dei mezzi di comunicazione dall’informare il pubblico su
questioni di interesse generale», facendo così «perdere alla stampa il suo ruolo indispensabile
di “cane da guardia”», osserva che « nello stesso senso, la Commissione interamericana dei
diritti dell’uomo ha ritenuto che la divulgazione di informazioni che si trovino tra le mani
dello Stato giochi un ruolo di primaria importanza in una società democratica, poiché
permette alla società civile di controllare le attività del governo», citando così le osservazioni
della Commissione, condivise anche dalla Corte interamericana nel caso Claude Reyes.
Ancora, nel caso Palomo-Sànchez, avente ad oggetto la violazione della libertà di espressione
di alcuni lavoratori dipendenti, appartenenti ad un sindacato, che erano stati licenziati in
seguito all’affissione - sulle pareti del luogo di lavoro - di un disegno e di due articoli
considerati offensivi nei confronti del datore di lavoro, la Corte EDU, citando la propria
giurisprudenza sull’imprescindibilità della libertà di espressione in una società democratica, si
rifà al principio già sancito dalla Corte IDU secondo cui la libertà di espressione è «una
condizione sine qua non per lo sviluppo […] dei sindacati»104
. Ciononostante, nella fattispecie
in esame, la Corte statuisce che il licenziamento fosse una sanzione proporzionata alla
condotta dei lavoratori e, pertanto, legittima.
L’attenzione reciproca mostrata dalle due Corti nei confronti delle limitazioni alla libertà di
espressione potrebbe segnare l’inizio di un vero e proprio dialogo per la determinazione di
standard internazionali sul punto, ma tale conclusione sembra ancora prematura, e bisognerà
attendere futuri sviluppi per confermarla o smentirla105
.
Anticipando parzialmente le conclusioni, possiamo dunque notare che l’influenza “a senso
unico” di una Corte sull’altra è divenuta una sorta di “interazione”, in conseguenza di due
principali mutamenti di contesto che hanno interessato le due Corti: da un lato, la Corte EDU
all’indomani dell’allargamento del Consiglio d’Europa e della conseguente estensione della
propria giurisdizione a Paesi di nuova democrazia, ha dovuto conoscere una mole importante
di questioni concernenti gross violations; dall’altra, la Corte IDU, man mano che si trovava ad
aver a che fare, all’interno del proprio ordinamento, con democrazie più stabili, ha cominciato
ad occuparsi anche di questioni più caratteristiche di un sistema democratico, che non
104
Palomo Sànchez e al. c. Spagna, Ric. n. 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, par. 56, dove è citata
l’opinione consultiva della Corte interamericana OC-5/85193. 105
E. A. BERTONI, The Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights: A
Dialogue on Freedom of Expression Standards, EHRLR, 2009, 332 ss.; F. J. EGUIGUREN PRAELI, R. BUSTOS
GISBERT, I. TORRES MURO, Las libertades de pensamento, información y expresión, y los derechos de reunión y
asociación: pautas para un diálogo, in J. GARCÍA ROCA, P. A. FERNÁNDEZ, P. SANTOLAYA, R. CANOSA (a cura
di), El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de derechos Humanos, cit. supra nota 1, 185 ss.
www.federalismi.it 36
riguardano soltanto i cosiddetti “core rights”. Questa «seconda generazione del contenzioso
dei diritti»106
nel sistema interamericano può offrire nuovi impulsi alle relazioni tra le due
Corti.
4. In conclusione: le Corti regionali tra universalismo e particolarismo dei diritti umani
L’analisi di cui sono stati proposti i risultati nel presente contributo mostra chiaramente che
per molti anni la relazione tra le due Corti si è articolata intorno all’influenza esercitata dalla
Corte EDU sulla sua omologa americana.
La Corte IDU ha cominciato sin dall’inizio della propria attività a citare la giurisprudenza
europea sia nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale che in quella consultiva.
Tale tendenza, ed è questo il dato che può destare maggiore interesse, non ha accennato a
diminuire nel tempo, come dimostrano sia il numero delle decisioni contenenti almeno una
citazione, sia il dato percentuale, letti in chiave diacronica. Ciò suggerisce che l’attenzione
della Corte IDU per la giurisprudenza europea non rappresenta un fenomeno contingente,
destinato a volgere al termine una volta che la stessa Corte abbia raggiunto un più elevato
grado di accettazione e influenza, bensì un elemento strutturale, figlio di una concezione dei
diritti riconosciuti dalla Convenzione quali diritti universali piuttosto che a portata
unicamente regionale.
In effetti, come è stato messo in luce, le numerose citazioni della giurisprudenza europea sono
frequentemente, seppur non necessariamente, accompagnate da altri riferimenti a elementi
extra-sistemici, quali atti o decisioni di altri organi giurisdizionali o quasi-giurisdizionali
internazionali, che testimoniano una spiccata propensione della Corte interamericana a
guardare oltre i confini del proprio sistema di riferimento. L’utilizzo delle fonti extra-
sistemiche operato dalla Corte è sempre improntato al principio della massima tutela, così che
essa prende da ogni ordinamento citato soltanto gli elementi maggiormente protettivi dei
diritti, dando prova di una sorta di cherry-picking, sulla base della clausola più favorevole
come criterio interpretativo generale107
. Nondimeno, si rileva che la giurisprudenza europea
assume, in questo quadro, una posizione privilegiata tra tutte le fonti esterne considerate dalla
Corte, come emerge dal numero e dalla qualità delle citazioni che la riguardano.
106
H. TIGROUDJA, I. K. PANOUSSIS, La Cour interaméricaine des droits de l’homme. Analyse de la jurisprudence
consultative et contentieuse, cit. supra nota 29, 10 s. 107
L. HENNEBEL, La Cour interaméricaine des droits de l’homme : entre universalisme et particularisme, in L.
HENNEBEL, H. TIGROUDJA (a cura di), Le particularisme interaméricain des droits de l’homme, Paris, 2009, 75
ss., spec. 117.
www.federalismi.it 37
Presso la Corte europea si inizia a registrare un cambiamento a partire dagli anni Duemila,
quando essa comincia ad inserire qualche sporadica citazione della giurisprudenza dell’altra
Corte anche nella parte in diritto delle proprie motivazioni.
Come dimostrato dalle materie oggetto delle citazioni, negli anni più recenti, man mano che la
Corte IDU sviluppava la propria giurisprudenza, la Corte EDU si è trovata sempre più di
frequente a decidere questioni concernenti gravi violazioni dei diritti umani, ambito nel quale
la Corte interamericana aveva acquisito un patrimonio di precedenti più ricco e avanzato. La
Corte europea aveva perciò nuove ragioni per interessarsi all’attività della sua più giovane
omologa. In effetti, la giurisprudenza interamericana è citata ampiamente nell’ambito del
processo equo, dei trattamenti inumani e degradanti e di altre gravi violazioni, specialmente in
casi che vedono come Stato chiamato in causa la Russia o la Turchia.
In tali decisioni, la Corte denota un approccio più universalista di quello adottato di solito,
tanto che le citazioni della giurisprudenza dell’altra Corte sono quasi sempre accompagnate
da riferimenti ad altre fonti extra-sistemiche, in particolare provenienti dalla Corte
internazionale di giustizia o dal Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite. Di rado la
giurisprudenza interamericana rappresenta l’unico riferimento esterno di cui si serve la Corte
europea. Una Corte, è bene ricordarlo, che suole trovare i propri riferimenti nelle
giurisprudenze e tradizioni giuridiche degli Stati membri piuttosto che in ordinamenti esterni
al proprio sistema regionale.
Inoltre, per quanto la Corte europea non faccia spesso ricorso a citazioni esplicite della
giurisprudenza interamericana, le influenze implicite sono notevoli, sì che in molti ambiti è
rinvenibile una vera e propria convergenza interpretativa tra le giurisprudenze delle due Corti.
Dall’altro lato, il contesto nel quale opera la Corte IDU è in rapido cambiamento: le gross
violations non costituiscono più la regola nel continente latino-americano, così che la Corte è
chiamata sempre più spesso a pronunciarsi su questioni concernenti la definizione e lo
standard di tutela di diritti diversi dai core rights. Tale mutamento ha riportato in auge il
dibattito sulla necessità di introdurre nel sistema interamericano uno strumento analogo al
margine di apprezzamento, che imponga di tenere in una certa considerazione il consenso
regionale nella determinazione degli standard (ad esempio, il governo del Cile l’ha richiesto
nel caso sull’affidamento al genitore omosessuale).
Nella dialettica tra universalismo e particolarismo dei diritti umani le corti regionali si trovano
in una posizione privilegiata, proprio sulla linea di demarcazione tra la universalità dei diritti
e la valorizzazione delle specificità dell’area di riferimento.
www.federalismi.it 38
Le due Corti prese in esame hanno assunto finora un approccio diverso rispetto a tali
posizioni, anche in conseguenza dei differenti contesti nei quali si sono trovate ad operare: più
votata all’universalismo l’una, più attenta a salvaguardare una certa dose di diversità e
pluralismo l’altra.
Ma quanto più muta il contesto politico e sociale nel quale le due Corti sono collocate, tanto
più esse saranno chiamate a una evoluzione, che potrà essere tanto più fruttuosa se riusciranno
a dialogare maggiormente, non solo attraverso le citazioni reciproche, ma anche mediante
l’ulteriore promozione di relazioni e incontri tra persone: in quanto “intermediarie” tra
l’ordinamento internazionale e gli ordinamenti nazionali, esse hanno nelle loro mani la
possibilità di trovare il tanto auspicato bilanciamento che eviti che l’armonizzazione degeneri
in omogeneizzazione.