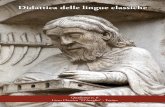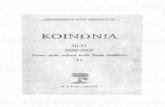Strategie per l’accumulo nelle piante di prodotti di interesse industriale
Proverbi e sentenze nelle commedie di Menandro
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Proverbi e sentenze nelle commedie di Menandro
¶APOIM IAKø™il proverbio in grecia e a roma
a cura di emanuele lelli
introduzione di renzo tosi
postfazione di riccardo di donato
· i ·
PISA · ROMA
FABRIZIO SERRA EDITORE
MMX
PHILOLOGIAAN TIQVA
an internat ional journal o f clas s ic s
2 · 2009
PISA · ROMA
FABRIZIO SERRA EDITORE
MMX
Amministrazione e abbonamentiFabrizio Serra editore®
Casella postale n. 1, succursale n. 8, i 56123 Pisa,tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, [email protected]
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabilipresso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.
Print and/or Online official rates are available at Publisher’s website www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)
Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa,tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, [email protected]
Uffici di Roma e Redazione: Rita Gianfelice, Via Carlo Emanuele I, i 00185 Roma,tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, [email protected]
*Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 23 del 14 · 6 · 2007
Direttore responsabile: Fabrizio Serra
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o perestratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica,
il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazionescritta della Fabrizio Serra editore®, Pisa -RomaOgni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*Proprietà riservata · All rights reserved
© Copyright 2010 by Fabrizio Serra editore®, Pisa -Roma
Stampato in Italia · Printed in Italy
www.libraweb.net
issn 1971-9078issn elettronico 2035-3561
isbn 978-88-6227-343-5
SOMMARIO
¶APOIM IAKø™
· I ·
Emanuele Lelli, Premessa 9
Abbreviazioni 11
Renzo Tosi, Introduzione 13
1. EsiodoAndrea Ercolani, Enunciati sentenziosi nelle Opere e Giorni di Esiodo 31
2. ArchilocoLuca Bettarini, Archiloco fr. 201 W.2: meglio volpe o riccio? 45
3. AlceoEmanuele Lelli, La pragmatica proverbiale di Alceo 53
4. TeognideFederico Condello, Proverbi in Teognide, Teognide in proverbio 61
5. EschiloMaurizio Grimaldi, Il proverbio in Eschilo: un aspetto della tecnica drammatica 87
6. SofoclePierpaolo Peroni, Inconsapevoli profezie 105
7. Sofocle, AntigoneGiovanni Di Maria, Antigone a Crotone 127
8. ErodotoLorenzo Miletti, «Ippoclide non se ne cura!»: Erodoto storico delle forme brevi 137
9. CratinoEmanuele Lelli, Il proverbio a teatro 145
10. AristofaneSilvio Schirru, Due ateniesi «ai corvi». Espressioni proverbiali negli Uccelli di Ari-
stofane 155
11. AristoteleMichele Curnis, «Reliquie di antica filosofia»: i proverbi in Aristotele 163
12. MenandroSilvio Schirru, Proverbi e sentenze nelle commedie di Menandro 215
13. Menandro, MonosticiCarlo Pernigotti, Il migliore dei testi possibili? Osservazioni su proverbi, sentenze e
critica testuale 229
8 sommario
12. Menandro
PROVERBI E SENTENZENELLE COMMEDIE DI MENANDRO*
Silvio Schirru
spressioni proverbiali di varia natura sono presenti in ogni genere della tradizione let-teraria greca. Il loro scopo principale è quello di veicolare, in maniera verbalmente più
economica ed efficace rispetto ad altre categorie espressive, la cosiddetta saggezza popo-lare, ovvero quell’insieme di norme e precetti (riguardanti diversi ambiti dell’esistenza)che dovrebbero regolare, o per lo meno indirizzare, la vita dei membri della società che haprodotto quei proverbi.
Sebbene si tratti di un genere universalmente noto e nonostante le raccolte di proverbisiano numerose,1 poche, nell’ambito della letteratura greca, sono le riflessioni teorichesull’espressione proverbiale in quanto testo letterario provvisto di peculiari caratteristichedi forma e contenuto.2 Più in generale, del resto, la stessa definizione di proverbio o senten-za è tutt’altro che univoca.3
È pertanto importante premettere che per proverbio (·ÚÔÈÌ›·) si intende qui4
* Il presente contributo, già pubblicato in «aflc», n. s. 22 [59], 2004, pp. 5-24 con il titolo La tradizione paremiogra-fica nelle commedie di Menandro, viene qui riproposto con alcune lievi modifiche, tra cui l’aggiornamento della biblio-grafia citata.
1 Tra le edizioni più recenti, segnalo Menandri Sententiae, ed. C. Pernigotti, Verona, 2008; PG, ed. E. Lelli; Bühler1, 4, 5; Spyridonidou-Skarsouli; M. Tziatzi-Papagianni, Die Sprüche der Sieben Weisen-Zwei byzantinische Sam-mlungen, Stuttgart-Leipzig, 1994. È, naturalmente, sempre imprescindibile il CPG.
2 A tal proposito, secondo J. F. Kindstrand, The Greek concept of proverbs, «Eranos», 76, 1978, p. 71 e n. 2 (ristam-pato in Proverbia in fabula, ed. P. Carnes, Bern, 1988, p. 233 e n. 2) non esiste neppure una definizione efficace di “pro-verbio” precedente a quella di Basilio di Cesarea, Princ. Prov. 2 (= Patr. Gr. 31, 388 b-c): Ùe ÙáÓ ·ÚÔÈÌÈáÓ ùÓÔÌ· âd ÙáÓ‰Ë̈‰ÂÛÙ¤ÚˆÓ ÏfiÁˆÓ ·Úa ÙÔÖ˜ ö͈ıÂÓ Ù¤Ù·ÎÙ·È, ηd âd ÙáÓ âÓ Ù·Ö˜ ï‰ÔÖ˜ Ï·ÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ó˜ Ùa ÔÏÏ¿Ø ÔrÌÔ˜ ÁaÚ ·Ú\à˘ÙÔÖ˜ ì ï‰e˜ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, ¬ıÂÓ Î·d ÙcÓ ·ÚÔÈÌ›·Ó óÚ›˙ÔÓÙÔ, ®ÉÌ· ·Úfi‰ÈÔÓ ÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔÓ âÓ Ù” ¯Ú“ÛÂÈ ÙáÓ ÔÏÏáÓ, ηdàe çÏ›ÁˆÓ âd Ï›ÔÓ· ¬ÌÔÈ· ÌÂÙ·ÏËÊıÉÓ·È ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ. ¶·Úa ‰b ìÌÖÓ ·ÚÔÈÌ›· âÛÙÈ ÏeÁÔ˜ èʤÏÈÌÔ˜, ÌÂÙ\ âÈÎÚ‡„ˆ˜ÌÂÙÚ›·˜ âΉ‰Ô̤ÓÔ˜, ÔÏf ÌbÓ Ùe à˘ÙfiıÂÓ ¯Ú‹ÛÈÌÔÓ ÂÚȤ¯ˆÓ, ÔÏÏcÓ ‰b ηd âÓ Ù† ‚¿ıÂÈ ÙcÓ ‰È¿ÓÔÈ·Ó Û˘ÁηχوÓ.Sempre Kindstrand, Greek concept, cit., p. 72 ipotizza che l’assenza di opere teoriche sulla letteratura paremiografi-ca sia dovuta al fatto che retori e filosofi erano verosimilmente diffidenti nei confronti di una categoria espressiva uti-lizzata soprattutto dagli incolti (a sostegno, lo studioso cita Arist. Rhet. 2,21,15).
3 Non mi addentro nella questione (per la quale rimando alla bibliografia citata nella nota 4), limitandomi a ricor-dare come A. M. Cirese, Prime annotazioni per un’analisi strutturale dei proverbi, «Dispense del corso di AntropologiaCulturale (Università di Cagliari, a.a. 1968-69)», pp. 1 ss., notasse quanto sia difficile persino trovare due dizionari checoncordino fra loro nel definire cosa sia un proverbio. Lo stesso A. M. Cirese, I proverbi: struttura delle definizioni, in«Documenti di lavoro e prepub blicazioni del Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica (Università di Urbi-no)» 12 (marzo 1972), pp. 1 ss. aggiunge: «[…] possiamo dire che ci sono stati sostanzialmente due modi di dichiarareche cosa sia quel particolare ‘genere’ di espressioni che diciamo proverbi. Il primo modo, diretto ed esplicito, è quellodelle cosiddette definizioni; il secondo, implicito e ‘di fatto’, è costituito dal contenuto effettivo delle raccolte. […] Nul-la esclude, in linea di principio, che possa esserci perfetta coincidenza tra definizioni e raccolte […]. Nella realtà, tut-tavia, le cose vanno altrimenti: al punto che la prima difficoltà in cui ci si imbatte studiando i proverbi è proprio quel-la di stabilire (sia pure in linea preliminare ma con un minimo di precisione) di che cosa ci si stia occupando […]».
4 Si vedano in proposito PG, ed. E. Lelli, pp. 11-16; R. Tosi, I Greci: gnomai, paroimiai, apophthegmata, in Teoria estoria dell’aforisma, ed. G. Ruozzi, Milano, 2004, 1-16; Tosi, pp. ix-xxiv; J. Russo, The Poetics of the ancient Greek Proverb,«Journal of Folklore Research», 20, 1983, pp. 121-130; Kindstrand, Greek concept, cit.; Cirese, I Proverbi, cit.; Cirese,Prime annotazioni, cit., Strömberg.
E
216 silvio schirru
un’espressione linguistica breve, contenente un precetto derivato dal cosiddetto ‘senso comune’, avente una forma definita e popolarmente nota. La sentenza (ÁÓÒÌË), espres-sione affine, si distingue dal proverbio principalmente per il fatto di non essere comune-mente nota e perché dotata di minore valore didascalico: mentre la ·ÚÔÈÌ›· esprime diper sé un insegnamento di portata ‘universale’, a prescindere dal tessuto testuale ed ex-tra-testuale nel quale è collocato, la ÁÓÒÌË è una constatazione o una riflessione (spesso‘d’autore’) legata ad una situazione particolare ed è solo suscettibile di acquisire valoreproverbiale se riproposta in un contesto diverso. In sostanza il valore ‘universale’ dellasentenza è strettamente vincolato alla sua collocazione effettiva e concreta: può essereconsiderata espressione proverbiale, ma, se estrapolata dal testo originario, tende a per-dere tale valore.1
Il legame con la realtà quotidiana proprio della tradizione paremiografica fa sì che trac-ce di essa si ritrovino frequentemente nella commedia, dall’antica alla nuova, che è forseil genere letterario più vicino a una raffigurazione ‘mimetica’ della realtà. In particolare,nell’opera di Menandro, la tradizione paremiografica ricorre spesso e appare regolata daalcune norme o, quanto meno, da caratteristiche ricorrenti, che investono tanto il signi-ficante quanto il significato dell’espressione utilizzata dall’autore comico.
1. I proverbi
1. 1. Formule introduttive
Nelle commedie menandree2 il proverbio è talvolta introdotto da una formula che ne de-nuncia esplicitamente l’appartenenza al genere paremiografico. Tali formule sono diquattro tipi. La più comune è Ùe ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ, che compare, per esempio,3 in:
– Asp. 372 s. Ùe Á]aÚ ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ Ù·Ö˜ àÏËı›·È˜ «Ï‡ÎÔ˜/ ̄ ]·ÓgÓ ôÂÈÛÈ ‰Èa ÎÂÓɘ».– Misum. 15 s. Ùe ‰[c ÏÂÁfiÌ]ÂÓÔÓ, Ôé‰b ΢ӛ, Ìa ÙÔܘ ıÂ[Ô‡˜, / ÓÜÓ [âÍÈ]ÙËÙfiÓ âÛÙÈÓ.– Sam. 11 Ùe ÏÂÁfi]ÌÂÓÔÓ ‰c ÙÔÜÙÔ, «ÙáÓ ÔÏÏáÓ ÙȘ üÓ».– Chera fr. 405 Ùe ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ ÙÔÜÙ\ öÛÙÈ ÓÜÓ, / ÙôÓˆ οو, Ê·Û›Ó, Ùa οو ‰\ ôÓˆ.
In altri casi, senza che vi sia alcuna differenza evidente di senso, la locuzione è Ùe ÙÔÜÏfiÁÔ˘:
– Dysc. 633 s. ¶fiÛÂȉÔÓ, ¥Ó· Ùe ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ ¿ıˆ, / âÓ Ù† ÊÚ¤·ÙÈ Î˘Ód Ì¿¯ˆÌ·È;– Misum. 566 ss. âd ÄÛÈÓ à[Á·ı]ÔÖ˜, ÙÔÜÙÔ ‰c Ùe ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘– Misum. 704 y˜ ùÚÂÈ, Ùe ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘.
Per due volte, il termine con cui ci si riferisce all’espressione proverbiale è ®ÉÌ· e, proba-bilmente non per caso, in entrambi i passi viene citato il medesimo proverbio:4
– Asp. 189 ss. ¿Ó˘ ÌÔÈ ‰ÔÎÂÖ/ Ùe ®ÉÌ· ÙÔÜÙ\ ÂrÓ·› ÙÈ ÌÂÌÂÚÈÌÓË̤ÓÔÓ/ Ùe «ÁÓáıÈÛ·˘ÙfiÓ».
– Ippoc. fr. 193, 3-4 àÏÏ\ âÎÂÖÓÔ˜ ®ÉÌ¿ ÙÈ/ âÊı¤ÁÍ·Ù\ Ôé‰bÓ âÌÊÂÚ¤˜, Ìa ÙeÓ ¢›·, / Ù†«ÁÓáıÈ Û·˘ÙfiÓ».
1 La diversa cura formale che Menandro riserva alle due tipologie espressive contribuisce a chiarire le differenzeesistenti, all’interno della produzione dell’autore, tra l’una e l’altra categoria, come verrà messo in evidenza più avanti.
2 Il presente lavoro non ha, naturalmente, la pretesa di essere esaustivo, limitandosi a mettere in evidenza alcunetendenze dell’usus menandreo. Salvo diversa indicazione, le commedie ‘integre’ (compresi i contesti frammentari) so-no citate secondo Menander, ed. W. G. Arnott, voll. i-iii, Cambridge-London, 1979-2000, mentre gli altri frammenti so-no citati secondo PCG, edd. R. Kassel, C. Austin, vol. vi-2, Berolini et Novi Eboraci, 1998.
3 L’espressione (nel senso di ‘detto proverbiale’) compare anche in: Phasma, v. 17; Ploc. fr. 296, 8; Fab. Inc. fr. 460.4 Cfr. Philem. fr. 139 K.-A., in cui ricorrono tanto il detto ÁÓáıÈ Û·˘ÙfiÓ quanto il termine ®ÉÌ· ad esso riferito.
12. menandro 217
Una sola volta compare in Menandro il termine ·ÚÔÈÌ›·:– Dis exap. 27 ss. [È]ı·Ó[¢Ô̤Ó]Ë ÁaÚ ·‡ÛÂÙ·È/ ¬Ù·Ó] ÔÙ\ ·úÛıËÙ·[È, Ùe Ùɘ ·]
ÚÔÈÌ›·˜, / ÓÂÎÚ†] ϤÁÔ˘Û· [ÌÜıÔÓ.
Naturalmente sono assai frequenti i casi in cui il proverbio è menzionato da solo, privo diqualsivoglia segnale. Alcuni esempi:1
– Epitr. 252 s. âÓ Ó˘ÎÙd ‚Ô˘ÏcÓ2 ‰\, ¬ÂÚ ±·ÛÈ Á›ÓÂÙ·È, / ‰È‰Ôf˜ âÌ·˘Ù† ‰ÈÂÏÔÁÈ˙fiÌËÓ.– Epitr. 284 ss. Âå ηd ‚·‰›˙ˆÓ ÂyÚÂÓ ±Ì\ âÌÔd Ù·ÜÙ· Î[·d/ qÓ ÎÔÈÓe˜ ‘EÚÌɘ,3 Ùe ÌbÓ iÓ
ÔyÙÔ˜ öÏ·‚[ÂÓ ôÓ, / Ùe ‰\ âÁÒØ– Misum. 696 ùÓÔ˜ χڷ˜.4– Anatith. fr. 31 K.-A. \AÚ¿‚ÈÔÓ àÚ\ âÁg ÎÂΛÓËÎ\ ôÁÁÂÏÔÓ.5
1. 2. Struttura logicaOgni espressione proverbiale è riconducibile a una struttura logico-sintattica di base, laquale, variata soltanto nei suoi elementi accessori, si ritrova immutata in tutti i proverbie le sentenze dello stesso tipo.6 Il riconoscimento di simili strutture è, ovviamente, su-bordinato alla conoscenza e alla comprensione della forma completa del proverbio che siintende analizzare: laddove il senso dell’espressione non sia chiaro, è infatti impossibileindividuare il nesso logico alla base della metafora espressa dal proverbio. In Menandro,sebbene i proverbi, per via della loro larga diffusione, siano spesso citati soltanto parzial-mente (il pubblico era comunque in grado di cogliere il riferimento), è tuttavia possibile,in alcuni casi, riconoscere e definire tali strutture.
Una struttura ben identificabile è quella esemplificata dal proverbio menzionato inAsp. 372 s. Ùe Á]aÚ ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ Ù·Ö˜ àÏËı›·È˜ «Ï‡ÎÔ˜/ ̄ ]·ÓgÓ ôÂÈÛÈ ‰Èa ÎÂÓɘ».7 Trala-sciando, infatti, la formula introduttiva Ùe ÁaÚ ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ (Ù·Ö˜ àÏËı›·È˜), il proverbiovero e proprio, χÎÔ˜ ¯·ÓgÓ ôÂÈÛÈ ‰Èa ÎÂÓɘ, permette di riconoscere uno schema xRa> xR1b. Il soggetto della proposizione, il lupo (indicato con la lettera x), compie l’azioneR (spalanca cioè le fauci, cerca di procacciarsi una preda) essendo in una condizione inizialea (qui sottintesa: avendo la bocca già piena); successivamente il medesimo soggetto x com-pie l’azione R1, si allontana, se ne va, trovandosi in una condizione differente da quella ini-ziale, quella di essere senza preda, a bocca vuota, o asciutta (condizione indicata con la let-tera b). Tale tipologia proverbiale designa una situazione in cui un soggetto subisce, permotivazioni esterne o interiori, un mutamento di condizione rispetto allo stato iniziale.Nel caso specifico, il riferimento menandreo potrebbe essere alla favola esopica del caneche, tenendo già fra i denti un pezzo di carne e vedendo se stesso riflesso sull’acqua, ten-ta di aggredire quello che ritiene un proprio simile per ottenere anche il cibo dell’altro,
1 Rinuncio, in questa sede, a fare un elenco completo dei passi, numerosi tanto nelle commedie relativamente in-tegre quanto nei frammenti. Per questi ultimi, ovviamente, non sempre possiamo essere certi che l’assenza di for-mule introduttive non sia da imputare a una lacuna nella tradizione.
2 L’espressione è registrata da Zen. 3,97, Diog. Vind. 2,46, Greg. Cypr. L. 2,4, Apost. 7,47. Cfr. Tosi nº 585 e PG, p.421, n. 342.
3 Il proverbio è citato nuovamente nella stessa commedia, poco più avanti (v. 317) ed è registrato da Diog. 5,38 eApost. 10,1. Cfr. PG, p. 506, n. 433.
4 Si veda anche Psophod. fr. 418 K.-A. A registrare il proverbio, che presenta qualche variante lessicale e/o sintatti-ca, sono Diog. 7,33, Greg. Cypr. 3,29 e Greg. Cypr. M. 4,66, Macar. 6,38 e 6,39, Apost. 12,82 e Arsen. 12,91. Cfr. Tosi nº483 e PG, p. 516, n. 605.
5 Si veda Apost. 3,70 \AÚ¿‚ÈÔ˜ ôÁÁÂÏÔ˜ (cfr. anche Apost. 3,71 \AÚ¿‚ÈÔ˜ ·éÏËÙ‹˜).6 L’analisi della struttura logica delle espressioni proverbiali è condotta sulla base di Cirese, Prime annotazioni,
cit., e Cirese, I Proverbi, cit.7 Cfr. Diogen. 6,20 §‡ÎÔ˜ ö¯·ÓÂÓØ âd ÙáÓ Ùɘ âÏ›‰Ô˜ àÔÙ˘Á¯·ÓfiÓÙˆÓ. Oî ÁaÚ Ï‡ÎÔÈ àıËÚ›0 ÂÚÈÂÛfiÓÙ˜,
¯·›ÓÔ˘ÛÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ.
218 silvio schirru
restando, ovviamente, a digiuno, dato che aprendo la bocca ha invece perso anche la pro-pria preda.1 Chi troppo vuole nulla stringe, insomma.
La medesima struttura può essere identificata in Epitr. fr. 5 ⤷۷/ âd Ùe Ù¿ÚȯԘ±Ï·˜.2 Anche in questo caso al medesimo soggetto x (Onesimo?) può essere dapprima at-tribuita un’azione R in relazione a un oggetto a (azione che non possiamo desumere dalcontesto, troppo frammentario) e quindi, in un accostamento metaforico, l’azione R1(spargere il sale) in relazione a un oggetto b (il pesce salato). Sia Gomme-Sandbach3 che Ar-nott4 si dicono convinti che il proverbio alluda fondamentalmente al peggiorare di una si-tuazione già negativa, o comunque al provocare dei danni.5 Si potrebbero citare espres-sioni corrispondenti quali rigirare il coltello nella piaga, piovere sul bagnato o, per mantenereil legame semantico col sale, spargere sale sulle ferite aperte. Arnott, del resto, traduce il pas-so utilizzando un altro proverbio, più familiare ad un lettore moderno, che esprime il me-desimo concetto, e cioè «I have really added fuel to the fire».
Altra struttura è xRa = xRb, che si registra per esempio in Dis exap. 27 ss. [È]ı·Ó[¢Ô̤Ó]ËÁaÚ ·‡ÛÂÙ·È/ ¬Ù·Ó] ÔÙ\ ·úÛıËÙ·[È, Ùe Ùɘ ·ÚÔÈÌ›·˜, / ÓÂÎÚ†] ϤÁÔ˘Û· [ÌÜıÔÓ.6 Per unipotetico soggetto x,7 compiere l’azione R (dire qualcosa) a un oggetto a (a te nel nostro pas-
1 Cfr. Aes. 133 Perry = 138 H.-H. L’espressione proverbiale, nella commedia, è inserita alla fine di una sequenzascenica che muove dai tentativi dell’avido Smicrine di sposare la giovane nipote, in seguito alla notizia (che poi si ri-velerà falsa) che il fratello maggiore di costei, Cleostrato, sarebbe perito in guerra. La ragazza è difatti latrice di unacospicua eredità, costituita dai tesori conquistati dallo stesso Cleostrato. Il servo Davo, per evitare che la ragazza, in-namorata di Cherea, sia costretta a maritarsi col vecchio, orchestra allora un inganno: a Smicrine viene fatto credereche anche suo fratello Cherestrato abbia perso la vita in seguito all’immenso dolore per la scomparsa di Cleostrato.La figlia di Cherestrato, a questo punto, diviene per Smicrine una ‘preda’ più appetitosa, dato che, a parità di gradodi parentela, dispone di una dote maggiore. Così Smicrine, credendo scomparso Cherestrato e lasciando che Chereasposi la sorella di Cleostrato, sarà simile al cane della favola, dato che alla fine avrà perso entrambe le spose e le rela-tive doti. Tosi, nº 873, p. 411 (seguito da PG, ed. E. Lelli, p. 510, n. 509) mette invece il proverbio in relazione con Aes.158 Perry = 163 H.-H., in cui un lupo affamato, avendo sentito una vecchia minacciare un bambino di darlo in pastoal lupo se non smetterà di piangere, attende invano il ‘premio’, finché non è costretto ad andarsene sconsolato, aven-do capito che la vecchia non darà seguito alla minaccia. L’ipotesi di Tosi ha l’indubbio vantaggio di collegare il passodell’Aspis a una favola il cui protagonista è un lupo (come nel passo menandreo), e non un cane; tuttavia, in base alcontesto scenico, parrebbe più pertinente accostare il proverbio in questione alla favola del cane che perde la predaperché troppo avido; quanto allo scambio tra cane e lupo in Menandro (animali peraltro non troppo dissimili, alme-no nel mondo della favola), esso potrà forse spiegarsi con l’esigenza comica di accostare l’avido Smicrine all’animale‘famelico’ per antonomasia.
2 Il contesto, a grandi linee, è il seguente: Carisio, durante una festa, ha abusato di Panfila. Mentre ciò accadeva,però, la ragazza riusciva a strappargli dal dito un anello. Il caso vuole che, in seguito, i due si incontrino nuovamen-te ma non si riconoscano, e finiscano per giunta con lo sposarsi. Mentre il marito è assente, Panfila dà alla luce unbimbo, frutto della violenza di quella notte. Decide di non tenerlo e lo fa esporre insieme ad alcuni oggetti, fra cuil’anello, che in seguito possano permetterne il riconoscimento. Carisio viene a sapere del bambino e, ritenendosi tra-dito dalla moglie, la abbandona e inizia a frequentare Abrotono, un’etera. Alla fine però tutto si appianerà, perché,grazie alla prova costituita dall’anello, l’equivoco verrà chiarito. Secondo Arnott i, cit., pp. 392 ss., il frammento inesame potrebbe collocarsi nella scena di apertura, quando Onesimo, servo di Carisio, descrive la reazione del padro-ne, venuto a conoscenza della nascita del bambino.
3 A. W. Gomme, F. H. Sandbach, Menander, a Commentary, Oxford, 1973, p. 293.4 Arnott i, cit., pp. 392 ss.5 L’ipotesi dei due studiosi si basa sul fatto che spargere sale su qualcosa che è già abbondantemente salato è
un’azione non soltanto inutile, ma anche dannosa, perché rende il cibo immangiabile: Ù¿ÚȯԘ, infatti, è un termineche designa carne o, più spesso, pesce conservati sotto sale, o comunque disidratati, ad esempio tramite essiccamen-to o affumicamento (cfr. LSJ, pp. 1758 s. e s. v. Ù¿ÚȯԘ; suppl. p. 290). Si tratta di un tipo di alimento cui sovente si allu-de nelle commedie di Aristofane (Ach. 967 e 1101, Eq. 1247, Ra. 558, Vesp. 491, frr. 347 e 639 K.-A.) e che viene usato anchecome metafora di individuo stupido, in analogia ai nostri stoccafisso o baccalà (cfr. e.g. Aristoph. Conv. fr. 207 K.-A.). InAthen. 3,119 E-F sono citati vari proverbi (tra cui anche quello in esame) in cui compare il termine Ù¿ÚȯԘ.
6 Cfr. Diogen. 6,82 (NÂÎÚ† ϤÁˆÓ ̇ıÔ˘˜ Âå˜ Ôs˜Ø âd ÙÔÜ Ìc â·˝ÔÓÙÔ˜), Diogen. Vind. 3,34 (NÂÎÚ† Úe˜ Ôs˜‰È·Ï¤ÁÂÛı·ÈØ âd ÙÔÜ àÓ·ÈÛı‹ÙÔ˘ ηd Ìc â·˝ÔÓÙÔ˜), Greg. Cypr. 3,12 = Greg. Cypr. M. 4,47 = Apost. 11,100 (NÂÎÚ†ÌÜıÔÓ Âå˜ Ôs˜ öÏÂÁÂÓØ âd ÙÔÜ Ìc â·˝ÔÓÙÔ˜· ηd âd ÙáÓ àÓ·ÈÛı‹ÙˆÓ).
7 Per ricostruire la trama del ¢d˜ âÍ··ÙáÓ, di cui ci è pervenuto un frammento molto esiguo, bisogna basarsi sul-
12. menandro 219
so) equivale, essendo altrettanto inutile, a dire quella stessa cosa (compiendo quindi la stes-sa azione R) a un morto (oggetto b).1
Un’altra tipologia è quella che può essere sintetizzata dalla formula xRa / yRb, di cuiun esempio è costituito da Misum. 696 ùÓÔ˜ χڷ˜.2 In questo caso la medesima azione (R)è messa in relazione a due soggetti (x/y) e a due oggetti (a/b) diversi. Più precisamente,considerando il contesto,3 viene istituito un parallelo tra il personaggio di Demea e il pro-verbiale asino, indifferente al suono della lira.4
Ancora, possiamo citare lo schema xRa / yRa, esemplificato da Dysc. 949 qÓ ‰\ óÛÂÚÂd\˜ ôÌÌÔÓ ÊÔÚԛ˘. La struttura logica presenta qui5 il soggetto espresso x (i convitati) be-ve/assorbe (azione R) tanto vino (oggetto a) quanto un diverso soggetto y (la sabbia) fareb-be (azione R) con lo stesso liquido (oggetto a). In altre parole, mentre il contesto rimaneinalterato, viene stabilito un parallelismo tra l’azione compiuta da un primo soggetto e lastessa azione compiuta da un secondo soggetto.
È anche presente6 un proverbio cosiddetto di preferenza7 (il cui schema è meglio A di B,come nel nostro meglio un uovo oggi che una gallina domani): Dysc. 811 s. ÔÏφ ‰b ÎÚÂÖÙÙfiÓâÛÙÈÓ âÌÊ·Óc˜ Ê›ÏÔ˜/ j ÏÔÜÙÔ˜ àÊ·Ó‹˜, nÓ Ûf ηÙÔڇͷ˜ ö¯ÂȘ.8
l’adattamento di Plauto, le Bacchides. Nell’opera plautina Mnesiloco crede che la donna che ama, l’etera Bacchide, lotradisca con l’amico Pistoclero: equivoco generato dal fatto che Pistoclero ha effettivamente una relazione con unadonna di nome Bacchide, che però è la sorella, omonima, dell’amante di Mnesiloco. Ritenendosi dunque tradito dal-la propria donna e dal migliore amico, Mnesiloco si abbandona a un accorato quanto umoristico monologo nel qua-le alterna bellicosi intenti di rivalsa verso l’etera e ammissioni di impotenza, vinto com’è dall’amore per lei. E quan-do, nelle sue fantasie, la donna giunge a chiedergli perdono per il tradimento e a tentare di conquistarlo nuovamentecon le sue arti seduttorie, egli si prende una rivincita rifiutando sdegnosamente Bacchide e dichiarando che le avan-ces della ragazza avranno su di lui lo stesso effetto che si otterrebbe raccontando storie a un morto. In Menandro il con-testo doveva essere pressappoco lo stesso: l’amante ‘tradito’ ha nome Sostrato, l’amico ‘fedifrago’ è Mosco, mentredelle due etere non siamo in grado di ricostruire il nome.
1 Un proverbio molto simile è ùÓÅ Ùå öÏÂÁ ÌÜıÔÓØ ï ‰¤ Ùa tÙ· âΛÓÂÈ (cfr. Zenob. 5,42, Diogen. 7,30, Greg. Cypr.3,30, Greg. Cypr. M. 4,67, Apost. 12.81; Phot. ii p. 20 Naber; Suda Ô 393 Adler).
2 Il proverbio è caro a Menandro, che lo utilizzava anche nel æÔÊԉ‹˜ (fr. 418 K.-A.), stando alle testimonianzedi Suda Ô 391 Adler e Phot. ii p. 18 Naber, che riportano anche la forma strutturalmente completa dell’espressione pro-verbiale: ùÓÔ˜ χڷ˜ õÎԢ ηd Û¿ÏÈÁÁÔ˜ y˜ (per la quale si vedano, con àÎÔ‡ˆÓ al posto di jÎÔ˘Â, Macar. 6,38 e Apost.12,91a). Ma cfr. anche Crat. fr. 247 K.-A. ùÓÔÈ ‰\àˆÙ¤Úˆ οıËÓÙ·È Ùɘ χڷ˜; Eupol. fr. 279 K.-A. ùÓÔ˜ àÎÚÔ3 Û¿ÏÈÁ-ÁÔ˜; Luc. Ind. 4 ùÓÔ˜ χڷ˜ àÎÔ‡ÂȘ ÎÈÓáÓ Ùa tÙ·; Phaedr. App. 14.
3 Trasonide è un soldato, tornato dalla guerra con una serva di nome Crateia come bottino. È innamorato di lei,ma si rende conto che la ragazza lo odia e lo respinge. Si viene a sapere che tale odio è suscitato dall’avere ella cre-duto di riconoscere, tra le armi del padrone, quella che apparteneva al defunto fratello di lei, così da dedurne che aducciderlo sia stato Trasonide. Purtroppo lo stato gravemente lacunoso del testo impedisce di farsi un’idea precisa del-l’esatto svolgimento degli avvenimenti fino al passo in esame, una scena del iv atto in cui Geta racconta come De-mea, padre di Crateia, da lei informato del presunto assassinio del figlio da parte di Trasonide, si sia dimostrato asso-lutamente impassibile di fronte alle richieste di Trasonide di prendere la ragazza in moglie, e si sia dunque comportatocome l’asino quando ascolta la lira.
4 L’accostamento di asino e lira si basa sull’opposizione ossimorica dei concetti che rappresentano: ignoranza orozzezza (l’asino) e cultura o raffinatezza (la lira). Cfr., con strumento diverso (l’aulos), Plut. Sept. Sap. 150 D-F.
5 Siamo alla fine della commedia, e il cuoco Sicone descrive i festeggiamenti che hanno avuto luogo in occasionedel duplice matrimonio che chiude l’opera. Per descrivere la quantità spropositata di vino che sarebbe stata ingurgi-tata dai convitati, Sicone fa ricorso a una metafora: era come versare (il vino) sulla sabbia. La lettura óÛÂÚÂd \˜ si deve aC. Diano (ˆÛÂÚÂå è il testo tràdito dal pap. Bodmer 4), ed era stata accolta già in F. H. Sandbach (ed.), Menandri Reli-quiae selectae, Oxford (19721), 1990, p. 90.
6 Ribadisco che la panoramica delle possibili strutture logiche presenti in Menandro qui fornita non è, natural-mente, esaustiva: soprattutto per quanto riguarda i contesti frammentari, come detto sopra, è spesso difficile ricon-durre il proverbio a uno schema logico coerente, specie quando il significato stesso dell’espressione è oscuro.
7 Cfr. A. M. Cirese, I proverbi di preferenza. Notarella tecnico-teorica, «Sigma», 11/2-3, 1978, pp. 91-104.8 Per un’analisi più approfondita di questo proverbio si veda infra.
220 silvio schirru
1. 3. Proprietà formali dei proverbi
Nei proverbi che Menandro utilizza è possibile riscontrare con una certa regolarità alcuniespedienti fonici e ritmici: allitterazione, assonanza/consonanza, chiasmo e riduzione delproverbio ad unità metrica.1 Alcuni esempi:
– Asp. 372 s. Ùe Á]aÚ ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ Ù·Ö˜ àÏËı›·È˜ «Ï‡ÎÔ˜/ ̄ ]·ÓgÓ ôÂÈÛÈ ‰Èa ÎÂÓɘ». Lecomponenti del proverbio2 sono disposte secondo una struttura chiastica:
χÎÔ˜ (soggetto) ¯·ÓÒÓ (participio attributivo)ôÂÈÛÈ (predicato verbale) ‰Èa ÎÂÓɘ (complemento di modo)
Il predicato chiude la prima proposizione e apre la seconda e i due predicati sono incor-niciati rispettivamente dal soggetto e dal complemento. Tale struttura permette di evi-denziare il parallelismo (o l’opposizione) tra il predicato attributivo ¯·ÓÒÓ e il comple-mento ‰Èa ÎÂÓɘ, ciò che esalta l’efficacia esemplare e mnemonica del proverbio. Dalpunto di vista fonico è interessante rilevare che i due elementi sui quali si focalizza l’at-tenzione, ovvero quelli che determinano la differenza tra la condizione di partenza e quel-la di arrivo (sancendo di fatto l’insegnamento morale del proverbio), ¯·ÓÒÓ e (‰Èa) ÎÂÓɘ,sono non soltanto allitteranti (la differenza è solo tra velare aspirata e velare non aspira-ta) ma anche consonanti, dal momento che entrambi i termini sono bisillabici e le con-sonanti iniziali e interne di ogni sillaba sono dello stesso tipo, nonché metricamente equi-valenti, trattandosi di due giambi. Le due parole risultano dunque ritmicamente simili:caratteristica che, considerando la sostanziale antitesi semantica, dà luogo ad una paro-nomasia, tale da accentuare la conclusione ‘ad effetto’ dell’asserzione e, quindi, il suo va-lore didascalico.
– Dysc. 811 s. ÔÏφ ‰b ÎÚÂÖÙÙfiÓ âÛÙÈÓ âÌÊ·Óc˜ Ê›ÏÔ˜/ j ÏÔÜÙÔ˜ àÊ·Ó‹˜, nÓ ÛfηÙÔڇͷ˜ ö¯ÂȘ. Il proverbio presenta una doppia struttura chiastica. Il primo chiasmo èquello originato dalla posizione, all’interno dei due versi, dei due elementi focali, âÌÊ·Óc˜Ê›ÏÔ˜/ ÏÔÜÙÔ˜ àÊ·Ó‹˜:
ÔÏφ ‰b ÎÚÂÖÙÙfiÓ âÛÙÈÓ âÌÊ·Óc˜ Ê›ÏÔ˜j ÏÔÜÙÔ˜ àÊ·Ó‹˜ nÓ Ûf ηÙÔڇͷ˜ ö¯ÂȘ
ma ve n’è anche un altro, causato, all’interno della coppia âÌÊ·Óc˜ Ê›ÏÔ˜/ ÏÔÜÙÔ˜àÊ·Ó‹˜, dallo scambio di posizione aggettivo-sostantivo/sostantivo-aggettivo. I due con-cetti cardine sono posti in evidenza, oltre che da questo duplice parallelismo, anche dallaloro collocazione metrica: âÌÊ·Óc˜ Ê›ÏÔ˜ occupa la parte finale del verso, una posizionedi per sé rilevante, ed è racchiuso tra la cesura eftemimere e la fine del verso; j ÏÔÜÙÔ˜àÊ·Ó‹˜ si trova invece ad inizio verso. La formulazione di questo proverbio di preferenza,inoltre, è esattamente di due versi, e costituisce pertanto un’unità metrica a sé stante.
Sam. 11 Ùe ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ ‰c ÙÔÜÙÔ «ÙáÓ ÔÏÏáÓ ÙȘ üÓ». Fonicamente possiamo notareun’insistenza sul suono o e l’allitterazione del suono t iniziale, mentre dal punto di vistametrico constatiamo ancora come Menandro conferisca al proverbio la forma di unÌÔÓfiÛÙȯԘ (qui con l’ausilio della formula Ùe ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ ‰c ÙÔÜÙÔ).
Ancora un ÌÔÓfiÛÙȯԘ abbiamo in Sycion. fr. 8: ηÎc ÌbÓ ù„Ș, âÓ ‰b ‰Â›Ï·È·È ÊÚ¤Ó˜ (sinotino peraltro l’allitterazione in d e la sequenza di suoni vocalici iniziali in e di âÓ ‰b‰Â›Ï·È·È).
1 Tali fenomeni si riscontrano con maggiore frequenza nelle sentenze, come si vedrà in seguito.2 Per questo proverbio cfr. Aristoph. Thesmoph. ‚\ fr. 350 K.-A.; Eub. fr. 14, 11 K.-A.; Euphr. fr. 1, 30 s. K.-A.
12. menandro 221
1. 4. Contenuto dei proverbiEsistono, fra i proverbi di Menandro, alcune categorie privilegiate. Tra queste spicca quel-la dei detti riconducibili al patrimonio favolistico, o comunque popolare, che chiama incausa animali. Oltre ai casi già citati (Asp. 372 s.; Dysc. 633 s.; Misum. 15, 696 e 704), altriesempi sono:
– Enchir. fr. 6 ñbÚ ùÓÔ˘ ÛÎÈĘ– Colax fr. 6 e Imbrioi fr. 192 K.-A. ‚Ôܘ KÜÚÈÔ˜– Eunuch. fr. 148 K.-A. χÎÔ˘ ÙÂÚa– Ploc. fr. 296.8 K.-A. ùÓÔ˜ âÓ Èı‹ÎÔȘ, ÙÔÜÙÔ ‰c Ùe ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ– Ploc. fr. 309 K.-A. ÙÚ˘ÁfiÓÔ˜ Ï·Ï›ÛÙÂÚÔ˜1– Fab. Inc. fr. 880 K.-A. çÚÓ›ıˆÓ Á¿Ï·2
Non è sempre agevole ricostruire il senso e l’origine di simili proverbi: talvolta si può in-terpretare l’espressione sulla base di testimonianze letterarie o paraletterarie, ma altrevolte a chiarire il significato del proverbio contribuisce solo ed esclusivamente la testi-monianza dell’autore che lo cita. Nel caso di Colax, fr. 6, per esempio, il passo è testimo-niato da Zenob. 2.72: ‚Ôܘ K‡ÚÈÔ˜, úÛÔÓ Ù† «ÛηÙÔÊ¿ÁÔ˜ Âr». §¤ÁÔÓÙ·È ÁaÚ Ôî ‚fi˜ âÓK‡ÚÅ ÛηÙÔÊ·ÁÂÖÓ. M¤ÌÓËÙ·È Ù·‡Ù˘ (scil. Ùɘ ·ÚÔÈÌ›·˜) M¤Ó·Ó‰ÚÔ˜ âÓ KfiÏ·ÎÈ.L’espressione equivarrebbe dunque a “sei un divoratore di sterco”, abitudine che venivaattribuita ai bovini di Cipro.3 Si tratta, in sostanza, di una variante del termineÛηÙÔÊ¿ÁÔ˜, insulto utilizzato in altre commedie menandree.4
Passando ad un’altra categoria, Menandro ama talvolta inserire espressioni proverbialiin contesti in cui esse possano acquisire un valore drammaturgico, facendosi latrici di si-gnificati ulteriori (magari a fini comici) rispetto a quello letterale e caratterizzando in ma-niera specifica il linguaggio dei personaggi.5 Un ottimo esempio è il già citato Dysc. 811 s.ÔÏφ ‰b ÎÚÂÖÙÙfiÓ âÛÙÈÓ âÌÊ·Óc˜ Ê›ÏÔ˜/ j ÏÔÜÙÔ˜ àÊ·Ó‹˜, nÓ Ûf ηÙÔڇͷ˜ ö¯ÂȘ, in cuiSostrato, nel tentativo di persuadere il padre a dare la propria figlia in moglie a Gorgia, nonpuò far altro che ricorrere a un discorso molto concreto, trattando l’amicizia alla streguadi una merce. La battuta di Sostrato risulta infatti essere la parodia di un’espressione trat-ta dal linguaggio giuridico, perché Menandro gioca sul doppio significato dell’opposizio-ne semantica âÌÊ·Ó‹˜/ àÊ·Ó‹˜.6 Al primo livello interpretativo, quello letterale (la pre-senza di un amico, tanto più âÌÊ·Ó‹˜, è elemento positivo anche senza specificazioni),infatti, si aggiunge un secondo e più sottile livello, in quanto âÌÊ·Óc˜ (Ê·ÓÂÚa) ÔéÛ›· edàÊ·Óc˜ ÔéÛ›· sono termini tecnici del lessico giuridico ateniese in materia di beni.7
1 Cfr. il proverbio Ï·Ï›ÛÙÂÚÔ˜ ¯ÂÏȉfiÓÔ˜ in Macar. 5.49 e l’espressione ÙáÓ ¯ÂÏȉfiÓˆÓ […] Ï·Ï›ÛÙÂÚÔ˜ in Theophr.Char. 7.9.
2 Cfr. Aristoph. Av. 734 e 1673; Vesp. 508; Eup. fr. 411 K.-A.; Mnesim. fr. 9, 2 K.-A., nonché Alex. fr. 123 K.-A (con ani-male diverso, ÁaÏ· Ï·ÁÔÜ).
3 La bizzarra quanto improbabile dieta dei buoi di Cipro è testimoniata da Antiphan. fr. 124 K.-A. âÓ Ù” K‡ÚÅ ‰\Ô≈Ùˆ ÊÈÏˉÂÖ Ù·Ö˜ ñÛ›Ó’ t ‰¤ÛÔı\, œÛÙ ÛηÙÔÊ·ÁÂÖÓ ÂÖÚÍ Ùe ˙†ÔÓ […] ÙÔf˜ ‰b ‚Ôܘ äÓ¿ÁηÛÂÓ.
4 Dysc. 488; Sam. 427 e 550; Peric. 394; Fab. inc. fr. 571 K.-A.5 Per una più articolata disamina dell’uso comico dei proverbi in Menandro, rimando a L. Leurini, Strategie del
comico: proverbi in Menandro, in Comicità e riso tra Aristofane e Menandro. Atti del Convegno di Studi (Cagliari, 29 set-tembre-1 ottobre 2005), edd. P. Mureddu, G. F. Nieddu, Amsterdam, 2006 e L. Leurini, I proverbi in Menandro, in Tra-gico e comico nel dramma attico e oltre, edd. P. Mureddu, G. F. Nieddu, S. Novelli, Amsterdam 2009.
6 Cfr. Gomme-Sandbach, cit., p. 257 ed Arnott i, cit., p. 319.7 La legge ateniese distingueva infatti tra proprietà visibile e proprietà nascosta: alla prima categoria apparteneva-
no possessi tassabili quali terreni, edifici o schiavi; alla seconda potevano venire ascritti denaro contante, depositi e si-mili (ma non necessariamente, molto dipendeva dal fatto che il possessore fosse o meno consapevole della loro esi-stenza). Cfr. re vol. i, p. 2710 s. v. àÊ·Óc˜ ÔéÛ›·; A. R. W. Harrison, The Law of Athens, Oxford, 1968, vol. i pp. 230 s.
222 silvio schirru
Altri esempi:– Epitr. fr. 5 ⤷۷/ âd Ùe Ù¿ÚȯԘ ±Ï·˜, con una metafora tratta dal linguaggio cu-
linario. Arnott fa notare1 come, se la sua ipotesi di collocazione del frammento in aper-tura di commedia fosse corretta, avremmo qui un vivido esempio della sottile ironia me-nandrea, che mette in bocca (è proprio il caso di dirlo) a Onesimo, durante unaconversazione col cuoco Carione, una metafora culinaria.
– Dysc., 633 s. ¶fiÛÂȉÔÓ, ¥Ó· Ùe ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ ¿ıˆ, / âÓ Ù† ÊÚ¤·ÙÈ Î˘Ód Ì¿¯ˆÌ·È; In que-sto caso, la citazione menandrea è pregnante e polisemica poiché, oltre che su un pianometaforico, è accostabile a quanto accade sulla scena anche a livello puramente letterale:Cnemone (il ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ da cui la commedia trae il titolo) è caduto davvero in un pozzo e ilsuo comportamento non è molto dissimile dall’abbaiare di un cane arrabbiato!2
– Theoph., fr. 5 àe Ì˯·Óɘ ıÂe˜ âÂÊ¿Ó˘, in cui si fa invece ricorso al linguaggio tea-trale.3
Altra tipologia di frequente utilizzo da parte di Menandro è quella dei ‘personaggi pro-verbiali’, ovvero figure storiche o universalmente note che si fanno archetipo di un vizioo, più in generale, di un atteggiamento specifico. Alcuni esempi significativi sono:
– Asp. 269 s. Úe˜ ıÂáÓ, MÂÏÈÙ›‰–4/ Ï·ÏÂÖÓ ñ›ÏËÊ·˜;– Dysc. 683 s. àÏÏ\ ï °ÔÚÁ›·˜ ≠AÙÏ·˜/ qÓ Ôé¯ ï Ù˘¯ÒÓØ– Colax fr. 2, 1 ss. (BIA™) ÎÔهϷ˜ ¯ˆÚÔÜÓ ‰¤Î·/ âÓ K··‰ÔΛ0 ÎfiÓ‰˘ ¯Ú˘ÛÔÜÓ,
™ÙÚÔ˘ı›·, / ÙÚd˜ â¤ÈÔÓ ÌÂÛÙfiÓ ÁÂ. (™TPOY£IA™) \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ϤÔÓ/ ÙÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜¤ˆÎ·˜, in cui Alessandro di Macedonia è rappresentato come il bevitore accanito pereccellenza.
– Asp. 230 s. Ôé ™ÈÓıÉÚ\, \AÚÈÛÙ›‰ËÓ ‰\ ö¯ˆ,5/ ñËÚ¤ÙËÓ ‰›Î·ÈÔÓØ
Un caso particolare è quello di Asp. 206 s. ºÚ‡Í ÂåÌÈ· ÔÏÏa ÙáÓ ·Ú\ ñÌÖÓ Ê·›ÓÂÙ·È/ ηÏáÓâÌÔd ¿Ó‰ÂÈÓ· ηd ÙÔéÓ·ÓÙ›ÔÓ/ ÙÔ‡ÙˆÓ, in cui, più che un personaggio, ad essere oggettodell’attenzione menandrea è piuttosto una intera etnia, quella dei Frigi. E se già la con-trapposizione tra due culture ha valore proverbiale di per se stessa, in quanto espressionemetonimica che implica una differenza di più ampia portata, la scelta di fare di Davo (chenella commedia si propone come personaggio saggio e animato da nobili sentimenti) unFrigio è quanto meno pregnante. In primo luogo perché rispetta un cliché comico: spes-so, infatti, i Frigi sono schiavi per antonomasia;6 in secondo luogo perché l’opinione chei Greci avevano dei Frigi, in generale, non era certo buona.7
1 Cfr. Arnott i, cit., pp. 392 ss.2 Per il significato del proverbio, Gomme-Sandbach, cit., pp. 232 s. rimandano a Zenob. 3,45 âÓ ÊÚ¤·ÙÈ Î˘Ûd
Ì¿¯ÂÛı·ÈØ âd ÙáÓ ÌÔ¯ıËÚᘠÙÈÓÈ ÚÔÛ·Ï·ÈfiÓÙˆÓ Î·d àÔÊ˘ÁÂÖÓ Ìc ‰˘Ó·Ì¤ÓˆÓ, a Hesych.  3449 Latte âÓ ÊÚ¤·ÙÈ΢ÓÔÌ·¯ÂÖÓ, a Suda  1505 Adler âÓ ÊÚ¤·ÙÈ Î˘Ûd Ì¿¯ÂÛı·È, e ad Apost. 7,40: âÓ ÊÚ¤·ÙÈ Î˘ÓÔÌ·¯ÂÖÓØ âd ÙáÓ àÔÊ˘ÁÂÖÓÔéÎ â¯fiÓÙˆÓ Î·d ÌÔ¯ıËÚ† ÙÈÓd ÚÔÛ·Ï·ÈfiÓÙˆÓ. Le origini dell’espressione sarebbero da ricercare nella favola in cuiun cane, caduto in un pozzo, morde un giardiniere che cerca di liberarlo, credendo che egli sia lì per annegarlo (cfr.Aes. 120 Perry = 122 H.-H.).
3 Sarebbe interessante scoprire se, anche in questo caso, fosse presente un gioco metateatrale simile a quello pro-posto da Menandro nel passo precedente, ovvero una situazione che richiamasse, e non solo metaforicamente, l’ar-tificio scenico del deus ex machina.
4 Melitide è un personaggio proverbialmente poco sagace, come testimoniano Hom. Od. 10, 552; Pseudo-Luc.Amores 53; Suda Á 118 Adler.
5 I due nomi sono qui usati entrambi ‘proverbialmente’: se Aristide (generale e uomo politico dei primi anni delv sec.) era un giusto per antonomasia (cfr. Aeschin. 3,181), ™ÈÓı‹Ú è ben documentato come nome di cuoco (cfr. e.g. Theop. fr. 33 K.-A.; Anth. Pal. 6,306), mestiere che, in questo caso, simboleggia.
6 Come per esempio in Ar. Vesp. 433 t M›‰· ηd ºÚ‡Í, ‚Ô‹ıÂÈ ‰ÂÜÚÔ, ηd M·Û˘ÓÙ›·, / ηd Ï¿‚ÂÛı ÙÔ˘ÙÔ˘d ηd ÌcÌÂıÉÛı ÌˉÂÓ› e in Herond. 2,37, in cui per dire il primo schiavo che incontri l’autore scrive ï ÚÔÛÙ˘¯gÓ ºÚ‡Í.
7 Si vedano ad esempio lo stesso Menandro, Aspis 233 ss. (i Frigi sono definiti buoni a nulla ed effeminati), Eur. Or.1369-1536, Tertull. De anima 20, ma anche un proverbio citato da Suda Ê 772 Adler: ºÚfÍ àÓcÚ ÏËÁÂd˜ àÌÂ›ÓˆÓ Î·d
12. menandro 223
Un discorso analogo è valido per Dysc. 604 ss., in cui a essere chiamata in causa è la ca-tegoria dei contadini attici: ÙÔÜÙ\ âÛÙdÓ ÂåÏÈÎÚ[ÈÓc˜] ÁˆÚÁe˜ \AÙÙÈÎfi˜Ø/ ¤ÙڷȘ̷¯fiÌ[ÂÓ]Ô˜ ı‡Ì· ÊÂÚԇ۷Ș ηd ÛÊ¿ÎÔÓ/ 片ӷ˜ âÈÛÄ[Ù\ Ô]é‰bÓ àÁ·ıeÓ Ï·Ì‚¿ÓˆÓ.
A questa categoria possono essere ascritti anche alcuni ‘proverbi’ di presumibile crea-zione menandrea, che fanno riferimento a personaggi contemporanei, noti per qualcheloro caratteristica peculiare, come in Colax 203 ss. Ę ‰‡Ó·Ù·È ηÎᘠÔÈÂÖÓ, / iÓ ÌcÊ˘Ï¿ÙÙ–. TeÓ ÛÊfi‰Ú\ åÛ¯˘ÚeÓ [ /.[.]..ıÂÓ.ÈÔÓ \AÛÙ˘¿Ó·Î[ÙÔ]˜ ñ[Ù›Ô˘/ Î[·]Ù·ÎÂÈ̤ÓÔ˘,‰Ô›‰˘[ÎÈ.]….Ù·[.].[…]ηȘ/ Ù]cÓ ®ÖÓ· Û˘ÓÙÚÈ„·ÈÌ..[.]Ì[..]..[….]·Ó.1
2. Le sentenze
A differenza di quanto accade coi proverbi, Menandro non utilizza formule che introdu-cano o identifichino le sentenze inserite all’interno delle sue commedie; né, del resto, lesentenze sono riconducibili a schemi ricorrenti. Lo studio delle ÁÓáÌ·È, pertanto, partedall’esame delle loro caratteristiche formali.
2. 1. Proprietà formali delle sentenzeI fenomeni fonici, ritmici e logici che riscontriamo nei proverbi sono presenti anche nel-le sentenze. La loro frequenza è tale, anzi, da indurre a ritenere che Menandro, quandonon utilizza espressioni che lo vincolino a una forma tradizionalmente ben definita, fac-cia uso con maggiore insistenza di espedienti formali. Ciò, presumibilmente, avviene per-ché la sentenza, non essendo universalmente nota, ha maggiore bisogno di accorgimen-ti adeguati a fissarla nella mente dello spettatore, che verosimilmente udiva per la primavolta, se non il singolo concetto espresso, quanto meno la specifica formulazione elabo-rata da Menandro.
Alcuni esempi:– Adelph. ‚ã fr. 9, 1 s. K.-A. öÚÁÔÓ ÂñÚÂÖÓ Û˘ÁÁÂÓÉ/ ¤ÓËÙfi˜ âÛÙÈÓ. Menandro, come è no-
to, compose due commedie dal titolo \A‰ÂÏÊÔ›; la seconda, cui appartiene il passo in esa-me, ci è quasi completamente sconosciuta. Sappiamo però che il poeta latino Terenziotrasse spunto, per i suoi Adelphoe, proprio da quest’opera menandrea. Perciò, pur essen-do la commedia terenziana un adattamento non necessariamente fedele, si può tentare dicontestualizzare il nostro passo facendo ricorso ad essa.2 La proposizione va definita sen-
‰È·ÎÔÓ¤ÛÙÂÚÔ˜Ø âÂd ‰ÔÎÔÜÛÈÓ àÚÁfiÙÂÚÔÈ Î·d Óˆ¯ÂϤÛÙÂÚÔÈ ÂrÓ·È Ôî ºÚ‡Á˜ ÔåÎ¤Ù·È (in cui si ironizza sull’indolenza e sul-la ‘predisposizione’ alla servitù dei Frigi). Un altro modo di dire è ricordato da Strabone (1,2,30): ‰ÂÈÏfiÙÂÚÔ˜ Ï·ÁgºÚ˘Áfi˜, ovvero “più vigliacco di un coniglio frigio”, come se i conigli, animali proverbialmente dotati di scarso corag-gio, in Frigia fossero ancora più fifoni. Tosi, nº 937, p. 437 cita il proverbio sero sapiunt Phryges, verso dell’Equus Troia-nus (234 R.3) di cui ci dà testimonianza Cicerone (Ad fam. 7,16,1) e di cui Festo (460, 36-462, 2 Lindsay) fornisce l’ezio-logia: soltanto nel decimo anno di guerra, oramai stremati, i Troiani pensarono di restituire Elena agli Achei. Comedire che i Frigi, agli occhi dei Greci, non erano nemmeno troppo svegli.
1 Da Ateneo (1, 413ab) sappiamo che Astianatte era un ·ÓÎÚ·ÙÈ·ÛÙ‹˜ e che vinse tre volte di seguito alle Olim-piadi. Inoltre uno scolio del P. Oxy. 2655 (cfr. E. G. Turner, The Oxyrhynchus Papiri 33, 1968, pp. 9-14) ci informa cheAstianatte era ricordato da diversi autori comici e che, secondo Eratostene, conquistò una delle sue vittorie nel 316.Qui è chiaramente utilizzato come esempio proverbiale di persona dalla possanza straordinaria: il senso è che persi-no l’avversario più temibile può essere sconfitto facilmente quando non si aspetta di essere attaccato.
2 Eschino e Ctesifone sono due fratelli, figli del severo Demea. Ma il primo è stato adottato ed educato dal per-missivo fratello di Demea, Micione, e conduce una vita scapestrata che desta il biasimo di Demea e la preoccupazio-ne, non manifesta, di Micione. Proprio quando Eschino sembra aver messo la testa a posto e decide di sposare Panfi-la, una ragazza di umile condizione che aspetta un figlio da lui, si viene a sapere che il giovane ha fatto irruzione nellacasa di un lenone e ne ha tratto via a forza una prostituta. La notizia giunge alle orecchie di Sostrata, madre di Panfi-la, la quale, indignata, volge subito il pensiero ai risvolti pratici della questione e, in previsione del matrimonio di Pan-fila con qualcun altro, fa subito mandare a chiamare un parente. Più o meno a questo punto della commedia me-nandrea doveva trovarsi la sentenza in esame, con la sconsolata constatazione che bisogna adoperarsi alacremente
224 silvio schirru
tenza e non proverbio giacché la frase, pronunciata relativamente a un contesto specifico(Sostrata la riferisce alla figlia Panfila, indigente e bisognosa di un parente) e senza che vifosse alcuna precedente attestazione di quella stessa proposizione, formulata nella mede-sima forma, nella tradizione orale o letteraria, assume un valore universale: in generalesi può dire che sia difficile per qualunque persona povera (che si trovi nello stesso conte-sto socio-culturale in cui operano i personaggi) trovare qualcuno disposto a dichiararsisuo parente e, quindi, ad aiutarla. In altri termini l’affermazione di Sostrata, sebbene for-malmente inedita, è latrice di un significato riconosciuto come valido da tutti gli spetta-tori, perché corrispondente ad un sistema di valori in cui essi si riconoscono. L’enunciatoesprime una verità propria della ‘saggezza popolare’, del ‘senso comune’. Alcuni accorgi-menti ritmici e fonici fanno sì che l’attenzione del pubblico si focalizzi sulla sentenza e, inparticolare, sui due elementi principali della proposizione, il concetto di arduo e l’azionedi trovare, che acquistano maggiore significato nel momento in cui sono specificati dal-l’oggetto parente (scil. di un povero). La sentenza, infatti, si divide tra la fine di un verso el’inizio del successivo, due posizioni di rilievo, dando luogo a un enjambement e conclu-dendosi con la cesura pentemimere del secondo verso. Le due parole iniziali della sen-tenza, öÚÁÔÓ e ÂñÚÂÖÓ, poi, risultano parzialmente assonanti e consonanti (vocalismo e ini-ziale, consonante interna Ú, consonante Ó finale).
Un esempio simile al precedente, ed anzi perfino più ricco, è dato da Asp. 20 s. ÛÙÚ·ÙÈ-ÒÙ–, ™ÌÈÎÚ›ÓË, ÛˆÙËÚ›·˜/ öÛÙ\ öÚÁÔÓ ÂñÚÂÖÓ ÚfiÊ·ÛÈÓ, çϤıÚÔ˘ ‰\ ÂûÔÚÔÓ.1 In questo ca-so, oltre al ripetersi dell’assonanza/consonanza tra öÚÁÔÓ ed ÂñÚÂÖÓ, sono compresenti di-versi fenomeni. Già l’utilizzo del termine öÚÁÔÓ si presta a qualche considerazione: esso èqui utilizzato in un’accezione metaforica, col senso di “compito difficile, arduo”, deri-vante da quello letterale di “risultato di un’azione”. òEÚÁ·, in greco, però, non sempre so-no azioni qualunque: spesso sono imprese belliche.2 Come non cogliere, quindi, l’amaraironia di Davo? Questi riferisce alla salvezza, spesso difficile per chi combatte, un terminesemanticamente legato al concetto di guerra, producendo pertanto un ossimoro che siconfigura come secondo livello interpretativo, subito dopo quello letterale: in guerra lavera impresa eroica, l’autentica prodezza, non la si compie combattendo, ma riuscendo asalvarsi. Strategica e meditata risulta poi la collocazione delle parole all’interno dei dueversi. L’esordio è costituito dal termine ÛÙÚ·ÙÈÒÙ–: si tratta del soggetto logico, anche senon grammaticale, della frase, e come tale non solo non potrebbe essere eliminato senzache la sentenza perda completamente o quasi di significato (che sia arduo salvarsi ma fa-cile morire, detto in generale e senza alcun riferimento a un contesto specifico, è un con-cetto troppo vago per risultare significativo), ma è anche posto in evidenza da Menandroall’inizio della sentenza. Va inoltre notato il perfetto parallelismo con il quale viene co-struito il seguito della battuta:
per procurare un parente alla ragazza, dato che trovare qualcuno disposto a dichiararsi legato a un povero da vinco-li di parentela è impresa ardua.
1 Sebbene il senso della battuta di Davo non sia in discussione, dal punto di vista testuale c’è da osservare che lagrafia ÛÙÚ·ÙÈÒÙ– è emendamento di J. M. Edmonds, The Fragments of Attic Comedy, Leiden, 1957-61, fr. 76a, ripropo-sto da C. Austin (ed.), Menandri Aspis et Samia, voll. i-ii, Berlin 1969-1970, ad. loc.; la congettura è stata confermata dalPSI 126, cfr. C. Austin, Comicorum Graecorum Fragmenta in Papyris Reperta, Berolini et Novi Eboraci 1973, fr. 109, 20 edaccolta tanto da Sandbach, cit., quanto da Arnott, cit. I manoscritti di Stobeo (4, 12, 6 H.) riportano però la formaÛÙÚ·ÙÈÒÙËÓ, mentre ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ è la lezione del papiro Bodmer 26 (cfr. Arnott i, cit., p. 14).
2 A titolo esemplificativo, LSJ citano una serie di passi, omerici (Il. 4, 175; 4, 470; 4, 539; 13, 366 etc.) e non (Aristoph.,Thesm. 414; Plat., Menex. 241c etc.).
12. menandro 225
La precisa corrispondenza degli elementi della prima metà e della seconda metà del-l’enunciato aiutano lo spettatore ad assimilare la proporzione salvezza: improbabile = mor-te: probabile e permettono alla sentenza di essere riconoscibile come tale, essendo il pa-rallelismo uno degli aspetti formali che conferiscono a un’espressione valore sapienziale.Dal punto di vista fonico, notiamo la presenza di due serie allitteranti, una in sibilante,ÛÙÚ·ÙÈÒÙ–, ™ÌÈÎÚ›ÓË, ÛˆÙËÚ›·˜, ed una in vocale e, öÛÙ\ öÚÁÔÓ ÂñÚÂÖÓ […] ÂûÔÚÔÓ.
– Georg. fr. 1, 4 s. ηd Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘ Âéıf˜ ï Ùe ÙÚÈ‚ÒÓÈÔÓ/ ö¯ˆÓ ηÏÂÖÙ·È, ÎiÓ à‰ÈÎÔ‡ÌÂ-ÓÔ˜ Ù‡¯–. Il fulcro semantico della sentenza è costituito dall’opposizione tra Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘e à‰ÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˜. La parola Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘ è vocabolo quasi ‘tecnico’ della commedia greca: in-dicando una tipologia di persona infida, metonimicamente e metaforicamente le indivi-dua tutte. Che un povero (cioè un individuo socialmente penalizzato) venga dunque con-siderato un sicofante è di per sé argomento ‘patetico’ ed emotivamente coinvolgente;diventa paradossale e causa di indignazione quando si precisa che colui che viene defini-to in modo negativo è in realtà l’à‰ÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˜, colui che ha patito l’ingiustizia. Altro con-cetto semanticamente importante è quello espresso da Ùe ÙÚÈ‚ÒÓÈÔÓ ö¯ˆÓ. In questa se-conda metonimia, in cui l’atto di indossare un mantellaccio significa povertà, è racchiusotutto il senso morale della sentenza, quello più profondo: “non importa chi tu sia o cometu viva: se non puoi permetterti vesti di valore allora non potrai mai godere di prestigiosociale, di credito, di fiducia e, in definitiva, non potrai ottenere giustizia, perché non seiun cittadino come gli altri o, per meglio dire, non sei affatto un cittadino”. Se fonicamen-te non ci sono rilievi particolari da fare, possiamo notare che sul piano ritmico la senten-za costituisce un’unità metrica a sé stante (in questo caso due versi). Inoltre è possibile in-dividuare una disposizione chiastica così strutturata:
La tabella evidenzia due tipi di parallelismo: lo schema chiastico complemento/predica-to-predicato/complemento e la collocazione antitetica dei due concetti chiave,Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘ e à‰ÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˜. Il termine Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘ è inoltre accostato, quasi come un lem-ma, a quella che, nell’ambito della sentenza, ne è l’interpretamentum: Û˘ÎÔÊ¿ÓÙË˜Ø ï ÙeÙÚÈ‚ÒÓÈÔÓ ö¯ˆÓ.
– Georg. fr. 2 Ùe Ùɘ Ù‡¯Ë˜ ÁaÚ ®ÂÜÌ· ÌÂÙ·›ÙÂÈ Ù·¯‡.1 La parola ®ÂÜÌ·, letteralmen-
1 Come ammette lo stesso Arnott i, cit., pp. 104 ss., la perdita delle scene di apertura del °ÂˆÚÁfi˜ impedisce difarci un’idea precisa delle premesse dalle quali prende il via la narrazione. Tutto ciò che sappiamo è che, circa nove
soggetto predic. nom.(copula +sostantivo neutro) compl. di specif.
ÂñÚÂÖÓ ÚfiÊ·ÛÈÓ öÛÙ\ öÚÁÔÓ ÛˆÙËÚ›·˜
(ÂñÚÂÖÓ ÚfiÊ·ÛÈÓ) (öÛÙÈ) ‰\ ÂûÔÚÔÓ çϤıÚÔ˘
ηd Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘(complemento predicativo
del soggetto)
[Âéıf˜] ï Ùe ÙÚÈ‚ÒÓÈÔÓ ö¯ˆÓ(predicato verbale + complemento oggetto,
che però equivalgono logicamente al solo predicato nominale essere poveri)
ηÏÂÖÙ·È(predicato verbale)
ÎiÓ à‰ÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù‡¯–(prop. concessiva)
226 silvio schirru
te, può essere resa con “corrente, flusso”, anche se qui il termine è evidentemente ado-perato come metafora indicante un procedere di cose astratto.1 Sul piano degli espedien-ti fonici va messo in rilievo che la sentenza è introdotta da una serie allitterante in Ù (ÙeÙɘ Ù‡¯Ë˜) e che Ù‡¯Ë˜ e Ù·¯‡, i due termini che con la loro contrapposizione costitui-scono l’essenza dell’aforisma, sono allitteranti, consonanti e metricamente equivalenti(sequenza giambica). Tutto ciò concorre a attirare l’attenzione dell’uditorio: la sentenza(di un unico verso, quindi facilmente ‘proverbializzabile’2) viene introdotta da un’allitte-razione e i due termini chiave sono messi in evidenza da diversi richiami sonori. Se poi siconsidera anche la consueta disposizione chiastica dell’enunciato, che colloca i terminichiave in apertura e in chiusura tanto del verso quanto della sentenza,
(Ùe) Ùɘ Ù‡¯Ë˜ ÁaÚ ®ÂÜÌ·(compl. di specificazione) (soggetto)ÌÂÙ·›ÙÂÈ Ù·¯‡(predicato verbale) (compl. di modo)
risulta praticamente inevitabile associare inconsciamente Ù‡¯Ë˜ e Ù·¯‡, ciò che dava alpubblico l’impressione che la Ù‡¯Ë fosse Ù·¯ÂÖ· per sua natura immanente, intrinseca,conferendo pertanto all’espressione proverbiale anche una legittimazione e una confer-ma irrazionali, oltre a quelle dettate dal buon senso.
2. 2. Contenuto delle sentenzeLe commedie di Menandro rappresentano un microcosmo popolato da personaggi e vi-cende che trovano la loro origine nel contesto storico e sociale di Atene nel periodo com-preso tra la metà del iv sec. a. C. e i primi anni del iii. Le violente repressioni delle rivol-te tra il 303 e il 295, gli assedi tra il 304 e il 296-4, le carestie fra il 320 e il 290 sono in partecausa di fenomeni che hanno sul tessuto sociale un impatto devastante: il divario semprecrescente tra ricchi e poveri, il contrasto tra gli abitanti della città e i campagnoli, la crisieconomica ormai costante e un generale senso di insicurezza e instabilità, che inaspriscei conflitti sociali e generazionali.3 Le conseguenze di questo stato di cose sul teatro me-nandreo sono due: la prima è che il pubblico delle sue commedie è costituito in gran par-
mesi prima degli eventi descritti nella commedia, un giovane ha messo incinta una donna libera. Per motivi che nonsono chiari, ha fino ad ora evitato di ‘regolarizzare’ la propria posizione. Di ritorno da un viaggio d’affari a Corinto,il ragazzo apprende che il padre gli ha combinato un matrimonio con la figlia che l’uomo ha avuto dalla seconda mo-glie. Sappiamo anche che la prima ragazza, quella che aspetta il bambino, è vicina di casa della famiglia del giovane,e che ha un fratello di nome Gorgia. Quest’ultimo, presumibilmente a causa della sua povertà, lavora al servizio diun certo Clineto, il ÁˆÚÁfi˜ dal quale la commedia trae il titolo.
1 Gomme-Sandbach, cit., pp. 116 s. fanno notare come il termine ®ÂÜÌ· non abbia altre occorrenze nella com-media nuova, e sospettano che Menandro abbia qui volutamente creato, tramite l’utilizzo di un termine inusuale, unaforisma dall’effetto straniante. È possibile, in effetti, che qui Menandro abbia utilizzato un tecnicismo di matrice agri-cola per ottenere un effetto comico; è anche vero, però, che vi sono diversi esempi di ®ÂÜÌ·, nel greco classico, usa-to in senso metaforico (cfr. ad esempio Aesch. Prom. 139, Hdt. 2,20,24, Xenoph. 4,2,11 etc.). In ogni caso non è un ter-mine usato casualmente, e perché ciò sia evidente Menandro lo inserisce tra la cesura pentemimere e quellaeftemimere.
2 La fortuna dell’aforisma menandreo è testimoniata dal gran numero di citazioni (cfr. Arnott i, pp. 126 s.): ol-tre che da Stob. 4,41,28, che nomina la commedia di appartenenza, il passo è menzionato anche da Schol. B Hom. ¢396 Dindorf, da Etym. M. p. 685, 38 Gaisford, da AG i 333.31 Cramer, tutti senza la citazione della commedia di Me-nandro, nonché da Schol. Soph. OT 1191 Papageorgiou e da Schol. Eur. Or. 343 vol. I p. 135 Schwartz, che non fanno cen-no nemmeno a Menandro, ma si veda pure Elias (vi sec.) nei suoi commenti a Aristot. Categor. in Porphyr. Isagog. ead C. A.G. xviii/1 pp. 45 e 252.
3 Cfr. W. G. Arnott, Moral Values in Menander, «Philologus», 125, 1981, pp. 215-227.
12. menandro 227
te da cittadini della classe media, composta in prevalenza da quei commercianti che era-no riusciti a trarre il maggior profitto dalla situazione contingente.1 La seconda è che ilpubblico della commedia nuova si reca a teatro non più alla ricerca di un momento di ri-flessione politica, per quanto accompagnato dall’ironia (come avveniva con Aristofane),né di un dibattito su temi etici o religiosi (come nel caso della tragedia classica), bensì de-sideroso di evasione, di uno spettacolo che appagasse sulla scena quel bisogno di una vi-ta serena e pacifica che era impossibile mettere in pratica nel mondo reale.2 In Menandrovengono raccontate vicende i cui protagonisti sono i suoi stessi spettatori, per quanto de-formati dalla lente della finzione, che però sulla scena affrontano situazioni lontanissimedalla realtà del mondo esterno: questioni di amore e passione, di debiti e crediti, di parentiperduti e ritrovati dominano le esistenze dei personaggi e si concludono immancabil-mente con la riconciliazione e l’appianamento di ogni contrasto. Ma anche a un universoidealizzato come questo è sotteso un sistema di valori nel quale il pubblico si riconosce-va e che, pur non potendo trovare applicazione nella realtà, è pienamente operante nelmicrocosmo menandreo, ciò che contribuiva a soddisfare nello spettatore quel desideriodi sicurezza che, fuori dal teatro, restava inappagato. In un simile contesto, le espressioniproverbiali, sintesi per antonomasia del sistema di valori della società che li produce, han-no enorme importanza, giacché permettono a Menandro di alludere con pennellate bre-vi ed efficaci al background sociale delle sue commedie e favoriscono l’identificazione del-lo spettatore con la persona che calca la scena. Le sentenze esprimono il senso di caducitàche investe, per l’ateniese contemporaneo, ogni sfera dell’esistenza;3 danno voce ai con-flitti sociali e alla disparità tra ricchi e poveri;4 affrontano il dramma della guerra e la ras-segnazione che da esso deriva;5 ma ricordano anche che è importante che l’uomo, nono-stante la Sorte possa essere imprevedibile, abbia sempre una certa misura in tutto ciò chefa e tragga insegnamento anche dalle esperienze negative.6
1 Soprattutto dopo la costituzione censitaria del 322, allorché oltre dodicimila persone vennero private della cit-tadinanza; tale perdita implicava il mancato ricevimento dei contributi statali, tra cui il ıˆÚÈÎfiÓ, sempre che que-st’ultimo ancora esistesse: cfr. Gomme-Sandbach, cit., p. 22 n. 1 e G. Bodei Giglioni, Menandro o la politica della con-vivenza, Como, 1984, pp. 15 ss.
2 Cfr. D. Del Corno, Vita cittadina e commedia borghese, in Storia e Civiltà dei Greci, diretta da R. Bianchi Bandi-nelli, t. 5, Milano, 1979, pp. 265-298.
3 Per esempio nÓ Ôî ıÂÔd ÊÈÏÔÜÛÈÓ, àÔıÓ“ÛÎÂÈ Ó¤Ô˜ (Dis Ex. fr. 4); Ùe Ùɘ Ù‡¯Ë˜/ ô‰ËÏÔÓ (Asp. 248 s.); Ùe Ùɘ Ù‡¯Ë˜ÁaÚ ®ÂÜÌ· ÌÂÙ·›ÙÂÈ Ù·¯‡ (Georg. fr. 2); fiÏÏ\ âÛÙdÓ öÚÁ\ ôÈÛÙ·, ·È‰›ÔÓ, Ù‡¯Ë˜ (Per. 802); Ù˘ÊÏfiÓ Á ηd ‰‡ÛÙËÓfiÓâÛÙÈÓ ì T‡¯Ë (Fab. inc. fr. 682 K.-A.).
4 Alcuni esempi: ÔéıÂd˜ âÏÔ‡ÙËÛÂÓ Ù·¯¤ˆ˜ ‰›Î·ÈÔ˜ üÓ (Colax 43); öÚÁÔÓ ÂñÚÂÖÓ Û˘ÁÁÂÓÉ/ ¤ÓËÙfi˜ âÛÙÈÓ (Adelph. ‚\fr. 9, 1 s. K.-A.); ÙáÓ ‰\ \¿ÓÙˆÓ úÛı\ ¬ÙÈ/ Ùˆ¯e˜ à‰ÈÎËı›˜ âÛÙÈ ‰˘ÛÎÔÏÒÙ·ÙÔÓ (Dysc. 295 s.); ‰‡Ó·Ù·È Ùe ÏÔ˘ÙÂÖÓ Î·dÊÈÏ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈÂÖÓ (Halieus, fr. 22 K.-A.); ï ÔÏf˜ ôÎÚ·ÙÔ˜ çÏ›Á\ àÓ·Áο˙ÂÈ ÊÚÔÓÂÖÓ (Fab. inc. fr. 735 K.-A.).
5 Con constatazioni fatalistiche, come il già visto ÛÙÚ·ÙÈÒÙ–, ™ÌÈÎÚ›ÓË, ÛˆÙËÚ›·˜/ öÛÙ\ öÚÁÔÓ ÂñÚÂÖÓ ÚfiÊ·ÛÈÓ,çϤıÚÔ˘ ‰\ ÂûÔÚÔÓ (Asp. 20 s.).
6 Per esempio ÙáÓ ‰’ àÓ·Áη›ˆÓ ϤÁÂÈÓ/Ï›ÔÓ\] ÔéÎ àÓ‰Úe˜ ÓÔÌ›˙ˆ (Dys. 740 s.), Ùa ηÎa ·È‰Â‡ÂÈÓ ÌfiÓ·/ â›ÛÙ·ı\ìÌĘ, ó˜ öÔÈΠ(Dys. 699 s).
composto in carattere dante monotype dallafabrizio serra editore, pisa · roma.
stampato e rilegato nellatipografia di agnano, agnano pisano (pisa) .
*
Giugno 2010
(cz3/fg22)
Tutte le riviste Online e le pubblicazioni delle nostre case editrici(riviste, collane, varia, ecc.) possono essere ricercate bibliograficamente e richieste
(sottoscrizioni di abbonamenti, ordini di volumi, ecc.) presso il sito Internet:
www.libraweb.net
Per ricevere, tramite E-mail, periodicamente, la nostra newsletter/alert con l’elencodelle novità e delle opere in preparazione, Vi invitiamo a sottoscriverla presso il nostro sito
Internet o a trasmettere i Vostri dati (Nominativo e indirizzo E-mail) all’indirizzo:
*
Computerized search operations allow bibliographical retrieval of the Publishers’ works(Online journals, journals subscriptions, orders for individual issues, series, books, etc.)
through the Internet website:
www.libraweb.net
If you wish to receive, by E-mail, our newsletter/alert with periodic informationon the list of new and forthcoming publications, you are kindly invited to subscribe it at our
web-site or to send your details (Name and E-mail address) to the following address: