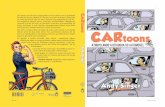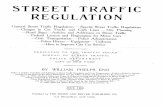Influssi nordici nelle Stregonerie di Salvator Rosa
Transcript of Influssi nordici nelle Stregonerie di Salvator Rosa
a cura di
Sybille Ebert-SchiffererHelen LangdonCaterina Volpi
Campisano Editore
BIBLIOTHECA HERTZIANAMAX-PLANCK-INSTITUTFÜR KUNSTGESCHICHTE
Salvator Rosae il suo tempo1615-1673
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMAFACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Indice
pag. ! PrefazioneSybille Ebert-Schifferer, Helen Langdon, Caterina Volpi
TAVOLE A COLORI
" Introduzione. Salvator Rosa pittore famosoCaterina Volpi
SALVATOR ROSA DA NAPOLI A ROMA
#$ Salvator Rosa: note in margine alla formazione a NapoliCaterina Volpi
%% Freedom in Friendship: Salvator Rosa and the Accademia dei PercossiAlexandra Hoare
&% Friendly Disagreements: Salvator Rosa and Lorenzo Lippi in seventeenth-century FlorenceEva Struhal
!$ Fortuna di Salvator Rosa nella letteratura del tempoFloriana Conte
'$ Salvator Rosa a Firenze: la collezione GeriniMariateresa Di Dedda
$$ Salvator Rosa, i soci dell’Accademia pisana degli Stravaganti equella volterrana dei Sepolti: amicizie e relazioni artisticheFranco Paliaga
"# Salvator Rosa a Milano: le ragioni di una presenzaAndrea Spiriti
#(% Salvator Rosa, i Colonna e la Commedia dell’arte: il mondo del teatro dipinto e recitato nella Roma del SeicentoNatalia Gozzano
SALVATOR ROSA INVENTORE DI TEMI E SPERIMENTATORE DI GENERI
#)! ‘Poor Painting’ and the Fortunes of Salvator RosaWendy Wassyng Roworth
#%" Influssi nordici nelle Stregonerie di Salvator RosaStefania Macioce, Tania De Nile
#!" Inquisizione, esorcismi e caccia alle streghe a Pisa alla metà del Seicento. Genesi e collezionismo delle Stregonerie di Salvator RosaSara Fabbri
#'" Un soggetto biblico di Salvator Rosa: il Sacrificio della figlia di JefteMarco Chiarini
#$! «L’unico aborto dei suoi pennelli»: Salvator Rosa’s AltarpiecesXavier F. Salomon
#"" Cold Anger: Salvator Rosa as a painter of battle piecesOliver Tostmann
)#" I ritratti di filosofi antichi: nuove considerazioni intorno a Salvator Rosa e il soggetto ritrovato di un dipinto di Domenico FettiMario Epifani
)%! «e Democrito caccia di Parnaso i poeti che sian savi». Salvator Rosa e il tema del Democritus cogitans tra Tasso e AccettoFrancesco Lofano
)&% Poised for Flight: Levitating Figures and the Resurrection Theme in Rosa’s ŒuvreEckhard Leuschner
)!! «Questa signor mio è la ruffiana delle pitture»: Salvator Rosa e l’invenzione di un nuovo modello di corniceAdriano Amendola
SALVATOR ROSA E LA GRAFICA
)'" Alcune osservazioni sulla necessità di un nuovo catalogo dei disegni di Salvator RosaAndreas Stolzenburg
)*" Il tempo infante: un disegno poetico-allegorico di Salvator RosaSybille Ebert-Schifferer
)"" I Sandrart e le incisioni di Salvator Rosa, Pietro Testa, Giovanni BenedettoCastiglione: una lettura tardo-seicentescaCecilia Mazzetti di Pietralata
%#! La fortuna di Salvator Rosa nel Settecento: la raccolta di incisioni di Carlo AntoniniMaria Celeste Cola
INTORNO A SALVATOR ROSA
%%! Salvator Rosa and Herman van SwaneveltSusan Russell
%!$ Jacques Courtois et Salvator RosaNathalie Lallemand-Buyssens
%$% Salvator Rosa e il mercato dell’arte a Roma: dinamiche e strategie commercialiLoredana Lorizzo
%*% Salvator Rosa per casa Chigi e nuovi contributi su Francesco RosaFrancesco Petrucci
%"$ Committenza e collezionismo nella Roma chigiana: il cardinale Giacomo Filippo Nini (Siena, #')* - Roma, #'*()Daniela Simone
&(" «Nella Trinità de’ Monti che vuol dire nella meglior aria di Roma»: il quartiere di Salvator Rosa e i suoi abitanti. Precisazioni e qualche novitàLaura Bartoni
&#" Il monumento funebre di Salvator Rosa in S. Maria degli Angeli. Precisazioni documentarie sull’attività di Bernardo Fioriti e Filippo CarcaniJacopo Curzietti
&)! Lunette a “paesi” di Augusto Rosa nel Chiostro di Sant’Andrea delle Fratte a RomaIlaria Miarelli Mariani
&%! Indice dei nomi
Influssi nordici nelle Stregonerie di Salvator RosaStefania Macioce -Tania De Nile
L’apporto delle raffigurazioni diabolico-stregonesche di ambito nordico sul-le Magherie e gli Incantesimi di Salvator Rosa è stato più volte sottolineato daautorevoli studiosi, tra i quali Helen Langdon 1 e Charles Zika 2. Questi hannoevidenziato il ruolo fondamentale che le stampe nordiche di Altdorfer e Bal-dung Grien hanno avuto a Firenze in relazione alla nascita di uno spiccato in-teresse nei confronti di tali tematiche da parte di Jacopo Ligozzi, Jacques Cal-lot e, soprattutto, Filippo Napoletano, i quali, a loro volta, vengono a costitui-re modelli di riferimento precipuo per Salvator Rosa 3. L’attenzione dell’artistanei confronti di simili soggetti trarrebbe spunto, inoltre, dalle opere dell’olan-dese Leonaert Bramer e del fiammingo Jacob Swanenburgh presenti a Napoli.
Degno di nota è che Zika, partendo da una riflessione della Langdon relati-va alla dipendenza del gruppo centrale della Stregoneria del Rosa a Londra 4
(fig. !, tav. VIII) dall’incisione con La partenza per il sabbat (!"!#) di Hans Bal-dung Grien5, sottolinei inoltre il marcato influsso de La preparazione al sabbatdi Jacques de Gheyn II 6, la cui figura centrale assisa fungerebbe da modelloper la donna intenta a preparare pozioni nella Stregoneria londinese.
Partendo da questa indicazione risulta quindi oltremodo interessante verifi-care le dipendenze e le relazioni tra Salvator Rosa e Jacques de Gheyn II, sug-gerendo tangenze e similitudini anche con altri artisti nordici.
Salvator Rosa e Jacques de Gheyn II: proposte di studio e confronti iconografici
Wendy Roworth 7 per prima riconosce l’importanza per il quadro londinesedi Rosa dell’incisione su disegno di Jacques de Gheyn II 8 relativa a La prepara-zione al sabbat, realizzata probabilmente da Andries Stock e pubblicata da Ni-colaes de Clerck tra il !$#% e il !$!# (fig. &). La scena si svolge in un anfrattocaratterizzato da una natura ostile ove campeggia un unico grande albero spo-glio. Al centro della scena tre donne: una, obesa e assisa, e altre due in piedi;di queste soltanto una è vestita, particolare che indurrebbe ad identificarla conuna vittima che sta per essere introdotta alle arti occulte proprio dalla donnanuda che, a sua volta, indica accanto a lei un libro aperto posto sopra un te-schio. Intorno compaiono rettili e altre creature fantastiche nate dalla fusionetra anfibi ed esseri umani.
Nel dipinto londinese di Rosa la figura centrale (fig. 'a) riprende la posa
!. Salvator Rosa, Stregoneria, Londra, National Gallery&. Andries Stock (?) da Jacques de Gheyn II, La preparazione al sabbat, !$#%-!$!#
!(# STEFANIA MACIOCE, TANIA DE NILE
INFLUSSI NORDICI NELLE STREGONERIE DI SALVATOR ROSA !(!
della strega assisa al centro dell’incisione di De Gheyn che si mostra seduta edi profilo, col viso rivolto alle compagne dietro di lei, cosicché ne scorgiamosolo la nuca. La strega brandisce ossa umane con la mano sinistra e tiene tra legambe un recipiente, particolare visibile in numerosi prototipi figurativi rin-tracciabili nei trattati di demonologia del tempo 9. Anche nel quadro di Rosa ilpunto focale è rappresentato dalla donna dai capelli arruffati che, seduta, è in-tenta a mescolare in un recipiente gli ingredienti per le sue pozioni: con la ma-no destra la strega ha afferrato un ammasso di viscere umane e con la sinistradelle ossa, esattamente come nell’incisione di De Gheyn10. Un altro dettagliodel fiammingo, vale a dire il teschio su cui poggia un libro aperto ai piedi dellafigura assisa, compare, solo in parte variato, nell’ovale su ardesia con Stregone-ria 11 attribuito a Rosa: tra le gambe del monaco al centro si vede un libro chiu-so su cui poggia un teschio sormontato da uno specchio12. L’animale dall’enor-me grugno che si trascina verso il centro della scena ricorda, a sua volta, tipi-che figure dal naso allungato frequenti in ambito fiammingo, di cui un esem-pio si trova nel foglio di De Gheyn con Studi di stregoneria e creature mostruo-se oggi a Francoforte 13.
Le tangenze sin qui individuate evidenziano una similarità tra le scelte ico-nografiche di De Gheyn e le creature ideate da Salvator Rosa 14, com’è possibi-le notare anche in altri esempi. Profonde somiglianze tra i due artisti emergo-no, infatti, dal confronto tra la figura mostruosa con bocca spalancata e unasorta di becco ad uncino, visibile su un foglio attribuito a De Gheyn in colle-zione privata inglese 15, e l’orrido essere contro cui combatte sant’Antonio nelquadro di Rosa a Palazzo Pitti 16. Nello stesso disegno, inoltre, compare un vol-to di vecchio dai lunghi baffi che risulta essere simile ad una figura visibile tracrani di bue in un’incisione siglata di Rosa 17; in essa sono rappresentati altridue studi di crani bovini 18 che potrebbero essere letti sia in chiave naturalisti-ca, sia come studi da utilizzare in scene di stregoneria ed incantesimo, comenel magnifico quadro con Saul e la strega di Endor del Louvre 19.
Principali protagonisti delle Stregonerie di Salvator Rosa sono i giganteschischeletri di animali dipendenti in larghissima parte dalla famosa serie disegna-ta da Filippo Napoletano per Johannes Faber 20. Scheletri di animali si riscon-trano anche in De Gheyn, il quale si era cimentato in questo tipo di rappresen-tazioni prendendo spunto da alcuni modelli conservati nel teatro d’anatomiadi Leida 21: ne è documento uno Studio con scheletro di roditore conservato nel-la Printroom di Copenaghen 22. Tali studi venivano poi modificati fantasiosa-mente per dare vita a forme metamorfiche, come si evince nel particolarissimofoglio della Christ Church di Oxford 23, ove appare l’enorme scheletro di unacreatura metà volatile e metà uomo. Scheletri di animali, del resto, erano asso-lutamente comuni e assai diffusi all’interno dei contesti diabolico-stregone-schi, sin dalle opere di Hieronymus Bosch 24, ma in precedenza non è dato ri-scontrare la violenza, la forza che questi esseri comunicano nel contesto in esa-me. Il più delle volte, infatti, tali figurazioni risultano statiche e semplicementeallusive ad un generico senso di morte, intesa come assenza di energia vitale,mentre nei citati esempi di De Gheyn, così come nel Saul e la strega di Endor e
!(& STEFANIA MACIOCE, TANIA DE NILE
nella Stregoneria Corsini 25 di Rosa, ciò che più colpisce è il loro essere real-mente temibili.
Le somiglianze iconografiche tra i due artisti evidenziano una consonanzaideativa riferibile non soltanto al libero dispiegamento della fantasia legata alleimmagini del mondo sovrannaturale, ma anche alla volontà di focalizzare l’at-tenzione su tematiche specifiche, rapportabili ai rispettivi contesti operativi.Lo stile personalissimo sviluppato da De Gheyn attraverso una proliferazionedi dettagli sembra riflettere, infatti, una specifica congiuntura culturale. Vannosegnalate, ad esempio, le frequenti discussioni in materia che videro protago-nisti alcuni tra i professori di Leida con i quali De Gheyn collaborava, specieHeurnius e Pauw, che parteciparono ad un processo di stregoneria nel !"%( 26.La fonte principale dell’artista è però verosimilmente da individuare nella tra-duzione olandese del testo di Reginal Scott, The Discoverie of Witchcraft, rea-lizzata sotto gli auspici dei membri della facoltà di medicina dell’Università diLeiden ad opera di Thomas Basson 27 e pubblicata nel !$#% dal figlio di questiGossen, per l’appunto cognato di De Gheyn. Secondo la gran parte degli stu-diosi La preparazione al sabbat non sarebbe una semplice opera di fantasia,bensì la prova della profonda conoscenza da parte dell’artista della letteraturaspecialistica 28, se non, addirittura, di una sua partecipazione attiva alle prati-che magiche 29. A nostro avviso le rappresentazioni di De Gheyn, pur non po-tendo essere considerate traduzioni in immagini di trattati di demonologia, sinutrono ampiamente degli attributi suggeriti dalla letteratura del tempo e vi siriscontra la volontà dell’artista di esprimere la sua originalità nella trattazionedella tematica, che diviene pretesto per dispiegare una fantasia visionaria al-l’interno di opere il cui soggetto era di grande interesse all’epoca 30.
Per quanto le tangenze sin qui rilevate non permettano una diretta conse-quenzialità tra i due artisti, essendo necessario tenere conto dei diversi suppor-ti ove si rintracciano le affascinanti ideazioni, si può sottolineare comunquequanto tali invenzioni nordiche fossero diffuse: la conoscenza delle opere diJacques de Gheyn II nel contesto fiorentino – ove si inserisce il nucleo princi-pale di opere di Rosa intorno a questi temi – può essere chiarita infatti facen-do riferimento a diversi possibili canali, diretti ed indiretti.
In seguito al matrimonio tra Cosimo II e Maria Maddalena d’Austria arriva-no a Firenze molti importanti disegni ed incisioni d’area nordica e, come po-sto in rilievo dalla critica, all’interno della città esisteva uno spiccato interessenei confronti di rappresentazioni di inferni e sabba: lo si evince a sufficienzadagli inventari del principe Ferdinando di Toscana del !'!) 31. È degno di rilie-vo inoltre constatare che De Gheyn risulta essere uno dei principali modelliiconografici di Jacques Callot 32 e tale dipendenza non riguarda solamente le fi-gurazioni mostruose, ma soprattutto i disegni con esercizi militari che deriva-no dalle ben note e imitate incisioni dell’artista fiammingo realizzate per illu-strare il trattato Maniement d’armes d’arquebuses, mousquetz et piques 33, editoin varie lingue intorno al !$#*, proprio durante il soggiorno italiano di Callot 34.Pe ral tro Carlo Stefano Salerno sottolinea il rapporto iconografico tra un dise-gno di De Gheyn, l’Orfeo agli Inferi di Brumswick 35, e il Dante e Vir gilio agli
Inferi 36 di Filippo Napoletano conservato agli Uffizi, ove compare in primopiano una gigantesca aragosta, proprio come nella parte sinistra del citato di-segno realizzato dal fiammingo e conservato a Francoforte 37.
È dunque plausibile che se alcuni tra i principali modelli di riferimento diRosa, come Jacques Callot e Filippo Napoletano 38, dipendono dall’immagina-rio di Jacques de Gheyn II, lo stesso Rosa abbia potuto prendere visione, diret-tamente o indirettamente, delle opere di stregoneria prodotte dal fiammingo,specie nel vitale ambiente fiorentino ove gli artisti utilizzavano evidentementemodelli iconografici comuni.
Jacob Swanenburgh e il ruolo dell’ambiente napoletano
Oltre al contesto fiorentino, anche l’ambiente napoletano da cui il Rosa pro-veniva deve aver favorito l’approccio del pittore alle tematiche diabolico-stre-gonesche 39. Il gusto per il macabro, il magico, il mostruoso, trova ampia tratta-zione nella pittura di Filippo Napoletano e Monsù Desiderio, entrambi marca-tamente influenzati dalle rappresentazioni infernali del citato Jacob Swanen-burgh, su cui ora è opportuno ritornare.
Nato a Leida nel !"'!, dopo un periodo di formazione a Venezia, l’artistasposa una donna napoletana vivendo nella città partenopea dal !"%* al !$!'.
INFLUSSI NORDICI NELLE STREGONERIE DI SALVATOR ROSA !()
). Jacob Swanenburgh, Inferno, Leida, Stedelijk Museum de Lakenhal
!(( STEFANIA MACIOCE, TANIA DE NILE
Per molto tempo opere di Filippo Napoletano sono state attribuite all’artistafiammingo 40, tra cui il celebre Enea e la Sibilla agli Inferi della Galleria DoriaPamphilj 41 e l’Inferno di Leida 42 (fig. )), alternativamente assegnato a Swa-nenburgh o a Vincent Malo 43. Per l’Inferno di Besançon è stata addiritturaipotizzata la possibilità di una collaborazione tra Monsù Desiderio, autoredelle quinte architettoniche e scenografiche, e Swanenburgh, che avrebbe in-vece realizzato le creature mostruose 44. Quanto detto induce a ritenere cheanche Salvator Rosa, come gli altri due artisti, sia entrato in contatto con lerappresentazioni del fiammingo, subendone il fascino ed imitandone le rap-presentazioni orrorifiche ampiamente dipendenti dall’iconografia di Hie-ronymus Bosch.
Risulta oltremodo interessante in questa sede ricordare che Swanenburgh,proprio a causa delle sue raffigurazioni, cadde vittima del Sant’Uffizio: egli do-vette presentarsi in tribunale il % ottobre !$#*, avendo esposto nella sua botte-ga un quadro «[...] dove ci sono pittate molte donne quale dicono che sianoJanare che fanno diverse attioni con figure ancora de demonii [...].» 45.
Negli atti del processo l’artista racconta che un ignoto gentiluomo si erapresentato nella sua bottega per chiedergli di realizzare due copie di una teladove erano rappresentati fatti legati al Noce di Benevento. In quell’occasioneSwanenburgh ammette di aver aggiunto al modello offerto dall’anonimo com-mittente alcuni demoni, ma afferma di averli ripresi da un quadro della Chiesadi Monte Oliveto, oggi Sant’Anna de’ Lombardi. L’aspetto più interessantedella vicenda, che ci fa comprendere anche quanto questo tipo di rappresenta-zioni fosse temuto, è che in tutti i modi l’artista cerca di nascondere l’identitàdel committente dell’opera – «il quale gentilhomo io non l’ho più visto ne soche ne sia» 46 – affermando di essersi solo limitato a copiare le figure del qua-dro – «Io non solamente non ho conosciuto alcune donne Janare ma ne menoho inteso dire da alcuno che le Janare faccino simili attioni ma tutto è stata co-pia di quello quadro di tela» 47 – e di aver aggiunto altri demoni ispirandosi adimmagini inserite all’interno di una rappresentazione sacra, giacché solo inquesto caso esse potevano essere tollerate.
La descrizione dettagliata del quadro conferma il ruolo di modello che eglidovette avere anche per Salvator Rosa:
«[...] le tre figure di donne Janare che stando pittate sopra di detto quadro sonodonne Janare le quale vanno per l’aria et cossi quel altra che sta appresso alla terza àmano destra, ch’è una Janara che escie dalla ciminiera sotto la quale vi n’è un’altra cheva ancora per l’aria et quelle tre Janare che stando con le torcie accese in mano chequella di mezzo sta à cavallo sopra di un demonio in forma di dragho [...] et quelledue che sequitano con due torcie accese in mano sopra di animali morti [...]» 48.
Swanenburgh non fu solo un importante modello per Rosa, ma presumibil-mente anche uno dei suoi tramiti d’elezione per la conoscenza di De Gheyn,giacché a Leida questi era amico di Isaac Nicolai Swanenburgh, padre di Ja-cob. È da rilevare inoltre che Willem van Swanenburgh, fratello di Jacob e fa-moso incisore, realizzò un ritratto del cognato di De Gheyn sulla base di un
(. Cornelis Saftleven, Due creature mostruose,Amsterdam,Rijksprentenkabinet
INFLUSSI NORDICI NELLE STREGONERIE DI SALVATOR ROSA !("
disegno di quest’ultimo 49: è ragionevole presumere, dunque, che il fiammingoabbia svolto un ruolo determinante a Napoli nella diffusione di motivi trattidall’opera di De Gheyn 50.
Salvator Rosa e Cornelis Saftleven: un confronto inedito 51
Un’interessante relazione, degna di attento approfondimento, è quella chelega Salvator Rosa a Cornelis Saftleven, definito «HOLLANDVS PICTOR NOCTIVMPHANTASMATVM» nel ritratto inciso da Lucas Vosterman su disegno di Antoonvan Dyck 52.
Caterina Virdis Limentani 53 per prima riconosce l’influsso delle opere diRosa, dai particolari iconografici alle cromie, nella Stregoneria di Saftlevenconservata oggi nel Museo Civico di Padova 54. In effetti vi ritroviamo molte fi-gure presenti nella Stregoneria di Londra, come l’impiccato, lo scheletro, ilcorpo di neonato morto, il particolare dello specchio e del cerchio magico e
!($ STEFANIA MACIOCE, TANIA DE NILE
anche una figura di soldato sdraiato in atto di leggere un testo di pratiche ma-giche 55. La presenza del soldato appare rilevante, giacché, come sottolineatoda Sybille Ebert-Schifferer, la Stregoneria di Londra non è l’unico caso in cuiSalvator Rosa leghi l’immagine del soldato in armatura ad un contesto strego-nesco 56. A detta della Limentani, però, il dipinto di Padova non rappresente-rebbe un sabba, bensì una summa dei mezzi magici a disposizione di chi vuoleporre il proprio controllo sulla terra a scopi malvagi. Nell’opera la maggiorparte delle creature mostruose risente con evidenza dell’ironica verve delle fi-gurine di Callot, che, come già detto, fu una delle fonti principali anche perFilippo Napoletano e Salvator Rosa. La seconda versione de Le Tentazioni diSant’Antonio fu conosciuta e ammirata in ambito nordico soprattutto in segui-to al viaggio di questi nei Paesi Bassi: anche Cornelis Saftleven dovette essernecolpito se, all’interno del suo vasto corpus grafico, troviamo addirittura tre di-segni che si concentrano sulla riproposizione di particolari derivati dalla notaincisione 57. In uno di questi fogli, conservato ad Amsterdam (fig. (), il mo-struoso essere volante visibile nella parte superiore risulta molto simile allacreatura diabolica della citata Tentazione di Sant’Antonio di Rosa.
Un ulteriore confronto iconografico tra i due artisti dimostra l’esistenza diun comune interesse nei confronti di motivi molto in voga in ambito nordico,come, ad esempio, quello della figurina piegata con le braccia a terra che si ri-trova nell’incisione con San Giacomo e il Mago Ermogene (!"$") realizzata daPie ter van der Heyden su un disegno di Pieter Brueghel il Vecchio 58. Tale mo-tivo compare a destra nell’ovato del Rosa più volte citato, dove si vede una fi-gura ricurva con le mani piegate in avanti reggente sulle spalle un grande sche-letro, e un’immagine simile è visibile anche su un foglio con Stregoneria di Saft -leven passato in asta Sotheby’s nel &### 59 (fig. ").
Non siamo a conoscenza di fonti documentarie in grado di motivare una co-noscenza diretta tra i due artisti; ciò nondimeno Baldinucci parla di «ErasmoSaftleven» 60, vale a dire Herman, fratello minore di Cornelis, anch’egli pitto-re 61. Esistono poi diverse tracce che lasciano supporre una conoscenza da par-te di Saftleven delle opere di Salvator Rosa. Lo suggerisce in primis la presenzadi un disegno attribuito a Cornelis e conservato a Darmstadt62, copia della no-ta Humana Fragilitas di Salvator Rosa 63. Di quest’opera, probabilmente realiz-zata intorno al !$"& per Fabio Chigi o per il cardinale Flavio Chigi 64, esiste an-che un disegno preparatorio attribuito allo stesso Rosa e conservato alla Fitz-roy Newdegate Collection nel Warwickshire 65: secondo Schulz questo e non ilquadro dovette essere il modello utilizzato da Saftleven.
È di rilevante interesse constatare che Cornelis sembra aver avuto scambianche con Leonaert Bramer, il quale viene spesso indicato come una delle fon-ti di Rosa a Napoli 66. Bramer si cimentò in rappresentazioni dedicate specifica-tamente alla tematica stregonesca 67 e la critica ha sottolineato le tangenze ico-nografiche tra i due artisti 68; il contatto, però, dovette avvenire probabilmentein Olanda, per cui è da escludere che Saftleven abbia potuto conoscere Rosatramite il noto artista di Delft. È però opportuno sottolineare come la produ-zione diabolico-stregonesca di Cornelis Saftleven risulti fortemente connessa a
". Cornelis Saftleven, Stregoneria, ubicazione attuale sconosciuta$. Cornelis Saftleven, Sabba di streghe, Chicago, Art Institute
INFLUSSI NORDICI NELLE STREGONERIE DI SALVATOR ROSA !('
!(* STEFANIA MACIOCE, TANIA DE NILE
quella di Jacques Callot e di Leonaert Bramer, due delle riconosciute fontinordiche di Salvator Rosa.
Analizzando da vicino alcune opere di Saftleven incentrate sulla rappresen-tazione di sabba o su tentazioni di sant’Antonio si nota una profonda vicinan-za allo spirito dell’artista partenopeo e, all’opposto, un differente approcciorispetto a molti esempi della coeva tradizione fiamminga ed olandese. Le crea -ture mostruose di Saftleven non fanno sorridere né sono divertenti: il tono èaspro, sarcastico e la violenza più accentuata, cosicché i mostri risultano in-quietanti e terrifici più che familiari e burleschi. Tutto ciò si fa evidente nelSabba di streghe di Chi cago 69 (fig. $) e in alcune Tentazioni di Sant’Antonio 70,opere ove una fervida fantasia si sposa con la drammatica tensione che emer-ge con forza nella Tentazione di Giobbe a Karlsruhe 71. All’interno di quest’o-pera, infatti, le figure seguono il procedimento di permutazione favorito daSaftleven, che consiste nell’aggiungere volti mostruosi e animaleschi a corpiumani: nel processo di metamorfosi le sue fantasiose creature si dotano diali e code. In tale seducente logica creativa la mostruosità di questi esserinon appare interamente fantastica e spaventosa, ma conserva sempre trattidi umanità: essi non nascono, ma divengono progressivamente mostruosi.L’aspetto orrido delle figure infernali deriva, dunque, da uno stato di deca-denza rispetto ad una primitiva condizione umana ed è proprio il legamecon il mondo reale a rendere queste figure tangibili nella loro violenza, comeaccade nelle opere di Salvator Rosa, ove il tema trattato non è dettato dallavolontà di far sorridere, ma rivela un’urgenza rappresentativa che esula dallamera scelta di genere. Come notava Salerno 72, tali soggetti sono trattati daRosa con una certa propensione verso uno spiccato realismo che tenta di rap-presentare altri sensi oltre quello della vista: essi evocano attraverso particola-ri tonalità l’odore pestifero, i sapori, la temperatura delle ambientazioni, inuna sorta di “quotidianità” che rende di conseguenza reale anche la presenzadell’elemento magico.
La stregoneria nel contesto fiorentino seicentesco:dagli atti dei processi alla letteratura
Il senso di concretezza riscontrato nelle Stregonerie di Saftleven si ritrovaanche in Rosa, essendo manifesta la volontà di attrarre l’attenzione su questio-ni e realtà che dovevano essere particolarmente dibattute in quegli anni 73, so-prattutto a Firenze, città che permetteva una più libera trattazione di temati-che che invece nello Stato della Chiesa o a Napoli potevano facilmente incap-pare nella censura. A tal riguardo risulta illuminante uno studio di AdrianoProsperi 74 sulle caratteristiche dell’Inquisizione fiorentina ai tempi di Galileo,da cui si evince che, in base alla documentazione giunta fino a noi, si registratra gli anni Trenta e Quaranta del Seicento un aumento dei controlli tanto sul-la cultura ufficiale, e dunque sulla stampa e sulle idee che si sviluppavano al-l’interno dei circoli intellettuali, quanto sul mondo magico e folklorico, conun conseguente aumento delle denunce contro malie e sortilegi. Ma, mentre al
'a-b. Salvator Rosa, Stregoneria, particolari, Londra, National Gallery
INFLUSSI NORDICI NELLE STREGONERIE DI SALVATOR ROSA !(%
di là delle Alpi questi sono anni di pesanti persecuzioni, in Italia molte denun-ce venivano lasciate senza seguito o concluse con semplici abiure. Eppure inqueste carte si accumulano le rivelazioni di persone pentite di essersi rivolte amaghi o guaritori per curare figli o parenti, per procurare danno a nemici oper trovare l’amore e spesso i racconti sono arricchiti da gustose descrizioni diricette e rituali che dovevano essere molto noti e non solo attraverso la lettera-tura specialistica 75.
Come conseguenza di questa situazione l’ambiente culturale fiorentino,personificato, tra le altre, dall’Accademia dei Percossi 76 fondata da Rosa, si mo-strò particolarmente sensibile al fascino delle arti occulte anche dal punto divista letterario e poetico, come sembrano confermare i ben noti esempi delcomponimento poetico di Rosa intitolato La Strega 77 (!$($) e il MalmantileRacquistato 78 (!$(%) di Lorenzo Lippi, amico del nostro e membro dell’Acca-demia. Sempre in ambito toscano streghe e pratiche magiche si ritrovano nelTorrachione Desolato 79, scritto intorno al !$$# da Bartolomeo Corsini (!$#$-!$')), poeta e letterato originario di Barberino del Mugello, da non confon-dersi con l’omonimo Corsini committente della famosa Stregoneria, ma co-munque in relazione con quella famiglia 80. In alcuni significativi passi del poe-ma, relativi soprattutto alla figura di Dianora, si fa riferimento a credenze sul-la stregoneria tipiche del periodo:
«Ma pur de’ nuovi a ricomporre ancora / Di mezza notte in questi e quei confini /In forma se ne va di gatta nora / Per le case a stregar mille bambini. / A’ quai sugg’ellail sangue, e quai divora, / E da quai tragga i teneri intestini, / Per poi comporne, al-l’apparir del die, / Con altri suoi miscugli, altre malie». (Canto X, 6)
«Ma Dianora d’Ortaglia intanto scende, / E ratta va da valianesi prati / Quasi inmezzo a quel luogo il qual s’estende / Per ampio spazio in fra i due campi armati; / Ivigiunta, fa un cerchio, e note orrende / Su vi sussurra: d’ossa d’impiccati / Ridotte inpolve lo cosparge e poi / Tra l’erbe il cela e torna agli orti suoi». (Canto XII, 3)
«Sorse per fine un vento impetuoso, / Che cangiatosi in turbine vorace, / La magalevò su dal prato erboso, / Come leva un pulcin nibbio rapace: / E fatone un fardel
!"# STEFANIA MACIOCE, TANIA DE NILE
più strepitoso / Di macchina mural che si disface / Per terremoto dalla cima al fondo,/ Portolla...(che so io?) di là dal mondo». (Canto XVI, %)
Streghe che rapiscono bambini per utilizzarli come ingredienti delle loropozioni, cerchi magici entro i quali si recitano formule magiche, impiccati,vor tici di nubi in cui streghe si levano in volo come uccelli, scenari selvaggi einquietanti: tali elementi si ritrovano anche in Salvator Rosa, che risulta, dun-que, pienamente inserito nelle tradizioni dell’epoca 81.
Osservando da vicino la Stregoneria Corsini emerge una piccola curiosità:nel cartiglio in primo piano (fig. 'a) si individuano alcuni segni, una sorta dialfabeto criptato legato al mondo della magia, forse alludenti ad una formulamagica. Alcuni caratteri sembrano trovare corrispondenze precise attraverso ilcelebre repertorio di Gettings 82: simboli alchemici connessi con significati diumidità, cenere, coagulazione riscontrabili, secondo lo studioso, in diversi ma-nuali del Cinquecento e Seicento. Il primo segno – una sorta di lettera M – sa-rebbe un simbolo alchemico relativo all’umidità individuato dall’autore già nelXVII secolo 83; il successivo – una sorta di lettera C – un simbolo alchemico rife-ribile alla cenere come quello con i due punti 84, mentre l’ultimo – in forma diX – un segno relativo alla coagulazione individuato in un testo del !$"!85. Certa-mente non si tratta di una ricetta specifica, ma di noti simboli magico-alchemi-ci variamente utilizzati, in questo caso in forma appropriatamente allusiva maal contempo decorativa, che sembrano riecheggiare i versi di Rosa ove il pitto-re parla di «[...] acque chimiche, neri balsami, miste polveri» 86.
Il dissenso del Rosa espresso attraverso le Stregonerie
Nel contesto appena descritto la posizione di Salvator Rosa appare quella dichi, pur tendendo razionalmente a confinare la magia nera nell’ambito dellecredenze popolari, ne subisce il fascino, in un momento in cui la scienza non sidistingue ancora del tutto dalla magia. In accordo con quanto asserito da Sa-lerno 87 è plausibile ravvisare nell’attenzione del pittore verso la stregoneria lavolontà di manifestare un sottile dissenso nei confronti della cultura ufficiale eistituzionale, atteggiamento che sarà evidente anche nelle sue satire. L’atten-zione nei confronti del mondo magico, dalla divinazione alla negromanzia, ri-flette un interesse di tipo filosofico ed etico verso ciò che esalta la capacità del-l’uomo di agire concretamente sulla realtà senza condizionamenti di ordinemorale. Il pittore sembra mosso da un profondo amore verso la libertà di co-scienza e di pensiero, elemento costante delle sue numerose lettere e che servea spiegare tanto il suo atteggiamento stoico quanto la sua predilezione verso lasatira. Le lettere, come le satire, non pensate per essere pubblicate, lascianotrasparire un profondo malcontento nei confronti di tiranni, corti e potere pa-pale, che sfocia poi negli attacchi contro la corte di Roma contenuti nella sati-ra Babilonia, dove il pittore si scaglia contro l’eclatante nepotismo di papaAlessandro VII 88. Il suo spirito anticlericale si evince da molti passi dell’episto-lario, così come una palese incapacità di piegarsi allo stato di cose nella stre-nua difesa della propria liberta di coscienza: «[...] negando e bestemmiando
*. Salvator Rosa, Studi per scene di stregoneria, Firenze, Galleria degli Uffizi
INFLUSSI NORDICI NELLE STREGONERIE DI SALVATOR ROSA !"!
chi ci introdusse nell’anima tanta paura, e chi trovò tante clausole e vincoli so-pra le nostre coscienze, che maledetto sia per tutti i secoli dei secoli» 89.
La trattazione di tematiche stregonesche non denota convinzioni particolari,ma piuttosto l’interesse verso argomentazioni non convenzionali o addiritturacensurate e per null’affatto comuni in Italia. La rappresentazione del diabolicoera in genere limitata all’episodio delle tentazioni di Sant’Antonio e, dunque,inserita all’interno di racconti sacri riconosciuti e non sembra essere solo uncaso che le scene di stregoneria di Rosa fossero state commissionate o vendutea collezionisti privati borghesi, come il Niccolini o il marchese Corsini e per lopiù nel contesto fiorentino.
Un latente anticlericalismo si evince anche dall’inserimento di figure di reli-giosi e monaci come attivi partecipanti alle messe nere nell’“ovato” in collezio-ne privata, sopra citato, nonché in un disegno al Metropolitan di New York 90,oggi interpretato dai più come uno studio per la Stregoneria Corsini, ma perlungo tempo considerato una tentazione di sant’Antonio per la presenza di unmonaco inginocchiato. Il disegno ci mostra un monaco colto nell’atto di versa-re il contenuto di una brocca con una mano, mentre con l’altra muove unabacchetta all’interno di un cerchio magico, azioni che sottolineano la sua par-tecipazione attiva alla messa nera che si sta svolgendo davanti a lui. Secondoquanto rilevato da Scott 91, il fatto che il monaco sia stato poi sostituito nel di-pinto con altre figure di streghe lascia supporre che si ritenesse rischioso tra-sporre in pittura un’aperta polemica contro la corruzione della Chiesa e degliordini religiosi. Tale idea appare confermata anche da un disegno con schizzi
!"& STEFANIA MACIOCE, TANIA DE NILE
conservato agli Uffizi (fig. *) che la critica 92 ritiene legato alla Stregoneria Corsi-ni per la presenza, a destra, di una figura di donna che brandisce due torce. Inalto si può vedere un uomo con abiti sacerdotali che sostiene un calice tra lemani, mentre al centro tre figure inginocchiate, rese attraverso il caratteristicotratto veloce di Rosa, circondano una donna che spalanca le braccia mimandoin maniera blasfema la crocifissione di Cristo. In questo caso non sembra trat-tarsi solamente della rappresentazione di pratiche di stregoneria come inver-sioni della liturgia tradizionale, ma è evidente una volontà di attaccare la Chie-sa e i suoi rituali.
Tali particolari avvicinano il Rosa alle consuetudini anticlericali comuni inarea nordica, ravvisabili in Bosch come in molti suoi seguaci, ma, al contrariodi questi, Rosa si cimenta in simili tematiche o all’interno di piccole opere de-stinate a borghesi o in schizzi e disegni preparatori che mostrano, ancor piùdei dipinti, idee spontaneamente scaturite dalla sua acuta e mordace fantasia.Il carattere di segretezza si evince anche dalle affermazioni del pittore in unalettera a Giovan Battista Ricciardi del dicembre !$$$ 93, ove egli dichiara che ilquadro di Stregoneria, oggi a Londra e allora in possesso del banchiere Carlode Rossi, era conservato dietro una cortina. Ciò aumentava forse il senso dimistero della composizione, ma, soprattutto, celava a molti un’iconografia tra-sgressiva agli occhi delle autorità ecclesiastiche, particolarmente incombenti inambiente romano 94.
Che vi fosse il rischio che certe immagini di Rosa fossero avvertite come licen-ziose sembra possa essere confermato anche dall’insolita insistenza con cui GianBattista Passeri asserisce che mai Salvatore dipinse temi che esulano dal buon co-stume, proprio come se, in realtà, volesse proteggerlo da possibili accuse:
«Quanto alla parte, che si conviene ad un Pittore veramente Christiano, che è disfuggire le oscenità, e le apparenze lascive, egli ne fu rigorosissimo osservatore, che nonlasciò mai uscire dal suo pennello quelle illecite mostruosità che sono bastanti a conta-minare l’innocenza, e la purità d’un’animo ben composto, e di recare all’anima propriaun pregiudizio notabilissimo di metterla in pericolo nella dannazione eterna»95.
Diverse opere di Rosa, tuttavia, sembrano smentire le parole del Passeri,mostrandoci un’artista che si dedica, forse per gioco, a rappresentazioni tut -t’altro che pudiche, come nello Studio con alberi e donna di spalle 96 al BritishMuseum o nel Foglio di studi 97 alla Joseph McCrindle Collection di Londra,ove piccoli putti sono mostrati a cavallo di grossi falli e, a destra, compare unvolto composto da piccoli falli assemblati “alla Arcimboldo”. All’interno dellaproduzione grafica, destinata ad un uso personale o, tutt’al più, a un destinata-rio privato, il pittore poteva esprimere liberamente la sua sarcastica ironia, aldi là di qualsiasi vincolo imposto dalle normative ecclesiastiche rispettose dellaliceità e del decoro.
Accogliendo nella sua opera stimoli provenienti dal mondo nordico, Rosasembra mostrare una sorta di rifiuto delle convenzioni, all’insegna di una pe-renne ricerca di libertà espressiva, e la matrice nordica della sua ironica tra-sgressività diverrà modello per molti artisti successivi.
INFLUSSI NORDICI NELLE STREGONERIE DI SALVATOR ROSA !")
NOTE
1 H. Langdon, Salvator Rosa in Florence 1640-1649, in «Apollo», (1974), 100, pp. 190-197.2 C. Zika, The Corsini Witchcraft Scene by Salvator Rosa: magic, violence and death, in D.R. Mar-
shall (a cura di), The “Italians” in Australia. Studies in Renaissance and Baroque Art, Melbourne 2004,pp. 179-190.
3 Sul proliferare a Firenze di opere testimonianti uno spiccato gusto per soggetti macabri e bizzarrisi veda S. Bellesi, Diavolerie, magie e incantesimi nella pittura barocca fiorentina, Firenze 1997.
4 Salvator Rosa: tra mito e magia, Catalogo della Mostra, (Napoli, Museo di Capodimonte, 18 aprile- 29 giugno 2008), Napoli 2008, pp. 170-171, cat. 42 (S. Ebert-Shifferer).
5 F.W.H. Hollstein, German engravings, etchings and woodcuts: ca. 1400-1700, Amsterdam 1954,vol. II, pp. 136-137, cat. 235; Les Sorcières, Catalogo della Mostra a cura di M. Préaud, (Paris, Biblio-thèque Nationale), Paris 1973, p. 33, cat. 43; J. Marrow at al. (a cura di), The Illustrated Bartsch.Hans Baldung Grien-Hans Springinklee-Lucas van Leyden, New York 1981, v. 12, p. 59, cat. 55; HansBaldung Grien. Prints & Drawings, Catalogo della Mostra a cura di J.H. Marrow e A. Shestack,(Washington, National Gallery of Art 25 Gennaio - 5 Aprile 1981), New Haven 1981, pp. 114-117,cat. 18. Zika ricorda che l’incisione di H. Baldung Grien era nota anche attraverso alcune copie ita-liane di L. degli Uberti e di A.F. Camoccio; la prova della conoscenza dell’opera da parte del Rosa èdata dal fatto che in un foglio di studi per l’Empedocle si vede una riproposizione del gruppo centra-le nella parte inferiore, come segnalato da J. Scott in Salvator Rosa: his life and times, New Havenand London 1995, p. 49, fig. 61. Per approfondimenti si veda ancora C. Zika, The Corsini WitchcraftScene..., cit., p. 184, nota 20 e, soprattutto, I. Zdanowicz, A note on Salvator Rosa’s study for “Thedeath of Empedocles”, in «Art Bulletin of Victoria», (1979), 20, pp. 45-48, figg. 2-3. Sulle streghe nel-la produzione di H. Baldung Grien si rimanda a S. Schade, Schadenzauber und die Magie des Körpers,Hexenbilder der frühen Neuzeit, Worms 1983, pp. 80-85 e L.C. Hults, Baldung and the witches ofFreiburg: the Evidence of Images, in «Journal of Interdisciplinary History», (1987), 18, pp. 249-276.
6 Per l’incisione e il disegno da cui essa deriva cfr. F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings,engravings and woodcuts: ca. 1450-1700, Amsterdam, v. VII, p. 120, cat. 96; R. Judson, The drawingsof Jacob de Gheyn 2, New York 1973, pp. 30; 44; I.Q. van Regteren Altena, Jacques de Gheyn. Threegenerations, The Hague - Boston - London 1983, vol. II, pp. 84-85, cat. 519; vol. III, figg. 337-339;Jacques de Gheyn II als tekenaar (1565-1629), Catalogo della Mostra a cura di A.W.F.M. Meij e J.A.Poot (Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen, 14 dicembre 1985 - 10 febbraio 1986;Washington, National Gallery of Art, 9 marzo-12 maggio 1986), Rotterdam 1985, pp. 74-75, cat. 68;J. Filedt Kok, Jacques de Gheyn 2: engraver, designer and publisher e Part II: a catalogue, in «PrintQuarterly», (1990), 7, pp. 248-281; 370-396; C. Swan, The Preparation for the Sabbath of Jacques deGheyn II. The issue of inversion, in «Print Quarterly», XVI (1999), 4, pp. 327-339, qui pp. 327-329,n. 4; J.P. Filedt Kok, M. Leesberg (a cura di), The new Hollstein. Dutch & Flemish etchings, engrav-ing and woodcuts: ca. 1450-1700. The De Gheyn family, Part. I, Rotterdam, 2000, v.10.1, pp. 234-235, cat. 155.
7 W.W. Roworth, “Pictor Succensor”. A study of Salvator Rosa as Satirist, Cynic and Painter, NewYork - London 1978, p. 133.
8 Jacques de Gheyn II nasce nel 1565 ad Anversa, dove il padre Jacques de Gheyn I, maestro spe-cializzato nella pittura su vetro, si era stabilito nel 1558 venendo da Utrecht. Il giovane Jacques con-centrò i suoi interessi sull’arte della stampa e, nel 1595, si stabilì a Leida, dove iniziò a indagare altricampi, dalle scienze alla natura, rilevabili negli studi di anatomia condotti con Pieter Pauw e quelli dibotanica con Carolus Clusius, insigni professori della neonata Università. Per un interessante ap-profondimento sulla figura di Jacques de Gheyn II si rimanda al notevole contributo di C. Swan, Art,Science and Witchcraft in early modern Holland: Jacques de Gheyn II (1565-1629), Cambridge 2005.
9 Tra questi si segnalano principalmente una delle illustrazioni di Geiler von Kaysersberg del DieEmeis (1516), il primo trattato di demonologia pubblicato in Germania, e l’illustrazione che comparenella pagina iniziale dell’edizione del 1586 del De praestigiis daemonum di Jan Wier; cfr. C. Swan, Art,science, and witchcraft..., cit., pp. 169-172, figg. 64-65.
10 È interessante notare che tale particolare non compariva nella citata opera di H. Baldung Grien.11 Si tratterebbe dell’“ovato piccolo con cornice intagliata dorata ove vi è dipinto alcune figure che
rappresentano come un incantesimo di mano di Salvator Rosa”, cfr. C. Volpi, Salvator Rosa e CarloDe Rossi, in «Storia dell’Arte», 93/94, (1998), pp. 356-373, qui p. 370; si vedano anche C. Zika, TheCorsini Witchcraft Scene..., cit., p. 185 e Salvator Rosa: tra mito..., cit., pp. 166-167, cat. 40 (S. Ebert-Schifferer).
12 Il particolare del teschio si trova anche nel foglio con Tre studi di rane emaciate e due studi di te-
!"( STEFANIA MACIOCE, TANIA DE NILE
schi reggenti libri aperti della Fondation Custodia a Parigi, in R. Judson, The drawings..., cit., pp. 28-30, fig. 106; I.Q. van Regteren Altena, Jacques de Gheyn..., cit., vol. I, p. 88; vol. II, p. 139, cat. 892;vol. III, fig. 386.
13 Ibidem, vol. II, pp. 83-84, cat. 514 (recto); vol. III, fig. 218.14 C. Zika sembra essere d’accordo con questa linea di pensiero affermando che “some icono-
graphical details of Rosa’s work in general, not least the grotesque animals and hibryds, as well as thecruel savagery, may will have been influenced by de Gheyn’s drawings”, in C. Zika, The CorsiniWitchcraft Scene..., cit., p. 186.
15 Il disegno è stato attribuito a De Gheyn da I.Q. van Regteren Altena.16 Salvator Rosa tra mito..., cit., pp. 224-225, cat. 74 (M. Chiarini). Si segnala la notevole somiglian-
za tra questa ideazione e alcune figurine visibili all’interno della seconda versione de Le Tentazioni disant’Antonio di Jacques Callot del 1635; sull’incisione cfr. D. Ternois, L’art de Jacques Callot, Paris1962, pp. 133-135 e Jacques Callot (1592-1635), Catalogo della Mostra a cura di D. Ternois (Nancy,Musée historique lorraine, 13 giugno -14 settembre 1992), Paris 1992, p. 424 ss., n. 532, n. 537.
17 G.K. Nagler, Die Monogrammisten, Munich-Leipzig 1879, vol. V, p. 110; Salvator Rosa: his etch -ings and engravings after his work, Catalogo della Mostra a cura di P.A. Tomory (Sarasota, John andMable Ringling Museum of Art, 4 novembre - 5 dicembre 1971) Sarasota 1971, cat. 14; G. Bozzolato,Le incisioni di Salvator Rosa, Catalogo generale, Padova 1973, pp. 178-179, cat. 77. L’incisione non èsegnalata dal Bartsch né da Petrucci.
18 Si veda anche il disegno e l’incisione siglata che sono stati pubblicati in Master drawings, Colna-ghi, Londra 1999, p. 26.
19 L. Salerno, Salvator Rosa, Firenze 1963, p. 113, tav. XXIV.20 Su questa serie si veda M. Charini, Teodoro Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano, 1589-
1626. Vita e opere, Firenze 2007, pp. 476-484, figg. 415-435.21 Un’immagine del Theatrum Anatomicum Leidense si può vedere in una splendida incisione di
Willem Swanenburgh su disegno di Jan Cornelisz Woudanus, in Stilleben in Europa, Catalogo dellaMostra a cura di G. Langemeyer e H.A. Peters (Münster, Westfälisches Landesmuseum für Kust undKulturgeschichte, 25 novembre 1979 - 24 febbraio 1980), Münster 1979, p. 193, fig. 108.
22 I.Q. van Regteren Altena, Jacques de Gheyn..., cit., vol. II, p. 92, cat. 558 (verso); vol. III, fig. 211.23 Ibidem, vol. II, p. 84, cat. 518; vol. III, fig. 336.24 C.S. Salerno sottolinea che l’inserimento di animali scheletrici all’interno di scene di stregoneria
era una pratica comune, come si evince dall’incisione de La Strega di Dürer, da Lo stregozzo di Agosti-no Veneziano e dalle famose carcasse che compaiono nelle già citate incisioni di Jacques Callot; si ve-da C.S. Salerno, Jacob Isaacsz van Swanenburgh in Italia e alcune “stravaganze di scheletri” di FilippoAngeli, in I. Badriga (a cura di), “fiamenghi che vanno e vengono non li si può dar regola”. Paesi Bassi eItalia fra Cinquecento e Seicento: pittura, storia e cultura degli emblemi, Sant’Oreste 1995, pp. 78-99,qui 94-95, nota 92. Va segnalato, però, che tale pratica si incontra già in Bosch, ad esempio ne Le Ten-tazioni di sant’Antonio di Lisbona, da cui deriva il motivo del cranio ripetuto poi anche nella famosis-sima incisione La caduta del mago Ermogene di Pieter Brueghel il Vecchio. L’immagine di uno schele-tro d’animale cavalcato da creature fantastiche si riscontra anche nella Tentazione di Jan Mandijn apalazzo Colonna a Roma, nonché in una tela del medesimo soggetto di Martin de Vos ad Anversa. At-traverso le già citate incisioni e l’esempio di Callot tali immagini popoleranno poi le opere di FilippoNapoletano e Monsù Desiderio.
25 Salvator Rosa: tra mito..., cit., p. 174-175, cat. 44 (S. Ebert-Schifferer); dell’opera esistono diver-se copie e repliche, una delle quali, in collezione privata napoletana, riprodotta nello stesso catalogo,pp. 176-177, cat. 45 (S. Ebert-Schifferer); cfr. anche C. Zika, The Corsini Witchcraft Scene..., cit., pp.179-190.
26 Si veda I.Q. van Regteren Altena, Jacques de Gheyn..., cit., vol. I, p. 86 ss.27 Per approfondimenti cfr. J.A. van Dorsten, Thomas Basson (1555-1613), English Printer at Lei-
den, in «Quaerendo», XV (1985), 3, pp. 195-224.28 A tal riguardo Machteld Löwenstein afferma che la famosa incisione con La preparazione al sab-
bat di De Gheyn sia la visualizzazione letterale di alcuni precisi passaggi della traduzione di Basson,mentre Jane Davidson suggerisce la possibilità che l’artista si sia ampiamente servito anche di alcunedescrizioni contenute all’interno delle Demonomanie di Jean Bodin; cfr. M. Löwenstein, Helse heb-zucht en wereldse wellust. Een iconografische interpretatie van enkele heksen voorstellingen van Jacquesde Gheyn II, in «Volkskundig Bulletin», I (1986), 12, pp. 241-261; J.P. Davidson, The Witch in North-ern European Art, 1470-1750, Düsseldorf 1987, pp. 60-64.
29 R. Judson, The drawings..., cit., pp. 28-29.30 Riguardo alle numerose opere incentrate sul tema della stregoneria in Jacques de Gheyn II si ri-
manda a R. Judson, The drawings..., cit., pp. 27-34; Les Sorcières, cit., p. 31, cat. 41; I.Q. van Regte-
INFLUSSI NORDICI NELLE STREGONERIE DI SALVATOR ROSA !""
ren Altena, Jacques de Gheyn..., cit., vol. I, pp. 86-89; J.P. Davidson, The Witch..., cit., pp. 57-64.31 C.S. Salerno, Jacob Isaacsz van Swanenburgh..., cit., p. 98, nota 110; per quanto riguarda gli in-
ventari della collezione di Ferdinando di Toscana cfr. M. Chiarini, I quadri della collezione del Princi-pe Ferdinando di Toscana, in «Paragone», XXVI (1975), 301, pp. 57-98; 303, 75-108; 305, 53-83. Si se -gnalano, tra le opere della collezione del principe Carlo di Lorena, fratello del granduca Francesco I,alcuni quadri dell’anversano David Ryckaert III (1612-1661): due Tentazioni di Sant’Antonio, conser-vate nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze, e un quadro con Strega che scaccia i demoni, og-gi al Kunsthistorisch Museum di Vienna; cfr. Rubens e la pittura fiamminga del Seicento nelle collezio-ni pubbliche fiorentine, Catalogo della Mostra a cura di D. Bodart (Firenze, Palazzo Pitti, 22 luglio -9 ottobre 1977), Firenze 1977, pp. 240-243, cat. 104-105; A. Balis et al. (a cura di), Die flämischenMalerei im Kunsthistorischen Museum Wien, Zurich 1989, p. 273 e S. Ferino-Pagden et al. (a cura di),Die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museum in Wien. Verzeichnis der Gemälde, Wien 1991, tav.470.
32 Tale aspetto è stato costantemente sottolineato dal Ternois negli studi dedicati all’artista lorenesee da Van Regteren Altena in quelli sull’artista fiammingo.
33 I.Q. van Regteren Altena, Jacques de Gheyn..., cit., vol. II, pp. 64-78; cat. 342-464. Tali incisioniebbero una grande importanza anche per le famose serie di Filippo Napoletano e Stefano della Bella.
34 D. Ternois, L’art de Jacques..., cit., 1962, pp. 79-80; I.Q. van Regteren Altena, Jacques deGheyn..., cit., vol. I, p. 88.
35 I.Q. van Regteren Altena, Jacques de Gheyn..., cit., vol. II, p. 37, cat. 131; vol. III, fig. 313.36 Cfr. M. Chiarini, Teodoro Filippo..., cit., pp. 288-289, cat. 64; 125, fig. 91.37 Cfr. nota 13 del presente studio.38 Sui rapporti tra l’arte di Filippo Napoletano e la cultura nordica cfr. M. Chiarini, Appunti su Fi-
lippo Napoletano e la pittura nordica, in Scritti in onore di Raffaello Causa, Napoli 1996, pp. 39-6239 Come giustamente segnalato, l’ambiente napoletano deve essere stato particolarmente stimolan-
te per questo tipo di interessi, soprattutto quello ruotante attorno all’Accademia degli Oziosi; si vedaS. Ebert-Schifferer, Il teatro filosofico della vanità. Le iconografie di Salvator Rosa, in Salvator Rosa tramito..., cit., pp. 66-82, qui pp. 74-77; per un approfondimento sulla diffusione degli studi sulla strego-neria nella città partenopea si veda anche B. De Giovanni, Magia e scienza nella Napoli seicentesca, inCiviltà del Seicento a Napoli, Catalogo della Mostra a cura di S. Cassani (Napoli, Museo di Capodi-monte, 24 ottobre 1984 - 14 aprile 1985; Museo Pignatelli, 6 dicembre 1984 - 14 aprile 1985), Napoli,1984, vol. I, pp. 29-40.
40 Su questo artista e sui suoi influssi su Filippo Napoletano si sofferma C.S. Salerno, Jacob Isaacszvan Swanenburgh..., cit., pp. 78-99. Si veda anche M.R. Nappi, Francois de Nommé e Didier Barra.L’enigma Monsù Desiderio, Milano 1991, pp. 23-31 e M. Chiarini, Teodoro Filippo..., cit., pp. 124-129.
41 Ibidem, p. 293, cat. 70; p. 126, fig. 92.42 M.L. Wurfbain, J.P. Sizoo e D. Wintgens (a cura di), Catalogus van de schilderijen en tekeningen,
Leiden 1983, p. 209, cat. 787.43 M.R. Nappi, Francois de..., cit., p. 26; C.S. Salerno ha proposto una nuova attribuzione a Vincen-
zo Mannozzi, imitatore del Napoletano e autore di un Inferno citato negli inventari medicei e oggiconservato presso le Gallerie Statali Fiorentine in C.S. Salerno, Jacob Isaacsz van Swanenburgh..., cit.,pp. 91-92; quest’ultima opera è invece assegnata da Chiarini a Filippo Angeli in M. Chiarini, Pitturasu pietra, in «Antichità viva», IX (1970), 2, pp. 29-37, 36, fig. 7.
44 P. Seghers, L’invitation aux Enfers, in «Connaissance des arts», (1981), 354, pp. 40-47.45 Gli atti del processo sono stati pubblicati da L. Amabile in Due artisti ed uno scienziato. Gian
Bologna, Jacomo Svanenburch e Marco Aurelio Severino nel S.to Officio Napoletano, Napoli 1890, pp.17-23; 58-65 e in C.S. Salerno, Jacob Isaacsz van Swanenburgh..., cit., pp. 82-84; per la citazione cfr.Amabile, Due artisti..., cit., p. 58.
46 Ibidem, p. 6447 Ibidem, p. 60.48 Ibidem, pp. 63-64.49 I.Q. van Regteren Altena, Jacques de Gheyn..., cit., vol. I, p. 133.50 Sulle dipendenze iconografiche di Swanenburgh dall’opera di De Gheyn cfr. I.Q. van Regteren
Altena, The drawings..., cit., p. 42; I.Q. van Regteren Altena, Jacques de Gheyn..., cit., vol. I, pp. 88-89; C.S. Salerno, Jacob Isaacsz van Swanenburgh..., cit., p. 88, nota 72.
51 Sull’opera di Cornelis Saftleven e sulle rappresentazioni nordiche di tipo magico-diabolico è incorso la ricerca condotta dalla dott.ssa Tania De Nile, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Storiadell’Arte presso la Facoltà di Scienze Umanistiche della Sapienza, Università di Roma.
52 Lucas Vorsterman incise un gran numero di ritratti di importanti personalità politiche ed artistiper L’iconographie di Antoon van Dick, tra cui anche quello di Cornelis Saftleven, rappresentato a
mezzo busto, con il braccio sinistro appoggiato ad una strana figura, forse un ippopotamo. Per l’inci-sione, cfr. F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings..., cit., v. VI, (van Dyck), p. 128, cat. 802;H. Hymans, Lucas Vosterman, 1595-1675, et son œuvre gravé, Amsterdam 1972, pp. 194-195, n. 208;C. Schuckman (a cura di), Hollstein’s Dutch & Flemish etchings..., cit., Roosendaal, 1993, v. XLIII(L. Vosterman), p. 213, cat. 199; S. Turner (a cura di), The new Hollstein..., cit., Rotterdam 2002,v. 12.2 (van Dyck), pp. 145-146, cat. 88; per il disegno di van Dyck da cui l’incisione deriva cfr.M. Schapelhouman, Tekeningem van Noord-en Zuidnederlandse kunstenaars geboren voor 1600, Am-sterdam 1979, pp. 36-37, cat. 16.
53 C. Virdis Limentani (a cura di), Fiamminghi. Arte fiamminga e olandese del Seicento nella Repub-blica Veneta, Milano 1990, pp. 164-165.
54 L’opera proviene dalla Collezione Piazza, ma viene segnalata all’interno dei beni del convento diSan Giovanni da Verdara.
55 Si veda anche A. Campoli, Le “Stregonerie” di Salvator Rosa, in S. Macioce (a cura di), L’Incante-simo di Circe. Temi di magia nella pittura da Dosso Dossi a Salvator Rosa, Roma 2004, pp. 158-180.
56 Si fa riferimento, principalmente, al Dittico della Pinacoteca Capitolina; cfr. Salvator Rosa tra mi-to..., cit., pp. 178-179, cat. 46-47 (S. Ebert-Schifferer). Nell’inventario dei quadri appartenenti a Carlode Rossi si parla anche di “un altro quadruccio con cornice liscia indorata dipinto in lavagna dove ci èun soldato armato a sedere in schiena, che con magia fa vedere il fuoco alli folletti di mano del dettoRosa”, cfr. C. Volpi, Salvator Rosa e..., cit., p. 370.
57 Studio di due figure mostruose, Rijksprentenkabinet, Amsterdam, inv. 55-146 in W. Schulz, Cor-nelis Saftleven, 1607-1681. Leben und Werke, Berlin-New York 1978, p. 76, cat. 21, fig. 112 (l’autoreomette la fonte iconografica delle figure del foglio); Studio di due figure mostruose, Metropolitan Mu-seum, New York, inv. 61-162-3, ibidem, p. 77; Studio di una lucciola con occhiali, on line database delRijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, n. 108075.
58 Cfr. F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings..., cit., v. III (Brueghel), p. 269, cat. 117 eidem, vol. IV (H. Cock), p. 187, cat. 229; R. van Bastelaer, Les estampes de Peter Bruegel l’Ancien,Brussels 1908, p. 43, cat. 117; Catalogue raisonné des estampes de Pierre Bruegel l’Ancien, Catalogodella Mostra a cura di L. Lebeer, (Brussels, Bibliothèque Royale Albert Ier, 6 settembre - 2 novembre1969), Brussels 1969, pp. 141-144, cat. 58; Les Sorcières, cit., pp. 17-18, cat. 17; R.H. Marijnissen etal., Bruegel: het volledige ouvre, Antwerp 1988, p. 239; N.M. Orenstein, Pieter Bruegel the Elder.Drawings and Prints, New York and London 2001, pp. 230-231, cat. 101; N.M. Orenstein (a cura di),The new Hollstein..., cit., Amsterdam 2006, v. 16 (Bruegel), pp. 28-29, cat. 11.
59 W. Schulz, Cornelis Saftleven..., cit., pp. 75-76, cat. 16; Dutch Drawings of the Seventeenth Centu-ry from a Collection, Catalogo della Mostra a cura di G. Creighton, (Ithaca, New York, Cornell Uni-versity, Herbert F. Johnson Museum of Art, 6 novembre - 23 dicembre 1979), Ithaca 1979, p. XXX,cat. 22.
60 F. Baldinucci, Notizie dei Professori del disegno da Cimabue in qua, a cura di F. Ranalli, Firenze1847 [Firenze 1681], rist. anast. Firenze 1974, vol. V, p. 129.
61 Per la figura di Herman cfr.W. Schulz, Herman Saftleven, 1609-1685. Leben und Werke, Berlin -New York 1982.
62 Tale attribuzione, che risale a Hofstede de Groot, viene accolta da Karl Freund nel catalogo didisegni del museo del 1929 ed è seguita anche da Wolfang Schulz nella sua monografia su Saftleven;cfr. K. Freund, Stift und Feider-Zeichnungen aus dem Kupferstichkabinett des Hessischen Landes -museum zu Darmstadt, Frankfurt 1929, tav. 117; W. Schulz, Cornelis Saftleven..., cit., pp. 73-74.
63 L. Salerno, Salvator Rosa, cit., pp. 110-111, tav. XV; L. Salerno, L’opera completa di Salvator Ro-sa, Milano 1975, pp. 94-95, cat. 116, fig. XXXV.
64 Ibidem, pp. 94-95, n. 116.65 M. Mahoney, The drawings of Salvator Rosa, New York and London 1977, vol. I, pp. 467-468,
vol. II, cat. 48.2; D. Miller, A preparatory Study for Salvator Rosa’s L’Umana Fragilità, in «TheBurlington Magazine», 119, (1977), pp. 272-273, fig. 75.
66 Leonaert Bramer (1596-1674), artista originario di Delft, soggiorna in Italia dal 1619 al 1627 e sispecializza nella realizzazione di quadretti con notturni da cui deriva il nome di “Leonardo delle Not-ti”. Il più grande committente di Bramer in Italia fu Gaspar Roomer, mercante fiammingo residente aNapoli, il quale possedeva circa 40 quadretti dell’artista; per un elenco di questi quadri si rimanda aB.W. Meijer, Collezioni e collezionisti fiamminghi e olandesi in Italia, in «Incontri», (1985/1986), n.s.1,pp. 72-76, qui p. 72.
67 Si segnalano i due notevoli esemplari conservati nella Národní Galeri di Praga e nel Musée desBeaux-Arts di Bordeaux, cui va aggiunto un disegno con Strega forse riferibile al suo soggiorno ita -liano; cfr. J. Ten Brink Goldsmith (a cura di), Leonaert Bramer 1596-1674. Ingenious painter anddraughts man in Rome and Delft, Delft 1994, pp. 127-129, figg. 27-27a e 188, fig. 6.
!"$ STEFANIA MACIOCE, TANIA DE NILE
68 Olivier Le Bihan, descrivendo la stregoneria di Bordeaux, notava una stretta relazione con l’o-pera di Cornelis Saftleven, specie nella resa degli animali fantastici; tale prossimità iconografica eragià stata sottolineata dal Wichmann, secondo il quale sarebbe stato Bramer a rifarsi alle fantasticheinvenzioni di Saftleven a partire dagli anni Trenta, e, dunque, dopo il suo ritorno in Olanda, mentreappare plausibile che lo scambio tra i due artisti non sia stato unilaterale, giacché Bramer si era oc-cupato del tema della stregoneria già in Italia. Cfr. O. Le Bihan, L’or et l’ombre: catalogue critique etraisonné des peintures hoolandaises du dix-septième et du dix-huitième siècles conservées au Muséedes Beaux-Arts de Bordeaux, Bordeaux 1990, p. 67; H. Wichmann, Leonaert Bramer. Sein Leben undsein Kunst, Leipzig 1923, p. 31; J. Ten Brink Goldsmith (a cura di), Leonaert Bramer..., cit., p. 72,nota 49.
69 Paintings in the Art Institut of Chicago: a catalogue of the picture collection, Chicago 1961, p. 409;W. Schulz, Cornelis Saftleven..., cit., p. 188, cat. 516, fig. 20.
70 Si veda la Tentazione al Bowes Museum di Durham e quella al Dorotheum di Vienna inW. Schulz, Cornelis Saftleven..., cit., p. 185, cat. 511, fig. 8 e per altre Tentazioni dell’artista si rimandaalle pp. 184-186, cat. 508-511.
71 J. Lauts, Katalog alte Meister bis 1880 - Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe 1966, p. 266, cat. 1832;B.J.A. Renckens, Enkele notities bij vroege werken van Cornelis Saftleven, in «Bulletin Museum Boy-mans van Beuningen», (1962), 13, pp. 59-74, qui pp. 65-66, fig. 19; W. Schulz, Cornelis Saftleven...,cit., p. 187, cat. 514, fig. 5.
72 L. Salerno, Salvator Rosa, cit., pp. 39-42.73 J.P. Davidson sostiene la tesi che le stregonerie di Salvator Rosa siano fortemente legate alla let-
teratura contemporanea sull’argomento, in The Witch..., cit., pp. 70-71; si veda anche R. Enggass eJ. Brown, Italy and Spain, 1600-1750, Englewood Cliffs, NJ 1970, p. 133.
74 A. Prosperi, L’inquisizione fiorentina al tempo di Galileo, in Novità celesti e crisi del sapere, Attidel Convegno di Studi galileiani a cura di P. Galluzzi (Pisa, Venezia, Padova, Firenze, 18-26 marzo1983), Firenze 1984, pp. 315-325, qui pp. 322-323.
75 Tra i processi di stregoneria almeno due furono portati avanti con decisione, vale a dire quellocontro Maddalena Serchia da Certaldo, del 1624, e quello contro Maddalena da Montevarchi del1638; idem, p. 325 nota 38. La situazione descritta evidenzia l’interesse e il fascino verso questo gene-re di superstizioni, cui non sfuggivano neanche i vertici della Chiesa romana se Gregorio XV con labolla Omnipotentis Dei del 20 marzo 1623 autorizzava i fedeli a denunciare i sospettati di stregoneria,per non parlare del particolare caso della serie di messe nere organizzate contro il superstizioso Urba-no VIII nel 1631, che terminò con la messa al rogo del suo ideatore.
76 Per approfondimenti sull’Accademia dei Percossi si veda J. Scott, Salvator Rosa..., cit., pp. 55-59.77 U. Limentani, Salvator Rosa. Poesie e lettere inedite: con un’introduzione, Firenze 1950, pp. 48-50.78 Si segnala l’ultima edizione del testo: L. Lippi, Il Malmantile Racquistato, ripr. facs. dell’edizione
della stamperia di S.A.S. alla Condotta, Firenze 1688, Empoli 2005.79 B. Corsini, Il Torrachione Desolato, Venezia 1872 [Parigi 1768]. La storia del Torracchione Deso-
lato prende spunto dal territorio del Mugello, pieno di antichi castelli abbandonati e diroccati che po-polavano la bella vallata. Proprio nei dintorni di Barberino, e precisamente sulla riva destra della Lo-ra, si vede ancora oggi un mucchio di pietre, unici resti di un antico castello detto“il Torracchione”che si trovava proprio nei pressi della villa del Corsini. Il poema narra della storia d’amore tra Alcida-mante, conte di Mangona, e la bella Elisea e delle lotte che seguirono il rapimento di quest’ultima daparte del figlio di Lambertaccio, signore del Torrachione. Tra i protagonisti di questo poema trovia-mo anche due streghe, Sirmalia e Dianora: la prima abita un castello incantato pieno di uomini lussu-riosi in cui vengono condotte le fanciulle rapite, mentre la seconda, maga d’Ortaglia, tende trappolecon i suoi incantesimi a chi si inoltri nei boschi da lei controllati.
80 Per approfondimenti sulla sua vita e la sua attività cfr. G. Baccini, Gli scritti inediti di Bartolo m -meo Corsini preceduti dalla sua vita, Firenze 1883, pp. XIII-XIV.
81 Come giustamente nota C. Zika il senso di reale violenza che si percepisce osservando le operedel Rosa evidenzia forse da parte sua una conoscenza della situazione non solo fiorentina, ma anchedelle terribili vicende relative ai roghi e alle condanne capitali che caratterizzano in quegli anni le zo-ne d’oltralpe e un possibile canale con quelle realtà può essere stato proprio Lorenzo Lippi, il quale sitrovava allora alla corte di Innsbruck presso Caterina de’Medici, in C. Zika, The Corsini WitchcraftScene.., cit., pp. 187-188.
82 F. Gettings, Dictionary of Occult, Hermetic and Alchemical Sigils, London 1981.83 Ibidem, p. 69.84 Ibidem, pp. 85, 104, 278.85 Ibidem, p. 87.86 U. Limentani, Salvator Rosa..., cit., p. 49.
INFLUSSI NORDICI NELLE STREGONERIE DI SALVATOR ROSA !"'
87 L. Salerno, Il dissenso nella pittura. Intorno a Filippo Napoletano, Caroselli, Salvator Rosa e altri,in «Storia dell’Arte», 5, (1970), pp. 34-65.
88 «Qui le civette cacano i mantelli, / et insino a color che non han testa piovono le tiare et i capelli; /qui raspa e canta con purpurea cresta / chi bisogno averia del catechismo, / e dogmi e leggi a suo vo-ler calpesta: / e sotto un cielo infetto d’ateismo, / cinti di gioglio il crine e il piè di socco, rintracciard’Epoloni ogn’afforismo/e per voler d’un nume cieco e sciocco / conferir grazie e fabricar decreti /con man grifagne e con cervei d’alocco; / e deridendo scrupoli e devieti» (v. 820 ss.). Esiste una ric-chissima bibliografia dedicata alle satire di Salvator Rosa; tra queste si segnalano soprattutto Satire diSalvator Rosa, con le note d’Anton Maria Salvini e d’altri ed alcune notizie appartenenti alla vita del-l’autore, Amsterdam 1770.
89 A. De Rinaldis, Lettere inedite di Salvator Rosa a G.B. Ricciardi, Roma 1939, p. 112.90 Cfr. L. Salerno, Il dissenso..., cit., p. 63; H. Langdon, Salvator Rosa in Florence..., cit., p. 196;
M. Mahoney, The Drawings..., cit., vol. I, pp. 335-336, vol. II, cat. 28.4.91 J. Scott, Salvator Rosa..., cit., p. 52, fig. 67.92 Cento disegni napoletani. Sec. XVI-XVIII, Catalogo della Mostra a cura di W. Vitzthum (Firenze,
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi), Firenze 1967, cat. 73, fig. 49; M. Mahoney, TheDrawings..., cit., vol. I, p. 334, vol. II, cat. 28.2. J. Bean ritiene che il presente disegno possa essereconsiderato uno studio per la Stregoneria Corsini, insieme al disegno del Metropolitan e ad altri tre di-segni attribuiti al Rosa e conservati a Princeton (inv. 48-798, 48-812 e 1271); cfr. J. Bean, Italiandrawings in the Art Museum, Princeton University: 106 selected drawings, New York 1966, p. 41, tav.56. Altri disegni del Rosa legati al tema della stregoneria sono stati pubblicati da M Mahoney, TheDrawings..., cit., vol. I, pp. 333-338, 698-699; vol. II, cat. 28.1-28.9, 82.12.
93 «Di quello delle streghe (...) atteso che trapassa i segni della curiosità, e come tale si mostra dopotutte le cose, e sta coperto col taffettà», cfr. G.A. Cesareo, Poesie e lettere edite e inedite di SalvatorRosa, pubblicate criticamente e precedute dalla vita dell’autore rifatta su nuovi documenti, Napoli 1892,vol. 2, p. 128, CXXI.
94 J. Scott, Salvator Rosa..., cit., p. 54.95 J. Hess, Die Künstlerbiographien von Giovanni Battista Passeri, Worms am Rhein 1995, p. 399,
edizione critica delle Vite de’ pittori, scultori ed architetti che hanno lavorato in Roma, morti dal 1641fino al 1673 di G.B. Passeri, Roma 1772.
96 M Mahoney, The Drawings..., cit., vol. I, pp. 451-452, vol. II, cat. 46.1.97 Ibidem, vol. I, p. 385, vol. II, cat. 36.6; sul foglio troviamo il monogramma del Rosa, cosa abba-
stanza rara per quanto riguarda i disegni.
!"* STEFANIA MACIOCE, TANIA DE NILE