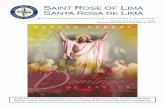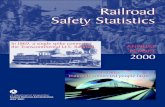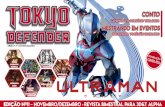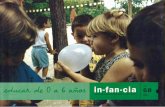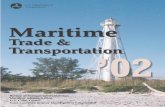"In forma dunque di candida rosa"
Transcript of "In forma dunque di candida rosa"
UnifePress è un progetto editoriale dell'Università di Ferlara. Per informa-
zioni sulle attiviti e i volumi pubblicati si può consultare il sito
www.unif e.it/unif epress
Comitato editoriale: Angela M. Andrisano, Davide Bassi, Giovanni BeIluzz|
Marco Di Tommaso, Riccardo Gavioli, Alessandro lannucci'
Editing e progetto grafico: Elena Pavini'
In copertina:
Ercolc con il qtradrantc, XV secolo. Bibliotcca Comttnale Arisotea (già PaTazzo
Paradiso), parctc sud dclla Sala c1'Ercolc, Fttrrarir
MENSURACAELI
Territorio, città,architetture, strumenti
Atti deIl'V[I Convegno Nazionaledella Società Italiana di Archeoastronomia (SIA)
A CURA DIMaNusra lNcunrt
UnifePress
201,0
In seguito saranno presi in esame i vari modelli di orologi solari fissimedioevali. Ogn i tipologia di suddivisione oraria (72, 4, 6, B, 10,77,13 e 16
parti) sa rà analizzata approfonditamente.Sebbene l'archivio ODP raccolga solo gli orologi solari fissi, non è
possibile sorvolare su quelli portatili che anche nel Medioevo abbondavanodi modelli. Si cercherà di descriverli al meglio anche se non è possibile trat-tarli con maggior approfondimento (gli orologi solari portatili richiedereb-bero un lavoro a parte) senza uscire inevitabilmente dai propositi di questoparticolare studio. Nonostante tutto, sarà dato uno spazio adeguato ad ognitipologia (primitivi, cilindrici, di altezza) e ad ogni genere (azimutali, not-turni, schemi delle ombre, candele e stelle, astrolabi e quadranti).
In ultimo, con l'aiuto di numerosi esperti di altri Paesi, si indagheràsu eventuali legami culturali con altre terre di cultura cristiana. Se possibilesaranno, inoltre, prese in esame le vie di pellegrinaggio (la via per Santiagodi Compostela, Francia e Spagna;le vie dei Romei, Italia;la via per Ceru-salemme) e le grandi strade che univano le popolazioni migranti dell'Eu-ropa medioevale per confrontare lo sviluppo stilistico e gnomonico degliorologi solari medioevali in: Germania, Grecia, Austria, Francia, Yugoslavia,Inghilterra, Irlanda, Scandinavia, Israele ed Armenia.
6. Censimento
I1 censimento vero e proprio sarà curato apatte, suddividendo le aree geo-
grafiche della nostra penisola in regioni e maclo-Iegioni (secondo il numerodi manufatti presenti o censiti). Ogni area sarà fornita di mappa provinciale,lista completa degli edifici religiosi presenti e visitati. Ogni orologio solaresarà descritto in una scheda specifica.
MaRia TpRrsa BaRrorr
IN FORMA DUNQUE DI CANDIDA ROSA.UN DISECNO GOTICO PER FIRENZE
Abstract. At the end of theDivina Commedia, Dante comes into "Empireo" (the
Iranaenly Jerustilem), the city of Angels ond Blessed People, in the form of a circularplnce, okind of amphithecLtre. The metaphor of the rose explains the symbolic mean-irrg of the city layout. Such on idea of tozun design is not testified in Gothic West
I',trope. A disctLssion nbout circular themes appears in o Medieaal Treatise of Math'tmatics written by Paolo Dell'Abbaco, contemporary of Dante. He gioes the rule
lir doubling, tripling, quadrupling the area of a giaen circle. The eighteenth centuryrrttp of Florence, analysed roith n metric ruler, reaesls that the great Gothic Monas'I trics are so placed that the churches fagades ore on the border of concentric circles,
rlrnutn so that etLch circular crozon in seqlLence has the same area of the inner circle,tlnt includes the ancient town. In 1265, Pope Clemente lV issued s bull in rohichIrt cstnblished that, infaaour of the Minors order, other urbtut religiotLs Ordersr o t rld not build inside n circle of 300 canne (: m 597 ) sround the church of the Mi-trors Order. The menning of the bull is probnbly at the origin of the urban layoutrtl rt'ligious buildings in Florence.
(lrrosta comunicazione riporta g1i esiti finora raggiunti nel corso di una ri-( ('rca condotta in margine ad alcuni estesi rilievi compiuti negli anni scorsi
l)(.r conto del Comune di Firenze su due grandi conventi, iI Carmine e S.
Mirria Novella. Lo studio della loro disposizione nel tessuto della città fa-( ('vr emergere alcune singolari circostanze che ponevano degli interrogativi,ri tyr-rali si è cercata una risposta: essa si è articolata in un complesso di-:;( ()l"so, che in maniera interdisciplinare ha coinvolto altri ambiti del sapere,, , , r I la f ine ha descritto uno scenario che allarga in maniera inattesa il quadro,lr,lla cultura architettonica nella Firenze del tempo e ne evidenzia la dipen-,1,'nzar dalle forme piu alte del pensiero scientifico contemporaneo, la rifles-,,iorrc sul cielo fisico e teologico.
Nei tre canti finali della Diains Commedia, Dante ha raggiunto l'Em-
l,in'o, luogo supremo del Paradiso. Fuori da1 primo mobile, si trova "il ciel, lr'i' pura luce», che accoglie le due milizie del Paradiso, i Beati e g1i Angeli.t,irrnto ad esso, Dante, superato l'iniziale accecamento, vede un,,lume inIolnra cli rivera / fulvido di fulgore, intra due rive / dipinte di mirabil pri-r r r, r \,('r.'r,>r . Mentre egli si sporge per abbeverarsene, il fiume si trasforma inrrrr,r lisLrra rotonda come un lago circolare. Sul pendio fiorito circostante,',1,r't t lriantesi nell'acqua luminosa, quasi un anfiteatro formato da "mille',r rl lit',,, sono disposti tutti coloro che dopo la morte sono tornati all'Empi-
I t,rtk,, l)iitiua Commedia, Paradiso XXX 61-63.
( r.) 63
reo. Beatrice, conducendo Dante «nel giallo della rosa sempiterna / che si
dilata ed ingrada e redole / odor di lode", 1o aiuta a comprendere ciò che
vede, svelandone la natura: .Mira / quanto è il convento delle bianche stole!
/ Vedi nostra città quanto ella gira!»2. Le "bianche stole» sono l'epiteto che
nell,Apocalisse di Giovanni indica i Beati della Gerusalemme Celeste.
Come si è formata in Dante questa immagine della città celeste, «in
forma di candida rosa», sorta di anfiteatro fiorito intorno ad un'orchestra
di luce?La Gerusalemme celeste dell'Apocalisse di Giovanni non era una
città polare, bensì una città di assi ortogonali: «La città è a forma di qua-
drato, la sua lunghezza è uguale allalarghezza. I-angelo misurò la città con
la canna: misura 12000 stadi; lalunghezza la larghezza el'altezza sono
eguali. Ne misurò anche le mura: sono alte centoquarantaquattro braccia,
sàcondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo [...]». Inoltre,
è costruita di pietre e metalli preziosi. Inmezzo allapiazza della città c'è
un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturisce dal trono diDio. Il tema della città di matrice circolare non appartiene a questo riferi-mento, esso entra nella storia dell'urbanistica piu tardi, con le città ideali
dei trattati d'architettura del Rinascimento'Una particolare discussione sul cerchio, che può avere relazione con
Ia figura descritta da Dante, è in un'opera appartenente ad altro ramo della
scienza medioevale.Nel Trattato d'aritmeticL del pratese Paolo Dagomari (detto dell'Ab-
baco, uno dei piìr autorevoli maestri d'abaco del suo tempo), la Rngione 130
si occupa di un uomo cui è affidato, insieme ad un compagno, il gravoso
compitò di levigare una immane macina del diametro di 10 braccia (quasi
6 metri). Egli chiede che venga definita una regola che ripartisca in maniera
equa il lavoro tra lui e il suo compagno, in modo che entrambi siano sotto-
pòsti alla stessa fatica. Il testo è molto efficace: .Due uomini hanno una
iuota, che è il suo diametro 10 braccia. Dice l'uno: voglio lavorare la mia
parte, cioè vz di questaruota. voglio sapere quanto diminuirà il suo diame-
iro. Fà così: moltìplica il diametro per se stesso, che fa 100 e poi, perché tudici che sono 2, dividi 100 in due, che ne viene 50; ora dirai che la parte che
tocca al secondo, cioè quella che rimane, è la radice di 50, e quella che lavorò
il primo è tanta quanto è dalla radice di 50 alla radice di 100"3.
L-argomento è l'occasione per svolgere il tema del calcolo del raggio
di cerchi di area pari alla metà, ad ur]rtetzo, ad un quarto e poi doppia, tri-pla, quadrupla etc. di un cerchio di area nota. Il tema è molto simile ad unàltroìelebeirimo, tramandato dall'antichità classica e divenuto familiare
alla cultura architettonica: dato un quadrato, costruire quello di area di-
2 f)arrtc, Diztina Comntedia,Paradiso XXX 124-130.,' Allitr:l lr (1964). Paolo del1'Abbaco, nato a Prato ne1128L, morto a Firenze nel1374ltr (rtto clci piÙr ar-rtorcvoli maestri di Abbaco del suo tempo'
64
rrrr'.'.',rl,r. Nt'l Mr'ltottr', l'lattltrc ltl risolvc dando con esso un esempio del
I'r,,, r,,lirrrt,tttrt rttaictttico. La semidiagOnale aPpare cOn evidenza.come Ia
lr rrrlilrcz z,t tlt'l lrrkr clcl cltraclrato .e..uto, con il rapporto U!2-con il lato del
g,,,,',ì,, (lu,t(lt.irt(). Analclgamente, Ia soluzione del problemadei cerchi è af-
ir,l,rt,r ,rl rrrrrrrt,ri raclice .,i Ia serie ^l2,.rb,r/4 etc. risolve il raggio dei cerchi ri-
, lrrr,,,tr. M,rt'slro l)aolo indica Ia soluzione aritmetica, ma dietro questa, per
r| il.rr lrio (,()ll1(, pcr il quadrato, esiste la soluzione geometrica, per cui il cer-
,lrr,,,li ,r't.ir rl.ppia hà il raggio pari alla diagonale del quadrato costruito
.rrl r,r1i1,,i.dcl primocerchiòllcòrchiodiareatriplahailraggiopariall'al-t,,...,,r tit,l triarrgolo equilatero il cui lato è il diametro del primo cerchio, il,,'rt lrio,li irrea quadrupla ha il raggio doppio rispetto a quello del primo
llrAl tli le\ del problema che assilla i due operai che levigano la macina,
1,,1r ,,,,t,r,t,izi .lcscritii, una volta disegnati sulla carta mostlano con evidenza
1,, l,,,,,,sPt,cificitàdistrumentoattoacostruireunadivisioneinpartiugualirr r, ,llr I Pir rt icolare. A parte lo scalpellino, a chi altri poteva giovare una simile
, , ',,llttzitlltC?IJrtaraggierachedivideinpartiugualil,angologiroaiutaaintrave-
, I r ,r (, r I rì p,,rribìl" obbiettivo degli esercizi: la costruzione di lotti di ugual,,r r1,r,r.lir.ic all'interno di una estensione circolare, equivalente all',operazione
, lr,, l'rrr.[rar.ristica del tempo andava facendo ne1le estensioni rettangolari.
l,it llngione 130 foràe conteneva il procedimento tecnico utile per di-,,r,l,,n,rr(, la ciità polare, in alternativa alla città ortogonale (Frcc. 5.1a. 5.1b.).
Ncl 1265 Papa Clemente IV emanò una bolla a favore dei conventi
,lr,r M intlri francescani: a loro vantaggio era proibito a tutti gli altri ordini
,lr t,()slrUire entro un raggio di 300 canne dalla chiesa dei Minori (infra spa-
Itrttrr 300 cannarum orrrlrlt Ecclesiis mensurandarum).Questahtnghezza,lad-
r lr rrrt. rìon possa essere misurata direttamente, dovrà esserlo per aerem (per
trr,tr,ttr ctiqm ubi rilias recte mensurari loci dispositio non permettif)a. Quale sia il,, r1,,rr il icato di questa espressione è attestato d a alcuni esercizi di celerimen-,,,ì,.,r riportatinelCodiCeOttobonianoLatino330TdellaBibliotecaVaticana1,,t't' XV), attribuiti dall'autore del codice all'insegnamento-del maestro fio-
r,t,rr I irrrr Gra zia de' Castellani (nato forse intorno al 7364)5 . Essi risolvono
l,r.oblcrni di calcolo delle distanze tra punti situati su luoghi di diversa ele-
,,,,ri,,rre ed in piano, in una casistica di situazioni tipica del rilievo topogra-
lit,o sia territoriale che urbano (testo e figure fanno riferimento sia a torri
:;rrlla cima di monti che a torri di palazzi o chiese), mediante iI ricorso ad
rrrro strumento molto semplice e accuratamente descritto, Che, applicando
rrrr principio stereografico permette di calcolare le distanze attraverso la
rrrira d"a dìe punti idi"tun ucostante. In tempi precedenti, già il Fibonacci
I Nclla bolla la canna è indicata come quella romana di octo palmorum
'Arrr<rcnt (1967).
65
{
nella Settima distinzione del suo trattato si era occupato del1a misura dellealtezze e delle profondità e delle lunghrezze in piano (Ftc. 5.3.).
AFirenze, la politica dell'inurbamento dei conventi degli ordini men-
dicanti nel 1265 era già in atto, e il metodo topografico del "misurare perl'aria" , data la dimensione e l'ambizione della città, poteva essere ben noto.La bolla di Papa Clemente non ha valore retroattivo. Essa è molto chiara inproposito, vale dal momento in cui è emessa in poi: non riordina l'esistente,
rna indirizza il progetto della città. E anche molto dettagliata sulla misurache impone: si tratta di trecento canne di 8 palmi. La canna di 8 palmi a
Roma è la canna mercantile, lunga m 7,991, circa.300 canne (2400 palmi)ammontano art597,3. A Firenze la misura corrispondente, con analogo ca-
rattere di rotondità, poteva essere di 1000 braccia fiorentine, pari a m 583,6,
corrispondenti a 200 canne agrimensorie (1 canna = 5 braccia) o 250 canne
mercantili (1 canna = 4 braccia).Se sulla pianta ottocentesca della città andiamo a cercare gli esiti
della bolla pontificia, con l'ausilio di un regolo commisurato alla lunghezzadi 1000 braccia fiorentine, vediamo affiorare uno straordinario disegno dicui maestro Paolo ci permette di capire la regola e Dante il significato. Ledue chiese maggiori degli ordini mendicanti, la francescana S. Croce (A),
fondata nel 1,289, e la domenicana S. Maria Novella (B), fondata nel 1279,
sono collocate in modo che la distanzatrai loro prospetti è di 2000 bracciaesatte, lungo un asse sul quale è appoggiata S. Croce, inclinato di 60' ri-spetto alla direzione nord-sud, secondo la quale è orientata S. Maria No-vella6.
Il centro di questa distanza cade nel punto in cui l'asse descritto in-terseca la via del Corso, decumano (asse est-ovest) della città antica. In talepunto si apre lapiazzetta che incrocia via di S. Elisabetta (C), sui cui verticisi levavano 3 o 4 torri. Ancora oggi, sulle due facce dello spigolo sfioratodall'asse descritto, due lastre di marmo bianco portano la croce rossa, em-
blema del Popolo Fiorentino. Il luogo si chiama Canto alla Croce Rossa (Ftc;.
5.2).In un cerchio con centro nel Canto alla Croce Rossa e raggio 1000
braccia, il diametro ortogonale all'asse sopra descritto si appoggia sull'asst'di ponte Vecchio, e il suo estremo sud sta sulla facciata della chiesa di S.
Felicita (D). Il diametro S. Croce-S. Maria Novella, prolungato di 1000 brac-cia verso sud-est, termina sul nodo rappresentato dalla torre Reale (poi
della Zecca)7 e dalla pila del previsto ma mai tealizzato ponte Realc (T);
6 Le date di fondazione hanno f importanza reiativa di termine post qucm rrort, pt'rr'lttlil progetto, e soprattutto f idea della Tocalizzazione delle chiese, ptrr\ r'sscrt' prt', t'dente anche di molti anni.7 Sulla riva dell'Arno, in prossirnità della pila del pontc Rcalc, porrtc Pr()rl('ss()/ rìì,r
:mat realtzzato, a calrsa dcgli cvcnti scguct'tti alla tlortt'cli Carlo d'Angiir, tli t tri l,r
[ril,t littt;ts,' t tttir.r It'sl itttortiitllz.t.
(r(r
l)r'olLtrlgato verso nord-oves! si appoggia in prossimità del convento delle
I )omenicane in via della Scala (O).Il cerchio di diametro 4000 braccia interseca il diametro nord-sud nel
t orrvcnto di S. Caterina d'Alessandria (P), vertice di un triangolo equilatero, li crri il segmento torre Reale-S. Maria Novella rappresenta l'altezza. Que-,,to ccrchio racchiude una superficie 4 volte più grande di quella del primor t'r'chio, di raggio 1000.
Il cerchio avente come raggio la diagonale del quadrato di lato 1000
r,rt chiude una superficie 2 volte piu grande l'area del primo cerchìo.
Esso incontra l'asse est-ovest (via del Corso) nel suo estremo (piazza'; Arnbrogio) proprio sulla facciata della chiesa (E)8; di 1à d'Arno trova poilt l.tittzzadel convento di S. Spirito (F) vicino alla sua scalinata e, passato ilI rr uìrc, sfiora la facciata di Ognissanti (G).
Il cerchio avente come raggio il doppio dell'altezza del triangolor .r
1r rilirtero di lato 1000 (ovvero 1000 !3) racchiude una superficie 3 volte piu
,ir,ilrcle di quella del primo cerchio. A sud dell'Arno esso passa per la chiesa
,lcl convento del Carmine (M) e sfiora la chiesa del Cestello (N), a nordt, rr t ir il convento di S. Domenico al maglio (H), e S. Teresa (L) '
I tre giri che abbiamo finora descritti, di raggio 1000, 1000!2, 1000!3,
,lr,lt'rminano tre figure, un cerchio e due corone, aventi la stessa superficie.II cerchio avente come raggio il doppio del raggio del primo cerchio
( , ,\'\,('ro 1000 {4) è già stato descritto. Ora consideriamo il cerchio di raggiot{)()0 \/5 (misura della diagonale del rettangolo di lati 1000 e 2000 braccia),, lrt' r'omprende un'area 5 volte maggiore del primo. Esso tocca, a sud, lat,rr t iirta della chiesa del convento dei Camaldolesi (R) e, appena fuori ler r u r',r, tocca la facciata della duecentesca chiesa di S. Leonardo (S).
l-a serie di cerchi che è stata costruita definisce una successione di, rr r,'lli (corone) intorno al primo cerchio (di raggio 1000 braccia), aventi tuttil.r :,lt,ssa superficie, uguale a quella del primo cerchio (FIc. 5.4.).
I-a disposizione dei punti individuati sembra avere come riferi-rìu,rìt(), oltre ai giri anulari equivalenti, una ripartizione angolare secondo
r r,r,,r]i di una ruota in cui l'angolo giro è diviso sui multipli del 4, del 6 e
,1,'l rì.
Una raggiera di 60 raggi uscenti dal centro, unita alla serie degli, rr r,,lli, costruisce una sorta di griglia polare sulla quale la posizione dei con-
r r,nli ircr-luista una particolare evidenza, e diventa descrivibile con riferi-rrrr,rìto ad angoli e distanze. I1 territorio urbano risulta otganizzato da unat,r',',t'llatura che descrive lotti di ugual superficie, sul margine dei quali si
r r rllr )t iìno i conventi. La loro distribuzione nelle diverse direzioni tende al, r ,r r I r ollt) della diffusione delle strutture religiose nel territorio urbano'
I rr.r r.ltit'sa di S. Ambrogio era stata costruita in epoca precedente, ma la chiesa at-
trr.rl,,r,tlt'l XIII secolo e fu ricostruita spostando in avanti la chiesa precedente.
67
Se osserviamo il disegno ancora impresso nella struttura viaria dellazona alle spalle di S. Croce, vediamo affiorare 1o schema della tassellaturanel tracciato radiale attestato da una serie di vie (Borgo la Croce, via del-l'Agnolo, via Ghibellina, via dei Conciatori e via del Fico, via de'Malcon-tenti); via delle Conce le taglia adagiandosi proprio sul cerchio di areadoppia (Ftc. 5.5.). Si direbbe che la messa in opera di un complesso pianourbano sia stata tentata a partire dall'area compresa tra la torre Reale e S.
Croce, ma che l'eccessiva difficoltà della realizzazione abbia indotto a cer-care programmi e strade più praticabili, dopo che erano stati collocati alcunicapisaldi della misurata e uniforme distribuzione di lotti urbani a genera-zione circolare. Quale iI senso di tale piano?
La "misura del cielo" è presente nella struttura circolare del disegno,che articola una sequenza di anelli di superficie equivalente a quella delcerchio interno, il cui raggio, 1000 braccia, allude nel numero a perfezioniultraterrene. Il cielo è presente nel1a figura, nella idealità della regola, nellaperfezione metrica (anche per Dante il numero dei gradini dell'Empireo èdi mille); e lo scopo finale è il raggiungimento del requisito di giustizia checar atterizza la Gerusalemme Celeste.
Dante contrapporrà Firenze all'Empireo proprio con le parole: «io,che al divino dall'umano, / all'etterno dal tempo era venuto, / e di Fiorenzain popol giusto e sano / [...]". La città aveva tristamente tradito f ispirazioneche in un certo momento ne aveva guidato f idea, informata ad un alto ob-biettivo. Se non abbiamo frainteso il senso del disegno medioevale, intra-vediamo nella pianta di Firenze i segni non di una pianificaziot:re, ma diuna utopia grandiosa e difficilissima da attuare, non ancora una città ideale,ma molto più un semplice programma di assetto urbano. In questa utopiaun ruolo speciale è affidato ai conventi, gangli vitali dell'assetto urbano,promotori e custodi dell'ordine civile virtuoso. Essi si pongono come sen-tinelle a custodia di porzioni di tessuto urbano ben proporzionate, aIle qualioffrono le loro strutture rivolte a esaltare funzioni speciali della vita urbana:la scuola, l'accoglienza dei malati, le sale delle adunanze, etc. Il disegno so-gnato appare cerebrale e il suo fallimento sembra inevitabile: ma non pos-siamo non rimanere ammirati di fronte all'audacia del pensiero, al coraggiodel tentativo di messa in opera, rimasto impresso in segni di importanzaeccezionale per la storia.
Lintreccio di ispirazione nelle ricerche tra il cielo e la terra rende in-certa I'alternativa: è stata una meditazione sul disegno della città che haispirato l'Empireo di Dante o è stata una meditazione teologica che ha ispi-rato un'idea di assetto urbano?
Uunità di visione tra teologia, scienza, e arti rivolte al sociale, di cuiDante è un testimone eccezionale, corrisponde ad una tensione intellettualeche ha un tempo, una durata e una fine. A Firenze, degli aspetti urbani diquesto impossibile pensiero sopravvive in maniera limitata, alla fine delXIII secolo, la figura, il simbolo e lavorando su qrlesto si cerca una conver-sione di rotta del disegno della città. La rosa, simbolo di una dedica a Mariaconfermata anche dalla dedica della cattedrale a S. Maria del Fiore, viene
68
int'lusa nel leone disegnato dalle mura, simbolo cristologico del potere di-virro, e insieme della regalità terrena (Frc. 5.6.). Lamensurs cseli si è allon-lanata, ma ha lasciato agli uomini, come sempre, il rigore della scienza e leIt'crriche dautllizzare per scopi laicamente ritenuti piu avanzati.
ll i fc r im en t i b ib li o gr afi ci
Atttucur C. (a cura d1) (1964), PaoLo Dagomari.Trattato d'aritmetica. Secondola lezione del Codice Mngliabechiano Xl, 86 della Biblioteca nnzionale di Fi-r enze, D otrrus Cali laeana, Pisa.
Atrntcut G. (7967), Un estrotto del De'oistL di Ml Grszia de' Costelloni, in Attidella fondazione Giorgio Ronchi e Contributi dell'lstitttto nazionale di Ot-tica, 30 11 (Gennaio-Febbraio), Arcetri, Firenze, pp. 44-58.
ll. (Jtl/l{}l{§ffi} l}l Àl{ÉA lX}}}}lA I: I}l À*.HÀ I4Laà.\" ilr\t." ML.}it}Nh $l t}I,Àlt}S}i
A*-24
Il-_-
ffiA
69
Iitt;.5. Ib. CLtslruzionedeicerchiclinreadoppia,tripla,quadrupladiquelladiuncerchiodoLLt
cfltclI Dr ArìHÀ DoPptA, 1R]H..A. TIUADRUI'1,A" QrJlMtJpl-A EtCì.
./-T\.tÌ?da PÀOI.{) Di-:I,1,'ARBAa{}
Ftc. 5.2. Il Canto alla Croce Rossa in aia del Corso a Firenze
'',,ffi,lffiI
I
lìrr ;. 5.3. Maestro Grazia dei Castellani, illustrazioni tratte dagli esercizi di misura delle di-'.lturzt tra torri
9". Eci essendo in fra 2 torrj o vero in tra 2 monti, ,: volessi sapere quentoò tloll* sommità <Iell'uno alla sommità dell'altro, è di bisognio, acciò'ch'à meglicclronprendere, fare al detto strum€nto uca misula eguetJisÀnre et i.gu*lj ult* i*tr:.rlr:., che s*rà arrchora 4 braccia. Ola pogniamo clre io {r:*si in {lalla tqrre.*i:, *r
rrl .b.. Benchè m+lfi sien* e'rnr:di, togli {L1e§10: ehe tu 6:igi.tr Llx'}0 s66uineqto fstto
in quur,o rnotJo qui d,Lllato cliscgniaro; cioè i pertiche cleile gual! Ie 2 sicnoperfendicularj *i1'ajma et theingul:gnm5l n§ll' est!:errx1trt. .L,, lle Z §Ieilo d1 luflBnea*
ii I irla**i*, ciaè mllo stattlra d'uolno, e queltra ehe è per b*se si* di qur*te
br:accin vuoj; rna qÉsnto è minore pi* è betrl* il s:od*; diciamo sia di 4 braceia,
lll quale sÈrrlfrreÈtf) pr:s* in *ul dette spighcl,: ifl il1od* ehe '1 purrt* "d. sia ln sul
prrnt* .*"0 et la llr.reu .de. sia une cholls lines .4b,. E quesro fatt*, e tu poni r-rnrr
1rt\
fii,"* Ii*; rln l
f.*'t rlb.'l "fili"
siS..S*H
d-*'.d"6$ri., S
",f14it41{" rlrr *lil-tr-. ril].dl.r*,: gsil r
70 71
Frc. 5.4. La distribuzione dei conttenti gotici a Firenze
72 73
lrrr ;. 5.5. Proiezione di uno schema di lotti commisurati sulla pianta ottocentesca di Firenze
Ftc.5.6.Geometria dei conztenti e geometria delle mura gotiche a confronto
ii+.,;iii,
74 75
Paolo BsRrel-orrr, MAURo LuceDr BERNARU,IzxsprAlcorsa E MARIA CureRa BoNoRe
GEOMETRIE PER IL DISEGNO DELLA TERRA E DEL CIELO-
Abstract. «'Nhy eaery project has been built on geometrical basis? lt is not suffi-t'ir'rrt to say that geometry, measure, etc.help the designer to conaey to thebuildertt rule for realization. The analysis of some forms introduces doubts that something
tttorc may exist; why bring all to unity, why establish a code for reading architecture
:;o t.ffectiae as to be rediscoaered qnd reread in the sttme way after many centuries?
It r the code there is all sense of the ancient artist, who fitted into his historical period
t tirrterpreting rules, aesthetic and stylistic canons, but with continuous fear to be
Iortotten. There is the fear of man to be abandoned into oblittion, to be not part ofItistory. There is aproblem of communication, not only transaersal (communicate
rr llnught thqt must be reqlized) but qlso zterticql (communicate in time a thought
lltul goes beyond dffirent cultures and that csn be interpreted and deciphered
llrrough the chosen code). If the code is geometry (built with knorun tools, propor'liotts, relstions, etc.) the code is uniaersal ond recoaertlble». Qv1.g. Bonora)
l. ()cometria
,,1 )i tutte le scienze, - dice Voltaire - "la più assurda, la piu capace di sof-
Iocare ogni specie di genio è la geometria. Questa scienza ridicola ha peroligctto superfici, linee, punti, che non esistono in natura [...]. La geometria,irr verità, è uno scherzo di cattivo gusto»1.
(]rrnndo leggo questa frase, ottengo reazioni contrastanti: sconcerto, appro-v,rzione e/ una volta... anche un applauso.
Perché molti studenti non amano la geometria e ne sono così di-:rlirrrti? Forse perché la geometria è astrazione ed appare distante dallan'irlta\ materiale.
Proviamo invece a pensare alla geometria come al sostegno di ogniIor.na costruita, come allo strumento ordinatore del pensiero spaziale, che
t'onscnte di definire la forma a cui la materia si appoggia.
' lillborazioni grafiche a cura di Izabel Alcolea.I Volta ire, Jannot et Colin, in SpecNol (1983).