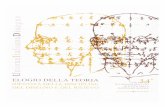Chora 16 - Tracce senza memoria, memorie senza traccia
Transcript of Chora 16 - Tracce senza memoria, memorie senza traccia
EDITORIALE
Chora N. 16, Settembre 2008
Si è sentito ripetere spesso, di recente, che l’Università italiana sta attraversando una fase di crisi.Una crisi che risuona con la più ampia crisi economica globale e che, per chi vive la vita accademi-ca, sembra amplificare lo stridio minaccioso del suo incedere. Prendiamo atto della subitaneità edella veemenza con cui l’incertezza sembra aver stretto i progetti e le aspettative di tutti, spingen-do i Rettori a esprimere una viva preoccupazione per i tagli contenuti nelle direttive ministeriali egettando intere generazioni di ricercatori, o aspiranti tali, in un’inquietudine non meno acuta, cheva assumendo non di rado toni cupi e angosciati. I filosofi sanno anche che crisi vuol dire passag-gio, svolta, e quindi opportunità di adoperarsi per dare un senso al futuro; opportunità che nonpossiamo fare a meno di collegare alla speranza nei principi di meritocrazia e di trasparenza aiquali la riforma dichiara di ispirarsi. Se si tratti o meno di una speranza ben riposta potremo valu-tarlo forse soltanto a cambiamenti avvenuti, tra qualche anno: il timore diffuso è che però, a quelpunto, il rimedio possa scoprirsi fatale al malato, e allora o la riforma sarà riuscita a uniformarel’Università tarandola sugli standard europei dell’efficienza, della valutabilità e della responsabili-tà, oppure probabilmente non avrà lasciato più alcuna università da potersi confrontare con quel-la degli altri Paesi. Quale che sia l’esito di questa crisi, rimane dolorosa e dilemmatica la situazio-ne di un sapere, quello filosofico-umanistico, che si distingue da tutti gli altri perché obbedisce aun diverso principio di efficienza e di merito, essendo chiamato a fondare autarchicamente, nelproprio esercizio vitale, le sue condizioni di verità. Potrebbe quindi essere onesta la domanda chechiede: come costringere questo sapere entro le maglie di oggettive valutazioni di efficienza, vistoche esso non potrebbe lasciarsi valutare se non attraverso i criteri della propria preziosissima, irri-nunciabile, inutilità? Bisogna forse sfruttare strategicamente la forza propulsiva del Maelstrom peruscire dalla sua spirale; non disponendosi a remare velleitariamente contro la corrente del vortice,ma impostando le proprie rotte filosofiche in maniera da rasentarne il baratro, avendo l’accortez-za di non essere trascinati a fondo.La Redazione di Chora, oggi, preferisce sospendere qualsiasi giudizio su questi argomenti, riman-dando l’approfondimento degli aspetti sia filosofici che tecnico-amministrativi a un possibile futu-ro confronto con le testimonianze delle persone più competenti e rappresentative dei processi chesono attualmente in corso. Nel frattempo, dedichiamo questo numero di Chora alle madri e aipadri che, in Italia, ancora mantengono i giovani ricercatori, così come quelli non più tanto giova-ni; madri e padri cui toccherà, ancora una volta, sostenere e accompagnare i destini dell’Università.
La Direzione
Chora N. 16, Settembre 2008
DossierMEMORIE SENZA TRACCIA, TRACCE SENZA MEMORIA
a cura di Massimiliano Cappuccio e Claudio Paolucci, p. 3
Se i libri non bastano? Le nebbie della memoria e i segni dell’autobio-grafia. Intervista a Umberto Ecoa cura di Massimiliano Cappuccio e Claudio Paolucci, p. 4 Memoria culturale e processi interpretativi. Uno sguardo semioticoDottorato in Discipline Semiotiche (SUM-Università di Bologna), p. 7 A scuola di segni. Il SUM e il Dottorato in Discipline Semiotichedell’Università degli Studi di Bologna. Intervista a Patrizia Violi a cura di Claudio Paolucci, p.30 L’immemoriale e la parola poeticadi Carlo Sini, p. 32L’oblio, il segno e la storia: la memoria in Heideggerdi Roberto Terzi, p. 35Memoria del non vissuto. La “visione degli anni” in Proust e Bergsondi Sara Guindani, p. 40Storia delle idee e arti della memoria. Intervista a Paolo Rossia cura di Massimiliano Cappuccio e Andrea Tortoreto, p. 47Dove sta il pensiero? Breve excursus sui progetti di lingua universale prima di Leibnizdi Rossella Fabbrichesi, p. 51La chimica dei termini. Un caso di mnemotecnica applicataalla generazione del lessicodi Paolo Valore, p. 57Maria Michela Sassi, Tracce nella mente. Teorie della memoria daPlatone ai modernirecensione a cura di Lorenzo Perilli, p. 61Quanto è veritiera e stabile la memoria?di Alberto Oliverio, p. 64Lo spazio della memoria: il senso del movimento e i ricordi in azione.Intervista a Alain Berthoza cura di Massimiliano Cappuccio, Emiliano Trizio, Martino Incarbone,Lodovica Maria Zanet, p. 70Come l’intervallo degli alberi fra gli alberi. Memoria, inconscio e oblionella fenomenologia di Merleau-Pontydi Lorenzo Altieri, p. 77Memorie oltre le generazioni. Memi, segni e neuroscienze cognitive perun’ipotesi evolutiva della culturadi Angelo Recchia Luciani, p. 85Silvio Ceccato e la meccanizzazione della memoria. Soluzioni fin troppoben localizzate di un antilocalizzazionistadi Roberto Bottini, p. 93
FILOSOFI A MILANOAntonio Banfi. Dal pacifismo alla questione comunista.Tre domande al professor Papi,a cura di Alessandro Sardi, p. 98Filosofi a Milano 3: Giovanni Emanuele Barié,a cura di Davide Assael, p. 100
OSSERVATORIO SULLE RIVISTELa Filosofia torna a scuola,a cura di Massimiliano Cappuccio, p. 101Comprendre, Archive international pour l’Anthropologie et laPsychopathologie Phénoménologiques, p. 105
IN LIBRERIA p. 106
La rivista è promossa e realizzata dal lavorovolontario e gratuito degli studenti e degli studio-si che compongono la redazione; viene pubbli-cata da Symposium ed è distribuita attraverso icanali della Rete Interuniversitaria Symposium.Questo numero nasce da un’idea degli studentidell’associazione studentesca “Chora”dell’Università degli Studi di Milano, che lohanno programmato e curato, e si avvale dellacollaborazione del Dottorato in DisciplineSemiotiche dell’Università di Bologna.Questa pubblicazione è resa possibile da uncontributo messo a disposizione dall’Universitàdegli Studi di Milano per le iniziative culturali stu-dentesche dell’a.a. 2007-2008, secondo quantoprevisto dalla Legge 429 del 03/08/1985. Lecopie prodotte con questi fondi vengono distri-buite gratuitamente tra gli studenti, i ricercatori ei docenti dell’Università degli Studi di Milano, iquali sono invitati a contattare la Redazione perricevere la loro copia gratuita. La rivista è distri-buita gratuitamente presso le bibliotechedell’Ateneo di via Festa del Perdono e in variDipartimenti dell’Università degli Studi di Milano.L’editore Symposium si riserva il diritto di pubbli-care, a proprie spese, ulteriori copie per la distri-buzione negli altri atenei italiani, tra i propri asso-ciati o nei circuiti librari. Qualora la Redazionenon fosse riuscita a rintracciare i titolari del domi-nio delle immagini utilizzate, essi sono invitati acontattarla per far valere il loro diritto.
Anno 7 - Numero 16 - Tiratura: 3000 copie.
Direzione editoriale: Andrea Polledri, NicolaSpinelli.
Direttore responsabile: MassimilianoCappuccio, Erasmo Silvio Storace.
Redazione: Davide Assael, PierpaoloBonfanti, Andrea Polledri, Davide Rizza, NicolaSpinelli, Francesco Cattaneo.
Hanno collaborato a questo numero: Lorenzo Altieri, Roberto Bottini, RossellaFabbrichesi, Sara Guindani, Martino Incarbone,Claudio Paolucci, Angelo Recchia-Luciani,Alberto Oliverio, Lorenzo Perilli, Paolo Rossi,Alessandro Sardi, Carlo Sini, Roberto Terzi,Andrea Tortoreto, Emiliano Trizio, Paolo Valore,Patrizia Violi, Ludovica Maria Zanet
Impaginazione e grafica:www.labombetta.it
Laboratorio di attualità, scrittura e cultura filosofica
Pubblicazione registrata presso il Tribunaledi Milano in data 20-9-2002 al numero 458;
ISSN 1974-1979.E-mail: [email protected]
In copertina: Saturday Works, 1996, di Peter Russell (paper collage on plyboard, lead metal, acrylic paint, oil glazes,honey, was, flowes of sulphur, etc.). Il dipinto è conservato presso Iris Murdoch Building - Università di Stirling, Scozia.
Peter Russell ha esibito estensivamente sia in collezioni pubbliche che private, ed è rappresentato in Scozia, Inghilterra,Irlanda, Francia, Germania, Polonia, USA. Il suo approccio si è evoluto dalle basi del disegno e della pittura nel corsodegli anni, includendo collage, assemblaggi e costruzioni 3-D. Le esibizioni da solo e in gruppo tendono ad avere unnucleo tematico suggerito dai luoghi, dalla storia, e da situazioni sociali o mentali, ucleo che si arricchisce progressiva-mente di una rete di immagini e testi collegati. Questi, a loro volta, suggeriscono soluzioni formali come, ad esempio, light-box, scavi archeologici, video, o spazi di istallazione. Spesso i media mescolati e sovrapposti includono pittura, superficidi metallo, cera e miele, tessuti e cenere, esibendo un dinamismo inquieto piuttosto che un’immobilità totemica.
3introduzionE
Chora N. 16, Settembre 2008
Dossier
MeMorie senza traccia,
tracce senza MeMoria
a cura di MassiMiliano cappuccio e claudio paolucci
Il paradosso delle scienze della memoria (storia,paleografia, archivistica, biologia evolutiva, neu-roscienze, semiotica…) consiste nel fatto cheesse, per loro costituzione, devono restare imme-mori delle proprie origini, ovvero delle condizio-ni di possibilità e dello sfondo di senso che nehanno consentito l’avvento. Se la scienza dellamemoria potesse r icordare l’evento che l’ha pro-dotta, allora questo evento farebbe parte dellascienza stessa, come suo risultato, e non potrem-mo più dire che stia a monte di essa; se peròl’evento che ha generato la scienza della memo-ria fosse tutt’altra cosa rispetto a questa scienza,allora non potremo mai sostenere che quest’ulti-ma abbia potuto interrogare seriamente i propripresupposti, risultando quindi – i n ultima anali-si – infondata e infondabile. Questo paradosso,insieme al fatto che (in qualche modo anch’essoparadossale) possiamo sempre ricordarcene eavvalercene criticamente, illustra come dietro lamemoria di cui la conoscenza si nutre (la memo-ria dissezionabile scientificamente e infinitamen-te riproducibile, perché intesa come testo, sup-porto di tracce o stratificazione di segni nei qualiil ricordo sarebbe iscritto), debba esservi ancheun’altra memoria. Una memoria che non consistein una capacità di agire della traccia, e che tutta-via è efficace proprio in quanto immemorabile èl’azione del segno scritto; che richiama proprioin quanto innominabile è il chiamare come fun-zione della traccia. Questo secondo tipo dimemoria non è più fondamentale o più arcaicodel primo, perché non conos ce alcuno originariosfondo di ricordi che possa rammentarci una suaipotetica priorità; è una memoria che non si con-serva né si accumula in ragione della permanen-za dei supporti; non conosce debiti, perché vive isuoi obblighi come estemporaneo ri-conoscimen-to che avviene anche sempre però come travisa-mento. Accadendo inavvertitamente nella cadu-cità dell’istante, ovvero nella possibilità aperta diun’infinita, e infinitamente produttiva, modula-zione obliosa dell’eternità. Questo dossier nasceper cercare di tematizzare la memoria come rica-duta inconsapevole, e tuttavia sapiente, prodottadallo sforzo di arricchirsi senza conservare, disapere senza trattenere, di governare il cambia-mento senza per questo illudersi di aver fissatouna regola che ne consenta la riproduzione iden-
tica. Modul iamo questo tema seguendo l’intrec-cio di tre grandi motivi: il primo, di naturasemiotica, approfondisce il rapporto che sussistetra ricordo e segno, e si giova della collaborazio-ne con la scuola di dottorato dell’Universitàdegli Studi di Bologna, con il prestigioso contri-buto offerto a Chora dai suoi studiosi illustri cosìcome dai suoi esponenti più giovani. Il secondomotivo, storico-filosofico e teoretico, è a suavolta articolato in due direzioni diverse: da unaparte approfondisce il ruolo che la memoria havia via assunto durante il corso della storia delleidee – fino a documentarne gli esiti più recenti -attraverso la maturazione dei grandi progettisistematici dedicati alla linguistica universale ealle arti della memoria; per altro verso, questasezione interroga il ricordo come sfondo impen-sato – e tuttavia concretamente agito - di ognistoria dei ricordi, ovvero come scrittura narranteche intende ricamare sempre nuovamente, in unatrama di storie e di figure, il senso del proprionarrare. Il terzo motivo, di argomento cognitivo ebiologico, approfondisce invece – e mette indiscussione - il ruolo della memoria come facoltàmentale, come risultato di un percorso evolutivo,come disp ositivo formale di trascrizione neuro-nale, ovvero come strumento per la fissazione e ilrecupero dell’informazione all’interno di suppor-ti oggettivi quali il cervello e il DNA.Quest’ultimo sviluppo della nostra ricerca assol-ve un compito che, dal punto di vista delleopportunità filosofiche che esso suggerisce,risulta ironico e perciò potenzialmente autocriti-co: la filosofia aiuta a ricostruire il senso tran-seunte sottostante alla storia della scienza, mainterrogare lo sfondo filosofico che è implicitoalle tesi del sapere scientifico serve anche a ricor-darci, con un gesto filosoficamente necessario,che neanche la memoria filosofica può rendersalva la verità che ha prodotto. Per questo moti-vo - una volta interrogata la provenienza delletracce dei saperi che la filosofia dichiara di pot ercustodire - le stesse tracce del sapere filosoficodovranno esaurire, o travisare, la propria inten-zione significativa, tramontando nell’oblio.Fondando quindi involontariamente una nuovascienza oggettiva del ricordo, una nuova erra-bonda narrazione destinata allo scacco di unsignificato irripetibile.
MEMORIA INDIVIDUALE E MEMORIA CULTURALE[Chora] Il tema della memoria attraversa in maniera
importante tutta la Sua produzione di narrativa, per nonparlare della saggistica; nel Suo ultimo romanzo - La miste-riosa fiamma della regina Loana – ne viene sviluppata lacomponente biografica e personale, maggiormente rispettoalle altre opere, dove se ne approfondiva soprattutto ladimensione storica, culturale, enciclopedica. Eppure, - emble-maticamente – anche nel sofferto lavoro introspettivo con-dotto dal protagonista del suo ultimo romanzo, un antiqua-rio affetto da amnesia, la memoria può essere ricostruita uni-camente attraverso il recupero delle letture che avevanoaccompagnato la sua infanzia e la sua adolescenza. Questopone il tema del rapporto tra memoria individuale e memo-ria culturale, che nasconde un altro problema sul quale lei hamolto lavorato, che è quello del rapporto che c’è tra il sogget-to e i segni enciclopedici che ne costituiscono l’identità. Credeche il tema della memoria possa essere un terreno privilegia-to per indagare questo tema così importante?
[Umberto Eco] Recentemente qualcuno in una intervi-sta mi chiedeva perché tutti i miei romanzi sono costruitia flash back – meno forse il Nome della Rosa, che è sì tuttoun flash back ma senza avanti e indietro. Invece gli altripartono da un presente, che magari continua a capitolialternati, ma continuamente il protagonista va indietro.Evidentemente il tema della memoria è centrale per me enon dimentichiamo che tutti i miei romanzi sono unBildungsroman. Non c’è formazione, crescita, conquistadell’identità, se non riandando indietro. Tutto questolavorio è quello che i seguaci di padre Pio chiamano inge-nuamente “anima”.
Si pensi alle idee sulla sopravvivenza dopo la morte: sibasano sulla permanenza della memoria. Facciamo infattila controprova: se ci promettono la sopravvivenza tramitereincarnazione, l’idea che sopravviveremo, poniamo, inuna mucca ma che quella mucca non si ricorderebbe diessere noi, e del nostro passato, questo tipo di sopravviven-za non ci interessa.
SE i libri non baStano?
Chora N. 16, Settembre 2008
4
se i liBri non Bastano? le neBBie della MeMoria e i segni dell’autoBiograFia
a cura di MassiMiliano cappuccio e claudio paolucciuniversità degli studi di Bologna
intervista a umberto eco
Umberto Eco. Foto Sergio Siano, 2008. http://dustinthewind69.splinder.com/
5umbErto Eco
Chora N. 16, Settembre 2008
Nello stesso senso una cultura è la memoria di una colletti-vità. Non identificherei l’enciclopedia con la memoria: essa èil magazzino collettivo per selezionare ciò che farà parte diuna memoria. Fa potenzialmente parte dell’enciclopedia ilnome del primo caduto della campagna di Russia (nellamisura in cui sia registrato da qualche parte) ma non fa partené della mia memoria personale né di quella collettiva (eppu-re potrebbe, un giorno o l’altro).
IDENTITÀ E LETTURA. ALLA RICERCA DELLAMEMORIA PERDUTA
Spostando la questione su un piano più filosofico, ma sem-pre in riferimento al problema del rapporto tra memoria indi-viduale e memoria culturale, vorremmo chiederLe se è possi-bile pensare alla memoria in un’ottica che riesca a svincolar-si da un modello concettuale tipografico, rappresentato daltesto, dal libro, dal documento. Il pensiero filosofico, almenoda Bergson arrivando fino a Derrida, passando per Husserl,Heidegger e Foucault, ha cercato di attingere una consapevo-lezza del flusso temporale che non riposasse sul paradigmadella semplice presenza della traccia, né sulla mera successio-ne lineare delle sue ripetizioni. Cosa resta di questi tentativifilosofici nell’epoca del predominio universale delle tecnolo-gie della scrittura? È ancora possibile immaginare unamemoria biografica basata sulla forza pulsante del vissuto,sull’esperienza della durata creatrice, sul senso del ritmo? Ese Platone avesse avuto ragione? Non è forse proprio l’ecces-so di conservazione archivistica o l’esattezza della cataloga-zione antiquaria a sprofondare i ricordi della nostra vita vis-suta nella nebbia dell’oblio?
Credo che la risposta sia implicita nella mia risposta prece-dente. L’eccesso di catalogazione è il WEB, ma la vitalità diuna memoria (che non sia la memoria WEB di Funes elmemorioso) consiste appunto nella selezione che sia noi chela cultura abbiamo fatto. Certamente l’eccesso di catalogazio-ne tipo WEB può indurre qualcuno a perdere la propriamemoria individuale. Così accade con l’eccesso di informa-zione sul presente dato dai media, che distoglie ormai i giova-ni dal ricostruire aspetti del passato, ed ecco coloro che nonsanno chi erano De Gasperi o Badoglio. ParimentiHollywood induce ormai a perdere il senso della differenzaontologica tra Spartaco e Vinicio di Quo Vadis, tra la contessaCastiglione e Elisa di Rivombrosa, tra Capitan Drake eCapitan Uncino, tra Buffalo Bill e Tex Willer. Si dissolve il con-fine tra reale e immaginario. In fondo quello che ci permettedi dire che il Benigni de La vita è bella è personaggio fittizio eSchindler è personaggio reale dovrebbe essere il fatto chericordiamo come sono entrati nella nostra vita, l’uno per viadi invenzione filmica e l’altro per via di apprendimento stori-co. Ma come farà chi ha visto entrambi solo al cinema?
SUI “NUOVI SUPPORTI”Nell’articolo “Memoria vegetale” lei aveva affrontato la
questione dei diversi supporti utilizzati dall’umanità perconservare la propria memoria. Abbandonati gli antichi sup-porti della memoria minerale (tavolette di argilla), e anima-le (le pergamene), la nostra civiltà ha a lungo prediletto lapraticità dei supporti di tipo vegetale (la cellulosa dellacarta). Ogni tipo di supporto dispone di caratteristiche pecu-liari e consente specifiche modalità di trasmissione del sape-re, in quanto medium capace di connotare la natura e il con-tenuto del suo messaggio. La questione diventa di estremaattualità con il ritorno dei supporti minerali, rappresentatioggi dai dispositivi di silicio che consentono la realizzazione
dei media informatici ed elettronici. Quali crede siano le par-ticolari novità che è giusto sottolineare a proposito del rap-porto tra i nuovi tipi di supporti e la conservazione dellamemoria?
La domanda non avrebbe senso se pensassimo a questisupporti come permanenti. Che un fatto ci venga conservatodalla carta o da un dischetto sarebbe irrilevante (come è irrile-vante che rievochi il passato su una fotografia in carta o sullastessa foto conservata nel computer). Il fatto è che un incuna-bolo può essere oggi fresco e integro come nel momento incui è stato stampato mentre non sappiamo quanto durerannoi supporti informatici. O meglio lo sappiamo, i nastri si sma-gnetizzano, se il supporto non si smagnetizza l’avvento dinuove tecnologie fa sparire i mezzi per farlo funzionare (suquale computer si può ancora leggere oggi un floppy diskflessibile degli anni ottanta?) e in ogni caso non sappiamoquanto durerà un DVD. L’unico modo sarebbe di salvareogni due o tre anni l’informazione su un altro supporto, mala forza del supporto cartaceo era proprio che non imponevaquesto lavoro faticosissimo. Se poi aggiungiamo che in que-sta crisi entrano anche i supporti cartacei (perché la vita mediadi un libro stampato su carta da legno è di circa settant’anni),la tecnologia da un lato moltiplica l’informazione (anche sulpassato) ma dall’altro la rende estremamente deperibile, per
umberto eco. la misteriosa fiamma della reginaloana, Bompiani 2004, p. 451 illus., isBn:9788848603225
Questo romanzo, benché illustrato a colori, è domi-nato dalla nebbia. Nella nebbia si risveglia Yambo,dopo un incidente che gli ha fatto perdere la memo-ria. Accompagnandolo nel lento recupero di se stes-so, la moglie lo convince a tornare nella casa di cam-pagna dove ha conservato i libri letti da ragazzo, iquaderni di scuola, i dischi che ascoltava allora. Cosìin un immenso solaio tra Langhe e MonferratoYambo rivive la storia della propria generazione, tra"Giovinezza" e "Pippo non lo sa", tra Mussolini,Salgari, Flash Gordon e i suoi temi scolastici di pic-colo balilla. Si arresta di fronte a due vuoti ancoranebbiosi, le tracce di un'esperienza forse atroce vis-suta negli anni della Resistenza e l'immagine di unaragazza amata a sedici anni.
cui un utente del futuro disporrà sempre più soltanto diinformazione sul presente – che è un brutto modo diavere un’anima.
LE ARTI DELLA MEMORIA E IL SOGNO DELLA LIN-GUISTICA UNIVERSALE
Lei ha offerto degli studi capitali sul tema dei linguaggiuniversali e sull’ideale della lingua perfetta (cfr. La ricercadella lingua perfetta nella cultura europea), mostrando comequesti progetti filosofici abbiano intrecciato la propria storiacon la vita culturale e scientifica del progresso europeo.Altresì, ha documentato come i progetti di autori come Lulloe Leibniz fossero radicati nel terreno talvolta misterioso eambivalente della ricerca sulle arti della memoria. Kant ebbea dire che il progetto della linguistica universale, pur perse-guendo un sogno metafisico impossibile da realizzare, non fuinutile e non fu privo di benefiche ricadute pratiche per gli svi-luppi della logica e della filosofia. Vorremmo chiederLe sepossiamo affermare la stessa cosa a proposito dell’anticosogno ciceroniano di dominare un teatro enciclopedico dinozioni e di ricordi attraverso il solo ausilio della disciplinainteriore, dell’organizzazione ferrea dello spazio mentale, edell’esercizio creativo dell’immaginazione. Ad esempio,ripercorrendo la storia delle mnemotecniche rinascimentali emoderne, come possiamo valutare la loro utilità e il lorodanno per quanto riguarda lo sviluppo del sapere razionale escientifico?
In fondo i sistemi scientifici come le tassonomie linneane,sono un modo di tradurre in termini più efficaci e meno fan-tasiosi i procedimenti delle vecchie mnemotecniche. Ma nondimentichiamo che le mnemotecniche nascono quando lascrittura non permetteva di trasportare facilmente l’informa-zione, o di avervi accesso (costo e ingombro dei manoscritti).Esse avrebbero dovuto scomparire dopo l’invenzione dellastampa. Se invece fioriscono ancora (e raggiungono anzi laloro stagione aurea tra rinascimento e barocco) è proprio per-ché prendono l’aspetto pre-scientifico di teatri del mondo, enon servono più per ricordare ma per organizzare il sapere.
ATTUALITÀ DELLA MEMORIADel problema della memoria si è sempre parlato e
sempre si parlerà, ma non è sicuramente un caso che nelcurriculum del dottorato di ricerca di cui lei presiede ilcomitato scientifico uno dei temi di ricerca sia proprioquello della memoria. Quale crede possano essere ledirezioni di ricerca più importanti su cui la semioticapuò dare un contributo al tema della memoria?
Lo sapevo, ma non ricordo bene.
SE i libri non baStano?
Chora N. 16, Settembre 2008
6
umberto eco (Alessandria 1932) è un accademico, filosofo, semiologo, linguista e bibliofilo italiano di fama interna-zionale. Dal 2008 è professore emerito e presidente della Scuola Superiore di Studi Umanistici dell’Università diBologna. Saggista prolifico, ha scritto numerosi saggi di semiotica, estetica medievale, linguistica e filosofia, oltre aromanzi di successo. Tra i saggi che ha scritto e che ha curato ricordiamo: Il problema estetico in San Tommaso (1956),Torino, Edizioni di Filosofia. Seconda edizione modificata: Il problema estetico in Tommaso d’Aquino, Milano, Bompiani,1970); Trattato di semiotica generale (1975), Milano, Bompiani; I limiti dell’interpretazione (1990), Milano, Bompiani; Lamemoria vegetale (1992), Milano, Edizioni Rovello; Kant e l’ornitorinco (1997), Milano, Bompiani; Dire quasi la stessa cosa.Esperienze di traduzione (2003), Milano, Bompiani; Bellezza Storia di un’idea dell’Occidente in CdRom (2002), Milano,Motta On Line (a cura di U. Eco); Storia della bellezza (2004), Milano, Bompiani (a cura di U. Eco); A passo di gambero.Guerre calde e populismo mediatico (2006), Milano, Bompiani; Storia della bruttezza (2007), Milano: Bompiani (a cura di U.Eco); 11/9 La cospirazione impossibile (2007), Milano, Piemme (Autori vari a cura di Massimo Polidoro); Dall’albero allabirinto (2007), Milano, Bompiani. I suoi romanzi sono: Il nome della rosa (1980), vincitore del Premio Strega nel 1981.Il pendolo di Foucault (1988); L’isola del giorno prima (1994); Baudolino (2000); La misteriosa fiamma della regina Loana (2004).
umberto eco, la memoria vegetale e altri scritti dibibliofilia, Bompiani 2007, p. 308, isBn9788845257858Le nuove riflessioni di Umberto Eco sul mondo affa-scinante e antico dei libri, sulla bibliofilia, sullamemoria e sulla gioia della lettura. Un volume ele-gante e raffinato, stampato in soli duemila esempla-ri, nel quale Eco traccia un elogio del biblos, del liber,nati ancor prima della stampa sotto forma di rotoli,e la cui etimologia rinvia alla scorza dell'albero, aquella memoria vegetale nata con la scrittura prima,con i papiri e la carta dei libri poi. Un libro perbibliofili, ma non solo, capace di trasmettere a tutti ilpiacere della lettura come dialogo ininterrotto congli scrittori. Un dialogo senza limiti di tempo, capa-ce di trasmette memorie e saperi, emozioni ed espe-rienze altrimenti perdute.
indice - sommarioSULLA BIBLIOFILIA: La memoria vegetale;Riflessioni sulla bibliofilia; Collazioni di un collezio-nista HISTORICA: Sul libro di Lindisfarne; Sulle TrèsRiches Heures; Sugli Isolari; Perché Kircher?; Il mioMigne, e l'altro; Lo strano caso della Hanau 1609.FOLLI LETTERARI (E SCIENTIFICI): Varia et curio-sa; Il capolavoro di uno sconosciuto.ETEROTOPIE E FALSIFICAZIONI; La peste dellostraccio; Prima dell'estinzione; Monologo interioredi un e-book; Shakespeare era per caso Shakespeare;Per una riforma dei cataloghi; Il codice Temesvar;Asta di libri appartenuti a Ricardo Montenegro; Ilproblema della soglia. Saggio di para-antropologia.
7dottorato in discipline seMiotiche
Chora N. 16, Settembre 2008
1. IntroduzioneIn questo saggio proveremo a mostrare l’euristicità di un
approccio semiotico ai problemi della memoria. Più in partico-lare, tenteremo di mostrare come un approccio semiotico tentidi superare tutta una serie di grandi dicotomie che hanno inve-ce largamente informato i vari dibattiti sul tema in oggetto —indipendentemente dalla loro provenienza disciplinare — qualiad esempio quelle tra l’individuale e il collettivo, tra il persona-le e l’impersonale, tra l’interno e l’esterno, tra il soggettivo e l’og-gettivo etc. Al fine di rendere chiara ed euristica la nostra propo-sta, ci occuperemo innanzi tutto di una ridefinizione del concet-to di esternalizzazione della memoria (§ 1 e 2), presenteremouna riflessione sul tema della distribuzione del senso e su comequesto approccio sia inte-grabile in una prospettivasemiotica (§ 2) e tenteremodi chiarire alcuni punti dinatura epistemologicaintorno al tema in esame,proponendo una letturadella memoria come pro-cesso esternalizzato distri-buito capace di rendereconto di alcuni dei proble-mi centrali del dibattitoattuale sulla memoria. Inseguito, in vista di una defi-nizione di concetti più ope-rativi, rifletteremo sul temadel filtraggio in quantodimensione essenziale diogni processo di produzio-ne di memoria (§ 3) e ana-lizzeremo alcuni casi concreti di restauro e di pratiche d’usodello spazio, che riteniamo essere fenomeni di costruzione dimemoria in cui emergono in maniera preminente le diverseproblematiche discusse (§ 4). In conclusione, alla luce di quantoemerso dall’analisi, proporremo una riflessione intorno al temadel soggetto come polo problematico dei processi descritti (§ 5).
Il nostro tentativo non è allora solo quello di illustrare le spe-cificità del punto di vista semiotico sul tema della memoria, maè anche quello di coniugare teoria e analisi empirica, seguendoun’opzione tipica della nostra disciplina. Da qui la nostra insi-stenza sui processi di significazione e l’ampio spazio dedicatoalle analisi concrete.
1.1. Enciclopedia e SemiosferaPer molto tempo la semiotica ha elaborato teorie e strumenti
di analisi per lo studio dei fenomeni di significazione privile-giando una prospettiva sincronica che riuscisse a descrivere lastruttura e il funzionamento degli oggetti semiotici prescinden-do dalla loro evoluzione. Questa prospettiva ha trovato neglianni una larga e duratura applicazione, derivante in parte dalclima culturale di matrice strutturalista in cui la semiotica si èsviluppata e dall’altra dall’euristicità che tale impostazione hadimostrato nell’analisi empirica dei fenomeni di significazione.
Accanto a questo approccio, tuttavia, è possibile fare riferi-mento ad altre teorie di matrice semiotica più orientate allo stu-dio della cultura nel suo complesso (piuttosto che a testi o a siste-
mi di significazione auto-nomi), che hanno collocatoal centro della propriariflessione l’evoluzione e ladimensione diacronica deifenomeni studiati.
Possiamo individuare,in particolare, nella semio-tica della cultura di JurijLotman l’identificazionedella dimensione tempora-le come problema teoricocentrale ed è interessantenotare che questa dimen-sione venga proprio decli-nata come memoria. Taletermine compare esplicita-mente nella definizionestessa di cultura, che vienedescritta appunto come la
“memoria non ereditaria di una collettività” (Lotman eUspenskij 1975, p. 43). Questa definizione rende, in un certosenso, quasi coincidenti le nozioni di memoria e cultura, anchese, volendo operare una distinzione all’interno della definizione,potremmo notare che in essa si assume che la cultura si dà lungouna durata temporale (ovvero permane nel tempo) mentre lamemoria è ciò che ne garantisce la continuità. In parte questavisione può essere ricondotta all’approccio organicistico ed evo-lutivo che Lotman applica allo studio dei sistemi culturali,secondo il quale ogni fenomeno è insieme se stesso e la storia delprocesso che lo ha prodotto; in questo senso anche la cultura èinsieme il risultato e la testimonianza della sua evoluzione.
MeMoria culturale e processi interpretativi
dottorato in discipline seMiotiche (suM-università di Bologna)1
uno sguardo semiotico
Acropoli ateniese, il Partenone
1 Questo lavoro è stato elaborato collettivamente nell'ambito del Dottorato in Discipline Semiotiche e costituisce un primo risulta-to di una ricerca dottorale sul tema della memoria culturale. Il testo è stato discusso nella sua impostazione e linee generali conPatrizia Violi, coordinatrice del Dottorato, e Anna Maria Lorusso, segretaria scientifica. Claudio Paolucci, tutor del dottorato, hacoordinato e seguito la struttura e la realizzazione del testo in tutte le fasi del lavoro. La stesura definitiva è stata realizzata dai dot-torandi del XXI ciclo. In particolare il § 1.1 è stato scritto da Marco Seghini; il § 1.2. è stato scritto da Paolo Odoardi; il § 2. è statoscritto da Tommaso Granelli; i § 3.1., 3.2., 3.3., 3.6. sono stati scritti da Agata Meneghelli; i § 3.4. e 3.5. sono stati scritti da DamianoRazzoli; il § 4. è stato scritto da Francesco Mazzucchelli; il § 5.1. è stato scritto da Daniele Salerno e il § 5.2. da Elena Codeluppi.
mEmoria culturalE E procESSi intErprEtativi
Chora N. 16, Settembre 2008
8
In questa prospettiva, il punto che risulta teoricamente rilevan-te è che la memoria non è considerata una semplice funzione chepermette la conservazione dell’informazione e dei significati e illoro immagazzinamento in un deposito statico. Viene invecemesso in evidenza come il passato sia continuamente seleziona-to e ritradotto da tutte le pratiche di senso che si danno nel pre-sente e si sviluppano localmente. Infatti, come afferma Lotman,“nella cultura entrano di continuo testi che provengono dal suopassato. Essi vengono sottoposti a una ricodificazione e diventa-no così fonte di nuove informazioni” (Lotman 1985, p. 88): lamemoria non è così pura eredità ma continua riconfigu-razione di ciò che viene tramandato. A partire da questadefinizione possiamo allora individuare tre ambiti in cui,in modo generale, si articolano i problemi legati alcampo della memoria. In primo luogo vengono chiama-te in causa le forme e le modalità di permanenza dei testi,cioè la durata della cultura nel tempo; in secondo luogole modalità di recupero, ovvero il fenomeno che Lotmanidentifica con la reimmissione di testi provenienti dalpassato; infine la modificazione della cultura stessa, leg-gibile in Lotman in un duplice senso: da una parte comericodificazione del testo e dall’altra come produzione dinuova informazione.
Questo primo inquadramento dei concetti in campopuò essere complessificato accostando un’ulterioreriflessione semiotica sulla cultura, individuabile nell’ideadi enciclopedia elaborata da Eco (1984). Il concetto, accan-to ad applicazioni più specifiche nel campo della seman-tica, è anche uno strumento utilizzato da Eco per descri-vere l’intero sapere di una collettività. Secondo unanota definizione:
l’enciclopedia è un postulato semiotico, non nel sensoche non sia anche una realtà semiotica: essa è l’insiemeregistrato di tutte le interpretazioni, concepibile oggettiva-mente come la libreria delle librerie, dove una libreria èanche un archivio di tutta l’informazione non verbale inqualche modo registrata, dalle pitture rupestri alle cinete-che. (1984, p. 109)
Questa definizione considera la cultura non tanto in terminiastratti, ma sottolinea come essa sia l’insieme di tutte le produ-zioni semiotiche circolanti in una collettività e le relazioni chesi stabiliscono tra di esse.
Facendo dialogare le due definizioni presentate, quella di“cultura come memoria” e quella di “cultura come insiemedelle produzioni di senso di una collettività”, si giunge a unavisione del fenomeno della memoria che potremmo definire,in prima istanza, esternalizzata. Il termine merita senz’altro unchiarimento, dal momento che, nel farne l’oggetto teorico chia-ve di questo nostro lavoro, non lo useremo in un’accezioneconforme a quella suggerita dal senso comune.
1.2. EsternalizzazioneIl concetto di esternalizzazione riguarda, in linea generale, la
possibilità di rendere disponibili informazioni e significati in untempo e in uno spazio diversi da quello in cui sono stati prodot-ti (Pethes e Rüchatz 2001, voce /esternalizzazione/). Nel quadrodei riferimenti ora esposti, uno dei primi problemi che taleimpostazione comporta potrebbe essere quello della permanen-za materiale delle occorrenze segniche, senza il quale sarebbedifficile immaginare il permanere stesso della cultura e, ancoradi più, la sua evoluzione. Per esemplificare questo problema, sipotrebbe pensare ai casi di oblio radicale che, ad esempio, pos-sono dipendere dalla scomparsa di tutte le testimonianze relati-ve a un evento, a un fatto, o a un’intera civiltà (Eco 2007, p. 97)2.Posta in questi termini, però, la questione dell’esternalizzazioneva senz’altro complessificata.
Bisogna, infatti, subito segnalare come la pura permanenzamateriale non sia ovviamente assolutamente sufficiente pergarantire la significatività futura di un dato oggetto culturale. Idispositivi esterni costituiscono il presupposto della trasmissio-ne culturale, ma la loro permanenza non garantisce la conte-stuale conservazione delle condizioni culturali per mezzo dellequali è possibile dare lettura di quello stesso oggetto.Semioticamente, la sostanza dell’espressione è esclusivamentecondizione necessaria — ma in nessun caso sufficiente — per laconservazione e la trasmissione del senso. Assmann, tra i mag-
Il memoriale della pace di Hiroshima
Il bacio del piede di S. Pietro, a Roma
2 Tutte le citazioni da Eco (2007) sono riferite alla seconda edizione del volume.
9dottorato in discipline seMiotiche
Chora N. 16, Settembre 2008
giori teorici della memoria culturale, afferma quanto segue inrelazione al problema della distanza temporale, di cui l’esterna-lizzazione consente il superamento:
il dilatamento di una situazione comunicativa rendenecessaria una memorizzazione intermedia esterna. Il siste-ma comunicativo deve quindi sviluppare un campo ester-no in cui si possano immettere gli atti comunicativi e leinformazioni, ossia il senso culturale; allo stesso tempo deveelaborare delle forme di archiviazione (codificazione),memorizzazione e rimessa in circuito (retrieval) deidati. Ciò richiede l’esistenza di quadri istituzionali, dispecializzazioni e normalmente anche di sistemi dinotazione. (Assmann 1999, p. XVIII tr. it.)
Quello che il brano mette in evidenza è come si rendasempre necessaria una complessa serie di strutture, isti-tuzioni e pratiche che reggano e rendano possibile (mache allo stesso tempo influenzano) il reinserimento ditesti provenienti dal passato, secondo una prospettivache può essere messa in relazione con la nozione di enci-clopedia precedentemente introdotta (Eco 1984), maanche con il concetto di semiosfera in Lotman, e cioè conquelli che mostreremo essere due ambienti comunicativiche rendono possibili i processi di senso che avvengonoal loro interno. Enciclopedia e semiosfera sono per noidue categorie fondamentali per pensare in maniera ade-guata il concetto di memoria esternalizzata, tanto che pos-siamo anticipare fin da subito come il complesso del-l’azione di tali ambienti possa essere descritto come unmeccanismo di filtraggio che opera a diversi livelli.Come si vedrà più avanti, è infatti l’azione operata datali strutture che agisce sui significati culturali e sulleoccorrenze testuali nel momento in cui queste entrano in nuovicircuiti interpretativi.
Come mette in evidenza il concetto stesso di filtraggio, la pro-spettiva semiotica tenta di complessificare il tema dell’esterna-lizzazione attraverso una focalizzazione del momento dellareimmissione degli oggetti significativi nella situazione presen-te. Concentrandosi sul momento in cui le varie occorrenze e isingoli testi rientrano in pratiche di senso localmente determina-te, venendo così riattivate da nuove interpretazioni, si spostal’attenzione dal semplice problema del supporto o dei codici, indirezione dell’allargamento dell’analisi a tutti gli elementi messiin campo dalla pratica di senso considerata. Si tratta in fondo diuna ricaduta teorica del concetto stesso di enciclopedia, cosìcome formulata da Eco (1984); è stato infatti già messo in eviden-za come la visione globale dell’enciclopedia valga unicamentecome ipotesi regolativa3, tanto che l’enciclopedia non può esse-re altro che lo sfondo su cui si stagliano processi di senso locali.In una dimensione situazionale vengono sempre attivate por-zioni diverse dell’enciclopedia e questo ritaglio di una sezioneenciclopedica parziale opera una costante ridefinizione conte-stuale dei rapporti tra gli elementi culturali di cui l’Enciclopediarappresenta lo sfondo4, producendo così di fatto una nuovavisione del passato.
Al livello fin qui considerato, rimane tuttavia ancora esclusauna dimensione comunque presente in tutti i processi di senso,quella interpretativa, in qualche modo responsabile della produ-zione dei significati. Tale dimensione sarà analizzata facendo rife-rimento da una parte alle articolazioni interne dell’Enciclopedia –ad esempio il rapporto tra enciclopedie specialistiche ed enciclo-pedia media (Eco 1984; Violi 1992) – e dall’altra alle modalità diacquisizione e di stabilizzazione degli abiti interpretativi. Come sivedrà di seguito, saranno proprio queste strutture, interpretabilicome ulteriori dispositivi di filtraggio, a consentire da un lato la
descrizione dei processi di appropriazione e acquisizione del pas-sato, e dall’altro a rendere possibile la mediazione tra una dimen-sione collettiva e potenzialmente astratta dei processi di memoriae una dimensione localmente determinata degli stessi.
In conclusione, vogliamo sottolineare come la prospettivasemiotica cerchi di riconciliare certe dicotomie, di passare oltre aogni distinzione tra una dimensione oggettiva del fenomenodella memoria (tutti i problemi relativi al supporto e al contesto)e una sua dimensione supposta soggettiva. La prospettiva semio-
tica, infatti, aspira a porsi trasversalmente rispetto a questi duepoli, con l’obiettivo concreto di studiare i processi attraverso cuiil senso — e con esso la memoria — vengono rinegoziati local-mente in situazione.
Fissato un simile inquadramento, è allora necessario specifica-re la taglia dei fenomeni che saranno discussi di seguito.L’ambito che vorremmo descrivere qui consiste nel momento incui testi e oggetti appartenenti al passato vengono rimessi ingioco, riconfigurati e offerti all’interpretazione. In questa sedenon ci occuperemo quindi della dimensione macroculturale, senon nella misura in cui la cultura entra nella situazione specifi-ca e la riconfigura localmente. Allo stesso tempo, non saranno dinostra pertinenza i problemi più strettamente connessi alladimensione individuale di appropriazione del passato, essendoil soggetto considerato esclusivamente nei processi locali neiquali si ricrea la memoria culturale. La memoria di cui si interes-sa la semiotica è quindi l’effetto dell’interazione fra i diversi ele-menti posti in relazione dalle pratiche di significazione. Seimmaginiamo un visitatore che cammina tra le rovine dell’acro-poli ateniese, e immaginiamo come il suo sguardo e il suo per-corso incontrino delle salienze che riattivano alcune conoscenzeo gliene offrano di nuove, ci accorgiamo di come questo sia uninteressante momento di produzione della memoria.
2. La memoria come processo distribuitoAl fine di rendere chiara ed euristica la nostra proposta, pre-
senteremo a questo punto una riflessione sul tema della distribu-zione, su come questo approccio sia integrabile in una prospetti-va semiotica e su come esso possa rendere conto di determina-te forme di memoria.
Abbiamo infatti visto come sia molto difficile e discutibileindividuare un solo centro di memoria, che si collochi univoca-mente nell’individuo, nei supporti o nei codici culturali. Una
Mostar, in Bosnia Erzegovina
3 Vedi anche Violi (1992).4 Cfr. Paolucci (2005).
mEmoria culturalE E procESSi intErprEtativi
Chora N. 16, Settembre 2008
10
prospettiva semiotica, intesa nel modo precedentemente deli-neato, non incoraggia una visione statica della memoria, ma pri-vilegia al contrario la considerazione dei percorsi dinamici dellasua riattivazione attraverso traduzione e interpretazione, inmodo trasversale rispetto ai soggetti e ai supporti materiali coin-volti. In questo senso, possiamo cercare nello sguardo dellasemiotica anche il fondamento di una delocalizzazione.Cercheremo, però, anche di oltrepassare la pura determinazio-ne in negativo di questo processo (la memoria in nessun centroesclusivo), al fine di studiare ciò che lo costruisce in positivo.
Una prospettiva semiotica sulla memoria incoraggia a nostroavviso un tipo peculiare di sensibilità, capace di proporre unanozione di memoria distribuita,non situata né negli oggetti nénei soggetti, ma circolante inconfigurazioni dinamiche edeterogenee di molteplici attanti5,legati tra loro da reti altrettantodinamiche di relazioni. In que-sto senso, esternalizzare la memo-ria, come vedremo nei casi par-ticolari di cui proporremo l’ana-lisi, significa riorganizzare i pro-cessi pragmatici e cognitivi coin-volti, orchestrandoli e coordi-nandoli, piuttosto che localiz-zarli una volta per tutte in unaserie di attori, sociali o tecnologi-ci che siano (soggetti, supporti,individui etc.).
Da dove proviene allora que-sta disposizione della semiotica? Quali sono le sue radici teore-tiche? Per rispondere a questa domanda, ci sembra utile indaga-re brevemente la tradizione teorica della nostra disciplina, al finedi comprendere meglio come vengano descritti al suo interno iprocessi cognitivi. Il primo passo è quello di confrontarsi con lateoria di Peirce, il quale propone appunto quella che si è potutachiamare una semiotica cognitiva6 . Se rileggiamo i suoi saggi anti-cartesiani, ci rendiamo conto di come per Peirce tutta l’attivitàcognitiva sia essenzialmente esternalizzata nella misura in cuiessa è semiotica, e cioè è conforme alle leggi dell’inferenza valida:non si può pensare se non attraverso segni, che non sono nient’al-tro che modi di collegare ad alcune premesse l’evidenza di unapossibile conclusione (o viceversa). Peirce pone, infatti, comeprima incapacità dell’uomo la possibilità di qualsiasi suo potere diintrospezione, senza che questo voglia dire in nessun caso la nega-zione dell’esistenzadegli stati interni del soggetto. Peirce sostiene,infatti, che noi non possediamo alcun accesso diretto e intuitivo ainostri stati interni, ma che essi sono sempre inferiti ipoteticamen-te a partire da conoscenze precedenti su stati esterni che funziona-no da segni. Ecco allora che l’esternalismo peirceano non va affat-to confuso né con un sostanzialismo né con una triviale negazio-ne dell’esistenza dei nostri stati interni; esso delinea invece unaprospettiva in cui l’esternalizzazione semiotica che definisce qual-siasi attività cognitiva di pensiero è sempre neutra rispetto all’op-posizione ‘soggetto vs oggetto’ o ‘interno vs esterno’, conforme-mente a quanto ci proponiamo di sostenere con questo nostrolavoro sulla memoria.
Ogni qualvolta pensiamo, abbiamo presente alla coscien-za un sentimento, un’immagine, un concetto o un’altra rap-
presentazione che serve da segno. Ma […] ogni cosa che siapresente a noi è una manifestazione fenomenica di noi stes-si. Questo non impedisce che essa sia un fenomeno di qual-che cosa esterna a noi, proprio come un arcobaleno è con-temporaneamente una manifestazione sia del sole che dellapioggia. (CP 5.283)
Dove sta dunque la cognizione? Qual è il luogo del pensieronel senso allargato che gli attribuisce Peirce (emozioni, senti-menti, immagini, concetti etc.)? In base a quanto detto, si può giàcomprendere che per Peirce i processi cognitivi non si localizza-no in un centro, ma sono piuttosto trasversali rispetto all’indivi-
duo; potremmo dire che lo attra-versano (Violi 2007, pp. 195-196),collegando un soggetto con isegni interpretanti di cui ègarante la sua comunità. Si trat-ta perciò di una vera e propriaistanza terza, arcobaleno semioti-co tra il sole e la pioggia, chemedia tra il collettivo e l’indivi-duale, e che è irriducbile al dipo-lo soggetto/oggetto. Peirce amadire che non è affatto correttoaffermare che “il pensiero è nel-l’uomo”, bensì occorre sempredire che “l’uomo è nel pensie-ro”, delocalizzato e distribuito inquella rete di segni interpretantiche potrebbero volgersi indietrodicendogli “tu non significhi
niente che non ti abbiamo insegnato noi” (CP 5.313). In questosenso, possiamo riprendere ciò che Violi dice a proposito delrapporto tra soggetto e semiosi, riferendosi alla teoria della sog-gettività che Eco ha elaborato proprio su questa base peirceana:
In quanto semiosi, il soggetto è una configurazione diffusa,non circoscritta né circoscrivibile, dal momento che non èriconducibile ad una istanza determinata una volta per tutte,né ad alcuna entità semiotica prefissata come era il codice.Non è statica ma dinamica, legata alle pratiche di costruzionee di trasformazione del senso. Ma poiché queste pratiche sonostoriche e integrate nella prassi e nel lavoro umano, anche lasoggettività ne risulta storicamente e materialmente fondata.[…] il soggetto non è né forma dell’individuale, né istanza deltrascendentale. (Violi 2007, pp. 181-182)
Un processo cognitivo, dunque, per Peirce non si esaurirà mainelle sensazioni individuali, nell’opposizione di un soggetto aun oggetto o nel normativismo delle convenzioni culturali.Chiamerà sempre in causa tutti questi tre aspetti come determi-nazioni parziali e temporanee, ma al tempo stesso li oltrepasse-rà sempre verso uno stato marcato dalla loro compresenza, san-cita dal procedere dell’interpretazione. Del resto “non abbiamoalcun concetto dell’assolutamente inconoscibile” per Peirce, e diconseguenza non avremo mai una cosa in sé (CP 5.310-312), masempre un insieme di rapporti e di relazioni che consentono diosservare e interpretare parti del mondo o aspetti della realtà.
Riformulata la natura dei processi cognitivi attraverso lasemiosi ed evidenziato il loro essere ‘istanza terza’ rispetto all’in-dividuo e alla collettività, si può procedere nella direzione di cer-
I binari verso Auschwitz
5 Il termine ‘attante’ proviene dalla linguistica di Lucien Tesnière. In semiotica, esso nasce col nome di ‘relativo’ nella logica dellerelazioni di Peirce e viene ripreso nella sua denominazione tesnièriana dalla teoria narrativa di Greimas (Greimas e Courtès 1979,p. 40 tr. it.). In tutti e tre questi casi, esso serve a definire qualunque istanza coinvolta in processi e programmi d’azione, indipen-dentemente dal suo statuto ontologico. Possono essere attanti degli esseri umani o degli artefatti tecnologici: ciò che conta è la loroposizione reciproca all’interno dei processi, in funzione del sistema di valori considerato. L’attante non è altro che una posizione chepresenta un’identità puramente topologica e relazionale e che si distingue dagli attori concreti in cui si incarna.6 Cfr. Bonfantini (1980, p. XXII).
11dottorato in discipline seMiotiche
Chora N. 16, Settembre 2008
care altre basi per un recupero di quest’ottica anti-essenzialistae anti-ontologica che è costitutiva della semiotica. A questoproposito, possiamo rifarci al portato positivo dello struttura-lismo, proveniente dalla genealogia che collega Saussure,Hjelmslev, Lévi-Strauss e Greimas, e che trova una felice sin-tesi dei suoi caratteri distintivi nella formulazione di Deleuze(1973, p. 91 tr. it.). Con grande lucidità, Deleuze coglie infattinello strutturalismo la premi-nenza teorica della relazione:esiste sempre uno scarto tra ter-mini, scarto che li colloca l’unoin rapporto all’altro in modoche essi intrattengano tra lorodelle dipendenze all’interno diun sistema differenziale chedefinisce la loro identità. Ognielemento ha infatti esclusiva-mente un valore posizionale chedipende dalla rete di rapportiche lo legano a tutte le altreposizioni. Queste correlazioninon derivano quindi mai dallapredicazione di presunte pro-prietà sostanziali e individuali,che per Deleuze appartengonoinfatti ai domini del “reale” edell’”immaginario”, rispetto aiquali la struttura è “terza”(1973, p. 92 tr. it.)7 . La nozione fondante che la semiotica ere-dita dallo strutturalismo è questa capacità di non identificareposizioni determinate in se stesse attraverso proprietà, ma dicogliere invece delle differenze tramite sistemi locali di relazio-ni8 . Per tutto ciò che abbiamo detto finora, si può quindi com-prendere come la semiosi inquadri uno spazio intermedio postoal di là, o al di qua, di ogni determinazione oppositiva tra l’in-dividuale e il collettivo, tra l’interno e l’esterno, tra il soggetti-vo e l’oggettivo: “arcobaleno tra il sole e la pioggia”.
In tale direzione, possiamo riprendere infine una delle logichedel senso più importanti in semiotica, vero e proprio principio diintelligibilità e di comprensione dei processi di attribuzione disenso, e cioè la narratività. Essa funziona infatti a un certo livelloproprio in un modo relazionale, non assegnando cioè figureattoriali fisse o ontologiche, ma situando al contrario delle posi-zioni in maniera relativa le une rispetto alle altre, distribuendoruoli che vengono negoziati localmente.
Prima la Logica dei relativi di Peirce (CP 3.45), poi la nozionedi valenza di Tesnière (1959) e infine la sintassi narrativa diGreimas (Greimas e Courtès 1979, p. 331 tr. it.) hanno dato lapossibilità di focalizzare come nei processi si organizzino ruoliattanziali, mediazioni e pertinenze, disposti sempre in modorelativo gli uni nei confronti degli altri. La teoria linguistica diTesnière, ad esempio, ha portato a rivedere tutta la strutturalogica della frase: ponendo al centro il verbo e consentendo diripensare criticamente il primato della costruzione soggetto-predicato, è riuscita a sfruttare le potenzialità di una linea dipensiero che partendo dagli Stoici è passata attraverso Peirce.Lo stesso tipo di eredità teorica ha portato Greimas al pienosviluppo di una grammatica narrativa che consente di identifi-care un fondamentale nucleo motore di comprensione e intel-ligibilità di percorsi d’azione inscritti nei testi.
Da questo punto di vista, laddove si ha produzione di sensoe circolazione di un’attività comunicativa e cognitiva concerta-ta, si ha sempre un processo e una negoziazione locale9 a chiu-dere un sistema. Allo stesso tempo, siccome la mutua intelligibi-
lità dei comportamenti, dei ruoli e delle posizioni è sempreun prodotto condiviso e pubblico, il modo in cui gli attan-ti si orientano reciprocamente all’interno di processi prag-matico-cognitivi è qualcosa di visibile e di concreto, dalmomento che è marcato inevitabilmente dalla produzione disegni e può dunque essere colto e descritto anche dalla pra-tica interpretativa esterna di un osservatore.
Secondo quanto abbiamodetto finora, capiamo dunquecome è la natura stessa dellasemiosi a poter essere descrittacome distribuita. Tanto piùche, tenendo presente il lega-me inscindibile tra semiosi ecognizione, ci è possibile nota-re come la svolta situata dellescienze cognitive e sociali noncolga certo impreparata lasemiotica, ma anzi crei le basiper una loro mutua traducibili-tà. Le cosiddette SituativityTheories (Greeno e Moore 1993,p. 49), tra cui ad esempio le teo-rie della Distributed Cognition(Hutchins 1995 e 2000), SituatedAction (Suchman 1987) eSituated Cognition (Lave 1988;Kirshner e Whitson 1997) –
insieme agli studi che nel campo etnografico o dell’analisidella conversazione hanno lavorato assiduamente nell’arcodi trent’anni sullo spinoso ‘problema del contesto’ (Goodwine Duranti 1992) – seppur con le loro differenti opzioni meto-dologiche, stanno costruendo ultimamente un quadrocomune di riferimento.
In questa chiave, i processi pragmatici e cognitivi sono sem-pre considerati come attività situate in relazione a precise e con-crete circostanze, che vengono portate avanti e negoziate inmodo collettivo e condiviso. Esse prevedono sempre la media-zione di artefatti, o di attori umani posizionati in rapporti reci-proci, rispetto al conseguimento di obiettivi e scopi comuni.Per questo sarebbe impossibile e assurdo isolare la cognizionein una situazione artificiale (un laboratorio) per ridurre edominarne le variabili. Al contrario, se si vuole raggiungere unqualche tipo di comprensione di questi processi (sempre inter-dipendenti rispetto a quelli pragmatici e percettivi), bisogneràstudiare attentamente le circostanze naturali della loro produ-zione, evidenziando limitazioni, risorse materiali, comunicati-ve e mediazioni attraverso veicoli di esternalizzazione.
Da un altro punto di vista, seppur con alcune forti mar-che anticognitiviste che la contraddistinguono rispetto alleteorie ricordate sopra, ci si può riferire anche alla posizionedella sociologia della scienza francese, in particolareall’Actor Network Theory. Anche secondo Latour (1994, pp.216-219 tr. it.), ogni azione attraversa ancora una volta unospazio medio, non riducibile né alla società né ad alcunamicrointerazione tra individui. Essa è in bilico tra una sedi-mentazione in una cornice materiale che la cattura tempo-raneamente e la sua dispersione in un tessuto relazionale dimediatori sociali e tecnologici, una vera e propria rete (ib.,pp. 205-210 tr. it.). La mediazione realizza quindi al tempostesso sia lo stabilizzarsi e il situarsi dei processi pragmati-ci e delle interazioni, sia la connessione e la messa in rap-porto di traduzione reciproca degli attanti (ib., p. 220 tr. it.)collegati da un sistema di relazioni.
FIG. 1 - L’effige del Teatro La Fenice
7 Anche in questo caso viene ribadito quello spazio intermedio, o “terzo regno” (Deleuze 1973, p. 92 tr. it.) occupato dal semioticoche Deleuze, dal canto suo, chiama peircianamente “simbolico”.8 Cfr. Violi (2007) e Paolucci (2005).9 Esprimibili linguisticamente con un verbo d’azione, o narrativamente come programma narrativo.
mEmoria culturalE E procESSi intErprEtativi
Chora N. 16, Settembre 2008
12
Non abbiamo bisogno d’insistere a questo punto su quantoqueste posizioni siano vicine a una teoria semiotica e a quantoabbiamo detto a proposito della semiosi e dell’interpretazione.Se si assume che la taglia dei processi cognitivi e di attribuzio-ne di senso sia trasversale rispetto all’individuo e alla colletti-vità, e che essi vengano realizzati solo attraverso una distribu-zione che collega e contratta rapporti e posizioni, sembra pro-ficuo utilizzare la stessa ipotesi interpretativa anche rispetto alproblema della memoria.
Nell’orizzonte teorico della memoria, la questione dellasemiosi sembra costitutiva, se ci ricordiamo come l’esternalizza-zione, che ne condiziona la possibilità, avvenga sempre tramitela mediazione di segni, e cioè attraverso l’interpretazione.Sappiamo infatti che l’inferenza alla base di un processo di signi-ficazione è soggetta alla permanenza e alla ripetizione, grazie auna stabilizzazione che le deriva da abiti e convenzioni.Nell’abito si perpetua la memoria di un’inferenza, della mediazio-ne tra un segno e un aspetto della realtà, che si distribuisce inmaniera condivisa e rende possibile perciò un recupero, unachiave d’accesso a ciò che diviene un’unità culturale. È la semio-si stessa che reca memoria delle interpretazioni precedenti attra-verso quello che per Peirce è il fissarsi della credenza tramite unabito, o, per Eco, il portato stesso dell’Enciclopedia.
Possiamo allora pensare alla memoria, sulla scorta di questeconsiderazioni, come processo mediato, né individuale, néappannaggio esclusivo di una collettività. Vorremmo indagareda un lato una memoria che si dà solo attraverso mediazioni, edall’altro proprio queste mediazioni che realizzano la memoria.
A questo proposito, occorre spendere una riflessione sulladuttilità del concetto di ‘abito’ in Peirce. Un abito è una “dispo-sizione ad agire in un certo modo in date circostanze e per undato motivo” (CP 5.480). In questo modo, si sta considerando unpunto di stabilizzazione dell’interpretazione attraverso “l’azio-ne di un segno” (CP 5.472): il pensiero a un certo punto ha biso-gno di prendere fiato, di “riposarsi” (CP 5.396-5.397), fissandosisu un significato stabile degli oggetti illuminati dalla semiosi. Sicrea perciò la permanenza condivisa di un significato attraversoun interpretante logico-finale (CP 5.476), che da quel momentodiviene guida per tutte le interpretazioni successive. Siccome inuna filosofia pragmatista il significato è inteso come effetto, con-seguenza pratica degli atti di pensiero (CP 5.466), questo signifi-cato stabilizzato è appunto un abito, visto come “tendenza acomportarsi effettivamente in un modo simile in circostanzesimili nel futuro” (CP 5.487). Una credenzaè il frutto compiuto diquesto “pensiero in riposo” (CP 5.397), che comporta l’iterazio-ne dei comportamenti e, in più, ha un carattere autoriflessivo: èun abito “deliberato” o “autocontrollato” (CP 5.487).
Ci sembra, dunque, possibile in questa prospettiva considera-re la memoria come mediata e realizzata sulla base di abiti; sistanno infatti prendendo in considerazione gli effetti pragmati-ci della sedimentazione e della permanenza di significati condi-visi, e lo stabilizzarsi e il rinnovarsi dell’interpretazione attornoa un nodo semiotico stabile che è una sorta di memoria delleinterpretazioni che guiderà quelle future.
Si può pensare allora a un sistema di norme collettive che gui-dano a monte i comportamenti? Oppure, in quanto credenze,possiamo pensare a un deposito mnestico individuale e a un’in-teriorizzazione di qualcosa che proviene dall’esterno? La nozionedi abito non sembra riducibile ad alcuna di queste polarità: inquanto segno e Terzità (un interpretatante logico), l’abito si trove-rà instancabilmente a mediare tra le istanze in gioco, a concatenar-le, a gettare i ponti per una loro commensurabilità, pur non esau-rendosi in alcuna di esse. In quanto costruzione corale, ripetibilenelle medesime circostanze, l’abito si offrirà per creare la pubblicavisibilità dei comportamenti, la loro condivisione e la loro intelli-gibilità. L’idea di disposizione all’azione e l’accento sul ripresentarsidi circostanze e scopi ci sembrano inoltre rinviare a un certo tipodi concatenazione pragmatica di elementi, a una configurazionedi condizioni specifiche. Infine, le considerazioni antipsicologiste
di Peirce e le osservazioni su abiti non umani, come quelli dei “corsid’acqua” o delle “piante” (CP 5.492), fanno pensare che ci si rife-risca a una tendenza ad agire configurata anche in base ad anda-menti e ripetizioni di determinate occorrenze esterne della realtà.
Vorremmo allora suggerire che la produttività della nozionedi abito riguarda per noi la costruzione di un dispositivo, e cioè diun sistema sempre locale, circostanziato ed emergente che rego-la la mutua disposizione e l’adeguamento reciproco tra istanzeeterogenee all’interno di una collettività. Un dispositivo non èinfatti in alcun modo riducibile a un deposito trascendente di
norme in varia misura interiorizzate né a un’istanza concretache presiede alle logiche di attori concreti. Come nota Bonfantini(in Peirce, CP; nota 8 tr. it.), si tratta forse più di marcare “unprincipio sintetico di azione che fonda insieme un abito e unaregola teorica per il dominio complessivo di aree ben delimita-te della realtà oggettiva”.
Notiamo infine che gli abiti forniscono certamente stabiliz-zazione, ma anche un principio per il cambiamento.L’interpretazione, infatti, non si arresta definitivamente a unadeterminazione immodificabile; nella credenza c’è anche latrasmissione del germe che contiene le potenzialità per il pro-prio stesso superamento (CP 5.397), che definisce un nuovopunto di partenza per l’azione e per il pensiero. In questa pecu-liare duplicità dell’abito, ritroviamo dunque sia il carattere dicostruzione condivisa su base semiotica di una permanenza,sia quello di una forza dinamica che può produrre nuovamemoria, permanenza rinnovata.
Vorremmo proporre allora una visione della memoria comedispositivo distribuito, cioè come prodotto emergente da una confi-gurazione di istanze eterogenee coinvolte da processi mediati daabiti. Non si pretenderà certo che le presenti considerazioni ridu-cano la memoria a un unico schema. Al contrario, stiamo sempli-cemente cercando di mostrare la specificità di un approcciosemiotico al problema in oggetto, specificità di cui ci preoccupere-mo ora di mostrare anche e soprattutto l’euristicità nella pratica dianalisi. Mostreremo cioè la potenza esplicativa dell’avere identifi-cato uno spazio della memoria nella sua distribuzione attanzialeirriducibile alle logiche dell’individuale e del collettivo, così comea quelle dell’interno e dell’esterno. In questo senso, e in modo piùcircoscritto, seguendo le indicazioni della semiotica e del panora-ma consonante delle scienze sociali ricordate, si potrà cercare divedere come una memoria culturale distribuita venga recupera-ta, riattualizzata e costruita localmente in modo inter-attanziale.Per fare questo, occorrerà però scoprire come vengono realizzatii meccanismi di permanenza, recupero e ripetizione che permettonola costruzione della memoria attraverso la mediazione di abiti.L’aspetto cruciale che occorrerà indagare a questo proposito è anostro avviso quello del filtraggio.
FIG. 2 - Palchi del Teatro La Fenice
13dottorato in discipline seMiotiche
Chora N. 16, Settembre 2008
3. Memoria distribuita e meccanismi di filtraggioSe la memoria di cui ci occupiamo è una memoria non
localizzabile una volta per tutte né nei soggetti (che ricorda-no), né negli oggetti (ricordati o che aiutano a ricordare), nénei codici intesi come depositi statici di conoscenze, ma èinvece circolante nelle relazioni complesse e dinamiche chele pratiche di significazione costruiscono di volta in volta, èallora necessario chiedersi che tipo di meccanismi caratteriz-zino una memoria distribuita.
Nella nostra ottica, la memoria viene costruita, ricostruita,decostruita attraverso dei dispositivi di filtraggio che regolanoil passaggio e la trasformazione del senso nel tempo.
Per chiarire che cosa intendiamo per filtraggio, vorremmoinnanzi tutto mettere in luce come tale concetto si distingua daaltri modelli che tentano di spiegare come il passato possaessere reso presente.
3.1. Filtraggio vs. trasmissioneIl concetto di filtraggio si contrappone innanzitutto all’idea
di una trasmissione di informazioni nel tempo intesa comemera trasposizione di dati archiviati in dispositivi di memoria.In una tale prospettiva, riconducibile all’opzione teorica cheabbiamo definito ‘esternalizzazione ingenua della memoria’,la trasmissione di significati nel tempo sarebbe delegata a deglioggetti esterni che, circolando da un momento storico a unaltro, porterebbero con sé informazioni del passato recupera-bili ogni qualvolta necessario.
Il concetto di filtraggio mette invece l’accento sulla naturaprocessuale e problematica di ogni passaggio di senso neltempo, passaggio che non è mai semplice trasmissione, macomporta sempre la produzione di nuova informazione. Se l’ideadi trasmissione di dati è la conseguenza di una concezioneingenua di memoria esternalizzata, l’idea di filtraggio è il cor-relato di una visione distribuita dell’esternalizzazione, secon-do cui il senso che rimane in memoria non è contenuto nell’og-getto tramandato, bensì è circolante nelle interpretazioni enegli usi del passato che si generano in situazioni localmentedeterminate. Giocando un po’ con le parole, potremmo direche l’approccio distribuito propone l’idea di una traduzione delpassato, che comporta sempre una sua trasformazione e rein-terpretazione; e non l’idea di una tradizione del passato, intesanel senso etimologico, e cioè come risultato dell’atto di ‘mette-re in mano’, ‘consegnare’ il passato ai posteri.
3.2. Filtraggio vs. selezione volontariaI meccanismi di filtraggio, pur funzionando come meccani-
smi selettivi, si distinguono da atti coscienti di selezione del pas-sato in cui i membri di una cultura decidono volontariamentequali aspetti debbano essere ricordati e quali dimenticati.
In armonia con un’idea distribuita di memoria, i meccanismidi filtraggio, per come vengono intesi in questa sede, non sonoascrivibili a un soggetto trascendente, ma sono in qualche modoimpersonali, anonimi. Potremmo dire, riprendendo le parole diEco, che il filtraggio avviene “per una sorta di inerzia”:
La dimenticanza-filtraggio operata dall’EnciclopediaMedia non dipende né dalla volontà di un singolo né daun atto cosciente di volontà collettiva: si stabilisce peruna sorta di inerzia, talora persino per cause naturali,come la cancellazione di tutto quello che concernevaAtlantide, se è mai esistita. (Eco 2007, p. 97)
Con questo non intendiamo dire che le scelte consapevoli evolontarie di soggetti individuali o collettivi non possano condi-zionare in alcun modo i processi di costruzione e ricostruzione
del passato, ma, ponendoci in una posizione neutra rispetto aldualismo soggetto-oggetto, vorremmo sottolineare come, neimeccanismi di filtraggio di cui parliamo, la soggettività umanadebba sempre fare i conti con il sistema di relazioni in cui si trovaad assumere un ruolo nella contingenza di una pratica situata.Ad esempio, come vedremo, nelle pratiche di restauro la sele-zione di ciò che viene mantenuto e di ciò che viene modificatodell’originale è sicuramente influenzata dalle scelte operatedagli attori coinvolti nella pratica stessa, ma, da un punto divista semiotico, il senso del passato che viene filtrato nel presen-te non è minimamente riducibile a questo atto intenzionale.
3.3. Filtraggio, traduzione e interpretazioneUna volta chiarito che cosa non è il filtraggio rimane aperta
la questione di come possano essere descritti i meccanismi fil-tranti che abbiamo posto al cuore del funzionamento di unamemoria distribuita.
Un primo passo in questa direzione consiste nel recupero delconcetto di ‘traduzione’10 in Lotman, il quale, nella sua teoriasemiotica della cultura, non solo pone l’accento sul tema dellamemoria, ma chiama in causa proprio l’idea di filtro al fine direndere conto dello sviluppo dinamico di una cultura.
Partendo dal concetto di semiosfera, intesa come “continuumsemiotico pieno di formazioni di tipo diverso” (Lotman 1985, p.56), “spazio semiotico al di fuori del quale non è possibile l’esi-stenza della semiosi”, Lotman giunge a caratterizzare il funzio-namento di ogni semiosfera in relazione all’organizzazione dei
suoi confini, intendendo per confine la “somma dei «filtri» lin-guistici di traduzione” (ib., p. 58 tr. it.), “meccanismo bi-linguisti-co che traduce le comunicazioni esterne nel linguaggio internodella semiosfera e viceversa” (ib., p. 60 tr. it.).
Il confine funziona come un filtro permeabile e poroso che rego-la il passaggio di un testo, inteso come un qualsiasi frammento disemiosfera, da uno spazio esterno (estraneo) a uno spazio interno(proprio) e viceversa. Se da un certo punto di vista il confine separauno spazio semiotico dal suo esterno, costruendo un’alterità, da unaltro punto di vista il confine unisceuno spazio semiotico a un altro,creando così un dialogo tra due sistemi diversi e costruendo cosìuna comunicabilità tra due alterità.
Il concetto di traduzione, in quanto processo “che va dall’alte-rità all’alterità” (Sedda 2006), può gettare luce sui meccanismi difiltraggio che caratterizzano una memoria distribuita: la tradu-zione del passato, istituendo un piano in comune tra uno spaziosemiotico più o meno lontano nel tempo e uno spazio semioti-co attuale, crea un dialogo reciproco tra due alterità, modifican-do allo stesso tempo il senso attribuito al passato e i sensi passa-ti circolanti nella situazione presente.
FIG. 3 - Sala Grande
10 Lotman usa il termine “traduzione” in un’accezione molto allargata che comprende anche i suoi significati metaforici: in questosenso non ci occupiamo qui della traduzione in senso stretto per la cui trattazione rimandiamo a Eco (2003), Nergaard (1993; 1995).Per il dibattito sulle relazioni tra il concetto di traduzione e quello di interpretazione rimandiamo invece a Dusi e Nergaard (2000).
mEmoria culturalE E procESSi intErprEtativi
Chora N. 16, Settembre 2008
14
In quest’ottica, il concetto lotmaniano di traduzionenon è lontano da un’idea di interpretazione intesa come“costruzione di commensurabilità locali tra elementi ete-rogenei appartenenti a domini differenti” (Paolucci 2006,p. 139), idea che permette di illuminare ulteriori aspettidei meccanismi di filtraggio in gioco nella costruzione ericostruzione di una memoria distribuita. Se la traduzio-ne mette in relazione reciproca un sistema semiotico dipartenza e un sistema semiotico di arrivo e rende contodel processo di scambio reciproco tra i due sistemi, l’in-terpretazione mette l’accento sul “processo genetico ditraducibilità, o di instaurazione di commensurabilità” erende conto di come il passaggio di un elemento da unsistema a un altro sia possibile solo attraverso la creazio-ne di una catena di interpretanti (ib., p. 139)11.
In questa prospettiva, per poter creare un collegamentotra un elemento del passato e una situazione presente, èfondamentale produrre un nuovo segno più o meno com-plesso che interpreti l’elemento del passato. È solo produ-cendo un nuovo segno, infatti, che è possibile tradurre unelemento del passato e renderlo presente e interpretabileoggi all’interno di una data cultura.
Sebbene il concetto lotmaniano di traduzione e quello peircea-no di interpretazione abbiano molti aspetti in comune, essi pos-sono illuminarsi a vicenda e aiutarci a comprendere i meccani-smi che regolano il passaggio di senso nel tempo proprio graziealle sottili differenze che li distinguono. Piuttosto che sceglierel’una o l’altra prospettiva, preferiamo quindi tenere insieme ilportato euristico di entrambi i modelli: da un lato l’interpretazio-ne peirceana ci permette di non perdere la natura processuale diogni passaggio di senso nel tempo e di tenere conto di comeogni passaggio comporti la creazione di una catena di interpre-tanti più o meno complessa, fondamentale per costruire unacomunicabilità tra due sistemi eterogenei. Dall’altro lato, ci sem-bra che il concetto lotmaniano di traduzione sia invece impor-tante per mettere in luce la relazione dialogica tra un sistemasemiotico di partenza (il passato potenzialmente recuperabile) eun sistema semiotico di arrivo (la situazione presente e attua-le)12, in un processo di recupero o di ricostruzione del passato.
3.4. Il filtraggio in Lotman ed EcoA questo punto, è senz’altro necessario porsi a un livello ope-
rativo al fine di provare a riconoscere cosa possa agire come fil-tro nel passaggio di senso nel tempo. Abbiamo descritto il mec-canismo filtrante attraverso i concetti di traduzione e interpreta-zione. Il nostro tentativo sarà ora quello di verificare che cosa siaindividuabile come meccanismo filtrante in Lotman ed Eco, incui si riconosce come centrale un legame inevitabile tra memo-ria e cultura.
Per Lotman, “solo ciò che viene tradotto in un sistema di segnipuò diventare patrimonio della memoria” (1985, p. 31). Lamemoria è cioè un meccanismo che contribuisce a creare uninsieme di testi, intesi come realizzazioni della cultura (ib., p.50)13. Questo comporta l’attenzione al processo diacronico pro-prio della cultura stessa, che per Lotman è dell’ordine di unaregola, e non certo di una casualità (ib., p. 67). Se la cultura èmemoria, essa si ricollega allora all’esperienza storica passata,acquisendone piena coscienza post factum; ma allo stesso modo,essa si ricollega anche a un futuro ricostruibile rispetto a ciò che
diverrà memoria, nel caso della creazione di nuova cultura(Lotman e Uspenskij 1975, p. 44). Un testo può essere così inte-so sia come realizzazione di un programma di comportamento,sia come un programma di comportamento rivolto al futuro14.Troviamo qui implicato un nodo centrale, e cioè quello del“sistema di regole semiotiche secondo le quali l’esperienza divita si fa cultura”, che presuppone “la costruzione di regole perla traduzione dell’esperienza immediata in un testo” (ib., p. 44).
Può allora essere utile ricordare che per cultura Lotman inten-de “un sistema di segni sottoposto a regole strutturali” e un“insieme di testi storicamente realizzati in questo sistema disegni” (ib.1975, p. 30). In questo modo, possiamo a questo puntoavanzare la proposta che per Lotman sia la testualità nel suocomplesso a essere il luogo in cui si compie filtraggio culturale,dispositivo capace di far passare forme e contenuti fra una zonae l’altra di una data cultura o fra strati della stessa, catalizzatoredi informazioni che in rapporto con altri testi permette un accre-scimento di senso (Lotman 1985, p. 65; Lotman 1993; Demaria2006, p. 35). Tuttavia, non pare essere sufficiente sostenere soloche la cultura crea un insieme di testi, che i testi la realizzano eche essa si riduca a un ambito di selezione di elementi cheappartengono a quel determinato universo che abbiamo dettoessere la semiosfera. Infatti, questo non aggiungerebbe molto aifini di una descrizione dinamica della semiosfera stessa e dellesue logiche, che è il nostro vero e proprio obiettivo. È necessario,di conseguenza, specificare come il meccanismo di filtraggio siattivi a causa dell’incontro-scontro tra diverse semiosfere, il cheavviene proprio grazie alla circolazione di testi da una semiosfe-ra all’altra. Un simile dinamismo chiama in causa l’insieme deisistemi di segni convocati in questo passaggio. Ne deriva cosìche il testo opera come catalizzatore del senso e il dialogo tra lin-guaggi e tra sistemi di segni che entrano in contatto grazie ai testi(e di cui i testi stessi sono realizzazione) svolge il ruolo di filtro.
Tale prospettiva invita dunque a orientare lo sguardo tantoverso il testo da un lato, quanto verso il sistema di segni cheviene realizzato e verso i codici che vengono convocati nell’in-terpretazione dall’altro, dal momento che anche questi ultimisono dotati di memoria, di una loro storia. Per Lotman, infatti, ilsistema complesso della memoria appartiene sia alle singole sot-tostrutture semiotiche sia alla semiosfera nella sua profonditàdiacronica ed è indispensabile per il suo funzionamento.Lotman ipotizza che nella semiosfera “ci sia una regolarità inter-na e una dipendenza tra le parti, la cui correlazione dinamicaviene a costituire il comportamento della semiosfera” (1985, p.69). Questa regolarità viene facilitata dal dispositivo di filtro cheattiva il testo. È grazie a questo dispositivo di filtraggio che “ilsistema possiede una memoria degli stati precedenti e un poten-ziale presentimento del futuro” (Lotman 1993, p. 213 tr. it.).
Una seconda prospettiva utile per capire quale dispositivooperi come filtro di memoria è quella offerta da Umberto Eco(2007). A un’enciclopedia massimale, non coglibile e non descri-vibile nella sua globalità15, Eco affianca infatti un’enciclopediamedia, una sorta di enciclopedia viva che corrisponde alle infor-mazioni condivise da una cultura:
Ogni enciclopedia rinvia a porzioni sempre più vastedi sapere, in un gioco di rimandi che è stato definito comevirtuale. Come sfondo, ecco l’enciclopedia veramente vir-tuale, quella Massimale. Che l’Enciclopedia Massimale
11 Nell’ottica peirceana la semiosi è descrivibile come un’influenza triadica tra un segno, il suo oggetto e un interpretante, il qualefunge da istanza mediatrice che dice che ciò che essa dice è la stessa cosa detta dal segno precedente (CP 1.553). Ma l’interpretanteè a sua volta un segno che dice sempre qualcosa di più rispetto all’oggetto designato dal primo segno ed è suscettibile di essere asua volta interpretato.12 Ovviamente sistema di arrivo e sistema di partenza sono artificiosamente definiti come tali all’interno di un processo di tradu-zione e quindi sono sempre ridefinibili.13 Abbiamo visto nell’introduzione (cfr. § 1) che Lotman (Lotman e Uspenskij 1975, p. 43) intende la cultura come “memoria nonereditaria della collettività”.14 Si veda a seguire la parte sull’abito per un possibile fecondo confronto con quanto qui sostenuto da Lotman.
15dottorato in discipline seMiotiche
Chora N. 16, Settembre 2008
abbia una propria caratteristica di virtualità non è datosolo dal fatto che non sappiamo mai dove essa si arresti;è che essa contiene potenzialmente anche quello che difatto (oggi) non contiene più. (Eco 2007, p. 99)
L’Enciclopedia media di una data cultura […] ci garanti-sce il ricordo dei grandi fatti storici o dei principi della fisi-ca, ma lascia cadere un’infinità d’informazioni che la collet-tività ha rimosso, in quanto non le giudicava utili o perti-nenti. (Eco 2007, p. 99)
L’enciclopedia media non contempla la compartecipazionedi tutti alle informazioni che contiene, ma contempla piuttostola loro compartecipabilità. Questo significa che nello spazioenciclopedico che caratterizza ogni cultura vi sono sempre siainformazioni attualizzate che sono condivise sia informazioni inlatenza che potrebbero essere compartecipate. È qui che Ecointroduce il problema della memoria e dell’oblio, nel tentativodi capire come possano essere condivise le stesse informazionie come possa emergere la necessità di recuperare informazioniin latenza o di produrne di nuove.
Per Eco, è la cultura sotto forma di enciclopedia media a svol-gere la funzione di filtro; essa “non fa altro che selezionare i datidella propria memoria” (Eco 2007, p. 97), per evitare di far sape-re ciò che non sarebbe compreso, secondo quindi un criterio dicompatibilità. Se la dimenticanza è infatti utile “per non sovrac-caricare oltre il sostenibile la memoria collettiva” (ib., p. 96), ciònon toglie che le informazioni scartate siano rese latenti e chepossano sempre riemergere ripresentificate e rivivificate nellacultura: “In questi casi, talora la memoria collettiva si riappro-pria di quei dati reinserendoli nell’enciclopedia media, taloradecide di lasciarli in qualche riserva specializzata” (ib., p. 97).Questo dispositivo di filtraggio fa allora cadere talune proprie-tà, seleziona e lascia in latenza (ib., p. 90) una serie di informazio-ni al fine di trattenere ciò che invece è considerato essenziale.
La cultura, quindi, conserva e filtra, opera continuamente unprocesso di cancellazione per sopravvivere:
Le culture si presentano proprio come dispositivi che nonsoltanto servono a conservare e tramandare le informazio-ni utili alla loro sopravvivenza in quanto culture, ma anchea cancellare l’informazione giudicata eccedente. La culturanon fa dimenticare agli individui quello che sanno ma taceloro quello che non sanno ancora. (Eco 2007, p. 95)
Tuttavia, è necessario chiedersi attraverso quali strumentiquesto possa avvenire. Sempre secondo Eco, se la culturaagisce come filtro, l’operazione di filtraggio si verifica nell’in-terpretazione testuale: è la testualità, intesa come meccani-smo di dimenticanza16, che induce a magnificare certe pro-prietà e a narcotizzare quelle che sono irrilevanti per l’inter-pretazione di un certo testo:
Si comprende come, ogni volta che per disambiguareun qualsiasi enunciato in contesto dato si costruisce una‘ontologia locale’ si fa ad hoc la stessa operazione che unacultura fa per costituire la propria Enciclopedia Media. Sisfronda, si narcotizzano, si eliminano nozioni per ritenerequelle giudicate pertinenti. Come accade che, nello sforzodi individuare il contesto appropriato, si possano identifi-care le nozioni da sfrondare? Consideriamo il contesto
come se fosse un testo, e agiamo esattamente come agia-mo nel tentativo di comprendere un testo. Un testo (oltreche uno strumento per inventare o ricordare) è uno stru-mento per dimenticare, o almeno per rendere latentequalcosa. (Eco 2007, p. 100)
Non si tratta, tuttavia, di una dimenticanza definitiva,bensì transitoria. Semmai, la dimenticanza prodotta daltesto permette l’istituzione di una certa regolarità inter-pretativa nel caso in cui siano le medesime proprietà aessere selezionate. Il dispositivo di filtraggio della cultu-ra attuato nel testo si realizza così attivando un processodi attualizzazione e narcotizzazione, delineando unatteggiamento più o meno stabilizzato, una disposizionerispetto a determinate informazioni.
Se proviamo a riprendere quanto è stato detto perLotman, e cioè che il testo sia luogo di filtraggio culturale,riusciamo a cogliere una certa attinenza con quanto affer-mato qui sopra da Eco. Nella cultura ci sono meccanismidi stabilizzazione e destabilizzazione. Lotman, nella fatti-specie, fa riferimento alle “metadescrizioni delle normeculturali che sono alla base della creazione di nuovi testi,ne stimolano la produzione e, nello stesso tempo, sioppongono alle formazioni di testi di un certo tipo”(Lotman 1985, p. 97).
3.5. Filtraggio e abiti interpretativiI testi della cultura coinvolti nei dispositivi di conservazione
ed elaborazione che strutturano lo spazio della semiosfera edell’enciclopedia sono prodotti e connessi tra loro in funzionedi norme culturali che intendiamo come non preesistenti.Vogliamo cioè affermare che le norme regolative che permetto-no l’organizzazione di una data cultura non sono sovradeter-minate e fissate una volta per tutte, ma sono invece costituitenella reciproca co-implicazione di sistema e processo, e cioèriconfigurate localmente nelle pratiche di produzione delsenso. L’idea di una memoria distribuita permette di cogliere laformazione processuale di regolarità, che tiene conto di unaconformazione sistemica che viene a sua volta modellata dallepratiche di significazione, e da queste stabilizzata o rinnovata.La memoria viene costruita e negoziata collettivamente duran-te la produzione del senso, in un interscambio relazionale checonsidera ciò che è stato già prodotto e depositato in funzione
FIG. 4 -Sala Grande
15 Si rimanda all’introduzione per una più precisa trattazione del rapporto tra enciclopedia e memoria. Qui ci limitiamo a recupe-rarne la definizione, considerando i contributi di Violi e Paolucci che hanno posto l’accento sul dinamismo proprio dell’enciclope-dia: si tratta del deposito potenzialmente infinito e sempre mobile di saperi e discorsi, insieme delle interpretazioni registrate e con-dizione di possibilità di qualsiasi nuova interpretazione. Di questa enciclopedia massimale se ne determinano diversi livelli di pos-sesso e porzioni specifiche, ovvero enciclopedie parziali (Eco 1984, pp. 109-111; Violi 1992; Violi 1997a; Paolucci 2007; Eco 2007).16 In questo, Eco si avvicina alla posizione di Lotman spiegata in precedenza (cfr. Lotman e Uspenskij 1975; Lotman 1985; Lotman1993; Demaria 2006).
mEmoria culturalE E procESSi intErprEtativi
Chora N. 16, Settembre 2008
16
della pratica contingente. In questi termini, si potrebbe afferma-re che la memoria istituisce nuovi codici, sfruttando al tempostesso ciò che è già in memoria.
Abbiamo visto in Lotman ed Eco come un dispositivo di fil-traggio, che regola il passaggio di senso nel tempo, si attiva alivello della testualità quale strumento che permette alla culturastessa di filtrare. Vedremo ora come sia possibile rileggere lasemiosfera e l’enciclopedia nell’ottica dell’abito interpretativo,valorizzandone il funzionamento dinamico. In questa direzionevorremmo affermare che sia una somma di abiti interpretativi,e cioè una serie di regolarità che stabilizzano norme culturali edi interpretazione, a fungere da filtro nel passaggio di senso neltempo. Si tratta di valutare come in questa prospettiva la memo-ria sia chiamata in causa localmente.
La funzione della dimensione normativa è coniugare il latodell’elaborazione e creazione a quello della conservazione,mediante il mantenimento e il rinnovamento di abiti interpreta-tivi. I sistemi linguistici e culturali, infatti, possono essere visti daun lato come l’insieme delle predisposizioni a interpretare sem-pre nello stesso modo testi in qualche modo analoghi, e dall’al-tro come l’insieme delle predisposizioni a produrre testi in undeterminato modo. Vorremmo quindi partire dal fatto cheall’interno della cultura si possano individuare tanto regolaritàquanto rinnovamenti interpretativi, per provare ad affermareche la nozione di abito può fornire un interessante aiuto nel ten-tativo di porre una maggiore attenzione sulle dinamiche proces-suali proprie della memoria.
In precedenza, nel rilevare come si possano descrivere i mec-canismi filtranti nei termini di traduzione e interpretazione, si èosservato che il passaggio di un elemento da un sistema a unaltro è possibile solo attraverso la creazione di una catenadi inter-pretanti, ovvero una “catena di significanti che spiegano i signi-ficati di significanti precedenti in una potenziale progressione eregressione all’infinito” (Eco 1975, p. 100). Secondo Peirce, “l’in-terpretante è un’altra rappresentazione riferita allo stesso ogget-to” (ib., p. 101). Peirce afferma inoltre che “un’infinita serie dirappresentazioni, ciascuna rappresentando quella che precede,può essere concepita come avente un oggetto assoluto comeproprio limite” (CP 1.339). Eco fa notare che Peirce definiscequesto oggetto come abito e lo intende come interpretante finaleche interrompe la semiosi illimitata, la “potenziale progressione eregressione all’infinito” (Eco 1975, p. 100; CP 5.473-5.492).
Il contributo che il concetto di interpretante offre allo studiodella cultura viene individuato dallo stesso Eco quando sostie-ne che “si possono «toccare» gli interpretanti, [cioè] si può veri-ficare con mezzi fisici l’esistenza di ogni unità culturale, astrazio-ni materializzate dal fatto che la cultura traduce continuamentesegni in altri segni” (Eco 1975, p. 105). Il problema della memo-ria si affaccia in questo rinvio da segno a segno, nel passaggio disenso lungo una catena di interpretanti. Da una parte, è interes-sante osservare quale memoria viene elaborata e conservata trainterpretanti; dall’altra, viene da domandarsi sotto quale rispet-to i segni vengano intesi lungo questa catena. Anche il punto divista che permette di preferire certe proprietà ad altre viene sot-toposto a regolarità e attraversato dal processo complesso dellamemoria. La cultura propone così una catena di unità culturali,segni che la vita sociale mette a disposizione (ib., p. 106).Vediamo allora come il rapporto fra segno e abitudine puòindurre la formazione di regole d’azione.
Peirce non è mai interessato agli oggetti come insiemi diproprietà, ma come occasioni e risultati di esperienza attiva.Scoprire un oggetto significa scoprire il modus operandi oscoprirne l’uso pratico. Dopo aver ricevuto una sequenza disegni il nostro modo di agire nel mondo viene permanen-temente o transitoriamente mutato. A questo punto lasemiosi illimitata si arresta, lo scambio dei segni ha prodot-to modificazioni dell’esperienza, l’anello mancante trasemiosi e realtà fisica è stato finalmente identificato. Ci sono
tendenze generali e ci sono regole operative che ci permet-tono di verificarle. Intendere un segno come regola che siesplica attraverso la serie dei propri interpretanti significaaver acquisito l’abitudine ad agire secondo la prescrizionefornita dal segno. (Eco 1979, p. 45)
In questo modo, la regolarità interpretativa con cui viene inte-so un segno, come più volte ribadito, “è una tendenza ad agirein modo simile in circostanze simili nel futuro” (CP 5.487) e “l’in-terpretante finale di un segno è questa abitudine quale risulta-to” (CP 5.491). L’interpretante finale si forma quando l’interpre-tazione si consolida nella formazione di un abito interpretativo,da una parte chiudendo il processo inferenziale, dall’altra isti-tuendo una nuova catena di interpretanti. L’abito diventa quin-di filtro di memoria, criterio di accettabilità o scarto delle ipotesiinterpretative collettivamente condiviso (Pisanty e Pellerey2004, p. 118) e che regola il passaggio di senso nel tempo. Si for-niscono così legami di continuità con il passato, che fornisconole coordinate entro cui muoversi nell’ambiente culturale presen-te e programmi d’azione futuri. Nel caso l’abito funzioni, e cioènel caso in cui porti a un’interpretazione collettivamente accet-tata e condivisa, esso si stabilizza e la sua applicazione procedein modo inerziale secondo una certa regolarità, diventando cosìconvenzione. Nel caso ciò non dovesse verificarsi, o si esaurissela sua adeguatezza, l’azione regolatrice di quel determinatoabito finirebbe per entrare in crisi e perdere di efficacia, stimo-lando così la formazione di un nuovo abito (ib., p. 91).
Per riassumere, in virtù di un insieme di rapporti e di relazio-ni condivise collettivamente, l’abito interpretativo i) è la sommadegli effetti concepibili di un segno; ii) tiene memoria della cate-na dei segni interpretanti che ha contribuito alla sua formazio-ne; iii) istituisce regole d’azione. Nell’ottica di una teoria degliabiti interpretativi, la cultura si può quindi intendere da un latocome un insieme di regolarità che intervengono in modo iner-ziale nel corso di una pratica, e dall’altro come un insieme dipratiche sedimentate che stabilizzano localmente l’interpreta-zione. Questa stabilizzazione porta allora a una scelta prelimina-re di pertinenza in base alla quale nell’interpretazione si selezio-nano “solo i percorsi di senso che appaiono più fecondi in quel-la determinata circostanza” (ib., p. 93). È facile quindi vederecome sia l’insieme di più abiti interpretativi che sono propri diuna data cultura a operare da filtro, determinando rispetti ecapacità sotto cui i segni vengono intesi e operando al contem-po come una sorta di principio di stabilizzazione condivisa e dicambiamento nelle determinazioni degli oggetti.
3.6. Alcune caratteristiche dei meccanismi di filtraggioRiassumiamo quindi quelle che ci sembrano essere le princi-
pali caratteristiche dei meccanismi di filtraggio che regolano ilpassaggio di senso nel tempo e, in particolare, i processi di rico-struzione del passato, di cui parleremo più diffusamente nelprossimo paragrafo.
Innanzitutto il filtraggio, in quanto interpretazione che creauna commensurabilità locale tra elementi eterogenei, avvienesempre localmente, in una determinata pratica di significazione.Se a livello di una semiotica generale è possibile postulare deimeccanismi di filtraggio come condizioni di possibilità del pas-saggio di senso nel tempo e della sopravvivenza di una cultura,è solo nell’analisi dei processi stessi che possiamo individuarecome il filtraggio di fatto agisce.
Anche se il filtraggio è sempre locale, questo non significa chesia soggettivo o idiosincratico, né che l’attribuzione di senso nonsia determinata culturalmente e storicamente. Anzi, il confrontotra la semiotica di Lotman e quella di Eco ci ha portato a ricono-scere che i filtri culturali e linguistici che regolano il passaggio disenso nel tempo sono descrivibili come abiti collettivamente con-divisi, i quali, pur derivando la loro forza dai processi interpreta-tivi del passato, fungono allo stesso tempo da regolatori e stabi-lizzatori dell’interpretazione attuale o futura.
17dottorato in discipline seMiotiche
Chora N. 16, Settembre 2008
In questa prospettiva, ogni operazione locale di filtraggiomagnifica certe unità culturali e ne narcotizza altre (Eco 2007, 90).In altre parole, essa rende significanti, pertinenti e accettabilicerte interpretazioni passate — facilitando così una loro riattua-lizzazione — ma allo stesso tempo ne lascia cadere altre renden-dole momentaneamente non pertinenti, senza per questoannullare le loro potenzialità significanti.
I processi di filtraggio che agiscono nel passaggio di senso neltempo vanno quindi intesi come meccanismi selettivi che por-tano all’attualizzazione di catene di interpretanti, intesi in sensoampio non solo come proprietà semantiche che definisconoqualcosa, ma anche come comportamenti e azioni. Come abbiamo
visto, tale selezioneavviene tramite un insie-me di abiti sedimentati econdivisi che arginano eregolano il passaggio delsenso nel tempo, tutta-via, nell’analisi di proces-si locali di filtraggio,saranno solo quegli abitichiamati in causa di voltain volta nelle interazioniin atto a operare da filtro,in virtù di un principiopragmatico secondo cuigli abiti in grado di fun-zionare in modo efficace
in una determinata circostanza avranno una maggiore probabi-lità di entrare in gioco come filtri.
In questo senso, il filtraggio non è mai dato, ma è sempreil risultato di una pratica localmente situata che prevede lanegoziazione tra diversi sistemi semiotici, o meglio, tra insiemidi abiti più o meno in opposizione tra loro, come vedremomeglio nel paragrafo 4.
L’operazione di selezione operata dai meccanismi di filtrag-gio è inestricabilmente connessa alla trasformazione del sensoche viene filtrato: selezione e trasformazione sono come le duefacce di un stessa medaglia, in quanto il filtro trasforma selezio-nando e seleziona trasformando. Se il filtraggio regola il passag-gio di porzioni più o meno complesse di enciclopedia, fram-menti più o meno ampi di semiosfera, questo passaggio com-porta una riconfigurazione locale dell’enciclopedia di una cultu-ra, con effetti più o meno catastrofici in relazione al grado di alte-rità tra lo spazio semiotico di partenza e quello di arrivo.
4. Il restauro e le memorie del passato. Traduzioni einterpretazioni
In questa sezione proveremo a mostrare come gli stru-menti teorici sopra illustrati possano trovare un’efficaceapplicazione nell’analisi. Ci occuperemo di fenomeni socia-li in cui la problematica della memoria, intesa soprattuttonella sua accezione ‘collettiva’ di struttura connettiva di unasocietà, occupa un posto centrale.
Il caso d’analisi che abbiamo scelto è quello del restauro archi-tettonico e urbano. Le motivazioni di questa scelta sono diverse,ma tutte sostanzialmente riconducibili a una considerazione disenso comune: ogni intervento di restauro è, prima di tutto, untentativo di recupero o di conservazione di una cosa passata epresenta, sotto questo punto di vista, un’evidente parentela conaltre pratiche di codificazione, memorizzazione e recupero diunità culturali, quali ad esempio l’archivistica, la storiografia o lafilologia. Al pari di queste altre pratiche, e anzi, in misura signi-ficativamente maggiore, gli interventi di restauro trovano postoall’interno di una complessa rete composta da istituzioni e spe-cializzazioni molto varie che, sole, li rendono possibili. Questaprima considerazione complica allora la definizione di senso
comune appena fornita (il restauro come ‘recupero del passato’) einvita a considerare gli interventi di restauro in termini non soloestetici o filologici, ma anche e soprattutto politici e valoriali. Perfare un esempio chiarificatore, si consideri la vicenda emblematicadel Palast der Republikdi Berlino, edificato negli anni ’70 sulle mace-rie dello Stadtschloss, un castello che ha rivestito una certa impor-tanza nella storia tedesca e che subì gravi danneggiamenti duran-te i bombardamenti della seconda guerra mondiale17. Il Palast derRepublik fu costruito nel periodo in cui Berlino era capitale dellaRepubblica Democratica Tedesca, sotto l’influenza sovietica. Purconservando alcuni elementi originali del prospetto delloStadtschloss (ad esempio il balcone da cui nel 1918 fu proclamata laRepubblica, che venne integrato nell'adiacente palazzo delConsiglio di Stato, lo Staatsratsgebaude), esso aveva comunquel’aspetto tipico degli edifici governativi della Germania socialistadell’epoca e ha rappresentato per cinquanta anni un elemento alta-mente riconoscibile nel profilo urbano della città. Tuttavia, proprioin questi ultimi anni, è stato approvato un progetto di demolizio-ne dell’edificio e di contestuale ricostruzione del precedente castel-lo dello Stadtschloss. Il risultato di tale operazione consiste dunquesostanzialmente nella cancellazione radicale delle tracce prodottenel corso di un periodo storico (quello socialista) e nel contempo-raneo recupero, forse più ideologico che filologico, del volto checaratterizzava quei luoghi nel periodo pre-nazista e pre-socialista.
L’esempio proposto può sembrare particolarmente estremo,anche se la scelta di demolire un edificio al fine di ricostruire àl’identique ciò che c’era prima è comunque contemplato nellacasistica degli interventi di restauro. Nondimeno, esso mostracon una certa efficacia come ogni intervento di restauro, di rico-struzione o di ripristino non coincida mai con una pratica inno-cente di conservazione di un generico passato, ma si caratteriz-zi piuttosto come un processo di selezione e, in definitiva, diinvenzione, e questo nella duplice accezione di riscoperta/rinve-nimento e di creazione/produzione di un passato. Tutto ciògetta una luce molto diversa sull’idea del restauro come restitu-zione fedele di una memoria passata, e ci spinge in direzione diuna concezione del restauro come interpretazione e rilettura diun passato al presente.
In questo senso, il caso del restauro rende a nostro avviso par-ticolarmente evidente quanto dicevamo nel paragrafo prece-dente a proposito di un approccio allo studio della memoria cheopponga alla nozione di tradizione quella, più semiotica, di tra-duzione. Il restauro, alla luce di questi concetti, finisce infatti conl’essere una pratica di scrittura e di produzione di memoria cheagisce su testi sociali (per continuare a usare la terminologia lot-maniana) del tutto particolari, e cioè su testi che somiglianomolto, nella sovrapposizione delle varie stratificazioni e deidiversi sensi che le percorrono, a dei palinsesti. Se di pratica discrittura si può dunque parlare, si tratta di una scrittura palinse-stuale, e cioè di una scrittura colta da un’apparente paradossali-tà che riproduce in realtà l’immancabile dialettica tra memoria eoblio: una scrittura che, per conservare una memoria, ne occul-ta altre, a volte volontariamente, a volte inevitabilmente. Le dif-ferenze tra tale cancellazione inevitabile e qualsiasi forma di can-cellazione volontaria sono allora le stesse che passano, per dirlacon Lotman, “tra la dimenticanza in quanto elemento dellamemoria e la dimenticanza in quanto strumento della suadistruzione” (Lotman e Uspenskij 1975, p. 47). La pratica delrestauro si rivela, dunque, utile a mostrare un’altra caratteristicadella memoria, ovvero il fatto di costituire un terreno di scontroacceso tra poteri e ideologie diverse, cosa che fa rientrare a pienotitolo il restauro tra quegli strumenti che Ricœur ha potuto defi-nire costitutivi degli “usi e abusi della memoria” (Ricœur 2000).
Per la semiotica, in questo senso, l’intervento di restauroandrebbe considerato come un processo di iscrizione, cancella-zione, o, meglio ancora, trasformazione di un sistema di valori(nel senso più astratto del termine). Ecco allora che l’apporto più
FIG. 5 - Particolare del soffitto
17 L’esempio è tratto da un saggio di Maria Grazia Ercolino (2006) che affronta argomenti vicini a quelli qui proposti.
mEmoria culturalE E procESSi intErprEtativi
Chora N. 16, Settembre 2008
18
significativo che può derivare da una modellizzazione semioti-ca del fenomeno della memoria consisterà nella capacità didisimplicazione dei sistemi di valori soggiacenti a ogni proget-to di restauro, esattamente come a qualsiasi altri tipo di procedi-mento di scrittura della memoria.
4.1. Memoria e spazialitàStudiare la memoria culturale a partire dalle azioni di
restauro conduce inoltre inevitabilmente a considerare daun’altra prospettiva il nesso che lega memoria e spazialità.Come fa notare giustamente Jan Assmann, illustrando lanozione di ‘mnemotopo’: “il medium primigenio di ogni mne-motecnica è la spazializzazione. […] L’arte della memoriaopera servendosi di spazi immaginari, la cultura del ricordo dipunteggiature dello spazio naturale” (Assmann 1992, p. 33 tr.it.). Senza soffermarci in questa sede su una nozione comples-sa come quella di ‘luogo della memoria’, che tanto spazio haricevuto nella recente riflessione sul tema della memoria e delricordo, vorremmo piuttosto provare a riflettere sulla parente-la che lega i ricordi ai luoghi, con l’obiettivo di recuperare larelazione — sulla quale tanto abbiamo insistito nei paragrafiprecedenti — tra dimensione esperienziale e situazione localenel processo di costruzione della memoria.
A questo scopo, facciamo nostre le riflessioni di Ricœurquando si interroga sulla memoria provando a collocarsi oltrequella che lui chiama una “fenomenologia dell’intenzionalità edel soggetto”, definendo così la memoria come un insieme diprocessi “che implicano il corpo, lo spazio, l’orizzonte delmondo o di un mondo”. Ricœur si serve dalla categoria rifles-sività/mondità per spiegare come, nell’atto del ricordo, non ci siricordi solo di sé nell’atto di fare, di sentire o di apprenderequalcosa, ma anche delle ‘situazioni mondane’ in cui si è agito,sentito o appreso qualcosa:
queste situazioni implicano il corpo proprio e il corpodegli altri, lo spazio vissuto, infine l’orizzonte del mondo edei mondi in cui qualche cosa è accaduto. Tra riflessività emondità c’è una vera e propria polarità, nella misura in cuila riflessività è un tratto irrecusabile della memoria nella suafase dichiarativa. (Ricœur 2000, pp. 56-57 tr. it.)
Ciò porta Ricœur a contestare quello che considera un limitedell’idealismo soggettivista (identificato con il concetto di epochédel primo Husserl) che difetterebbe della capacità di mettere inrelazione il polo riflessivo della soggettività con il polo dellamondità. Vediamo, in questa idea di memoria come fenomenoche si dà solo nella relazione tra riflessività e mondità, un forte
parallelismo con la concezione di memoria come processodistribuito e diffuso nei termini in cui abbiamo provato a defi-nirla in precedenza.
Un altro suggerimento interessante che ci fornisce Ricœur è lasua proposta di considerare il punto di sutura in cui si incontra-
no memoria corporea e memoria dei luoghi come unapossibilità di svincolamento da una dimensione esclusi-vamente riflessiva. L’esempio dato da Ricœur è illumi-nante e introduce molto bene, a nostro avviso, le analisiche seguiranno: “durante la visita di quel sito archeolo-gico, richiamavo il mondo culturale scomparso, cui lerovine tristemente rinviano. Come il testimone di un’in-dagine poliziesca, posso dire di quei luoghi che «ioc’ero»” (ib., p. 61 tr. it.).
Si tratta per noi di un’idea che complessifica la concet-tualizzazione del luogo della memoria come punto diraccordo tra memoria individuale e memoria collettivae che apre favorevolmente a una ricollocazione delledue istanze — individuale e collettiva — all’interno diun unico spazio vissuto. Fa qui la sua comparsa ladistinzione tra spazio geometrico e spazio vissuto; ilmomento in cui un soggetto abita uno spazio è quello incui — oltre a scandire e punteggiare i ricordi dell’indivi-duo — sembra ricucirsi lo iato tra la memoria riflessivae le memorie sociali. Ciò introduce una questione moltoimportante per il discorso che andiamo ad affrontare,ovvero quella relativa all’apporto della relazione sog-
getto-mondo nei processi di costruzione del senso e dellamemoria. Per tornare ai problemi posti da Ricœur, non possia-mo non notare come prima cosa che da un certo punto di vistala sua distinzione tra spazio geometrico e spazio vissuto riecheg-gia sia quella merlaupontiana tra spazio geometrico e spazioantropologico, sia quella proposta da De Certeau tra ‘luogo’ e‘spazio’ (che non a caso riprende proprio la nozione di spazioantropologico di Merleau Ponty). Proviamo allora ad affidarcidirettamente alle parole di De Certeau:
È un luogo l’ordine (qualsiasi) secondo il quale deglielementi vengono distribuiti entro rapporti di coesisten-za […], una configurazione istantanea di posizioni.Implica una indicazione di stabilità. Si ha uno spazio dalmomento in cui si prendono in considerazione vettori didirezione, quantità di velocità e la variabile del tempo.Lo spazio è un incrocio di entità mobili. È in qualchemodo animato dall’insieme dei movimenti che si verifi-cano al suo interno. È spazio l’effetto prodotto dalle ope-razioni che lo orientano, che lo circostanziano, lo tempo-ralizzano e lo fanno funzionare come unità polivalentedi programmi conflittuali o di prossimità contrattuali. Lospazio sarebbe rispetto al luogo ciò che diventa la paro-la quando è parlata […]. Insomma, lo spazio è un luogopraticato. (De Certeau 1980, pp. 175-176 tr. it.)
Sarà proprio attraverso questa accezione di spazio comeluogo praticato che indagheremo il rapporto soggetto-mondo,nella produzione di memoria. A questo punto, è però necessa-rio provare ad avanzare alcune definizioni più tecniche che cipermetteranno di abbozzare dei modelli che riproducono l’inte-razione soggetto-mondo attraverso l’attraversamento di spazi.
4.2. Per una semiotica della memoria dei luoghiTutte le considerazioni avanzate sino a qui, apparentemente
di ordine esclusivamente teorico-filosofico, ci consentono diintrodurre dei criteri per lo studio della memoria prodotta da unrestauro e rappresentano dunque lo sfondo teorico della nostraanalisi. A partire dalle nostre riflessioni sul restauro come prati-ca di scrittura della memoria, sui legami tra memoria e spaziali-tà e sulle modalità attraverso cui un determinato luogo dellamemoria produce una peculiare relazione soggetto-mondo si
FIG. 6 -Piazza Santo Stefano anni ‘80 prima degli ultimi restauri
19dottorato in discipline seMiotiche
Chora N. 16, Settembre 2008
tratterà dunque, a questo punto, di tentare un ulteriore passo indirezione di una definizione degli oggetti che verranno sotto-posti ad analisi. Si tratta di una mossa metodologica atta a iden-tificare luoghi che hanno subito, in virtù di un intervento direstauro, una trasformazione che riguarda soprattutto la loromemoria, i segni della memoria che portavano iscritti. I proble-mi che dobbiamo affrontare pertengono essenzialmente a dueordini differenti: da una parte abbiamo bisogno di una defini-zione di spazio che sia in grado di includere e prevedere al suointerno dei modelli di circolazione e di interazione tra attanti, aloro volta definibili esclusivamente a partire dalle posizioni cheoccupano all’interno di un sistema topologico relazionale.Dall’altra, dovremo invece rendere conto di come all’interno diun tale sistema spaziale definito da reti attanziali emerga,secondo le modalità distribuite descritte fin qui, qualcosa chepossa essere definito una memoria.
Prendiamo allora una prima definizione da Greimas, chedefinisce lo spazio, in opposizione all’estensione/sostanza,come una forma e una costruzione, ovvero come un’“estensioneinformata” (Greimas 1976, p. 125 tr. it.). Lo spazio, che si oppor-rebbe così alla continuità dell’estensione in quanto esito dellaproduzione di elementi discontinui, si caratterizzerebbe per ilfatto di essere ‘formato’ e ‘costruito’.
Pensare lo spazio come forma, rispetto alla sostanza, che èpura estensione, vuol dire riconoscergli la capacità di espri-mere delle morfologie significanti. Lo spazio costruito di unacittà, ad esempio, può dirci molto sull’organizzazione internadi una società, sulle modalità in cui essa si relaziona nei con-fronti di ciò che considera ‘esterno’ o ‘estraneo’ e anche sulmodo in cui essa si pone nei confronti del proprio passato e,di conseguenza, del proprio futuro. Queste modalità attraver-so cui uno spazio costruisce una propria memoria ci interes-sano ai fini della nostra trattazione, perché uno spazio puòsempre caricarsi di significanti sociali e costituire così unavera e propria semiotica tramite la quale “una società signifi-ca se stessa a se stessa” (ib., p. 127 tr. it.).
Ecco allora che pensare lo spazio come costruzione obbligaa includere nella problematica la questione del soggetto, inte-so come “produttore e consumatore di spazio” (ib., p. 339 tr.it.). Bisogna però chiarire subito che non stiamo parlando quidi una soggettività individuale statica posta di fronte a unmondo che percepisce e a cui assegna significati; stiamo inve-ce parlando piuttosto di una entità a un tempo corporea e cul-turale che, contemporaneamente, produce lo spazio che stia-mo considerando ed è inclusa nello stesso18.
Per la semiotica i sistemi spaziali così definiti non sono deter-minabili a partire da un paesaggio materiale fatto esclusivamen-te di ‘cose’ (edifici, architetture, monumenti, arredi, porte, scaleetc.), cui far corrispondere, in virtù di un determinato codice cul-turale, dei significati. Un sistema spaziale è invece piuttosto “unagglomerato di esseri e cose” (ib., p. 137 tr. it.) tra cui sono distri-buiti ruoli attanziali diversi. Come dice Marrone, riprendendo ilsaggio citato di Greimas: “non c’è, da un lato, una società fattadi uomini e, dall’altro, uno spazio fatto di oggetti che quellasocietà accoglie in modo più o meno adeguato; c’è semmaiun’unica, generale, forma sociale, che comprende sia uomini, siacose, sia spazi, portatori ognuno di ruoli attanziali specifici”(Marrone 2001, p. 319).
Nel nostro caso, dunque, lo spazio restaurato, o meglio ancora,l’oggetto restaurato (l’architettura, il monumento, la città, il benearchitettonico) diventa in questo senso un oggetto topologico che
appartiene a un agglomerato composito. Esso non si carat-terizza esclusivamente per il fatto di possedere una mor-fologia e delle salienze fisiche proprie, ma soprattutto peril fatto di essere una configurazione complessa dotata disenso e produttrice dello stesso. Questa concezione è allo-ra analoga a ciò che intendiamo con la nozione di rete attan-ziale, e cioè una configurazione in grado di determinare eprevedere posizioni non necessariamente antropomorfe(anche un edificio può essere considerato sotto il profiloattanziale nella misura in cui può far-fare o far-non-faredeterminate cose), di rappresentare e mettere in movi-mento valori e identità, di includere osservatori e punti divista, di funzionare come un operatore passionale etc.
Sempre per quanto riguarda il nostro oggetto, cheha a che fare con contesti spaziali di natura architetto-nica o urbana, adottare questa definizione di spazio cidà anche il vantaggio di prendere in considerazionequello che Hammad definisce “il complesso «architet-tura più spazio», […in cui] il soggetto umano è neces-sario per la costruzione del senso o del contenuto nonsolo come destinatario interprete di quel che è dettodall’espressione, ma anche e soprattutto come parte
del sistema dell’espressione” (Hammad 2004, p. 12), e cioècome attanti tra altri attanti. Non solo. Trascrivere una confi-gurazione spaziale come un insieme di interrelazioni e intera-zioni fra attanti ci permette altresì di valutare di volta in voltai pesi specifici dell’apporto di ogni posizione attanziale nelladeterminazione di una memoria sistemica.
Ciò che proveremo a fare nella nostra analisi sarà appuntoseguire la traccia delle interazioni tra un soggetto e uno spazioattraverso quelle che chiamiamo pratiche di attraversamento dellospazio. Per fare ciò, proveremo a definire i diversi statuti deidiversi attanti presenti nel sistema spaziale considerato.Riprendendo quanto dice Marrone (2001, pp. 320 e segg.), ma inparte rileggendolo alla luce dell’approccio che proponiamo,dobbiamo distinguere innanzitutto fra tre differenti tipi di sog-gettività attanziale coinvolta:
1. le porzioni di spazio cui viene delegato un ruolo attanziale;ad esempio, una finestra, incorniciando in un certo modo ciòche sta al di fuori, /fa vedere/ una certa porzione di paesaggio;un cancello, impedendo il passaggio, orienta un certo percorso;un ascensore risulta dotato di un /poter fare/ che permette alfruitore dello spazio (che invece non possiede lo stesso /poterfare/) di accedere a un piano superiore cui non potrebbe accede-re da solo; ecc. Parleremo in questi casi di soggetti delegati;
2. quelli che Marrone chiama gli “Utilizzatori Modello”19 dellospazio (che noi potremmo chiamare attraversatori modello), checonsistono in soggetti previsti e inscritti nella struttura topologicadello spazio (e quindi nel suo progetto, quando c’è). Questi sogget-ti sono quelli “che si fanno carico di quelle forme di comportamen-to che i luoghi esplicitamente richiedono” (ib., p. 321);
FIG. 7 - La netta separazione
18 Vedi anche Violi (2007).
mEmoria culturalE E procESSi intErprEtativi
Chora N. 16, Settembre 2008
20
3. i soggetti sociali reali (Marrone li chiama “UtilizzatoriEmpirici”) che, in virtù della loro pratiche, possono ri-seman-tizzare certi significati dei luoghi e dar vita a nuovi usi “social-mente accettati” di tali luoghi.
In questo modo, ogni spazio non solo include determinati attan-ti delegati che ne scandiscono l’articolazione, ma prevede inoltreda un lato dei comportamenti corretti e previsti al suo interno e dal-l’altro lato delle pratiche non previste che rimotivano le funzioni e isignificati dei luoghi. Se proviamo a piegare queste considerazionial nostro oggetto di studio (spazi restaurati) possiamo avanzaredue osservazioni. Come prima cosa, si potrebbe dire che, da uncerto punto di vista, il progetto di restauro rientra in quella cheAssmann (1992) chiama la mémoire volontaire di una società, nelsenso che un progetto seleziona sempre delle cose che devonoessere ricordate e il modo in cui devono essere ricordate. Tuttavia,per introdurre un aspetto che Assmann sembra considerare poco,è necessario notare in seconda battuta come le pratiche di fruizio-ne e di attraversamento di uno spazio restaurato possano tradursiin processi di riconfigurazione dei sensi passati dei luoghi, proces-si che chiamano in causa una sorta di mémoire involontaire.
Proveremo ora a testare questi strumenti su tre oggettid’analisi diversi: la ricostruzione del teatro La Fenice aVenezia, il restauro di piazza Santo Stefano a Bologna, laristrutturazione dell’ex campo di concentramento (oggimemoriale) di San Sabba, vicino Trieste.
4.3. La Fenice, com’era e dov’eraIl 29 gennaio del 1996 il Teatro La Fenice di Venezia viene com-
pletamente distrutto da un incendio doloso; si decide di ricostruir-lo “com’era e dov’era”, come recita una formula spesso utilizzatadai restauratori fautori dei ripristini. Dopo circa otto anni, i vari can-tieri chiudono e restituiscono alla città di Venezia la Fenice, com’erae dov’era. Ma com’era allora la Fenice prima dell’incendio?Leggiamo questo passo tratto da un volume sui restauri delledecorazioni del teatro:
il concorso per la rinascita della Fenice ha richiesto, daparte di un alto numero di specialisti, ancor prima dellaricostruzione grafica, la sua restituzione mnemonica. Mainessun teatro è stato così studiato, analizzato fin nei minimiparticolari, attraverso fotografie, documenti, disegni e sotto-posto all’occhio indiscreto del microscopio, nelle sue pove-re parti rimaste. (Amendolagine e Boccanegra 1997, p. 13)
Nonostante le migliori intenzioni di chi aveva deciso, com-missionato e progettato l’intervento, è evidente come sia proprioil “com’era” a costituire il principale problema del restauro delteatro. Per capire bene cosa è successo alla Fenice, è infatti neces-sario considerare che normalmente un intervento di ricostruzio-ne prevede delle fasi preliminari e necessarie, come l’acquisizio-ne di dati e di documentazioni varie, sopralluoghi, rilievi, etc. Sitratta di attività necessarie per risalire (per ricorrere a un’espres-sione molto usata dai restauratori) al significato filologico delbene che si intende restaurare. Tralasciamo per ora la questione,centrale per la semiotica, di come queste fasi, più che costituireun’innocente pratica di ‘raccolta di dati’ oggettivi, costituiscanosempre un’attività di interpretazione e di produzione di signifi-cati. Quello che ci interessa a questo livello è che, in questo caso,tutte queste preliminari attività di raccolta di informazioni,necessarie a stabilire ‘com’era’ il teatro La Fenice, erano resesignificativamente più difficili dal fatto che le fiamme avevanodivorato la quasi totalità degli arredi, delle decorazioni e deglielementi che si intendeva riprodurre fedelmente. In questomodo, da una parte si inizia fin da subito a riportare alla luce ciòche era rimasto tra le macerie annerite delle sale, raccogliendotracce, indizi e campioni bruciacchiati; dall’altra, si incomincia-no invece a consultare archivi e documenti, al fine di ritrovare
foto e disegni utili a ricostruire l’immagine di ciò che era andatoirrimediabilmente distrutto. Negli anni successivi, un numeroaltissimo di specialisti e artigiani viene impiegato per mesi in unmeticoloso quanto faticoso lavoro volto a ricostruire, con tecni-che antiche e con le stesse procedure utilizzate nel ’700, queglistessi decori, affreschi edorature che abbellivanole sale del teatro. Più chedi operazione di ‘messain pristino’, si dovrebbeparlare (e si è infatti par-lato) di ricostruzione stili-stica; in fondo la stessache il teatro conobbe giàuna prima volta a metà’800, quando andò afuoco e venne ricostruitodall’architetto GiovanBattista Meduna, rispet-tando lo stile e i progettidel primo progettista,Gustavo Selva.
Ricapitolando: la prima Fenice fu progettata e costruita daGustavo Selva, in pieno gusto settecentesco e con l’intenzionedi costruire un teatro per la musica lirica dell’epoca. Questoprimo teatro va a fuoco e viene ricostruito nell’800 dalMeduna, con l’intenzione di farne una copia il più fedele pos-sibile; e in seguito va a fuoco un’ultima volta nel 1996, per esserpoi ricostruito e consegnato alla città nel 2004 (progetto diAldo Rossi), ma, in realtà, come copia di una copia.
Il caso della Fenice rappresenta evidentemente un buonesempio di come anche il tentativo estremo di ricreare artifi-cialmente, ma fedelmente, un ‘passato perduto’ costituisca inrealtà una ri-produzione e un’interpretazione mediata da altreinterpretazioni e da altre pratiche che conferiscono determina-ti sensi all’interno della ‘memoria enciclopedica’ a quel passa-to che si pretende di conservare. Potremmo dire che, se è veroche dai valori iscritti nello spazio si può comprendere il modoin cui una società tematizza il proprio rapporto con il passato,nel caso della Fenice è il passato in sé a costituirsi come valoreiscritto nella riorganizzazione spaziale di quei luoghi, così chequesta re-iscrizione avviene proprio attraverso il tentativo diproduzione di una copia fedele.
Come applicare al caso dello spazio restaurato della Fenice iprincipi esposti nei paragrafi precedenti? Ci focalizzeremo,come già accennato, sulle pratiche di attraversamento di talispazi e sulle differenze tra le pratiche inscritte e motivate nellospazio pre e post-restauro. Per la nostra analisi, prenderemo inconsiderazione esclusivamente le cosiddette sale d’atrio e saleapollinee, che costituiscono l’ingresso e il foyer del teatro (figure3 e 4): si tratta di spazi che vengono attraversati dai frequentato-ri esclusivamente all’ingresso, all’uscita e durante gli intervalli.Bisogna premettere che i progettisti non avevano in queste salegli stessi problemi che si presentavano loro nelle sali teatrali veree proprie, per le quali si trattava non solo di restituire le decora-zioni e gli arredi preesistenti, ma di preservare le originarie pro-prietà acustiche della sala. Inoltre, se per quanto riguarda le saleteatrali si poteva forse ammettere che l’apparato decorativofosse del tutto funzionale e propedeutico a quello scenico — equindi all’acustica — per quanto riguarda le sale d’atrio e apol-linee, gli apparati decorativi non rivestivano invece nessun valo-re artistico particolare: si trattava per lo più di stucchi, decorazio-ni, affreschi e arredi vari inseriti a metà ’800 dal Meduna, in occa-sione dei lavori di ricostruzione di quel periodo. Stiamo parlan-do, per intenderci, di sale di gusto perlopiù settecentesco, facil-mente riconducibili al senso estetico delle residenze venezianedi lusso di quel periodo: pavimenti decorati con intarsi lignei,
FIG. 8 - Il progetto di restauro
19 Marrone riprende qui, adattandola allo spazio, la teoria echiana del “lettore modello”.
21dottorato in discipline seMiotiche
Chora N. 16, Settembre 2008
soffitti in marmorino, colonne corinzie e balaustre con fregidorati, pareti con campiture tappezzate in seta, lampadari inbronzo e cristallo etc.
La fruizione tipica di queste sale prima dell’incendio era orienta-ta verso programmi narrativi di socialità, secondo le modalità tipi-che dell’alta borghesia. Si trattava infatti di sale da attraversare inentrata e in uscita (sale d’atrio) e in cui stazionare durante l’inter-vallo (sale apollinee): luoghi in cui chiacchierare, bere qualcosa inattesa del secondo atto, incontrarsi, osservare gli altri, osservarsi inuno dei tanti specchi presenti. Questi programmi narrativi di tiposociale hanno di norma la meglio sui programmi di contemplazio-ne degli arredi e delle decorazioni che, come già detto, non rivesto-no nessun particolare valore e al massimo restituiscono un’inter-pretazione del gusto dell’epoca (ricordiamo che gli arredi settecen-teschi furono ricostruiti a metà ’800).
Che cosa succede allora dopo la ricostruzione? Lo statutodegli elementi di arredo cambia completamente: da sfondoindistinto essi diventano Oggetti20 che hanno iscritto in sé undeterminato valore, e cioè quello del passato in sé, del passato-in-quanto-valore che si intende preservare e conservare. Cambiadi conseguenza anche lo statuto dei soggetti che attraversanoquesti spazi, e cioè cambia la modalità di attraversamento el’assiologia che definisce il loro percorso, che coincide ora conla valorizzazione di un passato conservato, e che è orientatoverso l’appropriazione di tale valore, il passato fedele iscritto inquei luoghi. Lo statuto degli Oggetti (decorazioni, arredi, affre-schi etc.) cambia dunque non in sé, ma cambia nella misura incui cambia il suo valore per il soggetto, innescando a sua volta,un mutamento in tutta la struttura relazionale di tipo attanzia-le che conferisce un nuovo senso alla pratica di fruizione dellasala. Questo mutamento è a sua volta causato dal mutato sta-tuto cognitivo degli attori in gioco: il Soggetto sa21 che quegliarredi sono stati ricostruiti, sa che sono riproduzioni fedeli del-l’originale, riconosce il valore di passato in essi iscritto. È insom-ma cambiato quello che in semiotica chiameremmo il caricomodale del soggetto22, che passa così da un /poter non vedere/a un /voler vedere/. Per riprendere quanto dicevamo nei parr.2 e 3, siamo cioè in presenza di un mutamento d’abito determi-nato dal mutamento delle salienze e dei valori pertinentizzatidello spazio, così che una copia perfettamente identica dellostesso oggetto può assumere un valore semantico completa-mente diverso, dal momento che è cambiata la rete di relazioniin cui è presa e che ne definisce l’identità.
Ecco allora che lo status particolare delle decorazioni ricostruitechiama in causa una memoria e, soprattutto, il processo di costru-zione di una memoria: il valore di cui le decorazioni si fanno por-tatrici è infatti ora il valore in sé del passato di quel luogo, ribadi-to in quanto conservazione e ri-presentazione del suo stesso esse-re passato. E questo tipo di valore passato del luogo non è né unsignificato riferibile esclusivamente alla materialità della sala rico-struita né all’enciclopedia di riferimento del soggetto, ma è inveceprodotto in situazione, ovvero nel processo di fruizione e di attra-versamento della sala attraverso una mediazione continua e irri-ducibile tra gli abiti, le aspettative, l’enciclopedia del soggettoattraversatore e i rimandi enciclopedici di tipo culturale a cui l’or-ganizzazione spaziale rinvia il soggetto, istruendo la memoriadella sua enciclopedia. Per dirla in altri termini, da una parte c’è
un ambiente che ri-produce uno stile passato, dall’altra ci sono lecompetenze enciclopediche del soggetto attraversatore che, attri-buendo ad alcuni elementi di tale ambiente certi valori tempora-li, determina — attraverso un processo di datazione e di ricono-scimento di tali valori temporali — l’appropriazione della memo-ria di quel luogo e la riconfigurazione dell’esperienza di attraver-samento, che diventa così un’esperienza di partecipazione a unamemoria culturale. Questa interazione tra memoria enciclopedi-ca del soggetto da una parte, e istruzione e rimando mnesticodello spazio dall’altra, si traduce allora in un processo di filtraggioche, magnificando elementi prima narcotizzati e narcotizzabili,produce il senso del passato del luogo, che è, per l’appunto, uneffetto di senso generato all’interno del sistema attanziale localesoggetto/spazio.
4.4. Il restauro rinascimentale di Piazza Santo Stefano aBologna
Il caso di Piazza Santo Stefano a Bologna illustra alla perfezio-ne la natura palinsestuale dei sistemi spaziali di cui abbiamo giàdetto. Come fa notare De Certeau,
la differenza che definisce ogni luogo non consiste inuna giustapposizione, ma assume la forma di strati embri-cati. […] Così, la superficie di questo luogo appare un col-lage. Ma in realtà è un’ubiquità nello spessore. Una sedi-mentazione di strati eterogenei. Ciascuno, come la paginadeteriorata di un libro, rinvia a modalità diverse di unitàterritoriale, di suddivisione socio-economica, di conflittipolitici e di simbolizzazione identificatoria. (De Certeau1980, pp. 281-282 tr. it)
Allo stesso modo, stratificata e palinsenstuale, appare piazzaSanto Stefano a Bologna, per la complessità delle vicendecostruttive che l’hanno interessata nel corso dei secoli e cheaffondano le radici in periodi pre-romani, quando il sito ove orasorge la piazza e la basilica era sede di un tempio pagano. Sullespoglie di quel tempio venne in seguito edificata, in epoca lon-gobarda (la prima notizia che abbiamo risale allo 800 d.C.), unachiesa cattolica sulla quale poi venne a innestarsi (800-1000 d.C.)il progetto di costruzione di una riproduzione simbolica dei luo-ghi sacri del sepolcro di Gerusalemme. Le chiese di SantoStefano, sette secondo la vulgata bolognese, recano traccia diqueste stratificazioni e sedimentazioni di significati che si sonoaccumulati nel corso di due millenni, anche se si tratta di tracceche in effetti risentono degli interventi di restauro del secoloscorso, i quali, intendendo magnificare l’aspetto romanico delcomplesso delle chiese, hanno cancellato diversi strati tempora-li della basilica. Si tratta di un perfetto esempio di come anche ilrestauro, come pratica di (ri)scrittura della memoria, obbediscaa una vocazione palinsestuale, secondo la quale, per poter scri-vere e riscrivere, bisogna prima raschiare via alcuni strati. E d’al-tronde, come detto, il restauro costituisce un importante dispo-sitivo di filtraggio nella misura in cui decide cosa deve essereconservato e cosa, invece, può andar dimenticato.
In questa sede non ci occuperemo tuttavia dei restauri delcomplesso delle sette chiese, bensì dello spazio della piazza nellasua totalità. Sarà quindi senz’altro necessario, prima di procede-
20 Nella teoria semiotica, l’Oggetto è un attante (si veda nota 5), Soggetto e Oggetto si definiscono posizionalmente nella relazioneche intrattengono.21 Ed è istruito su ciò non solo da informazioni intertestuali ma anche dal materiale informativo sull’intervento solitamente pre-sente all’ingresso. Non sappiamo se esistono anche targhe commemorative: esse costituirebbero ulteriori istruzioni a valorizzare illuogo in un certo modo. Possiamo considerare anche il caso in cui il soggetto “non sa” e in quel caso ricadiamo nel tipo di fruizio-ne che caratterizzava il teatro prima del restauro. Tuttavia, bisogna considerare che anche i comportamenti delle altre persone, inquanto elementi di quell’“agglomerato di esseri e cose” che è lo spazio, diventano ulteriori “segni” che istruiscono sui rimandi enci-clopedici pertinenti, cosa che rende di fatto impossibile attraversare quelle sale come se fossero ottocentesche (anzi, come abbiamovisto, finto-settecentesche).22 In semiotica, l’acquisizione, da parte del Soggetto, delle modalità del volere, dovere, sapere, potere viene chiamata competenzadel Soggetto. Con carico modale intendiamo quindi le differenti modalità “possedute” dal Soggetto.
mEmoria culturalE E procESSi intErprEtativi
Chora N. 16, Settembre 2008
22
re, riassumere anche questa volta le principali vicende di trasfor-mazione di tale luogo. Per non appesantire troppo il nostrodiscorso e arrivare velocemente al punto che ci interessa, parti-remo, nella nostra breve ricostruzione, dai restauri degli anni’30, che modificano radicalmente l’assetto morfologico dellapiazza. Si passò, infatti, dalla classica conformazione a trebbomedievale, come si vede in figura11, a una nuova suddivisionedello spazio ottenuta tramite il ribassamento del sagrato cui siaccede da una scalinata e l’apertura del resto della piazza al traf-fico automobilistico (figure 6, 7). Le figure 8, 9 e 10 mostranoinvece l’assetto attuale della piazza, effetto dei restauri di fineanni ’80, tramite i quali si intendeva restituire a Piazza SantoStefano, riassumendo i termini del dibattito di quegli anni, la suaoriginaria valenza di anfiteatro urbano, eliminando così la divi-sione in due spazi distinti e accentuando in particolare gli ele-menti prospettici della piazza.
Proviamo allora ad abbozzare una mappa delle due piazze(prima e dopo del restauro del 1988), descrivendo i ruoli deidiversi attanti iscritti e definendo un inventario, seppur mini-mo, delle possibili azioni previste nell’attraversamento. Nellapiazza pre-restauro, siamo in presenza di due classi distinte diruoli attoriali (pedoni e automobili) e di tre spazi (portici, spiaz-zo, sagrato). Sostanzialmente, i pedoni percorrono la piazzaattraverso i portici mentre le macchine circolano o sostano nellospiazzo, ma esiste anche una sotto-classe di pedoni che sidistingue dai pedoni in generale per una diversa competenzamodale, in quanto dotata di un ‘voler-accedere alla chiesa’, eche quindi transita sul sagrato. Le modalità di accesso a ognisingolo spazio e le modalità di passaggio da uno spazio all’al-tro sono allora piuttosto differenti: il movimento dal porticoallo spiazzo presenta una leggera discontinuità, dovuta nontanto al passaggio da uno spazio semi-chiuso a uno aperto,quanto piuttosto alla presenza delle macchine che ostacolanol’attraversamento dello spiazzo. Il passaggio dallo spiazzo alsagrato è invece marcato da una discontinuità netta rappresen-tata dalle scale: solo i pedoni hanno quindi libertà di transito dauno spazio all’altro. Infine, il passaggio dal portico al sagratoimplica l’attraversamento intermedio dello spiazzo, resoimpervio, come dicevamo, dalla presenza delle macchine.
Siamo quindi in presenza sostanzialmente di tre differentiesperienze di attraversamento: i) il pedone semplice, che frui-sce della piazza osservandola ed esperendola esclusivamenteda sotto i portici; ii) l’automobilista, che ha una visione parzia-le della piazza da dentro la macchina e in velocità ed è portato,in virtù delle tattiche d’azione che sta seguendo, a pertinentiz-zare diverse salienze che probabilmente sfuggono agli attori alpunto 1 (ad esempio, un vuoto sta a indicare un parcheggiolibero o una buca dell’asfalto); iii) il pedone motivato, chevolendo accedere alla chiesa, ha una visione più complessa edisomogenea della piazza, in quanto portato a sommare e acommensurare spazi diversi cui corrispondono domini topolo-gici distinti (portici, spiazzo e sagrato, ognuno con conforma-zioni molto differenti).
La casistica potrebbe essere molto più complessa23 e articola-ta, ma, visti gli scopi di questa trattazione, la tripartizione propo-sta ci pare sufficiente a mostrare come le diverse esperienze pos-sibili della piazza pre-restauro rendano difficile la fruizione delsuo spazio come un tutto omogeneo.
Preoccupazioni simili, unite assieme a motivazioni di naturapiù filologica causate dalla convinzione che i restauri degli anni’30 avessero sconvolto gli equilibri originari della piazza, hannospinto assessori, sovrintendenze e urbanisti a provare negli anni’80 una soluzione di miglioramento. Si è quindi giunti nel 1988ad approvare un progetto di Luigi Caccia Dominoni (figura 8)che prevedeva l’eliminazione della scalinata verso il sagrato,ottenuta assecondando la lenta pendenza irregolare della piaz-za che fa convergere naturalmente la visione prospettica verso ilcomplesso della basilica. A completamento del progetto, si èdecisa anche la sostituzione della pavimentazione in cubetti inporfido (i ‘sanpietrini’) con un acciottolato grigio-ambrato cheriprende i colori delle facciate degli edifici, con guidane in grani-to per i corridoi di attraversamento da una parte, e con lastroniin granito per lo spazio antistante al sagrato dall’altra (un semi-cerchio contornato da sette piccoli globi in metallo). Stando cosìle cose, quest’ultimo spazio non risulta più a questo punto divi-so dal resto della piazza, ma viene anzi collegato a essa attraver-so le guidane/corridoi, che conferiscono alla piazza nel suo com-plesso un maggiore effetto di omogeneità.
FIG. 9 - Scorci prospettici dopo il restauro
23 Non stiamo considerando, ad esempio, i casi di ri-semantizzazione dei percorsi principali della piazza provocati da determina-ti eventi (ad esempio, provvedimenti di chiusura del traffico o manifestazioni religiose o di altro tipo).
23dottorato in discipline seMiotiche
Chora N. 16, Settembre 2008
Cosa comporta questa nuova morfologia? Quali cambia-menti essa si trova ad apportare? Come prima cosa, si puònotare un passaggio dal /lineare/ (la scalinata, gli spazi rigida-mente delimitati) al /concavo/ e al /curvo/ (la flessuosità dellapendenza assieme all’obliquità delle linee prospettiche). Sipensi ad esempio, per comprendere bene questo cambiamen-to di forme, alle guidane in granito, che svolgono l’importanteruolo di predisporre l’attraversatore a certi percorsi a scapito dialtri, sottolineando i percorsi preferenziali attraverso questiautentici corridoi collocati essenzialmente lungo le linee checongiungono i principali punti di fuga dell’invaso della piazza(figura 9 e 10). I percorsi proposti sono quelli che invitano a unalettura unitaria e prospettica della piazza; i punti di arrivo delleguidane costituiscono inoltre delle salienze che esse contribui-scono a mettere in risalto con il loro percorso, magnificandodeterminati elementi che vengono così enfatizzati nella letturadella piazza che viene offerta al passante (la chiesa del SantoCrocifisso, il Sacro sepolcro e la linea di fuga verso via Farini).Più nello specifico, tali percorsi preferenziali ridefiniscono lapiazza secondo una morfologia tipica del Rinascimento.Tuttavia, se osserviamo attentamente le illustrazioni in figura11 e 12, possiamo notare come, anche prima del restauro deglianni ’30 e pur presentando anche allora la classica forma a slar-go triangolare unitario percorso anch’esso da guidane (piùincerte e meno prospettiche), una tale forma rinascimentale lapiazza non l’ha probabilmente conosciuta neanche durante ilRinascimento. Le guidane insomma, al di là di ogni presuntovalore filologico che forse davvero non possiedono, assumonoinnanzi tutto un vero e proprio ruolo attanziale, in quanto/fanno fare/ un certo percorso, invitando chi passeggia a segui-re il tragitto da loro predisposto e sconsigliando al contempopercorsi alternativi (il deterrente in questo caso è costituito daun acciottolato dalle magnifiche qualità cromatiche, ma infini-tamente scomodo da calpestare). Sottolineiamo ancora unavolta che stiamo parlando dei percorsi iscritti nello spazio, e nonsolo nel senso di previsti, ma anche in quello di suggeriti, con-vogliati dalla struttura topologica della piazza.
Questi percorsi iscritti punteggiano una possibile lettura dellapiazza, che non è soltanto filologica, ma in cui il progetto di riqua-lificazione si mette in mostra e marca se stesso, valorizzando conforza un rapporto di rilettura critica del proprio passato, nel tenta-tivo di istruire e costituire un soggetto che sappia filtrarlo in base aivalori del presente. In questo modo, il restauro del 1988 produce
una differente memoria del luogo, ma anche una differentememoria culturale, nel senso che modifica il significato enciclope-dico dell’oggetto piazza Santo Stefano.
Anche in questo caso siamo dunque in presenza di unamemoria istruita e distribuita: istruita in quanto la piazzafornisce all’attraversatore le coordinate geometriche e cul-turali per orientare la sua enciclopedia e la sua lettura delluogo; distribuita perché il soggetto che attraversa la piaz-za, attraverso una mediazione tra le istruzioni che gli ven-gono fornite dagli elementi spaziali e le sue competenzeenciclopediche, è condotto all’appropriazione di unamemoria culturale riferibile al valore temporale e socialecondiviso di quel determinato luogo. Tutto ciò si traduceanche in questo caso in un mutamento d’abito, ma questavolta l’abito complessivo che riunisce le aspettative e ledisposizioni all’azione verso la piazza è una sorta dimacro-abito in cui confluiscono vari micro-abiti somatici(l’affordance offerta dalle guidane e la refrattarietà dell’ac-ciottolato al calpestamento), culturali (la lettura rinasci-mentale della piazza che sottolinea determinate salienzestoriche) e valoriali (il rapporto critico di rilettura di unpassato al presente).
4.5. Ricordi innominabili: la ristrutturazione dell’ex campodi concentramento di San Sabba
L’ultimo caso su cui ci soffermeremo riguarda la ristruttura-zione e la trasformazione dell’ex campo di concentramento diSan Sabba, vicino a Trieste. Questo luogo dell’orrore fu sottopo-sto nel 1975 a un intervento di metamorfosi e ristrutturazionedall’architetto Romano Boico, con l’intenzione di trasformarlo inun memoriale (figure 13, 14, 15).
L’aspetto più interessante del progetto è costituito dalla giustap-posizione ai volumi della struttura di un elemento nuovo, costitui-to da due altissime mura in cemento armato, una di fronte all’al-tra, tese a formare un corridoio d’accesso alle strutture del memo-riale. Siamo dunque in presenza di un esempio del così dettorestauro creativo, che in questo caso di configura come un restauromosso dall’obiettivo esplicito di far ricordare. Leggiamo a questoproposito le parole con cui l’architetto Boico ha motivato il suointervento (tratte dal sito ufficiale del museo di San Sabba):
La Risiera semi distrutta dai nazisti in fuga era squallidacome l’intorno periferico. Pensai allora che questo squallo-re totale potesse assurgere a simbolo e monumentalizzarsi.
FIG. 10 - Scorciprospettici dopo il restauro
mEmoria culturalE E procESSi intErprEtativi
Chora N. 16, Settembre 2008
24
Mi sono proposto di togliere e restituire, più che di aggiun-gere. Eliminati gli edifici in rovina, ho perimetrato il conte-sto con mura cementizie alte undici metri, articolate inmodo da configurare un ingresso inquietante nello stessoluogo dell’ingresso esistente. Il cortile cintato si identificanell’intenzione, quale una basilica laica a cielo libero.L’edificio dei prigionieri è completamente svuotato e lestrutture lignee portanti scarnite di quel tanto che è parsonecessario. Inalterate le diciassette celle e quelle della morte.Nell’edificio centrale, al livello del cortile, il Museo dellaResistenza, stringato ma vivo. Sopra il Museo, i vani perl’Associazione deportati. Nel cortile un terribile percorso inacciaio, leggermente incassato: l’impronta del forno delcanale del fumo e della base del camino.
Ciò che si vuole conservare questa volta del passato non èuna sua traccia materiale, bensì una sensazione passata: la sen-sazione di terrore, oppressione e inquietudine provata da chiha attraversato in quegli anni i cancelli del lager. È tale sensa-zione che deve restare e deve essere restaurata per sopravvi-vere al rischio dell’oblio, non la struttura materiale del luogo,che è invece puro supporto. Chi ha ristrutturato quei luoghivoleva provocare in chi si reca oggi a visitarli una sensazionedisforica gravida di passato che permettesse di conservare lamemoria vera di quel luogo, che non consiste certo nella suamorfologia architettonica,bensì nella traccia dell’or-rore che ha ospitato. Eracioè l’effetto del luogo e nonil luogo che occorrevarestaurare e conservare.Per raggiungere taleobiettivo, Boico ha alloraprevisto nel suo progettol’imposizione di un attra-versamento forzato lungoun ingresso claustrofobi-co, completamente inesi-stente nell’opera originale(figura 14). Ecco allora cheil visitatore che passa perquesto corridoio è condot-to a sperimentare nel suoattraversamento una seriedi sensazioni completa-mente disforiche, sensa-zioni che richiamano il dolore e la paura di chi, condannato allager, ha attraversato quei luoghi prima di lui. Ma questoeffetto di senso è ottenuto senza che quegli stessi luoghi attra-versati conservino una conformazione architettonica e spa-ziale analoga a quella che avevano in precedenza: per restau-rare il ricordo occorreva modificare il luogo nella sua materia-lità, procedendo “per togliere”, come dice Boico; o tutt’al piùper aggiunte tese a ottenere la conservazione di una tracciacostitutivamente non materiale.
Com’è evidente, anche in questo caso lo spazio istruisce ilsoggetto a produrre la memoria di un evento passato, ma laproduzione e l’appropriazione di una memoria questa volta sirealizza non attraverso la ri-presentazione o la conservazione diuna traccia materiale, bensì attraverso l’iscrizione di valenzetimiche che agiscono direttamente sulla costituzione passionaledel soggetto. Anzi, è esattamente attraverso il tradimento dellastruttura materiale del luogo che il restauro del ricordo puòavvenire e può innescare la conservazione di una memoriacondivisa. Questo dimostra non solo come nel ricordo ci possaessere una totale indifferenza nei confronti del supporto mate-riale in cui esso si inscrive, ma anche e soprattutto come unapproccio semiotico – in grado di porsi in una posizione neu-tra rispetto alle esternalizzazioni e alle internalizzazioni inge-
nue che localizzano la memoria nelle tracce sensibili o cogniti-ve del passato – riesca a rendere conto di alcuni fenomeni com-plessi come quelli della riappropriazione di un passato nel pre-sente, con le valorizzazioni eterogenee e complesse che unfenomeno del genere sempre comporta.
Il caso di San Sabba si rivela dunque un caso esemplare, per-ché, mentre mette in crisi un modello di esternalizzazione inge-nua, che pretende di localizzare la memoria esclusivamentenelle tracce sensibili del passato e nei supporti materiali in cui siinscrive, denuncia, contemporaneamente, l’incompiutezza diun approccio che si limiti a interiorizzarla nel soggetto e nel libe-ro gioco delle sue facoltà. Al contrario, il restauro di San Sabbaci è parso l’esempio migliore per mostrare come la memoria siadelocalizzabile nelle reti attanziali enciclopediche che definisco-no le identità e le valorizzazioni degli attori sociali umani e non-umani in gioco.
4.6. Riflessioni finaliI casi presi in esame ci hanno mostrato come a diversi inter-
venti di restauro possano corrispondere differenti modi di rap-portarsi col proprio passato, di valorizzarlo e di presentificarlo,costruendolo. Si tratta di vere e proprie valorizzazioni eteroge-nee della temporalità.
La ricostruzione della Fenice ad esempio definisce gli estre-mi di una valorizzazione del passato in quanto tale, che viene
quasi mitizzato nel tentati-vo di riproporlo in undiverso contesto storico eculturale, ricostruendolocosì quasi artificialmente.Sebbene il desiderio di ria-vere lo stesso teatro mala-mente perduto risulti deltutto comprensibile daparte della città diVenezia, ci pare però ine-vitabile — senza peraltrovoler entrare nel merito diun giudizio di valore sulprogetto di restauro chenon spetta a noi avanzare— sottolineare il profumodi profonda paradossalitàche ha avvolto i dibattitisulla ricostruzione dellaFenice e i lavori che ne
sono seguiti. La vicenda della Fenice non può non richiamarealla mente la "finzione" di Pierre Menard, il poeta simbolistadescritto da Borges che riscrive nel 900, ricopiandolo parolaper parola, il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, mutan-done però inevitabilmente il senso. Ci è sembrato in questosenso di poter mostrare come gli effetti di senso veicolati daglistessi elementi materiali e sensibili fossero profondamente dif-ferenti prima e dopo la ricostruzione del teatro.
Il riassetto di Piazza Santo Stefano a Bologna pare invece osten-tare, nel tentativo di recuperare i sensi passati della piazza, l’attitu-dine critica con cui viene riletto il passato di quei luoghi. Non siripropone infatti una ricostruzione pedissequa ricavata da docu-menti e mappe catastali (e magari spacciata per originale), ma sipropone invece un assetto che, pur richiamando esplicitamente lastoria di quella piazza, la rilegge criticamente alla luce delle muta-te condizioni urbane che ne costituiscono il contesto. A esserevalorizzato questa volta non è il passato in sé, bensì la continuitàtra passato e presente, ovvero la possibilità di trovare nel propriopassato una progettualità futura e un’esperienza condivisa.
L’ultimo caso, per cui abbiamo speso solo poche parole infunzione dell’economia di questo lavoro, ma che risulta per noiil più complesso e il più interessante da un punto di vista semio-tico, dà invece un’idea ancora più piena della dinamicità dei
FIG. 11 - La piazza in una illustrazione del ‘700
25dottorato in discipline seMiotiche
Chora N. 16, Settembre 2008
meccanismi della memoria culturale: il valore non è costituitodalla memoria in sé né dalle sue tracce materiali e sensibili, bensìda un “dovere di memoria” (Ricœur 2000) che si vuole incarna-re somaticamente nell’esperienza dell’attraversamento, così cheil progetto di restauro diventa un monito a ricordare e a costrui-re una memoria collettiva che diventi anche guida ed esperien-za per il futuro. Un ad perpetuam memoriam rei che non solo sele-ziona cosa del passato deve essere ricordato, ma ne proponeuna marcata lettura valoriale e assiologica che fonda e costruisceuna memoria autenticamente collettiva.
Per riassumere, possiamo allora dire che i tre restauri propon-gono tre diversi passati: il tentativo di ri-costruzione e ri-proposizione di un passato puro (Fenice), un progetto dipassato (Santo Stefano), una sensazione di passato (SanSabba). In tutti e tre i casi siamo sempre e comunque difronte a una proposta di adesione valoriale a un sensodel passato che costituisce la condizione di possibilità diogni memoria, e da cui la memoria è sempre costituti-vamente indistinguibile.
A questo proposito, è forse il caso di spendere ancoraalcune parole su un aspetto che abbiamo deciso di sottoli-neare più volte in questo nostro lavoro, e cioè la forteparentela che lega spazio vissuto e memoria. Sentiamoinfatti l’esigenza di ribadire che, da una prospettiva semio-tica, non è sufficiente parlare di memoria del luogo né dimemoria del soggetto, quanto piuttosto di differenti modali-tà attraverso cui i processi di decifrazione dei segni dellamemoria conducono alla produzione e all’interpretazionedi memorie culturali nuove, che sono effetto del sistemaattanziale locale che ne definisce l’identità e la valorizza-zione. Queste ‘memorie’ non si risolvono dunque né nellaconvocazione individuale di repertori e di porzioni diEnciclopedia né nell’apprendimento di segni esterni, ma emergo-no invece nell’atto di interpretazione/filtraggio che presiede a ognivalorizzazione della temporalità.
Che cosa distingue allora tale interazione di produzione econdivisione di memoria da un semplice processo di apprendi-mento? Innanzi tutto il fatto di essere istruito e distribuito neisensi precedentemente precisati: istruito, perché è l’interazionelocale che in-forma il soggetto, completandolo e spingendolo aconvocare un’enciclopedia condivisa che è essa stessa memoria;distribuito, perché non si tratta solamente di un ricorso all’enci-clopedia (media o condivisa che sia), ma di una costruzione cheemerge nell’interazione tra attanti di un sistema. Come sottoli-nea Paolo Fabbri:
Gli aspetti comunicativi e pragmatici hanno carattereriflessivo e indessicalico ma nello stesso tempo hanno unacogenza dei dettagli contingenti che solo nella realizzazionehanno coerenza. In altri termini, anziché dire ci sono le rego-le e poi c’è il modo in cui leggiamo le regole, che è la vecchiaidea del bricolage, possiamo sostituirla con l’idea che, alcontrario, nelle realizzazioni e nella interazione soggetto-oggetto, soggetto-soggetto o oggetto-oggetto ci troviamonella condizione della necessaria esplorazione della cogen-te contingenza di un ventaglio di realizzazioni che hannouna loro coerenza. […] Perché se è vero, come diceWittgenstein, che le azioni non sono governate da regole,esse sono però reintroducibili istruttivamente e hanno dun-que una validità prasseologica nelle interazioni intersogget-tive e interoggettive. Qui, tra l’altro, possono darsi fattori diinnovazione. (Fabbri 2005, p. 11)
Allo stesso modo, nel nostro approccio semiotico alla memo-ria, anziché esserci da una parte la memoria culturale e dall’al-tra un modo in cui ce ne appropriamo, c’è tutto un ventaglio direalizzazioni che hanno una loro coerenza, che si dà nelle rela-zioni tra soggetti e oggetti e che ne costituisce le identità localideterminate dalla pratica in corso. Tutto ciò può spiegarci alcu-
ni meccanismi di appropriazione di una memoria collettiva chesi attivano attraverso la mediazione di luoghi che recano in sésegni della memoria. La memoria non sarebbe dunque solo unprocesso di appropriazione di una fetta di Enciclopedia, ma,soprattutto, un processo attivo di costruzione valoriale di unpassato, che dipende sempre in modo sensibile da una proget-tualità futura e dall’adesione a un sistema di valori. Al modellodella trasmissione di tracce, vorremmo quindi opporre, ripren-dendo alcune riflessioni di Parret (2005), i processi di interpreta-zione di tracciati, intesi come percorsi a un tempo spazio/tempo-rali e valoriali:
La traccia è un’incisione. È separata da qualunque narra-zione visibile o credibile, manca di ogni leggerezza di inter-pretazione immaginativa, non si evolve, si è affrancata dallastoria evenemenziale. Ciononostante, non è affatto pura-mente spaziale – marca immobile e inamovibile – ma spa-zio-temporale. Una traccia è altresì un tracciato: bisogna per-correre i ricordi e le anamnesi. (Parret 2005, p. 21)
La memoria è esattamente il percorso e la produzione di que-sti tracciati, nel senso che abbiamo tentato di precisare in questonostro lavoro.
5. Conclusioni e prospettive
5.1. Il soggetto umano come produttore di memoriaIl restauro architettonico e urbano, così come l’abbiamo pro-
posto, si è rivelato un espediente particolarmente utile per unapiù ampia riflessione sulla questione della memoria. Questapratica, per i motivi già descritti, risulta essere una delle prassipiù evidenti di scrittura e produzione della memoria collettiva eci ha consentito di mettere in luce una complessa serie di proble-mi legati alla traduzione e alla ri-configurazione di elementi chetornano alla ribalta nella nostra stessa quotidianità, ma che, aben guardare, costituiscono la dinamica profonda di qualsiasitipo di stratificazione culturale, con i suoi meccanismi di produ-zione e interpretazione. Al fine di rendere conto di questa dina-mica e di questi stessi meccanismi, abbiamo allora proposto iconcetti di esternalizzazione non ingenua (di ispirazione peir-ceana), di costruzione distribuita della memoria e di filtraggio.
Affiancando alla proposta lotmaniana il concetto di enciclope-dia elaborato da Eco, abbiamo sollevato il problema dell’ester-nalizzazione di occorrenze concrete e delle manifestazionitestuali attraverso le quali il senso si produce. Recuperando unacaratteristica della nozione di enciclopedia, e cioè il suo essereesclusivamente un’ipotesi regolativa la cui attivazione avvienedi volta in volta localmente in funzione della pratica in corso, ci
FIG. 12 - Una foto della piazza nell’800
mEmoria culturalE E procESSi intErprEtativi
Chora N. 16, Settembre 2008
26
siamo allontanati sensibilmente da una visione che pone nel-l’oggetto o nel supporto il centro strumentale di conservazionedella memoria. Allo stesso tempo, questo non voleva affattodire localizzare la memoria nelle strutture cognitive del sogget-to o nelle sue procedure di riappropriazione enciclopedica indi-viduale o collettiva, bensì studiare i fenomeni della memorianella complessa rete di connessioni attanziali che si sviluppanosu diversi livelli, in maniera distribuita.
Questo, però, lascia un problema ancora aperto, e checostituisce una delle frontiere della nostra disciplina: laquestione del soggetto umano come produttore deisegni, e dunque, come produttore di memoria. La que-stione ricopre un ruolo centrale in questo lavoro, abbia-mo infatti proposto da subito di considerare il soggettoumano come un attante tra gli altri, la cui identità non èdeterminabile in modo differente rispetto a quella degliattanti non umani. Il problema, del resto, era già posto daEco nel 1975, quando concludeva il suo Trattato di semio-tica generale interrogandosi sul “fantasma” che la sezionesulla teoria della produzione segnica aveva lasciato intra-vedere: “si tratta del soggetto umano in quanto attoredella pratica semiotica. Qual è il suo posto nel quadrodella teoria sin qui delineata?” (Eco 1975, p. 375).
Dal momento che i processi di filtraggio e formazionedi memoria fin qui descritti sono processi che vedononel soggetto umano un attore tra gli altri, sembra che ilsoggetto non sia causa agente della semiosi bensì, piut-tosto, ne sia una conseguenza, tanto che divenga “ciòche i processi continui di risegmentazione del contenu-to lo fanno essere”, definendo così la sua identità (Eco1984, p. 53). Insomma, per la semiotica il soggetto puòessere colto metodologicamente solo in quanto traccia, e cioè inquanto mappa della semiosi stessa, così che “il soggetto di ogniattività semiotica non è altro che il risultato della segmentazionestorica e sociale dell’universo: […] un modo di vedere ilmondo” (Eco 1975, p. 375).
Tale approccio prende le distanze anche da un altro modellodi soggettività presente in semiotica e risalente alla teoria del-l’enunciazione di Émile Benveniste, che poneva a condizionedell’esistenza stessa di un testo un atto d’enunciazione che locostituisce e ne è logicamente anteriore, per quanto irrecupe-rabile per l’analista. Questo modello, infatti, pone un doppioproblema: da un lato la messa in campo di una soggettivitàtrascendente capace di attribuirsi la responsabilità dellasemiosi e del senso, dall’altra un testo cristallizzato in unastruttura e isolato rispetto a una dimensione sociale, storica epragmatica (da qui l’ambizione di computarne tutti i possi-bili percorsi interpretativi in un unico percorso generativoche vale per tutti).
Se il modello echiano ci consente di preservare la compo-nente relazionale e l’epistemologia non essenzialista che è allabase della disciplina, non sembra però rispondere ad alcunedomande che vorremmo declinare rispetto al tema dellamemoria qui affrontato.
Ciò che infatti abbiamo considerato per buona parte di que-sto lavoro è un concetto di memoria agita o di memoria-abito.Questa memoria costituisce il nostro vivere quotidiano e rap-presenta lo sfondo, potremmo dire inquestionato, del nostroagire. Tuttavia questa memoria-agita è il risultato di un proces-so di sedimentazione e la sua dinamica include al suo internoanche dei momenti di frattura e ricostituzione. In ambitosemiotico sono proprio tali momenti di frattura e i momentiaurorali di formazione degli abiti, e quindi della memoriacome abito, a rimettere in gioco e a rivelare un limite euristiconel modello di soggettività fin qui delineato. È infatti evidentecome esistano dei casi in cui l’iniziativa passa al soggettoumano nella sua individualità, e cioè a un attore sociale, e que-sto aspetto ci pare emergere proprio nel momento in cui cer-chiamo di descrivere non il soggetto, bensì i soggetti, e cioè gli
attori concreti colti nel loro agire nel momento in cui l’ambien-te pone loro più alternative interpretative e pratiche, o addirit-tura la possibilità di crearne di nuove.
Non è un caso che già nel Trattato di semiotica generale Ecostesso avvertisse chiara questa esigenza di inversione daaffiancare alla prospettiva fin lì indagata:
Si deve indubbiamente ammettere che la semiotica èforse destinata a violare anche i propri limiti naturali perdiventare (oltre che la teoria dei codici e della produzionesegnica) la teoria delle origini profonde e individuali dellapulsione a significare. In questa prospettiva alcuni argo-menti della teoria della produzione segnica (come peresempio i casi di istituzione di codice e mutazione di codi-ce) potrebbero diventare oggetto di una teoria dellatestualità o della creatività testuale. (Eco 1975, p. 377)
Eco sembra qui delineare un programma di sviluppoda lui stesso portato avanti in seguito sotto un certorispetto, indicando alcuni strumenti precedentementeelaborati e suscettibili di essere impiegati nel tentativo disuperare un limite descrittivo proprio del suo approcciosemiotico, e cioè quello di poter “rappresentare soloquanto, del senso, è socialmente prodotto e riconosciuto”,e cioè ciò che è già type (Violi 1986, p. 181).
Negli ultimi anni la semiotica ha seguito queste indi-cazioni liminali di Eco e si è dotata di quegli strumentimetodologici e d’analisi attraverso cui cogliere i testinon come forme pre-costituite, ma in quanto risultatodi operazioni alla base della loro costituzione, cioècome pratiche e lavoro di produzione segnica, secondoquanto appunto suggerito pioneristicamente da Ecostesso24. La descrizione del fare del soggetto ci permet-te così di descriverne e coglierne le attribuzioni identi-tarie proprio a partire dalle pratiche di costituzione deitesti, e di ritornare così alla definizione di semioticacome “scienza di come si costituisce storicamente ilsoggetto” (Eco 1984, p. 54). Proviamo, con un esempio,ad articolare meglio questo passaggio.
Prendiamo la statua bronzea di San Pietro che si trovanella Basilica Vaticana. Secondo la tradizione, i fedeli,come atto di devozione, devono toccarne il piede destro.Questo gesto, reiterato nei secoli, ha prodotto in quelpunto una evidente usura. L’usura, in questo caso, non èsolo fatto fisico, percettivo o estetico ma diviene, per il
FIG. 14 - Il corridoio aggiunto da Boico
27dottorato in discipline seMiotiche
Chora N. 16, Settembre 2008
fedele che si trova davanti alla statua, vera e propriaistruzione e tendenza all’azione. Siamo di fronte al pro-blema di definire semioticamente i momenti di questofenomeno, memoria culturale agita e ripresentificataquotidiamente innumerevoli volte. Siamo capaci didescrivere questo fenomeno in quanto abito, e cioèTerzità peirceana derivata da reiterazione: l’usura è ilrisultato di un fare del fedele ma è anche impronta intal senso di un suo essere fedele, e cioè di una sua attri-buzione identitaria.
Non siamo invece in grado di descrivere il momentooriginario della costituzione di questo atto, il momentoin cui da pura possibilità del sistema, tra un numeroindefinito (ma non infinito) disponibile, essa si costitui-sce come correlazione segnica tra un piano dell’espres-
sione e un piano del contenuto: quel gesto, come sintas-si gestuale e piano espressivo, si ricollega a un contenu-to preciso, cioè quello devozionale. È il momento del-l’istituzione di codice o, meglio, della sua invenzione,cioè il momento in cui il corpo, in un gesto inedito,imprime la traccia sull’oggetto e questa a sua volta silega a un significato. Il problema è appunto come unatto individuale e singolare possa trasformare le griglieculturali collettive, creare memoria, inventare tradizio-ni e divenire gesto condiviso da una collettività, sfondosociale e indiscusso del vivere collettivo.
Per invenzione, in semiotica si intende un “modo diproduzione in cui il produttore della funzione segnicasceglie un nuovo continuum materiale non ancora seg-mentato che si propone, e suggerisce una nuova manie-ra di dargli forma per trasformare in esso gli elementi
pertinenti di un tipo di contenuto” (Eco 1975, p. 309).Per invenzione però non si intende mai, neanche neicasi più audaci, una creazione pura e radicale. Si trattasempre dell’instaurarsi di una dialettica tra due poli, inquanto “la semiosi non sorge mai ex novo ed ex nihilo […]ma si disegna sempre sullo sfondo di cultura già organiz-zata” (ib., p. 319). Questo si traduce, all’interno dell’analisi,nella necessità di descrivere questi poli e la tensione in cui,in un processo inventivo, si vengono a trovare la dimensio-ne collettiva — lo sfondo del già-detto — e quella indivi-duale — l’invenzione nella dimensione locale.
Occorre quindi, al fine di descrivere la dimensione indi-viduale e locale a partire dalla quale creiamo o modifichia-mo una memoria collettivamente definita, precisare checosa intendiamo come “sfondo di cultura già organizzata”.Per sfondo culturale intendiamo l’insieme dei codici edelle norme socialmente condivise. Per definire il ruolo delsoggetto nell’ambito di una teoria semiotica della memoriadobbiamo quindi fare un ulteriore passo indietro e defini-re cosa intendiamo per ‘codice’.
Il concetto di codice (o norma) è stato utilizzato inizial-mente nell’accezione di regola che associa alcuni elementidel sistema sintattico con elementi del sistema semantico ocon una serie di risposte comportamentali (ib., p. 55). Il codi-ce era per Eco (1975) la regola di correlazione tra un pianodell’espressione e un piano del contenuto e cioè la regola dicostituzione del segno, nell’instaurarsi di un rapporto dieguaglianza tra i due piani. Definizione che Eco rivede inSemiotica e filosofia del linguaggio in quanto essa sarebbe “coe-rente con una ideologia del soggetto […] come presuntaunità trascendentale che si apre al mondo (o a cui si apre ilmondo) nell’atto della rappresentazione” (Eco 1984, p. 21).L’atto inventivo e la trasformazione di un sistema a seguitodi un atto individuale dovrebbe infatti essere concepito inquesto caso come un atto di totale sottrazione di un sogget-to alla cultura, e quindi ci porterebbe a pensare l’individua-lità come “pura intenzionalità significante” o “monade sog-gettiva senza relazioni” (Lorusso 2006, p. 106). In questosenso “la nozione di segno sarebbe solidale con la nozione(in crisi) di soggetto” (Eco 1984, p. 21).
È necessario allora riformulare la nozione di segno e dicodice in altri termini: la regola di costituzione del segnonella correlazione tra piano dell’espressione e del contenu-to non risponde al modello ‘a≡b’ bensì al modello ‘se a allo-ra…’, cioè a un modello inferenziale. Il codice non è piùidentità, ma una ipotesi regolativa, e cioè probabilità stati-stica di realizzazione di una possibile correlazione. Questoci permette di sciogliere il rapporto tra individuale e collet-tivo in una relazione tensiva e graduata, piuttosto che dico-tomica e discreta, in cui il codice non è una regola restritti-va, ma è molto più ampia del suo uso costituendo uno“spettro di variabili ammesse” (Lorusso 2006) che l’uso difatto realizza, chiudendo il campo di possibilità lasciatoaperto dal codice.
Su questa linea si colloca anche una recente rilettura delpensiero peirceano e del concetto di abito, come significa-to, di Fabbrichesi Leo. L’abito non è, come spesso siimmagina, una regola restrittiva che determina il signifi-cato del segno come equivalenza rispetto a un comporta-mento, ma è una ipotesi regolativa descrivibile comeordine probabilistico e abduttivo. L’abito non è quindiuna linea d’azione, ma più linee di azione potenzialientro cui un soggetto si muove.
Il soggetto non è quindi ridotto, in relazione alla dimen-sione normativa data dal collettivo, a pronunciare un sì oun no rispetto a una norma o a un codice ma ha “un campo
FIG. 15 - Il corridoio aggiunto da Boico
24 Si parla così di prassi enunciative (Greimas e Fontanille 1993), stile enunciativo (Violi 1997b), semiotica dell’impronta (Fontanille2004) o “pratiche” (Violi 2005; Lorusso 2006).
di possibilità rispetto a posizioni e identificazioni possibilie disponibili” (Demaria 2003, p. 47) in cui egli non è nécompletamente libero né completamente regolato, e in cui“il codice non è una regola ma un campo di associazio-ni, dove ciò che è possibile è ciò che si è verificato già(che si è già visto, già fatto, già letto)” (Lorusso 2006, p.108). La memoria culturale viene così a coincidere conquesto campo di possibilità dato da tutto “ciò che si èverificato già”.
5.2. Corporeità e memoriaRecuperando e ponendoci la questione del soggetto
non possiamo, poi, non parlare della dimensione cor-porea. I problemi sollevati, infatti sono più che mai viviin campi quali la filosofia, la psicologia, le scienzesociali, gli studi cognitivi e la teoria del linguaggio. Cisi chiede, in modo specifico, se e come la percezione siasociale (Greimas e Fontanille 1993) piuttosto che natu-rale e pre-individuale (Violi 1997).
Naturalmente non possiamo in questo luogo appro-fondire il tema e proporre delle soluzioni a un dibattitoancora in corso ma ci sembra doveroso sottolineare che,nell’ottica del restauro e della fruizione di un luogo daparte di un utente, esiste una stretta correlazione traprassi percettive e senso. Nonostante la semiotica nonabbia formulato dei modelli esplicativi esaurienti peraffrontare il problema, abbiamo la possibilità di analiz-zare la questione sotto diversi punti di vista.
Nella storia della semiotica tre sono le aree che sisono scontrate con il problema della soggettivitàumana, sia individuale sia collettiva, e che hannopreso in carico la questione del corpo. Innanzitutto lostudio della figuratività e dell’estesia la cui ipotesi allabase è che:
la percezione sensoriale, contribuendo allacostruzione della significazione dei discorsi e deitesti, permette altresì l’edificazione stessa di qual-cosa come una soggettività e, per contraccolpo, diqualcosa come un’oggettività. (Marrone 2005, p. 11)
L’atto della percezione diventa centrale nel rapportotra soggetto e mondo, poiché è attraverso il primo che,al di là di ogni atto intellettivo, subentra l’imperfezione,la variazione, lo stupore di un corpo che percepisce aldi là delle convenzioni sociali (Greimas 1987).L’esperienza estetica viene a configurarsi, nel percorsodi costruzione del senso, come momento non narrativodella quotidianità in cui il sensibile s’impone al sociale,in cui elementi della semiosfera globale rientrano nellesemiosfere parziali riconfigurandole. Nella prospettivadi una semiotica della memoria è interessante notarecome la percezione si fonda sul riconoscimento figura-tivo di una configurazione plastica precedente.
Riconoscere significa tornare al passato, ricercare in ciòche conosciamo un’esperienza famigliare, un elementosicuro da poter nominare a prescindere dagli elementiche compongono la configurazione plastica. Al contra-rio è nell’oblio delle convenzioni sociali, dimentico checulturalmente certe linee e colori compongono quelladata figura, che l’artista e il bambino ritornano allapura percezione e ri-vedono la base.
Un secondo campo di indagine affrontato in semioti-ca e che ha portato la disciplina a scontrarsi con il corpoè lo spazio e la fruizione dei luoghi. La domanda che cisi deve porre è se il luogo significa a partire da un sog-getto, sia esso individuale o collettivo, o se lo spazio, inquanto dotato di un’articolazione propria, determina lacostruzione della soggettività. Le opposizioni impostedalla cultura e dalla memoria a essa associata costrin-gono il corpo a essere contenuto in un certo modo piut-tosto che in un altro e le opposizioni, così divenutesistemi di valori, orientano il soggetto a un proprio pro-gramma d’azione.
Infine, si è scontrato con la problematica del corpo lostudio della dimensione passionale della significazione.Le passioni, infatti sono stati mentali soprattutto perchésono stati corporei e il lavoro della semiotica è statoquello di ritrovare “una generale componente corporeanei processi passionali, componente nella quale si inne-sta, o si disperde, l’immaginazione desiderante dicarattere mentale” (Marrone 2005, p. 15). Il corpodiventa esso stesso testo e mantiene traccia del vissuto,oppure lo dimentica momentaneamente, nel caso dicerti eventi traumatici o in date patologie, causandoall’intelletto sofferenza e dolore.
La ricerca semiotica attuale vede dunque l’esperienzacorporea come co-partecipante alla costruzione e modi-ficazione della significazione. Il corpo interviene inmodo preponderante al momento dell’enunciazionedel discorso, poiché l’istanza dell’enunciazione non èforma vuota che meccanicamente produce discorsività,ma piuttosto ha un corpo che, prendendo posizionenello spazio e nel tempo, determina l’interno e l’ester-no, il suo Me e il suo Sé (secondo le categorie di JacquesFontanille). Il corpo diventerebbe così un centro di rela-zione della significazione, un nodo di possibile contat-to con il mondo, un centro di memoria culturale, poichéè attraverso e con esso che si costruisce la memoriasociale (Connerton 1989).
Crediamo che tale centro di memoria culturale – ilcorpo – non sia da sottovalutare nel definire le dimen-sioni costitutive da cui dipende il fenomeno dellamemoria tout court. Dal nostro punto di vista, esso nonè l’operatore di una soggettività irrelata ma un altroelemento di stratificazione del senso, di raccolta del giàdetto che entra nel campo di relazioni in cui si dannoesternalizzazione, distribuzione, filtraggio.
mEmoria culturalE E procESSi intErprEtativi
Chora N. 16, Settembre 2008
28
nota bibliograficaAmendolagine F. e Boccanegra G. (1997, a cura di), Il decoro della Fenice. Tecniche per la ricostruzione e il restauro degli apparati decorativi, Marsilio,Venezia.Assmann A. (1999), Erinnerungsraume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedachtnisses, C. H. Beck, München(tr. it. di S. Paparelli,Ricordare. Forme e muta-menti della memoria culturale, Il Mulino, Bologna 2002).Assmann J. (1992), Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, Oscar Beck, München (tr. it. di F. de Angelis, La memo-ria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, Einaudi, Torino 1997).Bonfantini M. (1980), “Introduzione”, in Peirce Ch., Semiotica, Einaudi, Torino; ora in Peirce Ch., CP, tr. it. Chatelet F. (1973, a cura di), Histoire de la philosophie, vol. VIII, Hachette, Paris.Connerton P. (1989), How Societies Remember, Cambridge University Press, Cambridge (tr. it. di G. Berno, Come le società ricordano, Armando, Roma 1999).De Certeau M. (1980), L’invention du quotidien, I : Arts de faire, Gallimard, Paris (tr. it. di M. Baccianini, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma 2001).Demaria C. (2003), Femminismo, critica post-coloniale e semiotica, Bompiani, Milano.
29dottorato in discipline seMiotiche
Chora N. 16, Settembre 2008
- (2006), Semiotica e memoria. Analisi del post-conflitto, Carocci, Roma.Deleuze G. (1964), Marcel Proust et les signes, Presses Universitaires de France, Paris (tr. it. di C. Lusignoli e D. De Agostini, Marcel Proust e i segni, Einaudi, Torino 1986).- (1973), “De quoi on reconnaît le structuralisme?”, in Chatelet F. (1973, a cura di) (tr. it. parziale in Fabbri P. e Marrone G. 2000, a cura di).Dusi N. e Nergaard S. (2000, a cura di), Sulla traduzione intersemiotica, Versus, 85/86/87.Eco U. (1975), Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano.- (1979), Lector in fabula, Bompiani, Milano.- (1984), Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino.- (2003), Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano.- (2007), Dall’albero al labirinto, Bompiani, Milano.Ercolino M.G. (2006), “Il trauma delle rovine. Dal monito al restauro”, in Tortora G. (2006, a cura di).Fabbri P. (2005), “Istruzioni e pratiche istruite”, E|C, Associazione italiana di studi semiotici, online, www.ec-aiss.it.Fabbri P. e Marrone G. (2000, a cura di), Semiotica in nuce, vol. 1, Meltemi, Roma.Fontanille J. (2004), Figure del corpo, Meltemi, Roma.Goodwin C. e Duranti A. (1992), “Rethinking Context: An Introduction”, in Goodwin C. e Duranti A. (1992, a cura di).- (1992, a cura di), Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon, Cambridge University Press, Cambridge.Greeno J.G e Moore J.L. (1993), “Situativity and symbols: response to Vera and Simon”, Cognitive Science, 17.Greimas A.J. (1976), Sémiotique et sciences sociales, Paris, Seuil (tr. it. di D. Corno, Semiotica e scienze sociali, Centro Scientifico Editore, Torino 1991).- (1987), De l’imperfection, Fanlac, Périgueux (tr. it. di G. Marrone, Dell’imperfezione, Sellerio, Palermo 1993).- (1993), “Le beau geste”, (con J. Fontanille), Recherche sémiotiques/Semiotic Inquiry, 13 (tr. it. di F. Montanari, in Pozzato M.P. 1995, a cura di)Greimas A.J. e Courtès J. (1979), Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette, Paris (tr. it. a cura di P. Fabbri con la collaborazione con A.Fabbri, R. Giovannoli e I. Pezzini, Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, La Casa Usher, Firenze 1986).Hammad M. (2004), Leggere lo spazio, comprendere l’architettura, Meltemi, Roma.Hutchins E. (1995), Cognition in the Wild, MIT Press, Cambridge (Mass.).- (2000), “Distributed Cognition”, in International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences (IESBS), Elsevier, Amsterdam.Kirschner D. e Whitson J.A. (1997, a cura di),Situated Cognition. Social, Semiotic, and Psychological Perspectives, Laurence Erlbaum Ass., Mahwah.Landowski E. e Marrone G. (2002, a cura di), La società degli oggetti. Problemi di interoggettività,Meltemi, Roma.Latour B. (1994), “Une sociologie sans objet? Remarques sur l’interobjectivité”, Sociologie du travail, 4 (tr. it. parziale in Landowski E. e Marrone G. 2002, a cura di). Lave J. (1988), Cognition in Practice, Cambridge University Press, Cambridge.Lorusso A.M. (2006), La trama del testo, Bompiani, Milano.Lotman J.M. (1985), La semiosfera, Marsilio, Venezia.- (1993), Kul’tura i vzryv,Gnosis, Moskva (tr. it. di C. Valentino, La cultura e l’esplosione. Prevedibilità e imprevedibilità, Feltrinelli, Milano 1993).Lotman J. M. (2006), Tesi per una semiotica delle culture (a cura di Sedda, F.), Meltemi, Roma.Lotman J.M. e Uspenskij B. (1975), Tipologia della cultura, Bompiani, Milano.Magli P., Manetti G. e Violi P. (1992, a cura di), Semiotica: storia, teoria, interpretazione, Bompiani, Milano.Marrone G. (2001), Corpi sociali. Processi comunicativi e semiotica del testo, Einaudi, Torino.- (2005), La cura Ludovico. Sofferenze e beatitudini di un corpo sociale, Einaudi,Torino.Nergaard S. (1993, a cura di), La teoria della traduzione nella storia, Bompiani, Milano.- (1995), Teorie contemporanee della traduzione, Bompiani, Milano.Paolucci C. (2004), “Piegature della continuità. Semiotica interpretativa e semiotica generativa”, Versus, 97.- (2005), “Semantica referenziale, inferenziale, differenziale. Per una semantica unificata”, in Raynaud S. e Frigerio A. (2005, a cura di). - (2006), “Antilogos. Imperialismo testualista, pratiche di significazione e semiotica interpretativa”, Semiotiche, 4.Paolucci C. (2007, a cura di), Studi di semiotica interpretativa, Bompiani, Milano.Parret H. (2005), Tre lezioni sulla memoria, Le Monnier Università, Firenze.Peirce Ch., CP Collected Papers of Charles Sanders Peirce, voll. I – VIII, Belknap Press, Cambridge (Mass.) (tr. it. parziale a cura di BonfantiniM. in Opere, Bompiani, Milano 2003).Pethes N. e Rüchatz J. (2001, a cura di),Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon,Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek (tr. it. a cura di A. Borsari,A. Caridi, R. Lazzari, M. Mezzanzanica, M. Russo e E. Tetamo, Dizionario della memoria e del ricordo, Bruno Mondadori, Milano 2002).Pisanty V. e Pellerey R. (2004), Semiotica e interpretazione, Bompiani, Milano.Pozzato M.P. (1995, a cura di), Estetica e vita quotidiana, Lupetti, Milano.Raynaud S. e Frigerio A. (2005, a cura di), Significare e comprendere. La semantica del linguaggio verbale, Aracne, Roma.Ricœur P. (2000), La mémoire, l’histoire, l’oublie, Seuil, Paris (tr. it. di D. Iannotta, La memoria, la storia, l’oblio, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003).Scannavini R. (1991, a cura di),La piazza Santo Stefano. Da trebbo medievale a piazza prospettica rinascimentale, Grafis Edizioni, Bologna.Sedda F. (2006), “Imperfette traduzioni”, in Lotman J. M. (2006).Suchman L.A. (1987), Plans and Situated Actions, Cambridge University Press, Cambridge.Tesnière L. (1959), Éléments de syntaxe structurale, Éditions Klincksieck, Paris (tr. it. di G. Proverbio e A. Trocini Cerrina, Elementi di sintassi strutturale,Rosenberg & Sellier, Torino 2001).Tortora G. (2006, a cura di), Semantica delle rovine, Il Manifesto Libri, Roma.Violi P. (1986), Infinito singolare. Considerazioni sulle differenze sessuali nel linguaggio, Essedue Edizioni, Verona.- (1992), “Le molte enciclopedie”, in Magli P., Manetti G. e Violi P. (1992, a cura di). - (1997a), Significato ed esperienza, Bompiani, Milano.- (1997b), “Stile e soggettività nell’autorappresentazione del femminile: il linguaggio poetico di Elisabeth Bishop e Audre Lord”, in Versus, 76.- (2005), “«Il soggetto è negli avverbi». Lo spazio della soggettività nella teoria semiotica di Umberto Eco”, E|C, Associazione italiana di studi semiotici, onli-ne, www.ec-aiss.it.- (2007), “Lo spazio del soggetto nell’enciclopedia”, in Paolucci C. (2007, a cura di).
intervista a patrizia violi
a Scuola di SEgni
Chora N. 16, Settembre 2008
30
[Chora] Professoressa Violi, il gruppo di lavoroda lei coordinato, che qui presenta un lungo contri-buto collettivo, fa riferimento a un Dottorato diRicerca, quello in Discipline Semiotiche, che ormaiha una storia ventennale. Può illustrarci brevemen-te questo rapporto e i tratti salienti dell’esperienzadi un dottorato di ricerca che, ricordiamolo, ha inUmberto Eco il suo fondatore e il presidente del suocomitato scientifico?
[Patrizia Violi] IlDottorato inS e m i o t i c adell’Università diBologna è oggiormai al suo XXIIIciclo di attivazione.Possiamo dire che laquasi totalità deigiovani e meno gio-vani semiotici italia-ni si è formata allascuola di Bolognadove, tra la fine
degli anni ’70 e tutti gli anni ’80, intorno a UmbertoEco era attiva una vivacissima comunità semiotica.Paolo Fabbri, Omar Calabrese, Ugo Volli, GiovanniManetti, per non citare che alcuni dei nomi piùautorevoli, hanno tutti insegnato e operato aBologna in quel periodo. Tutti questi amici e colle-ghi sono ora in altre sedi universitarie, ma per moltianni Bologna, e il suo dottorato, è stato un centrounico in Italia. Qui si è formata una generazione disemiotici, che ora sono a loro volta professori intutta Italia: Isabella Pezzini, Maria Pia Pozzato,Francesco Marsciani, Costantino Marmo, GiovannaCosenza e tantissimi altri più giovani, ora ricercato-ri in varie sedi universitarie. La lettura di tutti i tito-li delle tesi del nostro dottorato potrebbe costituireun interessante repertorio per chi volesse studiarela storia della semiotica italiana, i suoi sviluppi, lesue trasformazioni.
Il dottorato di ricerca in Discipline semiotiche daormai tre anni ha cambiato statuto e fa ora partedei dottorati dell’Istituto Italiano di ScienzeUmane (SUM). Quali sono i principali cambiamen-ti? Ritiene che la strada intrapresa dal SUM possaessere feconda per il panorama della ricerca univer-sitaria d’eccellenza in Italia?
Nel 2006 il nostro Dottorato è entrato a far partedel SUM (Istituto Italiano di Scienze Umane) con
sede a Firenze. Oggi ha una doppia appartenenza,sia presso il Sum, che ne è la sede amministrativa,che presso l’Università di Bologna, in specificopresso la Scuola Superiore di Studi Umanistici(SSSUB), dove hanno luogo le lezioni e l’attivitàdidattica. I cambiamenti sono stati significativi,soprattutto a livello dell’organizzazione didattica. Idottorati SUM infatti prevedono una didatticaintensiva e obbligatoria per i primi 18 mesi, seguitida un periodo all’estero e dalla elaborazione delletesi dottorale. Abbiamo al momento quattro posticon borsa e tre senza borsa, ma a tutti gli studentifuori sede, con o senza borsa, durante il primo annoè garantita una sistemazione a Bologna: i dottoran-di vivono in comune in un grande appartamento nelcentro della città. Questa esperienza si è rivelatafinora altamente positiva, non solo nel creare unsenso di comunità e di aggregazione fra i dottoran-di, ma anche a livello della ricerca vera e propria.Ogni anno infatti i dottorandi dello stesso ciclolavorano insieme a un progetto comune, in generecon un forte aggancio ai temi della contemporanei-tà: al momento sono in corso, oltre alla ricerca sullamemoria che qui presentiamo, lavori sulla fictiontelevisiva e sulla comunicazione politica. Stiamocostituendo quello che ci piace chiamare un“Osservatorio semiotico sulla contemporaneità”,che presto sarà visibile in un sito dove raccogliere-mo e daremo notizia di tutte le nostre ricerche.
In quale spazio si colloca la ricerca semiotica nel-l’ambito del panorama post-universitario dellescienze umane in Italia? Quali ritiene siano le suespecificità e i suoi punti di forza e quali le disciplinecon cui ha maggiori tangenze e maggiore dialogo?
La semiotica è essenzialmente un metodo di anali-si di tutti i processi di significazione; è insommauna teoria generale del senso e dei suoi molti modidi manifestarsi e di circolare. Per questo la semioti-ca è stata talvolta accusata di occuparsi di troppecose, troppo differenti fra loro, dai testi letterari aifustini di detersivo. In realtà, proprio in quantodisciplina a forte vocazione metodologica, la semio-tica non si caratterizza a partire da un oggetto spe-cifico di indagine, ma piuttosto da un metodo, o piùprecisamente da un insieme di metodologie integra-te, e per questo può legittimamente rivolgersiall’analisi di oggetti anche assai differenti fra loro. Ilnostro Dottorato prevede due curricula, uno di teo-rie semiotiche, che dialoga più direttamente con lafilosofia, la filosofia del linguaggio e alcuni indiriz-zi delle scienze cognitive contemporanee, l’altro di
a scuola di segni il suM e il dottorato in discipline seMiotiche
dell’università degli studi di Bologna
università degli studi di Bolognaa cura di claudio paolucci
Patrizia Violi
31patrizia violi
Chora N. 16, Settembre 2008
semiotica della cultura, che ha un dialogo aperto econtinuo con altre scienze umane, dalla antropolo-gia alla sociologia. Fondamentale per tutti i semioti-ci è poi il confronto con le discipline che da semprelavorano sui testi, dalla filologia alla critica lettera-ria, da cui la semiotica ha preso in parte l’avvio.
In questo numero di Chora ilgruppo di ricerca da lei coordinatopropone un lungo saggio scritto incollaborazione collettiva, firmatoda lei e dai suoi più giovani colla-boratori e dottorandi. Come si èarrivati a questo progetto non cer-tamente usuale all’interno delleScienze Umane e che ricorda più ilmodo di lavorare di discipline aorientamento scientifico?
Come dicevo prima il nostro dot-torato è un’unità di ricerca moltointegrata e abituata a lavorare ingruppo. La particolare organizza-zione della didattica, con molti mesi di seminariintensivi e una vita quotidiana in comune, abituai nostri giovani a lavorare insieme, scambiandosiesperienze e critiche. Effettivamente questa è unasituazione poco comune nell’ambito delle scienzeumane, e pochissimo diffusa negli altri dottoratiche, con risorse più limitate, non hanno le condi-zioni per una simile metodologia di lavoro. Sitratta di una modalità di ricerca in effetti più vici-na a quella delle discipline scientifiche che uma-nistiche; da questo punto di vista il nostro dotto-rato è un vero e proprio laboratorio. Il lavoro chevi si svolge è assai diverso dall’usuale elaborazio-ne di una tesi di dottorato che quasi sempre haluogo in isolamento e nel chiuso della propriastanza; per noi anche la preparazione della tesi,un momento inevitabilmente individuale, avvieneperò attraverso un confronto e scambio continuofra tutti i dottorandi, tramite seminari in cui i piùvecchi presentano e discutono con i più giovani laloro ricerca.
Il tema di questo vostro lavoro su Chora è identi-co a quello da lei proposto per il dottorato di ricer-ca da lei coordinato: quali sono i motivi che l’han-no portata alla scelta della memoria come temaunificante per le tesi dei vostri dottorandi?
Per ogni ciclo di dottorato scegliamo insieme congli studenti un tema di ricerca comune, che a voltecoincide con quello delle singoli tesi di dottorato,ma non necessariamente. Nel caso specifico, moltidei dottorandi che hanno partecipato all’elaborazio-ne del testo che qui presentiamo stanno lavorando
per le loro tesi su argomenti connessi al tema dellamemoria, in vari suoi aspetti. Nel ciclo seguente, incui si è scelto come tema comune la comunicazionepolitica, gli argomenti delle singole tesi sono piùdiversificati, ma il lavoro di analisi comune sui testipolitici ha aiutato a meglio focalizzare anche letematiche non immediatamente connesse.
In cosa crede che la semiotica possafornire un contributo originale edeuristico al tema della memoria?
Per la semiotica la questione centra-le non è tanto la memoria in sé, quan-to i processi di costruzione, e distru-zione, della memoria intesa comerepertorio generale dei saperi e delleconoscenze di una data cultura. A dif-ferenza di una disciplina come la psi-cologia, che indaga i meccanismi indi-viduali e i processi cognitivi che pre-siedono ai meccanismi del ricordo, lasemiotica è piuttosto interessata alla
memoria culturale di una data comunità, ai luoghi ealle forme in cui è conservata e trasformata, e all’in-terazione fra la memoria individuale e quella collet-tiva. Si tratta di una memoria “esternalizzata”, inquanto depositata in quella che Eco ha chiamatoEnciclopedia e Lotman Semiosfera. L’approcciosemiotico può così integrarsi allo studio dellamemoria che altre discipline conducono, mantenen-do tuttavia una sua specificità di metodi e prospet-tive, che credo risulti evidente dalla lettura dellavoro che pubblichiamo qui.
patrizia violi, professore ordinario di Semiotica presso il Dipartimento Discipline della Comunicazione dell’Università diBologna. Dal 2002 è coordinatrice del Dottorato in Semiotica e vicepresidente della Scuola Superiore di Studi Umanistici diBologna. Dal 2005 è coordinatrice del Dottorato di Discipline Semiotiche, Istituto Italiano Scienze Umane e Università di Bologna.Dirige il Centro di Studi Semiotici e Cognitivi dell’Università di San Marino. E’ stata visting scholar a Berkeley, al centro di ricer-ca IBM a Yorktown Heights, all’Università di Tokyio Gaikokugo Daigaku; ha tenuto corsi e lezioni in molte università straniere fracui: Toronto, Vancouver, Trondheim, Lugano, Madrid, Valencia, Sapporo, Sofia, Imatra. Principali aree di ricerca: semantica e teo-rie semiotiche, semiotica del testo e della cultura, soggettività e genere. Sta attualmente conducendo ricerche sulle basi corporeedella significazione e l’emergenza del senso dalla corporeità, con particolare riferimento alle fasi preverbali dello sviluppo infan-tile. Tra i suoi studi ricordiamo: (con Anna Maria Lorusso) Semiotica del testo giornalistico (2004), Bari, Laterza; Significato ed esperien-za (1997), Bompiani, Milano (tr. Inglese: Meaning and Experience, Bloomington, Indiana University Press, 2001); (con Calabrese O.),I Giornali (1980), Milano Espresso Strumenti. Capitoli 1, 2 (sezioni 5, 6, 7, 8, 9); L’infinito singolare, Considerazioni sulla differenza ses-suale nel linguaggio (1986), Verona, Essedue. (tr. spagnola: El infinito singolar, Madrid: Càtedra, 1991).
in librEria
Chora N. 16, Settembre 2008
32
uMBerto ecoDALL’ALBERO AL LABIRINTO
STUDI STORICI SUL SEGNO E L’INTERPRETAzIONEBompiani, Milano, 2007, 575 pp
L’ultima impresa editoriale di Umberto Eco sipresenta come una raccolta di 18 saggi, scritti tra1961 e 2007 e sovente rielaborati per l’occasione,che coprono un arco temporale che va dal I secolod.C. (Plinio il Vecchio) a ieri (Rorty). I saggi – cuivanno affiancate le opere di teoria semiotica, cri-tica letteraria, di letteratura e di erudizione varia,composte negli stessi anni – mostrano, oltre allavastità di interessi del semiologo, una rara eimpressionante competenza enciclopedica.Seguendo l’ordine cronologico di composizionedi questi saggi (o dei loro nuclei originari) si puòseguire l’evoluzione degli interessi di ambitoestetico e medievistico in quelli più propriamentesemiotici (cfr. n. 8 su “Uso e intepretazione deitesti medievali”, il cui primo nucleo è costituitoda un saggio del 1961) e, insieme, il loro riaffiora-re in varie occasioni: è del 1991, per esempio, unintervento sull’estetica di Benedetto Croce (n. 16),che – mi si passi il facile gioco di parole – mette incroce l’estetica crociana e mostra un mai sopitointeresse per la definizione dell’arte e del bello,che affonda le proprie radici negli studi universi-tari torinesi condotti negli anni ’50 sotto la guidadi Luigi Pareyson. È a questi stessi anni che risalela passione di Eco per il Medioevo e le sue massi-me espressioni filosofiche (Tommaso d’Aquino intesta) e che trova poi, al di là dell’inaspettatoexploit letterario del 1980 (Il nome della rosa),degli sviluppi di notevole spessore nei decennisuccessivi: gli anni ’70 vedono la pubblicazioneda parte di Franco Maria Ricci delle tavole di unodei manoscritti del commento all’Apocalisse diBeato di Liebana accompagnate da un puntualecommento di Eco (il saggio n. 6 riprende l’intro-duzione scritta per l’occasione); negli anni ’80,dopo il successo editoriale del primo romanzo diambientazione medievale, escono una serie disaggi dedicati alle teorie medievali del segno edel falso (nn. 4, 9 e 5), lavori pionieristici che –soprattutto nel primo caso – hanno aperto la stra-da a numerosi studi, in Italia e all’estero, sulleteorie del segno e della significazione medievali,
in ambito grammaticale, logico, retorico e teologi-co (basti ricordare il recente monumentale volu-me di Irène Rosier-Catach sui sacramenti, uscito aParigi nel 2004); negli anni ’90, due grandi nomidella cultura medievale, , Dante (n. 7) e RaimondoLullo (n. 10), sono inclusi a vario titolo nella vastaindagine che Eco dedica alla ricerca della linguaperfetta, pubblicata nel 1993; all’inizio del III mil-lennio, infine, il Medioevo ritorna con l’esamedelle teorie della metafora e dell’analogia, svilup-pato in occasione di alcuni seminari sulla fortunadella teoria aristotelica della metafora, tenuti aBologna nel marzo 2001 (nn. 2 e 3).
La metà dei saggi raccolti, quindi, è dedicata alperiodo forse più fecondo per la storia dellasemiotica, il Medioevo, letto e interpretato peròsenza le ‘limitazioni’ dello specialista (a voltetroppo legato a un’epoca, a un autore o a un testodeterminati), ma con un occhio attento agli svi-luppi complessivi e alle linee di tendenza genera-li – che emergono anche dai dettagli più margina-li, come la posizione del latrato del cane nelleclassificazioni medievali dei segni – e con unasensibilità semiotica, ovvia e scontata in un intel-lettuale come Eco, ma sovente estranea alle impo-stazioni storiografiche correnti, ispirate piuttosto,nell’affrontare i medesimi testi o autori, alla logi-ca e alla filosofia analitica contemporanee (sipensi ai lavori di Marilyn McCord Adams oClaude Panaccio).
Gli altri saggi si distendono su epoche ed autoripost-medievali (Wilkins, De Maistre, Kant,Manzoni, Peirce, Bréal e il “pensiero debole”) inmodo più occasionale e rapsodico, ma non menopuntuale e rilevante per il dibattito semioticoattuale: il confronto con le teorie della percezionedi Peirce o con il silenzio di Kant sul ruolo del lin-guaggio nella conoscenza costituisce uno dei pas-saggi chiave dell’ultima opera teorica di Eco,Kant e l’ornitorinco (1997).
Una menzione a parte merita il saggio iniziale,da cui deriva il titolo del volume: “Dall’albero allabirinto” è infatti un saggio di storia della semio-
RECENSIONE DI COSTANTINO MARMO
33in librEria
Chora N. 16, Settembre 2008
tica, di lunga durata, dal forte impianto teorico.Nelle 84 pagine di questo articolo si trova infatti,ulteriormente articolata e storicamente esemplifi-cata nel passaggio da un modello ad albero (comel’arbor porphyriana) a un modello a labirinto(come già in parte nell’Encyclopédie diD’Alembert), quella opposizione tra modellosemantico dizionariale e modello enciclopedico orizomatico che aveva trovato fin dal Trattato disemiotica generale (1975) e, ancor più chiaramen-te, dai primi anni ’80 diverse elaborazioni daparte di Eco e che, coniugata con la teoria dellasemiosi illimitata di Peirce, costituisce una deipunti chiave della sua semiotica interpretativa.
Se questo saggio, da un lato, esemplifica unadelle due strade che Eco, fin dal 1984, indicavaper l’elaborazione di una semiotica generale comeinterrogazione filosofica (quella cioè di una‘archeologia’ dei concetti semiotici), dall’altromostra il rischio costante che incombe sulla lettu-ra dei testi (filosofici e non solo) del passato:quello di varcare la soglia, a volte molto sottile,che separa l’interpretazione (metodologicamenteregolata) dall’uso. Chi nell’affrontare la letturadei testi del passato, metta da parte le cautelemetodologiche (mirabilmente indicate dallo stes-so Eco in Lector in fabula) e ponga tra parentesi laloro distanza temporale ma soprattutto culturale(tralasciando di conoscere e tenere in debito contociò che gli specialisti ne hanno detto) rischia diimporre schemi interpretativi estranei a quei testi(come è, a mio avviso, l’opposizione tra segnocome equivalenza e segno come inferenza, pocopertinente per l’interpretazione della semioticamedievale) e di finalizzare così in modo eccessivola lettura di questi testi al loro possibile uso inambito teorico.
Al di là di questo rischio, corso dall’autore soloin alcuni saggi di questo volume (come quellosulla denotazione), l’immagine complessiva diUmberto Eco si conferma quella dell’ultimo eccel-lente poligrafo dei nostri tempi: penna acuta eleggera, un gigante sulle cui spalle volentieri cisediamo a godere il paesaggio.
SOMMARIO:1. Dall’albero al labirinto2. Metafora come conoscenza: sfortuna di Aristotele 3. Dalla metafora all’antologia entis4. Sul latrato del cane5. La falsificazione del Medioevo6. Noterelle su Beato7. Dante tra modisti e cabalisti8. Uso e interpretazione dei testi medievali9. Per una storia della detonazione
10. Su Lulllo, Pico e lullismo11. Il linguaggio della Terra Australe12. Un ritorno a Isidoro: le etimologie di Joseph de
Maistre13. Sul silenzio di Kant14. Semiosi naturale e parola nei Promessi Sposi15. La soglia e l’infinito. Peirce e l’iconismo primario16. Le definizioni nell’estetica di Croce17. Cinque sensi nell’estetica di Croce18. Il pensiero debole vs i limiti dell’interpretazione
in librEria
Chora N. 16, Settembre 2008
34
RECENSIONE DI RICCARDO FUSAROLIUNIVERSITÀ DI BOLOgNA
claudio paolucci (a cura di)STUDI DI SEMIOTICA INTERPRETATIVA
Bompiani, Milano, 2007, 424 pp, ISBN 45259173
Quale può essere il contributo della semioticainterpretativa, non solo per l'analisi di fenomeni disenso (film, comunicazione politica, pratiche sociali,etc.), ma anche per una riflessione filosofica? Qualimodi di pensare può offrire un approccio che artico-la un equilibrio instabile tra “la prospettiva struttu-ralistica di Hjelmslev e la semiotica cognitivo-inter-pretativa di Peirce” (Eco 1997, Kant e l'ornitorinco)?Queste sono le domande di fondo che muovono i seisaggi e la ricchissima introduzione che compongonoStudi di semiotica interpretativa, e che ne costitui-scono l'interesse. Un libro ambizioso, dunque, di cuivale la pena ricostruire il percorso.
Studi di semiotica interpretativa si propone comeun punto di snodo della riflessione semiotica, unrecupero di alcune eredità neglette per rimetterle ingioco nei nodi cruciali della ricerca contemporaneasul senso. Se diverse sono le opere che, soprattutto inanni recenti, hanno ripreso l'approccio interpretativo(cfr. Pellerey e Pisanty 2004, Semiotica eInterpretazione; Traini 2005, Le due vie della semioti-ca), questo libro si differenzia da esse per essere com-posto non tanto di mappe e sequenze di istantanee,quanto di traiettorie, che riconfigurano i concetti cheattraversano proiettandoli verso sviluppi futuri.
Un certo modo di fare semiotica, legato alla vulgatagreimasiana, si è concentrato sulle strutture in cui ilsenso è già articolato: individuando semi su quadratisemiotici posti come articolazione fondamentale eprofonda del senso; separando con cautela l'enuncia-to dall'enunciazione; definendo come propri oggetti itesti intesi come porzioni di realtà chiuse, coerenti ecoese. Ma la semiotica cognitivo-interpretativa diPeirce e il suo pragmati(ci)smo ci mostrano un pae-saggio ben più dinamico. Le strutture di senso sonodefinite all'interno di percorsi interpretativi più ampi,che a ben vedere le eccedono. L'enunciazione e l'inter-pretazione non avvengono nel vuoto ma sono proces-si situati già all'interno del senso e che risuonano dipratiche ben precise. Ecco allora la posta in giocodella semiotica interpretativa: il definire un regimeautonomo del senso che medi tra la soggettività el'oggettività, tenendo in giusto equilibrio le strutture
e i percorsi del loro formarsi e del loro mutare.Tre dunque sono i nodi cruciali che attraversano l'in-
tero libro: la prassi enunciativa, l'articolazione del rap-porto tra contenuto ed espressione all'interno di unateoria più generale dell'interpretazione e il soggettodella semiosi. Si tratta di problemi che già si pongononel Trattato di Semiotica Generale di Eco ma, comenota Paolucci nell'introduzione, solo nella ricerca con-temporanea essi emergono esplicitamente. Se la semio-tica si fa in corso d'opera e non da un fuori astratto daogni contesto, se le configurazioni di senso risuonanosempre già di un'enciclopedia di interpretanti, è fonda-mentale capire il processo di negoziazione di questestrutture e il soggetto implicato in esse.
Il primo nodo è quello di enunciazione insofferente auna opposizione rigida tra langue e parole, tra sistemae uso, tra livello dell'enunciato e livello dell'enunciazio-ne. Il dipanarsi del senso in semiotica interpretativa èdescritto come lo svolgersi di enunciazioni in atto, chia-mate nella semiotica post-greimasiana francese “prassienunciative” (Fontanille e Zilberberg 1998, Tension etsignification). Il cambiamento epistemologico non èirrilevante, si tratta infatti di passare dall'autopsia di untesto, all'analisi del suo essere costitutivamente in gioconelle pratiche di lettura in atto. In questo senso possia-mo leggere i saggi di Valle e Basso Fossali. Il primoriprende l'innovativa teoria dei modi produzionesegnica del Trattato di Eco, mostrando come in essa icodici venissero posti sotto l'egida di più flessibili ope-razioni di produzione del senso. Basso Fossali mette afuoco come la gestione del senso avvenga sempre all'in-terno di un contesto culturale più ampio, e in questosenso una semiotica del testo debba porsi all'interno diuna semiotica delle pratiche.
Il secondo nodo è quello della dicotomia tra espres-sione e contenuto. Dicotomia che, formulata daHjelsmlev in maniera puramente formale, si è poispesso trasformata in un'opposizione tra strutture delsensibile e strutture dell'intelligibile, dove il sensibilesi dà prima di essere interpretato. Ma se accettiamo ilprimo punto secondo il quale l'enunciazione e l'inter-pretazione sono in atto, lo stabilirsi di strutture delcontenuto e dell'espressione va negoziato localmente.
35in librEria
Chora N. 16, Settembre 2008
Lo stabilirsi di pertinenze percettive, [di] ciò chevediamo, ad esempio, è imbevuto delle pratiche incorso, delle nostre aspettative. Illustra chiaramentequesta posizione il saggio di Rastier. In esso vienepresentata la sua semantica interpretativa in cui ilsenso viene descritto come un processo di emersionedi forme da fondi (configurazioni di isotopie), fondi eforme dinamici che si modificano nel tempo, si dif-fondono, si concentrano. I semi che compongono que-ste forme sono l'effetto di percorsi interpretativi rego-lati “non soltanto dal ricorso a conoscenze condivisee a tecniche apprese che sono proprie della cultura incui il testo è prodotto e interpretato; ma anche da vin-coli generali che sono analoghi, se non identici, aquelli che reggono i processi percettivi”.
Il terzo nodo cruciale è quello che riguarda l’operato-re della semiosi, l’istanza che presiede allo stabilirsi dicontenuto ed espressione. Si tratta di un problema digrande rilevanza, che porta, ad esempio, certi ramidelle scienze cognitive (si pensi ad esempio all'operadi Talmy) a costruire soggetti tendenzialmente tra-scendentali, i cui meccanismi cognitivi di base forni-scono le condizioni di possibilità per la costruzionedel significato. La strada indicata dalla semioticainterpretativa è diversa: essa definisce il soggettocome “un operatore nel sistema[, sistema] che puòriconoscere questo operatore esclusivamente nellamisura in cui esso si manifesta attraverso i suoi pro-dotti, attraverso la bava e i detriti dell'interpretazio-ne”. Nel saggio dedicato all'esistenza fenomenologicadi un dato percettivo, Eco definisce il soggetto all'in-terno di una pratica, solo relativamente alla quale sipuò definire questo primum. Coerentemente, il sag-gio di Violi presenta una ricostruzione della soggetti-vità in Eco come un soggetto diffuso, “legat[o] allepratiche di costruzione e trasformazione del senso”.
Il saggio di Paolucci, infine, delinea nove criteriche definiscono l'approccio interpretativo che perva-de l'intero libro, esplorando il pensiero di Peirce eHjelmslev, aprendolo al dialogo con altri pensatori ealtre discipline, mostrando così come davvero lavocazione della semiotica sia quella di essere un“antilogos monotremico interpretativo che permettedi passare da una disciplina all'altra”.
Si può dunque dire che il libro raggiunge i suoi obiet-tivi? Una delle critiche che da sempre è stata rivolta allasemiotica interpretativa è quella che per quanto ricerca-ta teoricamente, sia carente nelle sue ricadute applicati-ve. Studi di semiotica interpretativa è una risposta nonbanale a questa critica. Innanzitutto, le argomentazionipresentate nei suoi saggi sono spesso supportate daesempi e risultati di analisi ben sperimentate, come leampie ricerche di Rastier su corpora che spaziano dallaletteratura francese ai siti web razzisti. In secondoluogo, il libro non si presenta come un'opera chiusa, ma
come un punto di snodo aperto a rimandi esterni, adanalisi già svolte e a futuri progetti. Non un'istantanea,ma un fascio di traiettorie. Si tratta ora di raccogliernela sfida e di trarne le concepibili conseguenze.
INDICE:Introduzione
Claudio PaolucciDa che cosa si riconosce la semiotica interpretativa?
Claudio PaolucciLa soglia e l’infinito
Umberto EcoLo spazio del soggetto nell’enciclopedia
Patrizia VioliSemantica interpretativa. Dalle forme semantiche alla testualità
François RastierInterpretazione ed analisi. Perizia e dominio della semiotica
Pierluigi Basso FossaliCortocircuiti: modi di produzione segnica e teoria dell’enunciazione
Andrea Valle
l’iMMeMoriale e la parola poetica
l’immEmorialE E la parola poEtica
Chora N. 16, Settembre 2008
36
L’essere umano si annuncia sulla soglia della parola: var-candola. Proviamo a cominciare da qui. Come ogni soglia,anche la parola ha due facce. Da un lato la parola nomina,dice la cosa attribuendole un nome: ripete la cosa nel nome.In questo senso, come comprese Platone, “ricorda”. Dice:“Eccolo di nuovo”, come si espresse una volta Whitehead,non a caso grande lettore di Platone. Ecco di nuovo il ‘sole’,ecco di nuovo la ‘luna’... Parola della memoria che, di neces-sità, è sempre parola seconda e mai parola prima coinciden-te con la cosa, parola che propriamente è segno della cosa.Entriamo per suo tramite nel regno della mente; siamo incammino verso il concetto.
Ma ora osserviamol’altro lato. Qui la paro-la non “conosce” mapiuttosto “miscono-sce”: cancella di frontea se stessa il fatto diaver dimenticato e per-duto, proprio per ilfatto che nomina ericorda. Quel che ricor-da, infatti, non c’è più,non è più presente. Siassenta nel momentostesso in cui la parola lo
riconosce ricordandolo: come Euridice non appena Orfeo lerivolge lo sguardo e la ravvisa. Nella parola seconda laparola prima si eclissa come parola dell’oblio: gesto-parolainvocante l’impossibile unità. Entriamo per suo tramite nelregno del corpo; siamo in cammino verso la parola poetica.
Due lati della soglia, dicevamo; s’intende che i due latisono al tempo stesso distinti e indisgiungibili; non posso-no stare separati (come il maschio e la femmina, dicevaAristotele), ma devono esser sempre l’uno per l’altro, e intal modo concorrere a quel sapere umano fondamentaleche è il “saper dire”. Abbiamo così scorto di sfuggita ilmovimento costitutivo della parola. Ma ora dobbiamo chie-derci: cosa originariamente dimentica e cosa ricorda laparola? Questo “segreto” della parola invano le modernesemiotiche e semantiche cercano in vario modo di chiari-re, specificare, ridurre a nozione logico-scientifica. Ciò chevorremmo mostrare è che tale segreto è più fruttuosamen-te avvicinabile se ci riferiamo a un circolo di nozioni checaratterizzano quell’azione in ogni senso primordiale cheè il “sacrificio” (sacrum facere). Vediamo.
Il sacrificio è il punto centrale della “festa”: atto celebrati-vo e commemorativo che richiama un’azione ancestraledella quale è segno e ripetizione. Il sacrificio è così, in origi-ne, il “pasto rituale” che fa accadere il sacro, cioè accomunai mortali e i divini, come diceva Heidegger. Ma che signifi-ca “pasto rituale”? La comprensione si illumina se ricordia-mo che le parole ‘rito’, ‘arte’ e ‘ritmo’ vengono dalla comu-
ne radice ‘rt’. Rito è allora ciò che rende valida, legittima edefficace, l’azione ripartendola (ritmandola): una parte rivol-ta all’immemoriale (l’evento ancestrale che viene celebrato)e un’altra rivolta alla memoria, alla celebrazione, appunto,del primo. E’ in tal modo che il rito rende valido ed efficace:esso non è infatti vano, ovvero “irrito”. Ma per far questo habisogno di un’arte, cioè di qualcosa che non è “inerte”: eccocome gioca il senso della radice ‘rt’ nelle sue due facce, posi-tiva e negativa. Ma che significa che il rito è un’arte ritmica,cioè qualcosa di “non inerte”? Semplicemente questo: che ilrito è una danza. Inerte è ciò che non danza. Al che siaggiunge il “mito”: la parola che spiega l’azione, la danza,ovvero l’atto del sacrificio e del pasto comunitario invocan-te i divini. Ma più propriamente la parola non si aggiunge:essa, come parola primordiale con le sue due facce, era giàlà sin dall’inizio. Scrive Claude Calame nel saggio La festa:
Religiosa o profana, non c’era festa in Grecia che nonprevedesse l’intervento di danzatori con accompagna-mento alla lira o al flauto. Si può addirittura affermareche in Grecia il passo di danza costituisce il ritmo, lascansione fondamentale di ogni festa, anzi uno dei gestirituali essenziali della festa. Ma il gesto è sempreaccompagnato dalla parola; e il canto, che nella musicagreca arcaica segna il ritmo della danza, assume nellaesecuzione del rito una funzione essenziale e comples-sa: non si limita a commentare il rito descrivendone igesti eseguiti, richiamandone l’occasione e narrandoneil mito che la fonda; serve anche da mezzo di comuni-cazione sia tra i cantori e la divinità, alla quale il rito èrivolto, sia tra i cantori stessi e il gruppo di uomini o didonne che assiste alla festa e di cui essi sono gli interpre-ti. [...] Nella sua componente musicale più ancora chenel pasto rituale, la festa rappresenta una forma dicomunicazione a un tempo religiosa e pedagogica;attraverso la parola musicale essa assume il suo valorepragmatico1.
Da queste feconde annotazioni vediamo emergere allorala parola poetica e il primordiale poeta come, al tempo stes-so, “profeta” e “pedagogo”. Ma in che senso profeta, in chesenso pedagogo? Cerchiamo di comprenderlo riferendociall’esempio fondamentale e famoso della festa e del rito dio-nisiaci, origine prima del “coro” che, come sì sa, è un con-temporaneo danzare e cantare. Che cosa siano questa festae questo rito ce lo faremo dire direttamente da due poeti (eche poeti!): Eschilo e Sofocle. Ci riferiamo rispettivamente alframmento 53 e ai versi 1146-1152 dell’Antigone. Li leggiamonella versione che ne ha dato Giorgio Colli2.
L’uno tiene nelle mani flauti dal suono profondo,lavorati col tornio, e riempie tutta una melodia strappa-ta con le dita, un richiamo minaccioso suscitatore di fol-
carlo sini
Carlo Sini
1 Cfr. C. Calame, La festa, in AA.VV., L’esperienza religiosa antica, a cura di M.Vegetti, Bollati Boringhieri, Torino 1992, pp.38-9.Cfr. anche C. Sini, Le arti dinamiche, in Figure dell’Enciclopedia filosofica, vol. VI, Jaca Book, Milano 2005.2 Cfr. G. Colli, La sapienza greca, cit..
37carlo Sini
Chora N. 16, Settembre 2008
lia (manias); un altro fa risuonare i cimbali cinti di bron-zo alto si leva il suono della cetra; da qualche luogosegreto mugghiano in risposta terrificanti imitatori(mimi) della voce taurina, e l’apparizione sonora di untimpano, come di un tuono sotterraneo, si propaga conoppressione tremenda.
Osserviamo questa mirabile descrizione del rito dionisia-co, che il filologo Rhode, l’amico e il compagno di studi diNietzsche, giudicò essere la testimonianza capitale dellaconnessione tra musica e culto orgiastico. Evidente è infattila funzione della musica nel rito, al fine di produrre unametamorfosi emotiva e una catarsi allucinatoria. Entro lacornice musicale si inserisce poi il terrificante risuonaredella voce taurina, il suo mugghiare da luoghi nascosti: essaconduce l’iniziato a rammentare che l’elemento essenzialedel rito è riferito alla duplicità costitutiva di Dioniso, l’ani-male-Dio, il toro e insieme la divinità del giovane “sedutto-re” dai riccioli biondi.
Nel contempo è anche evidente la compresenza duplicedi Dioniso e di Apollo (Apollo è l’altra faccia di Dioniso,come validamente sostenne appunto Giorgio Colli); infatti,se il suono del flauto è suscitatore di mania, cioè di follia, ilsuono cristallino della cetra è invece connesso all’elementoapollineo, cioè a quell’arte di ammansire le fiere che il miti-co cantore Orfeo ereditò appunto da Apollo. Per il flauto siricordi il flauto di Pan, il cui suono, dice il mito, coglie sulmezzogiorno il pastore sui monti, mentre cerca di ripararsidalla calura e di riposare sotto gli alberi; i suoni del flautodel Dio gli infondono un vaneggiante sopore, sino a con-durlo alla mania folle e visionaria. Nel contempo l’ora cani-colare, in cui le ombre scompaiono (cioè scompare ogni“doppio”), è anche un simbolo del “trauma della conoscen-za”, cioè dell’istante allucinatorio nel quale il soggetto el’oggetto, il nome e la cosa, l’uomo e il Dio, divengono uno(Nietzsche usò il simbolo del mezzogiorno in funzione ana-loga nello Zarathustra).
Infine l’elemento mimico, ovvero la funzione drammati-ca del rito, con la sua trasfigurazione “artistica” “Così, hascritto Colli, si scatena una nuova visione della realtà, inbase alla rottura della conoscenza quotidiana: tale è lamania: visione trasfigurata e allucinata che è però una folliaveritativa, una conoscenza di ordine superiore”. Questaconoscenza superiore è introdotta “dal terrore che precedeil suo erompere per il manifestarsi di un violento dislivellodi coscienza rispetto all’esistenza quotidiana. La musica ècosì lo strumento attraverso il quale il Dio si manifesta”. Lamusica, cioè, è la odos, la via di iniziazione, e insieme è ilmethodos, lo strumento, il “metodo”. Si noti, per esempio,il terrificante influsso che su tutta la scena gioca, al suo cul-minare, l’ossessivo suono grave, profondo e “sotterraneo”del timpano, che a un certo punto interviene a far vibrare etremare ogni cosa, sino a opprimere lo stomaco e a spauri-re il cuore degli iniziati. è in tutto ciò che si radica il mythos,la parola. Sofocle, come ora vedremo, espressamente lo dicee al tempo stesso lo mostra. Consideriamo quindi il sublimepasso dell’Antigone, in esso il coro invoca a gran voce il Dio,affinché si manifesti. In questo brano di altissima poesiaogni espressione meriterebbe la più attenta considerazionee un sottile commento.
O tu che guidi il coro delle stelle spiranti fuoco,guardiano delle parole notturne, fanciullo, progeniedi Zeus, manifèstati, o signore, assieme alle Tiadi cheti seguono, che folli per tutta la notte danzano intor-no celebrando te, Iacchos, il dispensatore.
Dioniso guida “il coro delle stelle”. Il termine ‘coro’ nomi-na la schiera danzante, per esempio il coro delle Tiadi, delleBaccanti, poi evocato. Ma si dice “delle stelle spiranti
fuoco”; si tratta quindi della portata “cosmica”, e non mera-mente psicologica, della ebbrezza prodotta dal “fuoco” dio-nisiaco. L’invocazione coinvolge gli astri: si tratta, disseKerényi, del Dioniso fanciullo dei misteri, invocato appun-to come una stella. Si tratta altresì di una versione dell’anti-chissimo mito del bimbo cosmico che giunge ogni anno arinnovare la vita dell’universo; la connessione tra questofanciullo e la stella cometa è ancora al centro della simbolo-gia cristiana della nascita di Gesù.
Consideriamo ora l’espressione “guardiano delle parolenotturne” (nuchion fthegmata episkope). La traduzione non èesatta (ed è del resto difficile renderla tale). Infatti fthegmatanon significa anzitutto e per lo più “parole”. Il verbo flhen-gomai significa invece emettere un suono, un grido o unavoce; indica cioè il “risuonare” e solo per un camminosemantico successivo arriva a significare anche “parlare”.Più propriamente il verbo significa urlare, gridare, stridere;anche cantare, ma nel senso che cantare fa rumore; quindivociare, chiamare a gran voce. In termini generali, dunque,il risuonare delle cose, compresa la voce. Viene subito inmente quello che abbiamo letto nel frammento di Eschilo:un rito accompagnato da continue sonorità e da immaginidi rumori, di urla taurine, di rimbombi sotterranei, di suoniacuti di strumenti musicali. Ecco perché la semplice tradu-zione con “parole” è riduttiva e anche fuorviante.
Dioniso è dunque il custode, il guardiano di questo risuo-nare notturno della voce. Guardiano è detto in greco episko-pos. Letteralmente: colui che presiede, che osserva dall’alto.Si ricordi che skepsis significa guardare con attenzione persapere e per conoscere (sicché gli “scettici” sono originaria-mente coloro che osservano attentamente i fenomeni e chevi si attengono scrupolosamente, e non coloro che non cre-dono in niente, come poi dice il senso popolare).
Dioniso è dunque il praesidens. Egli osserva e controlla leparole notturne non solo nel senso che questi suoni vengo-no emessi di notte, nel corso della festa, ma anche nel sensoche queste sonorità allusive alla parola sono remote e oppo-ste rispetto al solare Apollo, il fratello e l’alter ego diDioniso. Dioniso allora sovrintende propriamente al pas-saggio tra l’urlo belluino e il suono significativo della paro-la, tra grida animalesche e voci umane. Questo è un ulterio-re modo per intendere la duplice natura di Dioniso, anima-le e Dio. E si potrebbe aggiungere che in ogni umana paro-la resta dunque catturato un nucleo notturno: qualcosa dinon meramente convenzionale come un puro segno, qual-cosa di profondo e di inesprimibile, e tuttavia, proprio perciò, qualcosa di sommamente espressivo, “musicale”.
Al centro esatto del brano, armoniosamente preceduta epoi seguita da tre versi, risuona splendida l’invocazione:pais. La parola significa in greco, al tempo stesso, il fanciul-lo e il gioco, il gioco innocente, il gioco cosmico al di qua delbene e del male. Su questo “pais” converge tutto il senso delbrano, espresso in un verso che, pronunciato il nome esignificata l’origine divina dell’invocato (“progenie diZeus”), si conclude appunto con l’accorata e pressante invo-cazione al Dio a manifestarsi, a farsi immagine visibile, afarsi fenomeno (“prophanete”, da phaino, phainomenon). Ilnome Iacchos conferma successivamente l’identificazionedi Dioniso con Bacco il Dio della vite. Egli è detto “il dispen-satore”. Il termine greco è “tamias”, il cui significato è“dispensa” o “madia”, dove per esempio si ripone e si con-serva il pane. Iacchos è quindi dispensatore di beni e di teso-ri nascosti (il pane e il vino, evidentemente, cioè i “donieucaristici” che conferiscono la vita eterna). Egli è il sovrin-tendente e il custode dei medesimi (come si vede il terminetamias richiama coerentemente episkopos). Iacchos è il“moderatore” di questi beni e tesori: termine che nell’italia-no antico ebbe anche un significato politico, indicando peresempio una carica pubblica.
Possiamo allora, trascurando ancora molto altro, sintetiz-
l’immEmorialE E la parola poEtica
Chora N. 16, Settembre 2008
38
zare così il senso della invocazione. Da un lato essa si riferi-sce a Dioniso, il toro, simbolo delle forze feconde della vita,che urla furibondo in preda a spasimo e passione. Dall’altrol’invocato è colui che, con la sua skepsis, suscita la sapienzadel mondo e nel mondo, una sapienza piena di doni e ditesori nascosti. Nascosti appunto nell’urlo primitivo dellapassione, nella voce taurina che provoca lo stacco di coscien-za, e cioè, nel rito, la memoria delle origini primordiali eancestrali. Stacco che mostra all’iniziato la complessità miste-riosa delle sue origini e delle origini dell’umano. Dionisoregola, modera, tiene a freno, indirizza nel segno apollineodella parola sapienziale, impedendo che il rito orgiasticodegeneri nella fruizione titanica e belluina (il Dio protegge,come si sa, le Menadi, le Baccanti, dalle aggressioni sessualidei pastori sui monti). In tal modo Dioniso indirizza l’erosprimigenio verso un “più di conoscenza” (la connessione tral’eros e il conoscere venne consapevolmente ripresa daPlatone e la parola “conoscere” del resto, esaminata nelle suescritture, mostra, come osserva Alfred Kallir, il duplice sensodel conoscere sessuale e del conoscere spirituale).
Dioniso è allora la vita che si guarda e che così si distanziada sé e che si perde, si oblia, assegnandosi a un destino dimorte; ma anche a un destino di conoscenza e di continuarinascita, sia sessuale, sia memoriale nel rito, sia materialenella generazione, sia spirituale nella conoscenza. Sulla scor-ta del ritmo che attraversa la danza e il mito, la parola risuo-nante, danzante e perciò significativa (“ritmo”, si ricordi,allude al “fare le parti”, per esempio al ripartire la vittimasacrificale tra i commensali e il Dio, sancendone la “comunio-ne”), Dioniso indirizza alla parola luminosa e diurna diApollo: col che siamo ricondotti a quei due lati che, dicemmoall’inizio, contrassegnano la soglia della parola. A ciò alludeanche la sapienza orfica, dove Orfeo è, come si sa, il cantoredi Dioniso e una maschera di Apollo. Al centro del mito orfi-co è il dio Phanes, Dio, come dice il suo nome, della manife-stazione, cioè della manifestatività delle cose del mondo:Phanes è il Dio del “fenomeno”. In particolare Phanes è“colui che si manifesta e che appare rilucente”. Fenomeno(phainomenon) viene infatti da phos, la luce del sole che illu-mina gli enti e li fa apparire: alla luce del sole appunto.Phanes esprime dunque l’incarnazione divina di tutta la real-tà, nella sua molteplice apparenza di “cose”.
Egli, si badi, è tutto il reale, è un’apparenza senza residuie senza fondi ulteriori, e nondimeno custodisce, comeDioniso, un profondo: qualcosa che si manifesta in un sus-sulto come “qualcosa di abissale”. Peraltro questo abisso eprofondo non si manifesta altrove, ma sempre li, sullasuperficie della apparenza rilucente. Propriamente si mani-festa nel suo cuore (nel suo ri-cor-do, si potrebbe dire): diche si tratta? Phanes è l’alter ego diurno della duplicità diDioniso: come Dioniso, infatti, è al tempo stesso maschio efemmina (coloro che non possono stare separati, dicemmo,come la parola notturna e la parola diurna). Per compren-dere dobbiamo rivolgerci a un’altra divinità del cosmo orfi-co: Chronos, cioè il Dio che “mette in fila” e che, così facen-do, dispiega e mostra; vale a dire “temporalizza”. Chronosè sì il tempo, ma nel senso che è ciò che si tratta di attraver-sare per raggiungere l’origine del tempo medesimo, ovve-ro il senza tempo, l’eterno.
Queste osservazioni si completano con un riferimentoall’ulteriore divinità fondamentale dei riti orficì che èMnemosyne, la Dea che nei misteri eleusini incarna il “ritor-no”: ritorno a un’origine che non conosce Chronos, che è“fuor-del-tempo”, direbbe Montale. Tornare a questa origineè appunto il contenuto “misterioso” della visione finale, o
epopteia, del percorso iniziatico. Si tratta di andare indietroper procedere, nel che si compendia il cammino del rito diiniziazione. Chronos/Mnemosyne replicano Apollo/Dioniso,le due facce di Phanes. Chronos mette in fila e così dispiegae mostra quello che Mnemosyne coglie invece abissalmentein un sussulto, riportando là dove Chronos non c’è ancora némai potrà esserci. Ma a sua volta Mnemosyne non potrebbecogliere l’origine senza tempo se non attraversando la tem-poralizzazione di Chronos. E Chronos non potrebbe metterein fila nel tempo se non prendendo a oggetto quella dimen-sione senza tempo cui Mnemosyne allucinatoriamente allu-de. Bisogna dunque “attraversare tutto il tempo”; ovvero imiti, i racconti, le vicende e i canti di Orfeo, le sue favole poe-tiche; quelle favole che fanno da preludio “musicale” inizia-tico nel corso del rito misterico. Quindi le vicende degli Dei edegli Eroi, le loro generazioni e gestazioni, la morte e la resur-rezione di Dioniso e poi tutte le saghe degli Dei olimpici(della lucente schiera degli Dei olimpici, come disseNietzsche). Tutto questo è il canto di Orfeo. Ma nel contem-po tutto questo non è che la rilucente apparenza di Phanes;perché tutto questo non è altro che la “realtà”: noi, le nostrevicende, le nostre infinite storie e tutte le cose che le accom-pagnano, non siamo infine che un racconto, un sogno, unaparola del Dio.
Il ricordo abissale di Mnemosyne, il suo sussulto memoria-le, attraversando il filo della bella apparenza retta dal gioco(pais) del racconto (mythos) e insieme dalla tragica seriosità diananke, dalla necessità che governa la vita titanica, la suaautofagia di cui il Dioniso fanciullo dei misteri, sbranato daiTitani, è appunto il simbolo (Gioco e Necessità: due ulterioridivinità del cosmo orfico), questo ricordo abissale ci riportacosì all’evento umano primordiale: l’evento della parola cheè insieme “mito” e silenzio, ricordo della unità sacrale dellavita cui l’umano partecipa, e insieme suo distacco e precipi-zio nella necessità del cosmo e del regno della morte: eternafragilità “cronica” e ritornante del fenomeno umano. I duelati della parola si sono fatti ora più comprensibili ed eviden-ti. Essi suggeriscono di concludere così: che abbiamo semprebisogno della memoria dei poeti per ricordare che le parole,tutte le parole, sono, e non sono nient’altro, che memoria“poetica” appunto, e profondissimo oblio.
carlo sini, nato a Bologna nel 1933, insegna Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Milano. È socio corrispondente dell’Accademia dei Linceie membro dell’Institut International de Philosophie. Tra le sue pubblicazioni più recenti si ricordano: I segni dell’anima (1989), Etica della scrittura (1992),Teoria e pratica del foglio mondo (1998), Gli abiti, le pratiche, i saperi (1996), La scrittura e il debito (2002), Il comico e la vita (2003), Figure dell’enciclopedia filoso-fica. “Transito Verità”, in 6 voll. (2004-2005), Il gioco del silenzio (2006).
39robErto tErzi
Chora N. 16, Settembre 2008
Buona parte del pensiero del ‘secondo’ Heidegger èoccupata, come è noto, dalla meditazione sulla storia dellametafisica occidentale, la quale sarebbe contrassegnata daun fondamentale ‘oblio dell’essere’: a partire dai suoi inizigreci, la metafisica è caduta in un oblio dell’essere perchélo ha sempre in qualche modo ridotto a un ente e a fonda-mento dell’ente, dimenticando così la ‘differenza ontologi-ca’. L’oblio in questione assume la sua portata se si tienepresente che la storia della metafisica non è per Heideggersemplicemente il susseguirsi delle opinioni soggettive deidiversi filosofi, ma è la storia dell’essere stesso, la storia deldarsi e sottrarsi epocale dell’essere nelle sue diverse figurestoriche: l’essere si destina, cioè accade di volta in volta inuna certa apertura storica, in modo tale che il movimentostesso della donazione/destinazione si sottrae e si mantie-ne in sé, lasciando così emergere in primo piano solo ciòche è dato/destinato. C’è dunque un ‘oblio’ costitutivo del-l’essere stesso: nell’aprire lo spazio del rapporto tra l’uomoe l’ente, l’essere si sottrae, nel manifestarsi si nasconde. Maa questo oblio se ne aggiunge, per cosìdire, un secondo: l’oblio dell’oblio, ossial’oblio (da parte della metafisica) del-l’oblio proprio dell’essere, della sottrazio-ne costitutiva dell’essere, dovuta al fattoche l’essere non è un ente, ma il movimen-to del venire alla presenza degli enti stes-si. Data la centralità di questo confrontocon la tradizione e la caratterizzazionefondamentale di quest’ultima come oblio,era pressoché inevitabile che Heideggerincontrasse a un certo punto il tema dellamemoria. Tema per molti versi classico,ma il cui svolgimento deve ovviamenteessere qui inserito nel contesto complessi-vo del pensiero heideggeriano e delle suemotivazioni. Si deve quindi tenere presente la particolaretrasfigurazione ontologica a cui la questione si trova sottopo-sta nei testi di Heidegger. Bisogna, in altri termini, metterein luce le operazioni che Heidegger attua sulla memoria esui concetti connessi, operazioni che sono altrettante formedi una risalita al senso originario della memoria ovvero,secondo un gesto tipico di molte analisi heideggeriane, dirisalita a ciò che rende originariamente possibile la memo-ria in senso comune e che deve dunque essere chiamato‘memoria’ in senso proprio.
1. L’ontologizzazione della memoria. Memoria e oblioSi tratta innanzitutto di una ontologizzazione della memo-
ria: nei testi del secondo Heidegger il tema della memoria
compare nell’ambito della questione più generale del pen-siero come ciò che corrisponde all’appello dell’essere. Il pen-siero è pensiero dell’essere, nel duplice senso del genitivo:ha la sua ‘cosa’ più propria nell’essere stesso e provienedall’essere essendone reclamato. A partire dal problemadella coappartenenza tra essere e uomo, Heidegger ripro-pone così la questione “che cosa significa pensare?” ed èall’interno di questa che giocano un ruolo decisivo l’idea diun pensiero rammemorante (Andenken o andenkendesDenken) e il tema della memoria (Gedächtnis), contrappostial pensiero rappresentativo, che ha dominato la metafisicamoderna e che riduce l’essere alla sua oggettività presente.Già la scelta dei termini e l’interpretazione che ne dàHeidegger segnala la stretta appartenenza della questionedella memoria alla questione più generale del pensiero: iltermine Andenken rinvia a Denken, pensiero, e in particola-re al Denken an, al pensare-a, al volgersi del pensiero allasua ‘cosa’ più propria che lo ha già sempre preceduto eappellato, all’esser-fuori del pensiero verso ciò che è da
pensare; il termine Gedächtnis è a sua voltainteso da Heidegger come composto dalprefisso Ge-, che avrebbe un valore di rac-coglimento, e dalla radice dacht- cherimanda alla stessa famiglia lessicale delpensare (denken, gedacht): “memoria è quiil raccoglimento (Versammlung) del pen-siero, che rimane raccolto presso ciò a cuisi è già dapprima pensato, perché è que-sto che vuole essere pensato sempreprima di ogni altra cosa. Memoria è il rac-cogliersi della rimemorazione (Andenken)presso ciò che è prima di ogni altra cosada considerare. Questo raccogliersi alber-ga presso di sé e nasconde in sé quello acui preliminarmente sempre si deve pen-
sare nel guardare a ciò che è (west) e si afferma come essen-te e come essente-stato (als Wesendes und Gewesenes)”1.Heidegger intende dunque la memoria come il volgersi eil raccogliersi del pensiero presso ciò a cui si è già semprepensato e a cui si deve preliminarmente pensare, dalmomento che è ciò che rende possibile ogni nostro singolopensiero: si tratta dunque del volgersi del pensiero non alpassato nel senso comune del termine, ma a una sorta di‘passato trascendentale’, che è già sempre stato e ci ha giàsempre preceduti.
La memoria è innanzitutto memoria dell’essere o, in altritermini, il pensiero si configura come memoria perché siesercita a partire dall’oblio dell’essere, in un duplice senso: a)l’oblio dell’essere come il suo sottrarsi e nascondersi a
l’oBlio, il segno, la storia: la MeMoria in heidegger
di roBerto terziuniversità degli studi di Milano
Martin Heidegger
1 M. Heidegger, Vorträge und Aufsätze, hrsg. v. F.-W. von Herrmann, in Gesamtausgabe, Bd. 7, Klostermann, Frankfurt a. M. 2000; tr.it. di G. Vattimo, Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976, pp. 90-91 (in seguito indicato direttamente nel testo con la sigla SD seguitadal numero di pagina).in particolare pp. 134 sgg.
l’oblio, il SEgno, la Storia
Chora N. 16, Settembre 2008
40
favore degli enti, sottrazione che il pensiero deve ricorda-re come ciò che lo ha già sempre preceduto e che deve cer-care di esibire come tale; b) l’oblio dell’essere in senso sto-rico che ha contrassegnato la metafisica, la quale è giuntaal suo termine e lascia così al pensiero il compito di sottrar-re l’essere al suo oblio epocale e di rammemorare la tradi-zione come storia dell’essere. Questa osservazione ci per-mette di introdurre un altro punto decisivo, che a sua voltaconferma l’ontologizzazione di cui stiamo parlando:Heidegger pone la memoria in un rapporto di coapparte-nenza essenziale con l’oblio ed entrambi i concetti sono collo-cati su un piano eminentemente ontologico e non psicolo-gico. Heidegger pensa infatti il rapporto memoria-oblio apartire dalla questione della verità come aletheia e dal rap-porto tra aletheia e lethe, come emerge da alcune pagine delcorso del 1942-43 dedicate alla concezione greca dell’oblio2.Come è noto, per Heidegger la verità nel suo significatogreco originario deve essere pensata non come correttezzae adeguazione, ma appunto come aletheia, che Heideggerinterpreta sulla base della sua costruzione letterale come a-letheia: il concetto greco di verità è costruito con un alfa pri-vativo aggiunto alla radice leth-, lath-, che rimanda al verbolanthano, il quale significa ‘essere nascosto’; l’aletheia rac-chiude dunque in sé un’essenza conflittuale, perché signifi-ca letteralmente ‘non-nascondimento’, disvelatezza, laquale proprio perciò mantiene un riferimento essenzialealla lethe, al nascondimento, che è il “cuore”3 stesso dellaverità e rappresenta la fonte costante e inesauribile dellamanifestatività. L’ambito del velamento svolge dunque unruolo essenziale nell’esperienza dell’ente e proprio per que-sto i concetti che vi si riferiscono devono essere interpretatiadeguatamente rispetto all’esperienza greca, il che significainnanzitutto in modo non-soggettivo e in senso manifestativo;in quest’ambito rientra anche l’esperienza dell’oblio, dalmomento che dalla stessa radice proviene il vero lanthano-mai, che significa proprio ‘dimenticare’. Il verbo lanthanoinnanzitutto non significa transitivamente ‘io nascondo’,ma ‘io resto nascosto, velato’ e indica dunque un modo del-l’ente stesso: “«velato» e «svelato» sono un carattere del-l’ente come tale, non però un carattere del notare e del com-prendere” (PA, p. 68); “la esperibilità e la comprensibilitàdell’ente […] si fonda dunque sull’eventualità che accada lavelatezza oppure la svelatezza” (PA, pp. 73-74). Un discor-so analogo vale per l’oblio ed è per questo che la traduzio-ne immediata di lanthanomai con ‘dimenticare’ rischia perHeidegger di essere un fraintendimento che re-interpreta inchiave moderna e soggettivistica l’esperienza greca. L’oblioin senso greco deve essere compreso come un modo delvelamento: “i Greci hanno esperito il dimenticare come unaccadere del velamento” (PA, p. 75); “pensato in modogreco lanthanomai dice: io rimango velato a me stesso nelriferimento che qualcosa di altrimenti svelato ha con me. Intal modo quest’ultimo è a sua volta velato, così come io losono a me stesso nel mio riferimento a esso. L’ente sprofon-da nella velatezza in modo tale che in questo velamentodell’ente io rimango velato a me stesso. Nel contempo que-sto velamento viene a sua volta velato, il che accade quan-
do diciamo: ho dimenticato questo e quest’altro. Neldimenticare non soltanto ci sfugge qualcosa, ma il dimenti-care medesimo cade in un velamento tale che noi stessi, nelnostro riferimento al dimenticato, cadiamo vittime dellavelatezza” (PA, pp. 68-69).
Da questi passi di Heidegger possiamo ricavare alcunielementi essenziali: 1) l’oblio e, dunque, anche la memorianon devono essere concepiti innanzitutto come facoltàsoggettive, come vissuti psicologici, come il semplice frut-to di un’attività umana o della distrazione dell’uomo chenon presta più attenzione a qualcosa e così la dimentica:queste concezioni sono possibili solo sul fondamento diuna più originaria essenza dell’oblio, il quale deve essereesplicitamente sottratto all’interpretazione soggettivisticae psicologica in termini di vissuto. L’oblio deve essere inte-so in primo luogo come un evento ontologico e manifesta-tivo, che coinvolge in modo unitario e inscindibile gli entinel loro essere e l’uomo nel suo rapportarsi a essi: tanto il‘dimenticato’ quanto il ‘dimenticante’ accadono unitaria-mente in questo evento dell’oblio, inteso come un mododel velamento ontologico. L’oblio in senso comune è pos-sibile sullo sfondo di questo oblio ontologico e manifesta-tivo che permea il rapporto tra l’uomo e gli enti: non èl’oblio che accade in noi (nella nostra psiche), ma siamo noia essere collocati nell’oblio, “gettati in una dimenticanza”(PA, p. 143); 2) l’oblio non è semplicemente qualcosa dinegativo e assente, che non avrebbe nessun ruolo nel-l’esperienza e nella costituzione del positivo: se l’oblio è unmodo del velamento, come il velamento (la lethe) è costitu-tivo della disvelatezza (dell’aletheia) rappresentandone ilcuore, così l’oblio è costitutivo del ricordo e della sua pos-sibilità, è quell’assenza che contribuisce a costituire la pre-senza e il rapporto a essa. Infatti, ciò che è obliato non èsemplicemente non-esistente e assente, ma abita la presen-za e la incalza, contribuisce a determinarla proprio inquanto assente-da-essa o volgersi-via da essa (cfr. PA, p.144). L’essenza conflittuale della verità come aletheia siriflette nel conflitto tra oblio e memoria: non c’è memoriasenza un ruolo costitutivo dell’oblio, che non rappresentadunque solo un limite empirico e idealmente da superaredella facoltà del ricordo, ma è per certi versi la condizionedi possibilità del ricordo stesso; memoria e oblio accadonoin un evento ontologico unitario tale per cui ogni memoriaha il suo rovescio in un oblio, si esercita a partire da e sullosfondo di un oblio. L’ideale di una memoria piena e com-pleta, che abbia superato ogni oblio, è una finzione e unsogno metafisico, che si annulla da sé perché sarebbe l’an-nullamento del senso stesso della memoria, che non si dàse non nell’intreccio e nel conflitto con l’oblio; 3) nel passocitato Heidegger mette in luce un tratto fenomenologicocostitutivo dell’oblio, che spiega anche l’interpretazionedella storia della metafisica richiamata in precedenza:l’oblio è per essenza oblio dell’oblio, nel dimenticare ci sidimentica di aver dimenticato perché altrimenti si ricorde-rebbe la cosa in questione; nell’oblio qualcosa si vela el’oblio stesso rimane in quanto tale velato, così anche coluiche dimentica rimane velato a se stesso in quanto dimenti-
2 Non possiamo ricostruire qui l’insieme della trattazione heideggeriana, di cui richiameremo solo alcuni elementi. Cfr. M.Heidegger, Parmenides, hrsg. v. di M. Frings, in Gesamtausgabe, Bd. 54, Klostermann, Frankfurt a. M. 1982; tr. it. di G. Gurisatti,Parmenide, a c. di F. Volpi, Adelphi, Milano 1999, pp. 62 sgg., 141 sgg. (indicato in seguito direttamente nel testo con la sigla PA segui-ta dal numero di pagina).3 Cfr. M. Heidegger, Zur Sache des Denkens, Niemeyer, Tübingen 1969; tr. it. di E. Mazzarella, Tempo ed essere, Guida, Napoli 1980, p.190: “il nascondersi, l’ascosità, la Lethe appartiene alla A-letheia non come una semplice aggiunta, non come l’ombra appartiene allaluce, ma come il cuore dell’Aletheia”.
41robErto tErzi
Chora N. 16, Settembre 2008
cante (non ‘ricorda’ o non ‘sa’ di aver dimenticato): “acca-de qui dunque un velamento che colpisce simultaneamen-te il dimenticato e il dimenticante, senza tuttavia cancella-re nessuno dei due” (PA, p. 142). Il pensiero rammemoran-te deve dunque evitare di obliare l’oblio: bisognerà allora direche non solo la memoria si esercita costitutivamente a par-tire da e sullo sfondo di un oblio, ma che ha nell’oblio ilproprio ‘oggetto’; ciò che l’Andenken ricorda e custodiscenon è un ‘qualcosa’, ma l’oblio come tale.
2. La de-soggettivazione della memoria. Memoria esegno
L’ontologizzazione della memoria ha il suo pendant inuna de-soggettivazione: la memoria non è qui consideratasolo e innanzitutto come la “semplice facoltà, di cui parlala psicologia, per cui siamo capaci di conservare la rappre-sentazione del passato”(SD, p. 90), e questo per-ché, più in profondità,non è pensata esclusiva-mente come qualcosa diappartenente “alla dota-zione essenziale dell’uo-mo”, “come qualcosa distrettamente umano”4.La memoria non èinnanzitutto e semplice-mente una facoltà del-l’uomo, piuttosto è l’uo-mo a essere rimesso allamemoria nella suaessenza originaria, cioèall’essenza del pensierocome riferimento all’es-sere. La capacità umanadi conservare e ritenerenella memoria è resapossibile da un prelimi-nare ‘conservarsi’ e ‘serbarsi’ in sé del suo ‘oggetto’, che,reclamando l’esposizione dell’uomo a esso, può concederela memoria o l’oblio: la memoria, come “raccoglimento delpensiero che si ri-volge”, “non si fonda su una capacità del-l’uomo, magari sul ricordare o sul ritenere. Ogni pensieroche si ri-volge a ciò che è memorabile abita già esso stessoin quel raccoglimento grazie al quale tutto ciò che resta dapensare è protetto e nascosto. […] La memoria nel sensodel pensiero umano che si ri-volge abita in ciò che conser-va tutto ciò che va pensato. Questo noi lo chiamiamo la ser-banza (Verwahrnis). Essa nasconde e protegge ciò che ci èdato da pensare. […] La memoria poggia, in quanto pen-siero umano che si ri-volge a ciò che va pensato, sulla ser-banza del più considerevole. La serbanza è il fondamentoessenziale della memoria” (CSP, pp. 170-1). La memoria èdunque esposta e radicata nella possibilità di conservarsiin sé, di donarsi e sottrarsi della sua ‘cosa’, e questa dina-mica di manifestazione/sottrazione è al tempo stesso l’og-getto più alto del pensiero rammemorante. “La memorianon appartiene semplicemente alla facoltà del pensiero incui ha luogo, giacché ogni pensiero e ogni apparire di ciòche va-pensato trovano l’apertura in cui arrivano e si
incontrano soltanto là dove accade la serbanza del più con-siderevole. L’uomo si limita ad abitare la serbanza di ciòche gli dà da pensare. L’uomo non produce la serbanza”(CSP, p. 171). L’uomo può ricordare e dimenticare perchéabita una radura pre-soggettiva che concede di volta involta la possibilità del ricordo e dell’oblio: come era giàemerso, la dinamica memoria/oblio è un evento ontologi-co-manifestativo in cui l’uomo è collocato e che permettel’esercizio delle sue facoltà. Ma questa radura è anche ciòche determina l’essenza dell’uomo, dal momento che que-st’ultimo ha per Heidegger la sua essenza originaria nel-l’essere-esposto alla manifestatività, nell’essere appropria-to all’evento (Ereignis) dell’essere che è al tempo stessoespropriazione (Enteignis). Ciò che nella memoria va rite-nuto è ciò che a sua volta ci tiene nell’essenza a cui appar-teniamo: “ciò che ci tiene nell’essenza, ci tiene in essa tut-
tavia solo fino a che noi,a nostra volta, ri-teniamociò che ci tiene. E noi loriteniamo se non lolasciamo cadere dallanostra memoria. Lamemoria è il raccogliersidel pensiero.Raccogliersi in che cosa?In ciò che ci tiene nell’es-senza, nella misura in cuiesso è da noi tenuto inconsiderazione. […]Considerarlo significaoffrirgli la nostra rime-morazione (Andenken).Noi gli offriamo il nostropensiero rimemoranteperché lo amiamo comeil rivolgerci la paroladella nostra essenza”(SD, pp. 85-86). Se la
memoria è qui sottoposta a una peculiare de-soggettiva-zione, è dunque anche perché ciò che l’uomo innanzituttopuò ricordare, ciò verso cui si raccoglie e si tende la suamemoria e che sta per così dire al fondo di ogni singoloricordo particolare non è altro che l’essenza stessa dell’uo-mo, essenza che è ‘donata’5 all’uomo e che non è in suopotere, dal momento che è piuttosto l’uomo a essere con-segnato e rimesso a essa. Nel fondo di ogni ricordo l’uomoricorda la sua essenza a cui appartiene, rammemora la suafatticità essenziale, il fatto del suo essere e del suo esser-esposto all’essere: rammemora quindi ciò che è propria-mente immemorabile e che la memoria non può risolverecompletamente in sé, perché è il proprio dell’uomo che staal cuore di ogni suo atto e di cui l’uomo, in quanto essen-zialmente finito, non può impadronirsi. Al fondo di ogniatto di memoria sta un immemorabile, che non è semplice-mente una cosa in sé non ricordata o non ricordabile: l’im-memorabile accade con e per la memoria e al tempo stessone è la sorgente che garantisce la sua inesauribilità e insie-me la sua finitezza.
Questa linea teorica è confermata anche dall’emergere diuna connessione tra la memoria e il problema del segno. Si
4 M. Heidegger, Was heisst Denken?, hrsg. v. P.-L. Coriando, in Gesamtausgabe, Bd. 8, Klostermann, Frankfurt a. M. 2002; tr. it. di U.Ugazio e G. Vattimo, Che cosa significa pensare, prefazione di G. Vattimo, Sugarco, Carnago 1996, p. 170 (indicato in seguito diretta-mente nel testo con la sigla CSP seguita dal numero di pagina).5 È in questo ordine di considerazioni che bisognerebbe prendere in esame la connessione, esposta da Heidegger in Che cosa significa pensa-re?, tra i temi del dono e del pensiero (Denken) come memoria (Gedächtnis) e come ringraziamento (Danken): cfr. CSP, pp. 165 sgg.
Salvador Dali - La persistenza della memoria
l’oblio, il SEgno, la Storia
Chora N. 16, Settembre 2008
42
tratta di una connessione che si è imposta spesso nel corsodella riflessione filosofica (i segni di ciò che deve esserericordato, che la memoria deve interpretare e a partire dacui si esercita) e che può essere ritrovata nei testi heidegge-riani, anche se, come sempre, peculiarmente trasfiguratasu un piano ontologico generale. Nella conferenza Che cosasignifica pensare? Heidegger afferma che ciò che è piùdegno di essere pensato è il fatto che noi non pensiamoancora, il che però non è dovuto semplicemente a unainsufficienza umana: è infatti ciò che è da-pensare che sidistoglie dall’uomo e si sottrae, ma questo sottrarsi non èun vuoto niente, è un ritrarsi e un negarsi e come tale unevento. Ciò che così si sottrae non perde qualsiasi relazio-ne con noi, ma nel sottrarsi “ci porta con sé e ci attrae a suomodo verso di sé”, “è presente e ciò nel senso che ciattrae”: “quando noi perveniamo nel trarre (Ziehen) delsottrarre (Entzug), siamo già in marcia (auf dem Zug) versociò che ci attrae in quanto si sottrae” (SD, p. 89). L’uomo ècioè coinvolto nell’evento del sottrarsi di ciò che dovrebbepensare ed è così tratto e attratto fuori di sé, “in marcia”verso ciò che si sottrae. Ciò non indica una condizione trale altre dell’uomo, ma la sua stessa essenza, comeHeidegger indica in un passaggio notevole: “noi stessiadditiamo ciò che si sottrae. In generale, noi siamo noi stes-si e siamo quelli che siamo solo in quanto additiamo ciòche si sottrae. Questo additare (Weisen) è la nostra essenza(Wesen). Noi siamo, in quanto indichiamo (zeigen) ciò chesi sottrae. In quanto è colui che indica in questa direzione,l’uomo è colui che indica. L’uomo non è anzitutto uomo ein secondo luogo anche, e magari occasionalmente, unoche indica; ma: l’uomo è anzitutto e fondamentalmenteuomo in quanto è tratto nel movimento del sottrarsi, è inmarcia verso questo e in tal modo è colui che indica il sot-trarsi stesso. La sua essenza risiede nell’essere un tale indi-ce (Zeigender)”; e Heidegger può così trarre la conclusionedecisiva: “ciò che in se stesso, nella sua costituzione piùpropria, è qualcosa che indica, noi lo chiamiamo un segno(Zeichen). Essendo tratto nel movimento verso ciò che sisottrae, l’uomo è un segno” (SD, pp. 89-90). Poiché indicaverso qualcosa che si sottrae, questo segno non può farvedere chiaramente ciò verso cui indica, rimane senzainterpretazione. Heidegger lega le proprie affermazionianche ad alcuni versi di Hölderlin: “un segno noi siamo,che nulla indica (deutungslos) / senza dolore, e quasi /abbiamo dimenticato la lingua in terra straniera”.Heidegger nota come questi versi provengano dal pro-getto per un inno, per il quale Hölderlin aveva pensato adiversi titoli, tra cui anche Mnemosyne, il nome greco perla memoria (e, nel mito, per una Titanide che, come sposadi Zeus, diventa la madre di tutte le Muse). La figura del-l’uomo è dunque qui radicalmente de-sostanzializzata:l’uomo è essenzialmente un segno e lo è proprio in quan-to pensiero rammemorante, che è espropriato da e trattofuori di sé verso ciò che si sottrae, indica e fa segno versoquest’ultimo. La memoria dunque non è segnica sempli-cemente perché fa uso di segni per risalire all’oggettopassato, ma è in se stessa e costitutivamente segnica, èl’espressione dell’essere-un-segno proprio dell’uomo: lamemoria è segnica in virtù del suo riferimento al sottrar-si dell’essere come ‘passato’ già sempre accaduto, ‘passa-to’ trascendentale e che non è mai stato presente e cherende possibile il ricordo del passato nel senso abitualedell’espressione. Si potrebbe anche dire che è solo perchéla memoria è segno nel suo stesso essere, perché è segnodi ciò che si sottrae (il quale non è un ‘qualcosa’ che possa
essere ‘ripresentificato’ nel ricordo), che può poi relazio-narsi concretamente ai segni in senso abituale (segni pre-senti di ciò che è passato, segni che permettono di fissarequalcosa nel ricordo). Evidentemente, il senso del ‘segno’nei due casi è differenti. Come abbiamo visto, Heidegger,anche sulla scorta dei versi di Hölderlin, afferma che l’uo-mo è un segno deutungslos, un segno senza interpretazio-ne e che “nulla indica”, dal momento che l’uomo indica ilmovimento del sottrarsi in cui è tratto, sottrarsi che non èun ente o un significato determinato. L’uomo, il pensiero,la memoria come segno non rimandano dunque, nelsenso più profondo, a un ente o a un significato determi-nato, ma a ‘nulla’ di essente, all’evento del sottrarsi: ilsegno rimanda innanzitutto non a un’altra cosa, ma alsuo stesso accadere, all’evento stesso del segno e di ognisignificato; dunque la memoria è nel suo fondo memoriadel proprio evento e quindi dell’evento dell’umano,ossia, come era già emerso, memoria di quell’eventoimmemorabile che resta tale al fondo di ogni ricordo.
3. Temporalizzazione e storicizzazione della memoria.Il pensiero rammemorante e la storia dell’essere
Il passaggio dal pensiero rappresentativo al pensierorammemorante è anche il passaggio dall’essere considera-to come presenza e oggettività (e non interrogato nel suocarattere temporale) all’essere considerato nella sua pienatemporalità (cfr. SD, pp. 94-95). All’ontologizzazione siaccompagna allora anche una temporalizzazione dellamemoria, dal momento che, venendo a confondersi con ilpensiero stesso nel suo riferimento all’essere, la memorianon si riferisce solo a ciò che è passato e trascorso, maall’intero campo della temporalità, all’essere nel suodispiegarsi temporale: originariamente Gedächtnis indica“l’incessante, raccolto rimanere presso…, e non soltanto
Rene Magritte - Memoria
43robErto tErzi
Chora N. 16, Settembre 2008
presso ciò che è passato, ma allo stesso modo presso ciò cheè presente e ciò che può venire. Passato, presente e avvenireappaiono nell’unità di una presenza (An-wesen), che è ognivolta la loro propria” (CSP, p. 164). Questa temporalizzazio-ne della memoria è anche una storicizzazione ovvero si mostraconcretamente in atto proprio nel rapporto tra pensiero ram-memorante e storia, dal momento che l’essere per Heideggernon si dà se non nel suo accadere e sottrarsi nelle sue diver-se figure storiche. Ma naturalmente il rapporto tra pensierorammemorante e storia dell’essere deve essere inteso inmodo adeguato e conformemente all’impianto ontologicomesso in luce finora, quindi innanzitutto alla luce della tem-poralità originaria che caratterizza tanto l’uomo quanto l’es-sere stesso. Infatti se il pensiero è Andenken non è per un inte-resse alla ricostruzione storiografica e ‘oggettiva’ del passato,né per la rassegnazione al fatto che non resterebbero, per noiepigoni, altri compiti al di fuori del ricordo di una storiaesauritasi. Il pensiero è ontologicamente e strutturalmenteAndenken, non perché rivolto al passato, ma perché ogni pen-siero è già sempre preso “nel gioco del differire del presentecon se stesso”, proviene dalla propria “presente oscurità” epensa “il proprio presente essere-stato”6: l’uomo non hasemplicemente alle spalle un passato trascorso e scomparso,ma è un esser-stato ed è questo esser-stato (il passato ontolo-gico, coinvolto nel circolo della temporalità7) che deve essererammemorato e che fa sì che il pensiero sia Andenken; piùprecisamente, l’uomo insieme è il proprio esser-stato ed ènella differenza con esso, è in una differenza con sé e da sé eha da interpretare la propria differenza (in altri termini, l’uo-mo è un segno e ha da interpretare il proprio esser-segno). Ilpensiero è dunque rammemorante in virtù di questa costituzioneontologica, temporale ed ermeneutica, che coinvolge non solo l’uo-mo, ma l’essere stesso: se il pensiero è rammemorazione è per-ché l’essere si destina a noi e nel destinarsi si trattiene in sé esi sottrae, perché l’invio dell’essere ci ha già sempre precedu-to, perché l’essere è differenza da ogni ente e da ogni confi-gurazione determinata. In altri termini, il pensiero ramme-morante è il pensiero che corrisponde all’essere come diffe-renza (temporale e storica) ovvero all’essere come evento edestino: “l’iniziale avviene anticipando tutto ciò che verrà e,pertanto, benché velato, viene all’uomo storico come purovenire. Non passa mai, non è mai un passato. Per questo nontroviamo mai nemmeno l’iniziale nel rivolgerci storiografica-mente al passato, ma solo nel pensiero rammemorante chepensa soprattutto all’essere essenzialmente presente (il giàstato essenzialmente presente [das Gewesende]) e alla veritàdell’essere destinata”8.
È la dinamica che emerge, ad esempio, anche in alcunepagine de Il principio di ragione e che permette di mostra-re sul concreto piano del rapporto alla storia quel proces-so di ‘temporalizzazione’ della memoria a cui abbiamofatto riferimento: “rammemorare (an-denken), e cioè ri-pensare il destino già stato, significa però pensare a fondociò che è ancora impensato nel già stato, come ciò che èda-pensare. A quest’ultimo, il pensiero corrisponde sol-tanto in quanto pensiero che pensa-già (vor-denkend). Ri-pensare (An-denken) il già stato è pensare-già (Vor-denken)all’impensato che è da pensare. Il pensare è un pensaregià che ripensa (Denken ist andenkendes Vordenken)”9. Inogni pensiero si cela un impensato che lo determina e cheresta nascosto al suo autore. Rammemorare un’epocapassata del pensiero non significa quindi semplicementeripresentificare un oggetto non più presente, ma propriovolgersi a quel che è rimasto impensato: questo impensa-to ‘passato’, infatti, non scompare, ma permane comepossibilità e come tale ci viene incontro a partire dall’av-venire. L’esser-stato è il permanere essenziale dell’essereche ci viene incontro a partire dall’avvenire come possi-bilità, ma quest’ultima può dunque essere pensata/ram-memorata solo se il pensiero è già anche volto all’avveni-re, se è pensiero progettante e interpretante. In altri termi-ni, per interpretare bisogna aver già interpretato, ramme-morare ciò che non è stato pensato e non si è realizzato inciò che è stato; ma, viceversa, non potrei volgermi a que-st’ultimo (e attenderlo come possibilità) senza essere giàin un nuovo progetto interpretativo, che dischiude l’av-venire a partire dal quale mi volgo al passato. Il pensierorammemorante rispecchia dunque la circolarità tempora-le e ontologica tra avvenire ed essere-stato (circolaritànella quale soltanto si costituisce il presente), indica lacostituzione essenzialmente ermeneutica del pensiero e,sulla base di questa, il rapporto essenziale dell’uomo allastoria. Il pensiero rammemorante (andenken) è già sempreanche pensiero proteso avanti a sé (vordenken). Non si dàmemoria se non in e per un progetto, così come non c’è proget-to che non sia anche rammemorante. Riferito alla visione hei-deggeriana della storia dell’essere, questo significa chec’è un rapporto circolare e di rimando reciproco tra ilprimo inizio greco del pensiero e l’altro inizio che puòdischiudersi al termine della metafisica: il secondo non sidà se non nel ricordo pensante del primo (dei suoi limitie delle sue possibilità), così come il primo inizio non puòessere ricordato se non nel salto anticipante verso il pro-getto di un altro inizio10.
6 Cfr. A. Carrera, L’esperienza dell’istante. Metafisica, tempo, scrittura, Lanfranchi, Milano 1995, pp. 152-153.7 Sull’esser-stato e più in generale sulla temporalità dell’esserci cfr. M. Heidegger, Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen 199317;tr. it. di P. Chiodi rivista da F. Volpi, Essere e tempo, a c. di F. Volpi, Longanesi, Milano 2005, §§65 sgg.8 M. Heidegger, Nietzsche II, hrsg. v. B. Schillbach, in Gesamtausgabe, Bd. 6.2, Klostermann, Frankfurt a. M. 1997; tr. it. di F.Volpi, in Nietzsche, a c. di F. Volpi, Adelphi, Milano 1994, p. 931. Cfr. anche G. Vattimo, “An-Denken. Il pensare e il fondamen-to”, in Id., Le avventure della differenza. Che cosa significa pensare dopo Nietzsche e Heidegger, Garzanti, Milano 2001³, pp. 123-149,in particolare pp. 134 sgg.9 M. Heidegger, Der Satz vom Grund, hrsg. v. P. Jaeger, in Gesamtausgabe, Bd. 10, Klostermann, Frankfurt a. M. 1997; tr. it. di G.Gurisatti-F. Volpi, Il principio di ragione, a c. di F. Volpi, Adelphi, Milano 1991, p. 161.10 Sul rapporto tra primo e altro inizio cfr. in particolare M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), hrsg. v. F.-W. v.Herrmann, in Gesamtausgabe, Bd. 65, Klostermann, Frankfurt a. M. 1989; tr. it. di A. Iadicicco, Contributi alla filosofia (Dall’evento), ac. di F. Volpi, Adelphi, Milano 2007, in particolare la sezione III Il gioco di passaggio (Das Zuspiel).
roberto terzi (Bergamo 1977) si è laureato in Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Milano, dove collabora con le cat-tedre di Propedeutica filosofica e di Filosofia teoretica II. Ha conseguito il DEA in “Histoire de la philosophie” presso l’UniversitéParis IV-La Sorbonne e il dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino. È in corso di pubblicazione presso l’editoreRubbettino un suo volume intitolato Il tempo del mondo. Heidegger, Husserl, Patočka.
MeMoria del non vissutola “visione degli anni” in proust e Bergson
Si je cherchais simplement à me souvenir et à faire double emploi par ces souvenirs avec les jours vécus,
je ne prendrais pas, malade comme je suis, la peined’écrire.
Marcel Proust, lettera a Jacques Rivière, 6 febbraio1914
1.Quale filosofia per ProustSi è spesso visto nell’affermazione proustiana
“un’opera imbevuta di teorie è come un oggetto sulquale si lasci il cartellino del prezzo”1
una perentoria conferma del fatto chela Recherche non rivendichi per séalcuna “verità” filosofica. In realtàquesta dichiarazione di Proust ne sot-tende un’altra, che ne complica ilsenso e ci impedisce di arrivare alleconclusioni spicciole di cui sopra. “Hotrovato – scrive infatti Proust in unasua lettera – più retto e delicato, comeartista, non lasciar vedere, nonannunciare che era proprio alla ricercadella Verità che partivo”2. Non è quin-di l’assenza di un peso “teorico” o“teoretico” a dissuadere l’artista dal-l’esibire teorie, ma al contrario è pro-prio la sua presenza a rendere neces-sario che essa si faccia discreta, differendola semprepiù, perché la fibra letteraria e romanzesca dell’operanon ne sia soffocata.
Sono allora proprio le parole di Proust a configura-re la Recherche come viatico per una qualche verità, edunque a manifestare la sua portata filosofica. La filo-sofia di Proust presenta però, possiamo già indovi-narlo, caratteri assai particolari, se non altro nel suovolersi differire e dissimulare. Gilles Deleuze ha benvisto questo aspetto dell’opera proustiana: “essa riva-leggia con la filosofia. Proust traccia un’immagine delpensiero che si oppone a quella della filosofia, pren-
dendo di mira quanto è più essenziale a una filosofiaclassica di tipo razionalista”3. È in particolare il carat-tere di pensiero naturalmente orientato verso ilbuono, il bello e il vero che, secondo Deleuze, vieneradicalmente contestato da Proust. Il filosofo è, etimo-logicamente, l’amico della verità, presupponendoperciò che la ricerca del vero nasca e si compia in unatto di buona volontà. A sua volta, la volontarietà del-l’atto conoscitivo presuppone che vi sia già qualcosada conoscere, un mondo di entità oggettive o di signi-
ficati ideali cui il pensiero, e l’opera,devono semplicemente tendere eriprodurre quanto più fedelmentepossibile. In Proust questo schema,comune alla conoscenza, alla memoriae alla creazione artistica, quest’imma-gine del pensiero, come la chiamaDeleuze, è completamente rovesciata.In Proust “la verità non si concede, sitradisce; non è voluta, ma involonta-ria”4. Questo primato dell’involonta-rio abita tutta la Recherche, ben al di làdella sola facoltà della memoria. Comemette bene in luce ancora una voltaDeleuze, in Proust possiamo parlareanche di un’intelligenza involontaria,qual è per esempio quella mossa dai
segni amorosi e dalle loro laceranti verità. In essiinfatti la verità si tradisce attraverso le menzogne del-l’amato, si disegna attraverso i silenzi, i lapsus, ledimenticanze. L’intelligenza è costretta a pensare laverità insita in questi segni, e in nessun modo potreb-be presupporla. Per questo l’intelligenza involontaria“viene dopo”5 opponendosi così a quella della filoso-fia, che è sempre presupposta e che per questo èimpossibilitata a trovare alcunché. Lo stesso avvieneper la memoria, secondo una perfetta simmetria. Laceleberrima memoria involontaria è infatti, come tuttisanno, provocata da uno choc, da una costrizione
di sara guindani
Marcel Proust
mEmoria dEl non viSSuto
Chora N. 16, Settembre 2008
44
1 M. Proust, Il Tempo ritrovato, p. 397. Per le citazioni tratte dalla Recherche, faremo riferimento all’edizione italiana Alla ricerca deltempo perduto, tr. it. di G. Raboni, Mondadori, Milano 1987 sgg., 7 voll. 2 M. Proust, Lettres, Plon, Paris 2004, p. 667. 3 G. Deleuze, Proust et les signes, Presses Universitaires de France, 1964, 1979, tr. it di C. Lusignoli, Marcel Proust e i segni, Einaudi,Torino 1967, 2001, p. 87.4 Ibidem, p. 88. 5 Tutto il tema dell’intelligenza che “viene dopo è già esplicitamente presente in Proust: “Le idee formulate dall’intelligenza purahanno soltanto una verità logica, una verità possibile e la loro scelta è arbitraria. […] nello scienziato il lavoro dell’intelligenzaprecede, mentre nello scrittore viene dopo”, Tempo ritrovato, p. 395.
Chora N. 16, Settembre 2008
45Sara guidani
esterna; ciò che essa “trova” però è ben lungi dall’es-sere un ricordo nel senso abituale del termine.Sappiamo come la Combray prodigiosamente “risor-ta” da una tazza di tè, grazie al sapore della madeleineinzuppatavi, non possa assolutamente considerarsicome semplice “doppio” o sorta di “fermo immagi-ne” della Combray vissuta dallo scrittore nella pro-pria infanzia. Non si tratta qui di ritrovare un’imma-gine, un istante già vissuto e sepolto chissà dove, diquesto si occupa la memoria volontaria che, comel’intelligenza dello stesso genere, si limita a “ripro-durre” ma non apporta nulla di nuovo, non scuotel’essere nel suo profondo. Ciò che vi è di sconvolgen-te nelle esperienze della memoria involontaria è cheesse ci consegnano il passato con una forza mai cono-sciuta, e che può essere tale proprio perché appartie-ne a qualcosa che mai è stato vissuto6 e per questocapace di scivolare nel nostro essere senza che lacoscienza abbia ancora saputo sviluppare le propriedifese. È questo ad attribuire tanta importanzaall’oblio nella memoria proustiana: l’oblio non è sem-plicemente la forza che occulta qualcosa che fu pre-sente e in seguito dimenticato, ma la dimensionenascosta e non vissuta che accompagna ogni evento egli permette di divenire “passato”. La questione dellamemoria e del passato divengono necessariamenteaporetiche se pensate secondo una logica della pre-senza: come pensare infatti questo “passaggio”, comepuò una pura presenza “passare” ed essere richiama-ta alla memoria in quanto passato? È da qui che lamemoria proustiana riceve tutta la sua forza – di chocestetico ma anche teoretico: essa si riferisce a un pas-sato che non fu mai presente, a un istante che non fupropriamente mai vissuto.
Viene dunque esplicitamente meno, nella memoriainvolontaria, ogni carattere meramente riproduttivo.Ecco perché Proust stesso, proprio nel celeberrimopasso della madeleine, a seguito delle peripezie dellamemoria involontaria, scrive:
Depongo la tazza e mi rivolgo verso il mio spi-rito. Trovare la verità è compito suo. Ma in chemodo? […] Cercare? Di più: creare7.
La memoria involontaria dunque non trova nulla digià esistente: essa crea. Ecco perché Deleuze parladella Combray in sé come mitica8, ovvero appartenen-te a “un passato che non fu mai presente”9. Non deveallora sorprendere che Proust fosse il primo ad espri-mere perplessità sul titolo scelto per la propria opera.In una lettera del 1919, lo scrittore infatti confessa:“Quest’opera (il cui titolo scelto male trae un poco ininganno)…”10.
La lettera di Proust che abbiamo citato come esergova d’altronde nello stesso senso: “Se cercassi sempli-
cemente di ricordarmi e di far sì che questi ricordidiventino dei doppi dei giorni vissuti, non mi affati-cherei, malato come sono, per scrivere”. Viene alloraqui in luce il nodo che stringe insieme la questionedella mimesis e quella della memoria, che sin dall’ori-gine greca condividono la stessa radice: per Proustripensare il problema della memoria significa allostesso tempo sottrarre la scrittura a una pratica banal-mente mimetica di ripetizione e riproduzione dieventi passati. Come precisa bene anche Miguel deBeistegui, nel suo libro su Proust, “il ricordo involon-tario è esattamente la via d’uscita a questa concezio-ne mimetica dell’arte; rompendo con la memoriacome rappresentazione, Proust rompe anche con l’ar-te intesa come simulacro”11.
L’involontario si pone allora come centro generato-re di un pensiero in grado di mettere in crisi e dimostrare allo stesso tempo un’alternativa a quellodella filosofia “tradizionale”, tanto di stampo ideali-sta quanto razionalista. Attraverso il primato dell’in-volontario Proust muove infatti una critica radicaletanto a una concezione oggettivista della conoscenza,basata su entità esterne preesistenti cui il pensierodovrebbe semplicemente tendere, quanto a una con-cezione soggettivista e romantica della memoria, percui attraverso un’intuizione introspettiva il soggettopuò accedere integralmente al proprio passato.
È d’altronde sottolineando l’importanza dellamemoria involontaria all’interno della propria operache Proust prende le distanze anche da quel filosofocui già allora la sua opera veniva tanto insistente-mente associata:
Non provo alcuna vergogna a definire [i mieilibri] “romanzi bergsoniani” […]. Ma ciò nonsarebbe esatto perché la mia opera è dominatadalla distinzione tra la memoria involontaria ela memoria volontaria, distinzione che nonsolo non compare nella filosofia di Bergson,ma anzi viene da questa contraddetta12.
Tuttavia la distinzione tra mémoire invlontaire emémoire spontanée è solo la cifra più evidente di unapiù vasta e generale frattura che si viene a creare tradue orizzonti ontologici. Cerchiamo allora di tracciar-ne i caratteri salienti e di mostrare per quali motivi,secondo noi, l’opera di Proust anticipa per molti versialcune considerazioni sulla memoria della produzio-ne filosofica francese più recente.
2. Ipermnesia e altre dimenticanzeThe man with a good memory does not remember any-
thing because he does not forget anything.Samuel Beckett, Proust
6 A proposito della “logique de l’invécu” su cui cresce la Recherche si veda il bel libro di M. de Beistegui, Jouissance de Proust. Pourune esthétique de la métaphore, Encre marine, Fougères 2007, in part. pp. 78-128.7 M. Proust, Dalla parte di Swann, p. 56. 8 G. Deleuze, Différence et répétition, Presses Universitaires de France, Paris 1968, tr. it di G. Guglielmi, Differenza e ripetizione,Raffaello Cortina Editore, Milano 1997, p. 118.9 Ibidem, p. 114; per una bella analisi di questo passo proustiano e delle sue implicazioni filosofiche cfr. anche M. Carbone, Unadeformazione senza precedenti. Marcel Proust e le idee sensibili, Quodlibet, Macerata 2004, pp. 7-22. 10 M. Proust, Correspondance de Marcel Proust, 1919, t. XVIII, Plon, Paris 1990, p. 536.11 M. de Beistegui, Jouissance de Proust, p. 78. 12 Intervista di Marcel Proust al giornale Le Temps, 1912.
mEmoria dEl non viSSuto
Chora N. 16, Settembre 2008
46
Il titolo À la Recherche du temps perdu sembrò dun-que mal scelto e fuorviante allo stesso Proust, inquanto ogni volontà di ricerca è per questi destinata afallire e ciò che si crede ritrovare è semplicemente ciòche non è mai stato vissuto; tuttavia lo stesso titolopotrebbe ancora designare l’operazione tentata daHenri Bergson. Quest’ultimo infatti avverte a piùriprese la necessità di trattare il problema dell’apper-cezione ipermnesica, fenomeno che sembra fornire alfilosofo la prova inconfutabile che nessun ricordo èdefinitivamente sepolto nell’oblio e avvalorare l’ipo-tesi di una memoria totale, in grado di conservareintatti tutti gli avvenimenti passati, di restituirci inte-gralmente il tempo perduto. L’appercezione ipermnesi-ca è infatti quel fenomeno per il quale, trovandosi inpericolo di morte, l’individuo vede dispiegarsi,simultaneamente o successivamente, tutti gli avveni-menti della propria vita13. Ecco come Bergson descri-ve questo fenomeno e quale spiegazione ne offre:
Ma se il nostro passato ci resta quasi tuttonascosto perché è inibito dalle necessità dell’azio-ne presente, esso ritroverà la forza di superare lasoglia della coscienza in tutti quei casi in cui cidisinteresseremo dell’azione efficace per ricollo-carci, in qualche modo, nella vita del sogno. […]non c’è niente di più istruttivo, a questo proposi-to, di ciò che si produce in certi casi di soffoca-mento brusco, negli annegati e negli impiccati. Ilsoggetto, ritornato in sé, dichiara di essersi vistosfilare davanti, in poco tempo, tutti gli avveni-menti dimenticati della sua storia, con le loro piùinfime circostanze e nell’ordine stesso in cui sierano prodotti14.
L’articolazione secondo cui Bergson legge questofenomeno tradisce in filigrana una concezione deltempo e della memoria ancora in larga parte debitoridi una tradizione filosofica vetusta e per certi aspettiin contraddizione con alcune delle tesi più originalidello stesso Bergson. Innanzitutto notiamo come,benché si parli di casi di annegamento o di soffoca-mento, l’accento non sia messo sullo choc esternoquanto su un ripiegamento interiore, un ritorno allapura vita contemplativa, reso possibile proprio dalcompleto disinteressamento all’azione presente. È quichiara, nel filosofo francese, la volontà di marcare laseparazione e la distanza fra le diverse dimensionitemporali che possono darsi solo in alternativa: esse-re collocati nel presente e volti al futuro significanecessariamente distogliersi dal passato e dall’inte-riorità, unica via d’accesso a quest’ultimo. Tutto ilpassato va dunque incontro a chi, avendo rinunciatoad agire, rinuncia anche al fatto che il passato abiti,sconfini, nel presente. Il tempo ritrovato in Bergson èdunque effetto di un distacco, di una rinuncia, diver-gendo anche per questo, come vedremo, dalla conce-zione proustiana.
Per Bergson, inoltre, gli avvenimenti passati sonocontemplati retrospettivamente “nello stesso ordinein cui si erano prodotti”. In questa pretesa visionepanoramica sugli istanti passati, il filosofo sembraperò trovare la pietra d’inciampo della sua stessafilosofia. La mémoire spontanée, memoria puramentecontemplativa finalmente libera dai vincoli che laimpegnano nelll’azione, non conosce zone di ombrao di vuoto. Essa registrerebbe sotto forma di imma-gini-ricordi “tutti i nostri stati via via e man manoche si producono, lasciando a ogni fatto il suo postoe […] la sua data”15. Quest’ultima affermazionemostra come Bergson non sia riuscito ad evitare, asua volta, una sorta di reificazione degli istanti tem-porali, in particolare nel momento memoriale.
Credere alla possibilità di una redenzione inte-grale del passato significa inoltre considerare lacoscienza quale visione di sorvolo sotto cui iltempo interamente si dispiega. Questa concezionediviene rapidamente aporetica poiché, come notabene Enrica Lisciani-Petrini, “in virtù di quellaspecie di ‘occhio panoramico’ di cui sarebbe dota-ta la coscienza […], la realtà viene ridotta a uneterno Presente già tutto e da sempre dispiegato”;ma paradossalmente ciò che ne esce sminuito è ilsenso stesso della memoria, “dato che per quellosguardo costantemente rivolto all’enorme distesadell’eterno presente […] non c’è passato e quindinon c’è memoria”16.
Marcel Proust
13 Per un’analisi particolarmente accurata dell’ipermnesia: G. Poulet, L’espace proustien, Gallimard, Paris 1963, tr. it. di G.M.Posani, Lo spazio di Proust, Guida, Napoli 1972, pp. 107-125.14 H. Bergson, Matière et mémoire, Presses Universitaires de France, Paris 1959, tr. it. di A. Pessina, Materia e Memoria, Laterza, Bari1996, pp. 130-131.15 Ibidem, p. 128, corsivo nostro.16 E. Lisciani-Petrini, “Rileggendo Proust, Bergson, Merleau-Ponty”, in Il Pensiero, Edizioni Scientifiche italiane, 1999/2, pp. 47-67.
47Sara guidani
Chora N. 16, Settembre 2008
Nel testo della conferenza sulla Perception duchangement, del 1911, la mancanza di specificitàdella modalità d’esistenza del passato divieneancora più esplicita:
Un’attenzione alla vita che fosse sufficiente-mente potente, e sufficientemente liberata da ogniinteresse pratico abbraccerebbe… in un presenteindiviso la storia passata tutta intera della personacosciente […] come del continuamente presente17.
In questo testo stupisce l’insistenza sull’attualizzazio-ne del passato, il cui statuto ontologico sembra distin-guersi a fatica dalla percezione presente. A questa para-dossale difficoltà del bergsonismo non rimarrannoinsensibili alcuni dei maggiori filosofi francesi delsecondo dopoguerra. Merleau-Ponty si mostra partico-larmente attento e critico rispetto all’incapacità bergso-niana di uscire dall’impasse rispetto alla questione dellamemoria: “Una percezione conservata è una percezio-ne, continua ad esistere, non lascia dietro di noi quelladimensione di fuga e di assenza che è il passato”, scri-ve ne Il visibile e l’invisibile; e, rendendo ancora piùesplicito il proprio bersaglio critico, continua: “insuffi-cienza della rappresentazione bergsoniana di un’animache conserva tutto (questo rende impossibile la diffe-renza tra percepito-immaginario)”18.
Ciò che si trova a monte di questa serie di aporie inBergson è la volontà di marcare e ribadire una frattu-ra netta tra “passato puro” e presente; questa separa-zione insanabile rende di conseguenza difficile ognicomunicazione e passaggio tra le due dimensionitemporali, il cui innegabile e costante reciproco scon-finare non può essere spiegato che appiattendo unadimensione sull’altra (appunto il passato ridotto adeterno presente). È quanto ci sembrano confermareanche alcune pagine di Materia e memoria: “Non appe-na diventa immagine, il passato lascia lo stato di puroricordo e si confonde con una certa parte del mio pre-sente. L’immagine è uno stato presente e non puòessere partecipe del passato”19.
E tuttavia non potremmo negare che ricordarsi è sem-pre, anche, una questione d’immagine. Merleau-Pontylo scrive chiaramente nella stessa nota di lavoro de Ilvisibile e l’invisibile considerata sopra: non si compren-derà il ricordo se non attraverso la visione20.Accogliamo dunque il suggerimento di Merleau-Pontye cerchiamo di considerare come la riformulazione delproblema della memoria e della sopravvivenza del pas-sato sottenda un nuovo rapporto al visibile e una ride-finizione di ciò che chiamiamo visione. Vediamo dun-que come Proust riprenda e rielabori originalmente ilmito millenario della “visione panoramica” degli anni ein cosa questa formulazione scuota l’ontologia vetustache abbiamo visto ancora sopravvivere, per certi versi,nell’opera dello stesso Bergson.
3. La visione ottica degli anni in Proust
Étrange sectionnement du temps où seuls de raresjours notables apparaissent.
Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve
Anche in Proust il Tempo infine ritrovato sembraoffrirsi in termini eminentemente ottici. Tuttavia,numerosi sono gli aspetti che lo allontanano dallavisione bergsoniana degli anni e dalle formulazioniprecedenti. Vediamo allora concretamente qual èl’articolazione data da Proust alla resurrezione“ottica” del passato.
Benché quello della visione sia un tema che perva-da l’intera Recherche, è alla fine dell’opera, nelle ulti-me centocinquanta pagine del Tempo ritrovato, cheProust moltiplica insistentemente le allusioni al vede-re e al mondo dell’ottica intrecciandole esplicitamen-te alle riflessioni sul tempo e sulla memoria. Come ènoto, la scena finale della Recherche, il celebre Bal detêtes, ha luogo dopo una lunga assenza del protagoni-sta da Parigi. In occasione di una matinée dal principedi Guermantes, l’eroe si ritrova dunque al cospetto dipressoché tutti i personaggi frequentati in gioventù.La scena assume rapidamente caratteri grotteschi, inuovi volti non si lasciano sovrapporre a quelli fami-liari fissati nella memoria, come se ogni invitato aves-se voluto indossare una maschera. Per esprimere ladifficoltà nel riconoscere gli invitati, Proust fa ricorsoall’immagine fotografica:
Confrontando queste immagini con quelleche avevo sotto gli occhi della memoria, quelleche mi venivano mostrate per ultime mi piace-vano di meno. Come, tante volte, troviamomeno buona e scartiamo una delle fotografiefra le quali un amico ci ha pregati di scegliere,così davanti a ogni persona e all’immagine chemi mostrava di sé avrei voluto dire: “No, nonquesta, non siete venuto bene, non sembrateneanche voi”21.
La fotografia sembra offrirci qui una sempliceimmagine istantanea, e per questo impedire l’atto diriconoscimento che, al contrario, sottende almeno lasovrapposizione di due immagini e dunque unavisione che si muove nel tempo. La fotografia consi-derata come “scatto” fotografico, immagine “fatta”è qui associata a una memoria volontaria, eserciziodel ricordo che non conduce a nulla di essenziale,che scortica e ricostruisce artificialmente la realtà eche in fondo può solo allontanarci dalla verità pro-fonda dei nostri cari.
Tuttavia, dopo un primo scacco, i personaggi sonoriconosciuti, in maniera lenta e progressiva; ma ciòè reso possibile grazie a uno sdoppiamento dellavisione che Proust descrive in questi termini:
17 H. Bergson, La perception du changement, a cura di J. Ricot, PUF, Paris 1998, corsivo nostro.18 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964, tr. it. di A. Bonomi, riv. da M. Carbone, Il visibile e l’invisibile,Bompiani, Milano 1993, p. 210.. 19 H. Bergson, Materia e memoria, tr. it. cit., p. 119.20 M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, tr. it. cit., p. 210. 21 Il Tempo ritrovato, p. 296.
mEmoria dEl non viSSuto
Chora N. 16, Settembre 2008
48
Burattini, ma che, per identificarli come le per-sone conosciute un tempo, era necessario legge-re contemporaneamente su più piani, posti die-tro di loro e tali da dar loro profondità e dacostringere, in presenza di quei vecchi fantocci,a un lavoro mentale, giacché bisognava guar-darli, oltre che con gli occhi, con la memoria22.
In queste ultime pagine assistiamo dunque a unbrusco cambiamento di atmosfera: l’insistenza sutermini come “burattini” e “fantocci” ci rinvia altema della maschera e del grottesco.
Eppure questa mascherata mostruosa e grottescasembra rendere visibile all’eroe l’immagine del pro-prio passato, evocando termini non dissimili, inapparenza, dal topos della visione panoramica deglianni recuperato da Bergson. Questa visione assumeperò in Proust tratti ben particolari:
Un ricevimento come quello a cui mi trovavo eraqualcosa di molto più prezioso di un’immagine delpassato; mi offriva, per così dire, tutte le immaginisuccessive, e che non avevo mai viste, che separa-vano il passato dal presente, meglio ancora: il rap-porto fra presente e passato; era come ciò che unavolta si chiamava una veduta ottica, ma una vedu-ta ottica degli anni, la veduta non d’un momento,ma d’una persona situata nella prospettiva defor-mante del Tempo23.
Questa visione degli anni passati presenta dunquecaratteri ben particolari: se inizialmente potremmocredere a una reviviscenza panottica (“tutte leimmagini successive”), quest’idea s’infrange prestocontro l’evidenza che si tratta di “immagini maiviste”. La veduta ottica prende infatti forma attra-verso il vuoto e la distanza tra due immagini, attra-verso questo particolare entre-deux che si crea trapassato e presente e che invece di separare unisce.Appare dunque chiaro come la visione proustianadegli anni diverga radicalmente da quella diBergson: nel momento della sua resurrezione, ilpassato apre lo spazio per l’esperienza dell’oblio edella morte. Attraverso la resurrezione di un fram-mento di passato nell’istante presente (si noti, di unframmento, mai di una totalità) è la distanza incol-mabile che separa questi due momenti a farsi senti-re, non la piena distesa degli anni passati. In Proust,a risalire la china degli anni sono solo “pochi giornisignificativi” e soprattutto, come scrive WalterBenjamin in Angelus Novus, “non sono contrasse-gnati da nessuna esperienza vissuta”24. I giornidella Recherche, al contrario di quelli di Materia ememoria, non conoscono “data” e “posto”, tanto che“taluni episodi sembrano insieme vissuti in età
diversissime, vissuti e rivissuti nella simultaneitàintermittente di tutta una vita, non come purimomenti, ma nella mobile intensità del tempo sferi-co”25. Potremmo attribuire all’opera proustianaquello che lo stesso Proust scriveva a propositodella poesia di Baudelaire: “Il tempo è scisso inmaniera sconcertante; si dischiudono solo pochigiorni, e sono significativi”26.
Questo carattere frammentario, “rapsodico” dellamemoria, è affermato d’altronde con altrettanta chia-rezza già all’inizio della Recherche, e anche qui secon-do una formulazione che presenta sorprendenti ana-logie – ma anche decisive differenze – con un branodi Materia e memoria. Ricordiamo infatti comeBergson pensasse che il nostro passato ci fosse inlinea di principio integralmente accessibile una voltache ci si fosse disinteressati all’azione presente. Ilsognatore quindi, in quanto impedito nella propriapratica sensorio-motrice, è la figura che, dopo ilmoribondo, più si approssima alla “visione panora-mica” degli anni formulata da Bergson: “Un essereumano che sognasse la propria esistenza al posto diviverla senza dubbio terrebbe così sotto il suo sguar-do, in ogni momento, l’infinita moltitudine dei detta-gli della propria esistenza passata”27.
Come sappiamo, anche Proust dedicò particolareattenzione al tema del sonno. All’inizio di Dallaparte di Swann, nelle celeberrime pagine dedicate aldormiveglia, Proust infatti scrive: “Un uomo chedorme tiene in cerchio intorno a sé il filo delle ore,l’ordine degli anni e dei mondi”, sembrando cosìconsuonare con quanto scriveva Bergson. Tuttavia,poco più sotto, precisa: “ma i loro ranghi possonospezzarsi, confondersi”28, contestando così qualsia-si possibilità di ridurre la memoria a una cronologia
Madeleines
22 Ibidem, p. 284. 23 Ibidem, p. 285. 24 W. Benjamin, Über einige Motive bei Baudelaire, in “Zeitschrift für Sozialforschung”, 1940, tr. it. di R. Solmi, Di alcuni motivi inBaudelaire, in Angelus Novus, Einaudi, Torino 1962, 1981, pp. 89-130, p. 117.25 M. Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, Paris 1959, tr. it. di G. Ceronetti e G. D. Neri, Il libro a venire, Einaudi, Torino 1969, p. 32.26 M. Proust, À propos de Baudelaire, contenuto in Contre Saint-Beuve précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, acura di P. Clarac e Y. Sandre, Éditions Gallimard, Paris 1971, ed. it. a cura di M. Bongiovanni Bertini, Scritti mondani e letterari,Einaudi, Torino 1984.27 H. Bergson, Materia e memoria, tr. it. cit., p. 131.28 Dalla parte di Swann, p. 7.
49Sara guidani
Chora N. 16, Settembre 2008
e a una piena visibilità. L’atto rammemorativo d’altron-de in Proust sembra discostarsi da una logica mera-mente intellettuale e coscienzialistica. Qualche rigadopo infatti viene scritto: “E prima ancora che il miopensiero, esitante sulla soglia dei tempi e delle forme,identificasse la casa mettendo l’una accanto all’altra lecircostanze, lui – il mio corpo – ricordava”29. Proustparla di una memoria “delle costole, dei ginocchi, dellespalle”, capace di orientare la visione del ricordo, di farrisorgere mano a mano spazi e tempi diversi, ribaden-do perciò il ruolo attivo del corpo nella memoria esmentendo l’idea bergsoniana che vorrebbe il corpoprigioniero del solo presente. Se è attraverso il nostrocorpo che ci è dato accedere al passato, e non distoglier-cene, è perché il nostro corpo intrattiene con il mondosensibile una relazione non posta da un atto di coscien-za ma attiva a livello non-tematico30. Come il sintomoin Freud è al contempo espressione e travestimento delrimosso grazie un’esperienza che si sottrae alla coscien-za, allo stesso modo il nostro corpo è contemporanea-mente custode immemore del nostro passato e accessoprivilegiato ad esso. Ecco perché nel sonno ci sembra dipoterci riappropriare fuggevolmente dei tempi e deglispazi vissuti: durante il sonno il corpo è lontano daquel mondo della veglia “in cui lavora l’intelligenza ec’è solo l’essere”31. L’esperienza autentica del ricordo èinvece, secondo l’espressione di Proust, “sintesi dellasopravvivenza e del nulla”, essa lascia dietro di noi lascia del dolore. L’intelligenza tende a “travestire”, adimenticare ciò che è doloroso. Ma proprio per il fattodi essere trattenuto nelle maglie misteriose dell’oblio,l’evento doloroso conserva intatta la sua forza e, unavolta risorto, rende possibile l’esperienza autenticadella memoria. È quindi secondo questa logica che dob-biamo leggere le parole di Merleau-Ponty, ispirate alcelebre passo proustiano delle intermittences du coeur:“il vero ricordo è solo dolore che abbiamo inflitto all’al-tro e dunque a noi stessi, ed è nel ricordo e in questecrudeltà che si perpetua veramente la doppia scia dellamorte scavata in noi come dalla folgore”32.
La memoria proustiana dunque, come aveva giànotato Walter Benjamin nel suo saggio su Proust33,pare inclinare più dalla parte dell’oblio che da quelladel ricordo, se quest’ultimo è ancora inteso come attivi-tà volontaria. È quanto viene sottolineato anche daMerleau-Ponty in quegli stessi appunti per il corsosulla passività già citati: “L’oblio: il ricordo è salvaguar-dato proprio perché è inabbordabile. Cfr. Freud: fino ache punto è falso credere che la sopravvivenza delricordo sia ‘conservazione’. Il passato esiste nellamodalità dell’oblio”34. Ma l’oblio, come abbiamo giàanticipato, proprio per il suo essere inestricabilmenteintrecciato alla memoria, necessita a sua volta una
nuova formulazione. Ne Il visibile e l’invisibile Merleau-Ponty dà grande rilievo alla riformulazione della que-stione dell’oblio: “L’oblio è discontinuo. Si deve conce-pirlo non come occultamento (Bergson), non come pas-saggio al nulla, nullificazione – e non come funzionepositiva che involge conoscenza di ciò che occulta(Freud – Sartre), ma come maniera di inerire a… disto-gliendosi da…”35. In questo senso l’oblio sembra quin-di configurarsi non come un presente sprofondato inseguito nel buio della coscienza ma come la dimensio-ne d’ombra, di passività o di non vissuto che si accom-pagna sempre e necessariamente ad ogni presente, con-ferendo a esso spessore e permettendogli di dimensio-nalizzarsi nel tempo (e dunque di “passare”).
È precisamente nella sua particolarità di passato chenon è mai stato vissuto o, se vogliamo raccogliere lametafora della veduta ottica utilizzata da Proust e chesottolinea ancora una volta la parentela tra memoria evisione, di immagine che non è mai stata vista, che lamemoria proustiana viene raccolta da Deleuze per illu-minare e sostenere la propria concezione di “passatopuro”. Combray, per riprendere l’episodio più cono-sciuto della Recherche, quello della madeleine, non risor-ge come fu ma come un passato che Deleuze, comeabbiamo visto, riprendendo l’espressione di Bergsondefinisce “puro” perché irriducibile tanto al presenteche è stato quanto al presente attuale (in cui risorge).Combray non risorge come rappresentazione (cosa checonferirebbe al ricordo la sua data e il suo posto in unaserie causale di ricordi-rappresentazioni) ma come in-sédi Combray: “Gli antichi presenti si lasciano rappresen-tare nella sintesi attiva al di là dell’oblio […]. Ma qui,nell’Oblio, e come immemoriale, Combray sorge sottoforma di un passato che non fu mai presente, come l’in-sé di Combray”36. Attraverso l’esperienza della memo-ria involontaria ritroviamo l’in-sé di Combray, ci diceDeleuze, vale a dire la sua essenza. Appare allora quichiaramente il ruolo idealizzante della memoria prou-stiana. Idealizzante innanzitutto nel senso più comunedel termine: la Combray ritrovata grazie alla memoriainvolontaria è una Combray mai esperita, in uno statodi eccezionale splendore, e dunque per questo idealiz-zata. In secondo luogo, l’esperienza profonda dellamemoria proustiana è idealizzante perché essa ci offrel’essenza, l’idea, l’in-sé di Combray. La Combray ritro-vata grazie alla memoria involontaria non è infattiun’entità immobilizzata in un posto o ad una data macostituisce piuttosto la possibilità stessa di riconoscere,di ricordare, di ritrovare Combray grazie allo scarto,alla differenza tra il presente che fu e il presente attua-le. Ciò che appartiene più intimamente alla memoria èallora la sua possibilità di aprire al trascendentale, enon quella di recuperare una serie di dati preesistenti.
29 Ibidem, p. 9. 30 Per un’accurata analisi del brano proustiano e dell’interesse che questo ha costituito per la fenomenologia, rinvio a M.Carbone, Di alcuni motivi in Marcel Proust, Cortina, Milano 1998, pp. 24-36.31 M. Merleau-Ponty, L’Institution. La Passivité. Notes de cours au Collège de France (1954-1955), Belin, Paris 2003, p. 277.32 Ibidem. 33 W. Benjamin, Zum Bilde Prousts, “Literarische Welt”, 21 e 28 giugno, 5 luglio 1929, tr. it. di A. Marietti, Per un ritratto di Proust,in Avanguardia e rivoluzione, Einaudi, Torino 1973.34 M. Merleau-Ponty, L’institution. La passivité, cit., p. 272.35 M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, tr. it. cit., p. 212.36 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, tr. it. cit., p. 114.
Merleau-Ponty, nelle note sulla passività dedicate aProust, scriveva qualcosa che presenta numerose ana-logie con l’analisi deleuziana: “L’immanenza e la tra-scendenza del passato, l’attività e la passività dellamemoria possono essere riconciliate solo se rinunciamoa porre il problema in termini di rappresentazione”, e ilfilosofo continua, “la memoria non sarebbe allora ilcontrario dell’oblio, vedremmo che la vera memoria sitrova all’intersezione dei due”37.
Malgrado le divergenze note e più che evidenti traquesti due pensatori, Merleau-Ponty e Deleuze sembra-no tuttavia trovare una preoccupazione comune nel-l’approccio al problea della memoria. Entrambi infattiriprendono il problema a partire da Bergson (Merleau-Ponty prende l’avvio dal problema della “conservazio-ne del passato”, Deleuze da quello di “passato puro”,entrambe espressioni bergsoniane) ma soltanto persuperarlo, e in gran parte grazie al contributo dell’ope-ra di Proust. Per entrambi appare essenziale un tripliceordine di preoccupazioni: innanzitutto mostrare il lega-me tra memoria e oblio, riformulando al contempo idue termini di questo rapporto; in secondo luogo, neidue autori troviamo la volontà di non ridurre l’imma-gine propria al ricordo alla rappresentazione; quest’ul-tima infatti rinvia a una visibilità piena, di sorvolo,incapace di dare eco alle ombre e al sentimento di“mancanza” o di lutto che abbiamo visto distinguerel’esperienza della memoria38. Infine è essenzialemostrare come, a differenza di quanto portava a con-cludere Bergson, sia per noi possibile penetrare questo“passato puro” che, benché si sottragga al linguaggiodella rappresentazione, non le è completamente estra-neo: esso si pone piuttosto come il suo in-sé o la suaessenza.
Questo genere di preoccupazioni viene ribaditoanche negli appunti per l’ultimo corso che Merleau-Ponty terrà al Collège de France, dove ancora una voltail filosofo volge il proprio interesse al tema della memo-ria attraverso la lettura di Proust: “la realtà non siforma che nella memoria”, intendendo con questo chela realtà acquista la propria dimensione trascendentalesolo nella memoria; e continua: “attraverso la distanza,il presente «sviluppa» tutto il suo senso”, per conclude-re, non senza un’allusione critica a Bergson, “Il passatonon puro ricordo (immateriale) e nemmeno ricordoimmagine (conservato e ricreato nel presente), ma pas-sato-ombra, carne divenuta essenza”39.
Il trascendentale che Deleuze aveva definito in termi-
ni di “passato puro”, può dunque definirsi, secondo unvocabolario merleau-pontiano, come nota MauroCarbone, “l’invisibile di questo mondo”40. Ancora unavolta troviamo ribadito lo stretto nodo che pare avvol-gere inestricabilmente la questione della memoria aquella della visione e del trascendentale. Ecco perché,riprendendo le parole di Merleau-Ponty già citatesopra, “comprenderemo il ricordo – e il suo potere ditrasformare la carne in essenza – solo attraverso lavisione”.
È senz’altro in questo senso che dobbiamo intenderela volontà proustiana di concludere la propria operasecondo un’incalzante progressione di metafore otti-che: nelle ultime pagine della Recherche, Proust affondail modello rappresentativo che risultava ancora domi-nante tanto nell’approccio della memoria quanto inquello dell’arte. Liberando la memoria dal giogo delparadigma riproduttivo e rappresentativo, Proust trac-cia i lineamenti della propria poetica di scrittore e alcontempo quelli di una nuova teoria dell’immagine (lostile infatti, non lo si dimentichi, è sempre questione divisione41).
Attraverso l’opera di Proust ci viene allora offertauna doppia possibilità: non solo quella di una nuova“immagine del pensiero”, come notava a propositoDeleuze, ma anche, e allo stesso tempo, quella di unnuovo “pensiero dell’immagine”.
mEmoria dEl non viSSuto
Chora N. 16, Settembre 2008
50
37 M. Merleau-Ponty, L’institution. La passivité, cit., p. 270.38 A questo proposito, si veda L. Marin, Della rappresentazione, ed. it. a cura di L. Corrain, Meltemi, Roma 2001 (scelta di saggitratti dal volume De la représentation, Gallimard, Paris 1994): “Cos’è dunque rappresentare se non rendere presente un oggettoassente, renderlo presente in quanto assente, controllarne la perdita e la morte, con e nella rappresentazione, dominando il dispiace-re o l’angoscia provocati dalla sua assenza nel piacere di una presenza che lo sostituisce”, pp. 142-143.39 M. Merleau-Ponty, Notes de cours au Collège de France 1958-1959 et 1960-1961, “Préface” de C. Lefort, texte établi par S. Ménasé,Gallimard, Paris 1996, tr. it. di F. Paracchini e A. Pinotti, ed. it. a cura di M. Carbone, E’ possibile oggi la filosofia?, Cortina, Milano2003, p. 191. Cfr. anche M. Carbone Una deformazione senza precedenti, cit., in part. pp. 49-72.40 Cfr. M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, tr. it. cit., p. 166; M. Carbone, Una deformazione senza precedenti, p. 50. 41 M. Proust, Il Tempo ritrovato, p. 250.
sara guindani è dottore di ricerca in Filosofia. Ha svolto attività di ricerca post-dottorale presso il Collège de France di Parigi gra-zie a una Borsa di studio in discipline letterarie. Dal 2002 al 2007 ha collaborato con l’Università degli Studi di Milano per laCattedra di Estetica Contemporanea. Attualmente è responsabile di un seminario su Le Temps dans l’art all’Université Paris 8-SaintDenis. Le sue ricerche si sono occupate soprattutto dei rapporti tra letteratura, filosofia e psicanalisi. Tra le sue pubblicazioni: Lo ste-reoscopio di Proust. Fotografia, pittura e fantasmagoria nella Recherche, Mimesis, Milano 2005; “Je ne savais pas voir”. Image, temps etmémoire dans. À la recherche du temps perdu, La Transparence, Paris 2008.
51paolo roSSi
Chora N. 16, Settembre 2008
intervista a paolo rossi
1. MEMORIE DI UNO STORICO DELLA MEMORIA[Chora] Professor Rossi, avendo scelto di parlare
di memoria, non possiamo non cominciarechiedendoLe di raccontarci dei Suoi ricordi di stu-dioso e degli esordi delle Sue ricerche nell’ambitodella storia delle mnemotecniche. Com’è iniziato ilsuo interesse per le arti della memoria, e in che con-testo si collocava la pubblicazione del suo impor-tante saggio dedicato all’argomento, il tuttora fon-damentale Clavis Universalis? Sembra che nelperiodo degli anni ‘50-‘60 vi sia stato un forte inte-resse nei confronti della memoria e degli artificifinalizzati al suop o t e n z i a m e n t o :potrebbe parlarci delclima di quegli anni?Infine, quali motivifilosofici hannosegnato il suo percor-so personale e profes-sionale, orientandoloverso lo studio dellastoria delle idee?
[Paolo Rossi] Perrispondere a questadomanda devo parti-re da un dato storico;Francis Bacon avevateorizzato, nel NovumOrganum, l’idea che sidovessero costruiredegli aiuti per i sensi,per la memoria e perl’intelletto. I primi, gliaiuti per i sensi, eranostrumenti tecnici tipoil cannocchiale e ilmicroscopio, alcunianche solo immagina-ti e mai realizzati, gliaiuti per la memoriaerano proprio le artidella memoria mentrequelli per l’intellettosi condensavano nelnuovo metodo.
Ho comincito l’analisi del pensiero baconiano nellibro Francesco Bacone: dalla magia alla scienza, uscitopresso Laterza nel 1957. Quel testo si occupava, perla prima volta, di temi che esulavano dalle classicheanalisi sugli idola e sull’induzione, ponendosi su diun piano di rottura nei confronti della tradizionale
letteratura della riflessione baconiana. I suoi puntidi forza, gli elementi centrali, erano infatti rappre-sentati dalle indagini dei rapporti che intercorreva-no tra il pensatore inglese e la magia, il pensieroermetico e le tecniche.
Dai risultati raggiunti in questo primo libro, trassispunto per altri due lavori; il primo fu I filosofi e lemacchine, che costituiva un approfondimento deicapitoli che avevo dedicato al rapporto tra Bacone ei tecnici del suo tempo. Devo chiarire che, quandoparlo di tecnici del suo tempo, mi riferisco agli inge-gnieri minerari che operavano al di fuori dell’am-
biente accademico,progettando macchinenelle miniere e nellefonderie, e i cui lavoriBacone lesse e studiò.Si trattava di un cetoin grande ascesa cheaveva cominciato asvilupparsi già allafine del 500, anchesulla scia dell’opera diLeonardo da Vinci.Ebbene, proprio que-sto testo, è stato il piùfortunato.
Il secondo lavoro acui facevo riferimento,ha la propria generidagli studi sulle artidella memoria, neiquali mi muovevomosso dalla necessitàdi cercare cosa inten-desse Bacone quandoparlava di aiuti per lamemoria. Mi accorsi,lungo questo percorso,che egli considerava lamemoria, da un lato,come una parte dellaretorica e, dall’altro,con mia grande sor-presa, in relazione allearti magiche. Questascoperta diede grande
impulso alle mie analisi; cominciai a indagare unaenorme quantità di testi, partendo da quelli raccoltinel Fondo magico della biblioteca … di Milano e daquelli dell’Istituto Warburg. Fondamentale è stato,in proposito, il soggiorno a Londra. Comunque, stu-diai una così grande quantità di materiale da pensa-
storia delle ideee arti della MeMoria
università degli studi di Firenzea cura di MassiMiliano cappuccio e andrea tortoreto
Paolo Rossi
Storia dEllE idEE E arti dElla mEmoria
Chora N. 16, Settembre 2008
52
re che, un tema con implicazioni così interessanti,non poteva restare confinato in un semplice capitolodel testo su Bacone, ma meritasse di essere appro-fondito in modo autonomo. Si spiega così il testoClavis Universalis: arti della memoria e logica combina-toria da Lullo a Leibniz. Nel percorso che condusse aquesto risultato, la prima persona che incontrai fu lasignora Frances Yates che, proprio all’istitutoWarburg, mi accolse benissimo, quasi come un nipo-te, perché ero allievo di Garin. Venni così a contattocon i suoi studi, in particolare con un suo lavoro suCicerone e le arti della memoria, un articolo pubbli-cato in lingua inglese che vide la luce molto primadel suo noto studio The art of memory il quale, tra lealtre cose, è stato pubblicato circa dieci anni dopo ilmio.
Mi piace ricorda-re, in proposito, chequando le portai lebozze della ClavisUniversalis, eromolto timoroso;temevo la reazionedella nota studiosache, vedendo ungiovinastro pubbli-care un lavoro suun tema che lei stu-dia da anni, lorespinge facendosibeffe di lui. Invecel’accoglienza fumeravigliosa, laricordo ancora conemozione ed èanche per questoche le dedicai illibro; fu davverocontentissima dellamia opera, tanto
più che il lavoro che pubblicherà poi lei, e nel qualemi citerà abbondantemente, sarà molto diverso e,onestamente, molto più bello e fortunato.
Dopodiché, la discussione sulla memoria, sia dal-l’ottica biologica e neurologica, sia soprattutto da unpunto di vista generale, diciamo gonfiato, è di moltoposteriore, direi prende le mosse negli anni ’70quando trae forza dalle analisi sulla Shoa e sullosterminio degli ebrei. Negli anni ’50, quindi, non erapresente con la forza che avrà successivamente.
E per quanto riguarda la storia delle idee?
Io considero già la Clavis Universalis un libro distoria delle idee. Ricordo che, in quel periodo, parte-cipai al primo convegno della Società Internazionaledi Storia delle Idee che si tenne a Cambridge. È dav-vero un bel ricordo, parteciparono Lowith, Koyré,Noland, Wiener, e molti altri.
2. CONTINUISMO E AMNESIA STORICANella “Prefazione” della Clavis Universalis, e
poi di nuovo in Il passato, la memoria, l’oblio, Leidenuncia il banale continuismo e la mancanza diprofondità storica che va affermandosi tra gliodierni studiosi. In particolare, nel contesto spe-cialistico delle scienze esatte, “il passato servesolo a trovare conferme alla verità del presente, siconfigura come una riserva entro la quale è oltre-modo facile la caccia agli ‘esempi’”. Pare quasi che
gli scienziati ritengano essere spuntato dal nulla –oppure sempre esistito – lo specifico orizzonte disenso entro il quale si articola la loro scienza. Checosa ci insegna, da questo punto di vista, lo studiodella mnemotecnica – una disciplina che è assai piùantica della rivoluzione scientifica, e che in qual-che misura ha accompagnato l’avvento di quest’ul-tima? Che funzione pedagogica positiva può assu-mere un sapere che si proponga di conservare ilricordo di tutti gli altri saperi?
C’è qui da considerare il tema dell’amnesia storica.Ci sono scienze che esistono da sempre, come lamatematica e la geometria, e scienze che sono stateinventate recentemente, quali la chimica e la minera-logia. Il professore di geologia, ad esempio, fa ingenere una sorta di introduzione nella quale, muo-vendo da Aristotele, immagina che la sua scienza cisia sempre stata. È però questa una continuità imma-ginaria; la geologia è una scienza nata nel ‘700. Siproietta all’indietro, magari utilizzando dei nomiimmaginari, una scienza specifica considerandolacome sempre esistita.
Per quanto riguarda la memoria, come tecnicaessa è certamente sparita, non esiste più una tecni-ca per ricordare o, per meglio dire, non c’è più alivello di indagine culturale elevata, ma soltantocome pratica nelle scuole di pubblicità o in certescuole di polizia. Questo anche perché, nel mondocontemporaneo, numerosi strumenti la sostituisco-no. Se si torna indietro nel tempo, nell’universodella cultura orale o a prevalenza orale, chi ascol-tava qualcuno parlare doveva restare concentratis-simo perché non possedeva la carta su cui scrivere,i registratori, e molto probabilmente nemmeno unlibro dove andare a recuperare alcune delle nozio-ni affrontate. Ecco allora che, in suo soccorso, pote-vano andare soltanto delle mnemotecniche. Primadella stampa la memoria possiede una funzioneenormemente più grande perché non si può scrive-re, non si possono prendere appunti, scrivere com-porta un dispendio enorme, degli strumenti costo-sissimi. I manoscritti, le miniature in oro sonooggetti di lusso, veri e propri tesori che nei con-venti sono custoditi sotto chiave insieme ai calicid’oro della messa. La diffusione del libro, la massi-ficazione della carta stampata costituisce, proprioper questo, una rivoluzione senza precedenti.
Labirinto inciso nel Campanile del Duomo di Lucca
53paolo roSSi
Chora N. 16, Settembre 2008
In definitiva, rispondere alla domanda riguardola presenza di un elemento antimnemonico nellescienze, non è semplicissimo; se ci si riferisce allaconservazione delle conoscenze del passato, sonodaccordo con Khun, allo scienziato poco importadel modo in cui, in epoche passate, venivano con-siderati i problemi che sono oggetto dei suoi studi.Un fisico, in sostanza, non legge Newton oKeplero. La storia della scienza può contribuire auna maggiore consapevolezza da parte degli scien-ziati, alla strutturazione di un sapere che abbiamemoria di se stesso, ma non può essere fatta dagliscienziati in quanto tali. Per comprendere quelloche si diceva in passato bisogna, in alcune circosta-ne, dimenticare ciò che si sa.
3. LA MEMORIA AL BIVIO, TRA SCIENZA E MAgIALe arti della memoria hanno goduto di notevole
vitalità durante il Rinascimento, ossia nel periodoin cui è venuta maturando la biforcazione – e poi lanetta opposizione - di scienza e magia, le quali pro-vengono dalla comune radice della filosofia natura-le. Da questa duplicità di piani e di esperienze deri-va forse la sostanziale ambiguità delle arti dellamemoria e la difficoltà nel definire il loro statutocome forma di sapere: le arti della memoria rappre-sentano il vizio metafisico della retorica umanisti-ca, ammalata di credulità mistica e di esoterismo,oppure hanno offerto davvero degli strumenti razio-nali alla nascita e allo sviluppo della metodologiascientifica? Vorremmo chiederLe di parlarci dell’in-treccio di questo duplice cammino, ad un temporetorico-metafisco e logico-naturalistico, tracciatodalla storia delle mnemotecniche.
Questa terza domanda pone un problema vero.Nell’arte della memoria accade una cosa strana che,generalmente, nella cultura non accade. C’è una tra-dizione, quella ciceroniana, per certi versi banale; èla tradizione dei luoghi e delle immagini, pura pras-si tecnica, semplice aiuto per ricordare. E c’è poi latradizione del lullismo che ha la pretesa di costruireun quadro del mondo, una macchina della verità;una tradizione completamente differente dallaprima che però, per via di quelle stranezze checostellano la storia delle idee, finisce per sposarsicon essa. Da questo matrimonio, nel ‘500, scaturisceun elemento esplosivo grazie al quale una tecnicaneutra, utile a chi deve fare un’orazione in tribuna-
le, si tramuta in un’avventura mistico-metafisica diportata universale, per cui si pensa che ci sia unastruttura del mondo individuabile e una grammati-ca di questa stessa struttura. In altri termini, possia-mo senza dubbio dire che tra un trattato ciceronianosulla memoria e la characteristica universalis diLeibniz è enorme ma, senza l’incontro appenadescritto, la stessa opera di Leibniz sarebbe impen-sabile. Quest’ultimo parla di “cabala innocente”,“magia non chimerica”, alludendo al sogno, alla pre-tesa, che si manifesta sullo sfondo della characteristi-ca, di aver individuato l’alfabeto del mondo.
Dalla commistione tra lullismo e arte dellamemoria vengono fuori le teorie della lingua per-fetta o, in altri termini, di una lingua che dice, sullascia della cabala, come si chiamano effettivamentele cose, non come noi le indichiamo convenzional-mente; la lingua che parlava Dio quando indicavaad Adamo il nome delle cose, la lingua della coinci-denza tra termine e cosa. L’unico modo però perindividuare questa lingua è procedere, primaria-mente, all’ordinamento del mondo, vedere comequesto è ripartito, costruire, in sostanza, un’enci-clopedia. L’enciclopedia era, per questi pensatori,un “teatro del mondo”, una sua rappresentazione,una copia dello stesso le cui regole coincidono conle regole del mondo. Questa pretesa conduce a unaltro, inatteso matrimonio, il legame tra gli studio-si di botanica e coloro che indagavano il mondoanimale. Dietro le loro classificazioni, dietroLinneo, possiamo rinvenire questa temperie, ilsogno di strutturare una “magia innocente”, unoschema che sia specchio del mondo. C’è da dire chepoi, questo sogno enciclopedico, si rivelerà illuso-rio. Ciò non toglie che, quando Leibniz costruisce epensa la propria logica, la pensa in questo modo.Quando usa la terminologia richiamata, Leibnizmanifesta ancora la presenza, nel sottosuolo delsuo pensiero, del sogno di una enciclopedia comespecchio del mondo. Sia detto per inciso che, tra lealtre cose, una pallida eco di questo sogno albergaancora tra le pieghe della logica contemporanea.
5. ENCICLOPEDISMO E ORgANICITÀ DEI SAPERILe mnemotecniche hanno incrociato più volte
l’avventura dell’enciclopedismo e l’ideale di unasistemazione organica ed esaustiva dei saperi nelleloro multiformi articolazioni. Anche per questomotivo vengono ad opporsi, a partire
dall’Illuminismo, due concezioni del metodoclassificatorio: come criterio tassonomicoconvenzionalistico basato sulla univoca esemplice appartenenza a generi e specie diver-se; oppure come sistema di rapporti polimor-fici, come rete di nessi e di rimandi che aiutala memoria a dominare la tessitura dei rap-porti effettivi che uniscono le cose e i lorosimboli. Questo secondo ideale mira allacostruzione di una nomenclatura intesa comerispecchiamento dell’ordinamento profondodelle forme naturali e delle loro qualità sullabase di un criterio che – per utilizzare un’im-magine cara all’Età dei Lumi - sia come “unfilo che aiuta ad orientarsi nel labirinto”.Ritiene che sia attuale o auspicabile recupe-rare questo filo organico e unitario delle mne-motecniche nell’orizzonte irregolare e trava-gliato delle scienze contemporanee, semprepiù sospinto verso l’orlo della crisi dall’estre-mizzazione del proprio settorialismo?Schema del Teatro della Memoria di Giulio Camillo (particolare)
Storia dEllE idEE E arti dElla mEmoria
Chora N. 16, Settembre 2008
54
La domanda cinque non è del tutto accettabi-le. C’è in alcuni dei pensatori richiamati ancheun intento metafisico: si pensi a CamilloDelminio, il suo teatro del mondo non è unarecita, una commedia, ma il mondo stesso, lasua costruzione e non una mera immagine. Ciòche rif iuto è l ’ idea, che trapela da questadomanda, che queste strutture aiutino a orien-tarsi nel labirinto del mondo, perché, secondoquesti autori, il mondo non è affatto un labirin-to. Sono gli empiristi che considerano il mondoalla stregua di un labirinto, ma questa visionefa a pugni con l’idea che il mondo sia un qual-cosa di ordinato, è l’idea meno platonica emeno gali leiana che si possa sostenere.Equivale a dire, in sostanza, che il mondo non èscritto in termini matematici, è una opzioneradicalmente antirazionalistica.
In fondo, anche per un fisico o per un astro-nomo il mondo non è un labirinto; la cosa piùincomprensibile è che esso sia comprensibile.Keplero diceva che l’astronomo era l’uomo piùvicino a Dio, perché guardava alla struttura cheil creatore aveva usato come modello. È, al più,un finto labirinto, un labirinto costruito, dalquale si può uscire, che si può dipanare. PerFrancis Bacon il labirinto è una selva impene-trabile, dalla quale non si può affatto uscire.
Una volta ho assistito, durante un convegno,a un’esibizione di memoria improvvisata da ungiovane che, tra lo stupore generale, fu ingrado di ricordare circa cento nomi, scritti acaso dagli astanti, in pochissimi minuti e, cosaancor più incredibile, li sapeva ricordare anchein ordine inverso o partendo dalla metà o da unnome a caso. Credo che ora questo giovaneabbia anche raggiunto una certa fama e mi pareinsegni le sue tecniche dicendo, ma questo èdavvero impossibile, che le ha apprese leggen-do Giordano Bruno. Ebbene, al giorno d’oggi,la psichiatria considera casi come questo comeuna sorta di deficit al contrario; non esistonoinfatti solo degli handicap, ci sono anche deisoggetti con caratteristiche ipersviluppate. Aitempi di Piero da Ravenna, che girava il mondoe si esibiva nei teatri più famosi, si pensava che
a fondamento di quelle incredibili prestazionici fossero delle tecniche specifiche. Permanecertamente, considerando questi aspetti , unalone di mistero; probabilmente non sapremomai chi fossero realmente persone come Pieroda Ravenna.
La storia dell’arte della memoria, da un certopunto di vista, non ha un lieto fine, perché ter-mina con il fallimento della tecnica ciceronianadella collocazione delle immagini nei luoghi.Ciò che è stato realmente significativo, che hadato qualcosa, è stata la fusione di quella tradi-zione con quella di matrice metafisica derivatadal lullismo. L’arte della memoria è come unfossile intellettuale, può interessare moltissimo,affascinare, perché si trova, in modo inatteso, afondamento di cose che noi non penseremmomai essere a essa collegate. Penso, soprattutto,alla logica. È un fossile, inutilizzabile ma, pro-prio per questo, dimostra come il passato siapieno di cose impensabili, interessantissime.
paolo rossi si è dedicato per oltre trent’anni al tema della memoria, in chiave filosofica e storica, al quale ha dedicato nel 1991 ilsaggio Il passato, la memoria, l’oblio con il quale ha vinto il Premio Viareggioha dedicato studi particolarmente approfonditi aFrancesco Bacone e Giambattista Vico, ma il campo nel quale ha dato il contributo più innovativo è quella della cosiddetta “rivolu-zione scientifica” del Seicento.si è laureato nel 1946 a Firenze, con il filosofo dell’umanesimo Eugenio Garin. Dal 1950 al 1959 è stato assistente di Antonio Banfiall’Università di Milano. Fra il 1950 e il 1955 ha lavorato all’Enciclopedia dei ragazzi presso la casa editrice Mondadori. Ha insegna-to storia della filosofia, prima all’Università di Milano (fino al 1961), poi a Cagliari (1961-1962), Bologna e, dal 1966 al 1999, a Firenze.Dal 1999 è professore emerito nell’Università di Firenze. Ha pubblicato centinaia di saggi e articoli su riviste italiane e straniere. Hacurato edizioni di diversi autori tra i quali Cattaneo (Mondadori), Bacone (UTET), Vico (Rizzoli), Diderot (Feltrinelli), Rousseau(Sansoni). Ha diretto collane scientifiche e filosofiche per le case editrici Feltrinelli, Sansoni e La Nuova Italia. Partecipa alla direzio-ne di varie riviste tra le quali la “Rivista di Filosofia” e ai comitati di consulenza di numerose riviste, tra le quali “European Journalof Philosophy”, “Révue Internationale d’Histoire et Méthodologie de la Psychiatrie”, “Science in Context”, “Time and Society”. Nel 1972 è stato eletto membro del “Comitato 08” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (rieletto nel 1977). È stato presidente siadella Società Filosofica Italiana (dal 1980 al 1983) sia della Società Italiana di Storia della Scienza (dal 1983 al 1990). È “socio corri-spondente” dell’Accademia Pontaniana di Napoli e “socio nazionale” dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Ha ricevuto la MedagliaSarton per la storia della scienza dalla American History of Science Society (USA) nel 1985 e successivamente la Medaglia Pictetdalla Société de Physique et d’Histoire Naturelle de Genève. Dal 1988 è presidente del comitato scientifico del centro di studi filo-sofici “Antonio Banfi” di Reggio Emilia. È membro dell’Accademia Europea dal 1989. È presidente della Società italiana per lo stu-dio dei rapporti tra scienza e letteratura. Ricordiamo alcune delle sue opere: Francesco Bacone. Dalla magia alla scienza, 1957; ClavisUniversalis: arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz, 1960; I filosofi e le macchine 1400-1700, Feltrinelli, 1962; Le stermi-nate antichità: studi vichiani, 1969; La scienza e la filosofia dei moderni, Bollati Boringhieri, 1989; Il passato, la memoria, l’oblio, 1991 (PremioViareggio 1992); La filosofia [4 voll., a cura di P. Rossi], UTET, Torino, 1995; Un altro presente, il Mulino, 1999
55roSSElla FabbrichESi
Chora N. 16, Settembre 2008
Voglio qui brevemente analizzare i presupposti del progettodi scrittura logica che Leibniz denominò characteristica universa-lis, presupposti rappresentati dai molteplici e proteiformi siste-mi di scrittura universale che trovarono sviluppo dal Medioevoin avanti. Leibniz aderì infatti ad un’aspirazione persistente ereiterata, tipica del pensiero del ‘500 e del ‘600, ma già inaugura-ta da Raimondo Lullo verso la fine del ‘200: quella che miravaalla costruzione di una lingua perfetta modellata su di un alfa-beto logico, un alfabeto dei pensieri primi ed elementari, assolu-tamente rispondente all’ordine delle cose e simbolizzato dacaratteri singolari, precisi e potenzialmente universali. Ogniragionamento si sarebbe ridotto, in tal modo, ad una specie dicalcolo di composizione e scomposizione di queste nozioniprime, e la scienza, la filosofia, la teologia avrebbero potuto final-mente trovare appoggio su basi sicure, proprio perché, indivi-duate poche ed essenziali nozioni comuni, ad esse si sarebberopotuti associare pochi e ben definiti caratteri univoci, in mododa rendere il ragionamento molto simile ad un calcolo.
Tale ricerca degli elementi ultimi del pensiero presupponeevidentemente una profonda fiducia nell’indissolubile alleanzatra segni e idee, ma anche, com’è chiaro, la certezza di un lega-me altrettanto profondo tra segni ed essenze ‘reali’. Gli elemen-ti atomici della scrittura razionale devono corrispondere infatti -almeno strutturalmente - ai pensieri atomici e agli elementi sem-plici del reale; la loro combinazione permetterà poi di elaborarenozioni complesse, di ordine, per dir così, molecolare. In sintesi:Leibniz (e gli altri autori che nomineremo con lui) crede siaattuabile la costruzione di un alfabeto dei pensieri umani, ordi-nato su di una serie predicamentale organizzata secondo rigidivalori enciclopedici e rispecchiata nella “connessione e sostitu-zione” di caratteri puramente formali1.
Aggiungiamo allora subito una cosa: Leibniz è l’ultimo pen-satore di una certa statura a reputare attuabile un tale proget-to. Sul suo sogno irenico e universalistico si abbatte la scuredell’aspro giudizio kantiano, che ne segnerà definitivamente ildestino. D’altronde, le carte dedicate da Leibniz alla characteri-stica universalis giacquero decenni sepolte negli archivi hanno-veriani, prima che il genio di Couturat ne comprendesse ilvalore e l’importanza2 . Lo stesso Leibniz, prima ancora di affi-darle ai posteri, sembrava dunque cosciente del fatto che il suoprogetto non era del tutto convincente, che esso andavameglio spiegato, limato, perfezionato.
Ma sentiamo come il grande Kant pronuncia il suo anatema,chiudendo di fatto un’intera epoca di speranze e progetti lin-guistici ‘architettonici’, e consegnando alla posterità l’idea di
un Leibniz visionario, il cui impegno di ricercatore, pur enco-miabile, poteva essere assimilato a quello degli alchimisti: “Perdire apertamente in questa occasione ciò che io penso di que-st’arte [l’ars characteristica combinatoria] che Leibniz raccoman-dava vantandola come sua invenzione e che tutti i dotti rim-piansero seppellita nella stessa fossa di così grand’uomo, con-fesso che nell’affermazione del grande filosofo scorgo il testa-mento di quel famoso padre della favola esopica il quale inpunto di morte aveva rivelato ai propri figli d’aver sotterratonel suo campo un tesoro, spirando tuttavia prima di poter loroindicare il luogo esatto: egli diede così occasione ai figli di som-muovere e dissodare vangando senza requie il campo, finché,frustrati nella speranza, si trovarono tuttavia indubbiamentepiù ricchi per la fecondità del terreno. E io giudico che questosia l’unico frutto che ci si posa aspettare dalla ricerca di questocelebrato meccanismo (artificium), se ci sono coloro che ancoravogliono dedicarsi a quest’opera”3 .
Qual è il peccato di Leibniz? “Quando si tratta di esprimereuna conoscenza composta per mezzo di segni, tutta l’acutezzadell’ingegno d’improvviso si incaglia come su uno scoglio ecade in inestricabili difficoltà”4 . Kant anticipa con ciò il giudi-zio altrettanto negativo che su Leibniz darà Hegel. Hegelopporrà infatti proprio questo a Leibniz e ai suoi predecesso-ri: non è nella scrittura, ma nella spiritualità del concetto, che sigioca la ragione. Leibniz ha creduto di poter fissare il concettocon un numero caratteristico, ma il concetto è vita, sviluppo,movimento e non si dà mai in modo determinato. “Il raziona-le - scrive Hegel5 - viene preso come qualcosa di morto, privoaffatto del concetto, e si lascia da parte quel che il concetto e lesue determinazioni hanno di proprio: cioè che essi sono, inquanto fatti spirituali, relazione, e che per virtù di questa rela-zione sopprimono la loro determinazione immediata”.
Ecco dunque qual è il peccato sommo dell’autore lipsiense:di aver tradito il concetto, consegnando il pensiero al “giocodei caratteri”, al puro simbolismo, alla forma vuota dei segni,al calcolo logico depurato da ogni rinvio al significato. L’”ari-dità e immaturità” del suo sistema si evidenzia così in tutta lasua nettezza, chioserà Hegel. Con buona pace del cosiddetto“razionalismo” leibniziano.
A ben vedere, la scrittura e la sua pura formalità d’espressio-ne è sempre stata la ‘bestia nera’ del logos, da Platone in poi.Forse, Leibniz è uno dei pochi ‘grandi’ a reputarla fondamen-tale, a dedicare le proprie migliori energie a carpirne il segreto:per il resto, il “maestoso silenzio” che il testo scritto oppone,secondo Platone, a chi lo interroga, è stato ricambiato da un
dove sta il pensiero?
di rossella FaBBrichesiuniversità degli studi di Milano
Breve excursus sui progetti di lingua universale prima di leibniz
1 Mi sono più ampiamente occupata di questi temi leibniziani in I corpi del significato, Milano, Jaca Book, 2000.2 Gran parte degli scritti logici inediti di Leibniz sono stati pubblicati da L.Couturat con il titolo di Opuscules et fragments inédits de Leibniz, a Pariginel 1903.3 Sono parole tratte da un’opera del periodo pre-critico, Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova delucidatio, e citate da F. Barone in Logicaformale e logica trascendentale, Torino, Edizioni di filosofia, 1957, cap.I “Leibniz e la logica formale”, p.19.4 E’ sempre Kant che parla nel seguito del brano citato, riportato da Barone (ibidem).5 Sto sempre seguendo lo schema di Barone (op.cit., p.58).
dovE Sta il pEnSiEro?
Chora N. 16, Settembre 2008
56
altrettanto maestoso disinteresse da parte dei filosofi classici alriguardo, pochi dei quali si sono soffermati ad indagare il pote-re del corpo scritto della parola. Che non significa solo, beninteso, potere del simbolismo formale, ma potere della ‘morfo-logia’ del simbolo, del contenuto esibito nel supporto stessodella forma logica. Oggi da più parti si crede invece che siaproprio nell’indagine sulla scrittura e le sue differenti modali-tà d’espressione che si gioca la possibilità di capire la ragione,e che la “spiritualità del concetto” in realtà risulti determinata,“formata”, dalle tracce grafiche che la costruiscono come voca-bolo significante.
Proviamo allora a ripercorrere la storia dei progetti di linguaperfetta che precedono Leibniz: questo aiuterà forse a com-prendere quanto essi siano già orientati verso un’architettoni-ca di stampo cibernetico e quanto siano importanti come ante-signani del simbolismo della logica. Partiamo senz’altro daRaimondo Lullo, che è stato proprio il primo ad ipotizzare lacostruzione di un’ars magna, come lingua universale in gradodi condensare ogni contenuto significativo della realtà, e dun-que di fungere da linguaggio immediatamente e naturalmen-te accessibile a tutti, anche a fini religiosi. L’intento da cuimuove Lullo è dunque di stampo irenico (egli era infatti natoa Maiorca, che rappresentava una sorta di crocevia tra la cul-tura araba, quella cristiana e quella ebraica), non diversamen-te da quanto accadrà con Leibniz. I suoi principi elementarierano rappresentati dalle nove “dignità divine” - bontà, gran-dezza, gloria, verità, eternità,ecc.6 - , che, unitamente a noveprincipi relativi, nove questioni, nove soggetti, nove virtù enove vizi, venivano contraddistinti da una lettera che potevaessere posta su di una rotula: combinata con altre, essa produ-ceva ‘automaticamente’ nuove verità.
Nove elementi a gruppi di tre permettono 84 combinazioni,che poi divengono addirittura 252 secondo un mecca-nismo di combinatoria simbolica che non può nonricordare il linguaggio cibernetico .
Ma la combinatoria in Lullo non è solo mecca-nismo di calcolo formale; deve anche rifletterel’ordinamento della realtà e aiutare a costruirequelli che Lullo chiama “alberi della scienza”,che avranno come radici le nove dignità divine,unite alle nove relazioni (differenza, concordan-za, contrarietà, maggiore, minore, uguale, ecc.),e si suddivideranno in sedici rami, ognuno deiquali rappresenta una disciplina specifica (l’am-bito morale, vegetale, animale, ecc.) .
Il sistema degli alberi è dunque rappresentativodell’organizzazione del reale, dell’enciclopedia delsapere. Quello che gli obietterà Leibniz (che per altro
incorrerà per parte sua in analoghe ingenuità) è che quellaenciclopedia non è davvero universale, ma rispecchia ilsapere (cristiano) dei dotti del tempo (e l’uccisione di Lulloper mano dei Saraceni, per nulla catturati dall’universalitàdel suo progetto, lo dimostrerebbe). Gli attributi divini nonpossono dunque fungere da elementi né universali, népuramente formali, delineando unicamente una certavisione prospettica di ciò che in un certo tempo e unacerta cultura appare fondamentale.
Comunque, l’idea della combinatoria - di una lingua con-cepibile come puro calcolo formale di elementi semplici, ele-menti che, a loro volta, sono a fondamento dell’organizzazio-ne del reale - persiste e diviene un richiamo obbligato per moltiautori scolastici. Il magistero lulliano trova seguaci entusiasti -Leibniz sarà, con tutte le sue riserve, tra di essi - e si tramande-rà intatto attraverso buona parte della storia moderna. NelRinascimento esso si combina con l’ermetismo e la Cabala, conla magia, l’arte della memoria e i progetti bruniani, preparan-do di fatto, pur in questo strano amalgama, le grandi costru-zioni della scienza moderna, come è stato ben dimostrato7 .
6 Per una migliore esposizione, anche iconografica, rimando al testo dal quale ho prevalentemente attinto le informazioni presenti in questo artico-lo: U.Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Roma-Bari, Laterza, 1996.
57roSSElla FabbrichESi
Chora N. 16, Settembre 2008
Edmund
Husserl
Di lingua perfetta tornano poi a parlare nel ‘600 moltiautori, che lasciano cadere l’idea del carattere magico e inef-fabile dei caratteri - sulla quale aveva scritto pagine ispira-te, ad esempio, Bruno - e sottolineano invece la funzioneutile, scientifica, addirittura commerciale, di un progetto dilingua universale ex novo istituita. Voglio ricordarne soloalcuni: Athanasius Kircher che lavora ad una “poligrafianuova e universale”, in cui ogni termine del dizionario divarie lingue viene accostato ad un numero, che divienedunque parametro universale di riferimento per ogni con-cetto corrispondente; Cave Beck che scrive The UniversalCharacter, con intenti non molto diversi; Joachim Becher chenel 1661 pubblica il suo Character pro notitia linguarum uni-versali, sempre fondato sull’accostamento tra un terminelatino e un numero corripondente, per cui ad esempio ladedica iniziale del testo (“Inventum EminentissimoPrincipi”) andava scritta: 4442.2770:169:3.6753:3. Becher,come molti altri autori coevi, si rende conto che i numeriarabi non sono però universalmente decifrabili, e ipotizzaallora un altro sistema di traduzione, immediatamente ico-nico, fondato su puntini, linee dritte e linee curve, di questostampo:
Caspar Schott, nel 1664, propone una tabella divisa in ottocaselle, dove le linee orizzontali rappresentano le unità, le deci-ne, ecc.; quelle a destra si riferiscono ai morfemi grammaticalie quelle a sinistra alle unità lessicali. Un punto significa unità,una linea cinque unità. Così, la tabella riportata sotto si legge23.1 15.15 35.4, cioè: “Il cavallo mangia la biada”
Come scrive Eco, “impraticabile come appare per esseriumani, il sistema prelude però a pratiche di traduzione com-puterizzata”. Ma che tutti i progetti che fluiscono dalla sorgen-te lulliana (cioè da una sorgente universalistica, metafisica almassimo grado e cristianamente ispirata) abbiano questa dire-zione destinata, è del tutto evidente, e di ciò bisognerebbetener conto quando si discute della genealogia delle pratichedi computazione logico-informatica.
Tutti gli autori che ho ricordato erano conosciuti da Leibniz,che li cita nel suo De arte combinatoria, commentandone i lavo-ri. Ciò dimostra che se oggi i loro progetti appaiono utopici equasi ridicoli, a quei tempi erano oggetto di vivaci discussioni
e di verifiche approfondite da parte dei migliori ingegni del-l’epoca. Leibniz è per altro tra i primi a comprendere che ciòche risulta inaffidabile in essi, segnandone la decisa inattuabi-lità, è proprio il tentativo di ordinare rigidamente una classifi-cazione predicamentale. L’enciclopedia, o gli alberi del sapere,per dirla con Lullo, sono sempre ritagliati su di un’arbitraria equanto mai prospettica visione del mondo - quando nonaddirittura su di un linguaggio storicamente determinato,come il latino - che tutto può essere, meno che universale ecomune all’intero genere umano. Ma, come vedremo, ancheper Leibniz il sogno enciclopedico sarà duro a morire.
Ecco allora che intorno alla metà del secolo vediamo sor-gere un nuovo atteggiamento nei confronti della lingua uni-versale. Più che a facilitare la comunicazione tra gli uomini,la lingua universale - si pensa - dovrà fungere da “terapialinguistica” nei confronti delle lingue esistenti, depurare illinguaggio corrente da ogni idolum e ambiguità, fornendodei caratteri semplici, in grado di rispecchiare direttamentel’ordine delle cose. Antesignano di questa diversa fase pro-gettuale è Jan Comenio, creatore della pansofia, di derivazio-ne mistica e rosacrociana, orientata verso una riforma peda-gogica fondata proprio sulla costruzione di una lingua arti-ficiale in cui “il lessico rispecchi la composizione del reale eogni parola abbia un significato definito e univoco”. Il suoJanua linguarum del 1631 chiarisce ancora una volta comevocabolario e enciclopedia debbano coincidere, in modo dacondurre l’uomo a leggere univocamente l’alfabeto divinoimpresso sulle cose. “Per quanto le cose poste al di fuori del-l’intelletto sembrino qualcosa di infinito, tuttavia esse nonsono infinite perché il mondo, opera stupenda di Dio, con-sta di pochi elementi e di poche forme differenti e perchétutto quanto è stato escogitato mediante l’arte può esserericondotto a determinati generi e a determinati punti princi-pali. Poiché dunque fra le cose e i concetti delle cose, fra le imma-gini dei concetti e le parole si dà un parallelismo, e poiché nellecose singole sono presenti alcuni principi fondamentali daiquali tutto il resto risulta, io pensavo che quei principi fonda-mentali, che sono egualmente nelle cose, nei concetti e nel discorso,potessero essere insegnati” (la sottolineatura è mia)8 .
La stessa impostazione teorica - ben nota a Leibniz, che diComenio può considerarsi un discepolo - la ritroviamo nel-l’opera di altri maestri, diretti o indiretti, del nostro autore.Penso a Enrico Alsted, editore dei testi di Bruno e seguace di
Lullo, alle cui lezioni Comenio partecipò; a JohanAndreae, altro maestro di Comenio e affiliato aiRosacroce, come Leibniz stesso, che credeva nellapossibilità di pacificare le nazioni grazie all’istituzio-ne di un linguaggio a tutti comune. Infine, bisognaricordare Jacob Boehme, convinto sostenitore di unoriginario linguaggio della natura sommerso dallaconfusione delle lingue, che egli pensava dovesseessere ricostituito per la salvezza del genere umano.
Questa lunga tradizione di ricerche magiche, esoteriche,lulliste, rosacrociane, è di fatto alla base della nascita dellanuova scienza e della nuova logica, come hanno magistral-mente dimostrato gli autori che ho citato nella nota 6. Leibniz,filosofo del passaggio tra magia e metodo scientifico, comevogliono questi interpreti, riconosce negli uomini che horicordato i propri maestri, ma addirittura lo stesso Peirce -scienziato e filosofo della fine dell’800, inventore della semio-tica e di un progetto che potrebbe essere equiparato ad unagrammatica universale, quello dei ‘Grafi Esistenziali’ –ammette di sentirsi più vicino a Leibniz che a Peano, perquanto riguarda la sua visione complessiva, e asserisce che la
7 Rimando ancora, per chi voglia approfondire, al testo di U.Eco prima citato, che è comunque stato preceduto da almeno quattro fondamentalilavori: Frances Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, Roma-Bari, Laterza, 1983; id., L’arte della memoria, Torino, Einaudi, 1972; P.Rossi, ClavisUniversalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz, Bologna, Il Mulino, 1983; Lia Formigari, Linguistica e empirismo nel ‘600 inglese, Bari,Laterza, 1970. 8 E’ un brano tratto da Pansophiae prodromus, citato da P.Rossi (op.cit., p.210)..
dovE Sta il pEnSiEro?
Chora N. 16, Settembre 2008
58
propria cosmologia deriva per certi versi dal trascendentali-smo di Emerson e dei suoi amici “che disseminavano le ideeche avevano preso da Schelling, e Schelling da Plotino, daBoehme e da Dio sa quali menti colpite dal mostruoso misti-cismo proveniente da Oriente”9 . L’aspirazione alla linguaperfetta di lulliana memoria ha dunque una straordinariavitalità, che arriva fino all’ipotesi logico-diagrammatica diuno dei pensatori più fecondi del ‘90010.
Ma il passaggio verso la nuova logica è attestato da altrefigure del periodo: Sebastian Izquierdo, ad esempio, identificachiaramente la combinatoria con il calcolo matematico, per cuila metafisica dovrà procedere secondo lui con rigore dimostra-tivo, secondo il modello delle scienze esatte. Non diversamen-te la pensava Kircher: quest’impostazione permette quella“matematizzazione del lullismo” che si compirà, secondoRossi e la Yates, proprio con Leibniz.
I progetti più convincenti di lingua universale si per-fezionano poi nella seconda metà del ‘600, per opera diJohn Wilkins - i cui scritti Leibniz conosce e studiaattentamente - , di Seth Ward e di George Dalgarno.Questi autori non cercano più di ripristinare la perdu-ta lingua perfetta, né si accontentano di partire dai ter-mini del dizionario corrente, ma costruiscono un pro-getto di linguaggio del tutto artificiale, fondato su diuna lista di concetti elaborati filosoficamente e depura-ti dalle ambiguità del linguaggio comune. L’influenzadi Bacone e della discussione sul nuovo metodo è evi-dente: si tratta di individuare caratteri universali e reali,che rispecchino l’organizzazione del contenuto, for-nendo una sorta di primitiva “grammatica delle idee”.Occorre dunque elaborare una lista di termini primiti-vi che, composti tra loro, forniscano tutti i contenutidel pensiero razionale e li riproducano attraverso unelenco di caratteri assolutamente artificiali: si approdacosì a dei progetti di lingue filosofiche a priori, comescrive Eco, non più a posteriori, cioè basate su di un lin-guaggio o un contenuto già dato e ben definito.
Partiamo da Dalgarno, la cui classificazione entusia-smò Leibniz al punto che egli la riprodusse per interonei suoi manoscritti. Nel suo Ars signorum vulgo charac-ter universalis et lingua philosophica del 1661 ad ognicarattere corrisponde una nozione rigidamente classi-ficata nelle tavole che egli appronta, in modo che icaratteri rappresentino “non lettere e parole, ma cose onozioni”.
John Wilkins scrive due testi interessanti: il Mercurydel 1641 e l’Essay towards a Real Character and aPhilosophical Language, del 1668. In quest’ultima operapropone anch’egli una tavola di 40 generi maggiori, lisuddivide in 251 differenze peculiari e ne deriva 2030specie. A queste tavole Wilkins appone una grammati-
ca filosofica che denomini esattamente tutti i concettiutilizzabili. Egli distingue poi una lingua solo scritta,sulla base di ideogrammi modellati su quelli cinesi, euna destinata alla pronuncia:
Possiamo allora provare a sintetizzare brevemente gliintenti di questi ultimi progetti di lingua universale11 :
I teorici della lingua perfetta muovono dalla contrappo-sizione tra lingue naturali e lingue artificiali, e aspirano acostruire un linguaggio del tutto artificiale, un linguaggio“modello”, indipendente dalla lingua naturale che ognunocontinuerà a parlare.
Essi credono che, se le parole che gli uomini usano sonodiverse e nate dalla convenzioni, comuni a tutti sono però leimmagini mentali a cui le parole si riferiscono: compito dei
9 C.S.Peirce, Collected Papers, Cambridge, Harvard University Press, 1932-5, vol.6.102.10 Su questo aspetto mi permetto di rimandare ad un mio articolo in corso di stampa per la rivista ‘Semiotica’: Iconic Thought and DiagrammaticalScripture. Peirce and the Leibnizian Tradition. Sul sistema dei grafi esistenziali di Peirce cfr. in italiano F.Vimercati, La scrittura del pensiero, Milano,Alboversorio, 2005 e R.Fabbrichesi, Sulle tracce del segno, Firenze, La Nuova Italia, 1986, cap.2. Sono anche stati tradotti alcuni scritti dell’autore al pro-posito: C.S.Peirce, Pragmatismo e grafi esistenziali, a cura di S.Marietti, Milano, Jaca Book, 2003.11 Cfr . P.Rossi, op.cit., pp.237-248.
59roSSElla FabbrichESi
Chora N. 16, Settembre 2008
progettisti di lingue artificiali sarà dunque quello di appron-tare delle espressioni comuni e universali che corrisponda-no a queste nozioni generali e astratte.
Contro le ambiguità del linguaggio comune e gli idola foriindividuati da Bacone, la nuova scienza dovrà porsi tra imolti suoi obiettivi anche quello di costruire un linguaggioadeguato, che, tra l’altro, sarà utile nel commercio e nellacomunicazione tra le genti.
La lingua artificiale eserciterà una funzione terapeuticanei confronti della filosofia, che potrà essere liberata damolti dei suoi falsi problemi e, con la sua esattezza, aiuteràa perfezionare anche la logica (si pensi allo sviluppo cheavrà questo aspetto, sempre in ambito anglosassone, nelcorso del nostro secolo).
La lingua artificiale avrà inoltre una funzione irenica epacificatrice tra i popoli, permettendo di trasmettere piùfacilmente le idee e raggiungere ogni nazione del mondo.
I segni che verranno privilegiati saranno “caratteri reali”,cioè ideografici: significheranno direttamente cose e nozio-ni, e non suoni o parole, e saranno dunque comprensibili datutti, in seguito ad un veloce apprendimento.
“Il progetto di una lingua universale implica dunquequello di una enciclopedia, implica cioè la enumerazionecompleta e ordinata, la classificazione rigorosa di tutte quel-le cose e nozioni alle quali si vuole che nella lingua perfettacorrisponda un segno”, conclude Paolo Rossi, cioè ancora esempre “una preliminare classificazione di tutto ciò che esi-ste nell’universo”. Se le espressioni devono essere specchiodelle nozioni comuni, queste ultime devono essere specchioevidentemente dell’ordine delle cose reali, per cui “appren-dendo i caratteri e i nomi delle cose, verremo istruiti simil-mente sulle nature delle cose: questa duplice conoscenzadev’essere congiunta”, scrive Wilkins.
Questi autori non procedono più, dunque, come faceva-no Kircher o Becher, dall’enumerazione dei termini primiti-vi delle varie lingue alla costruzione di un dizionario essen-ziale esemplificato da numeri o lettere. Ora si lavora ad unagrammatica filosofica, in cui ogni nozione ritenuta generalee essenziale deve essere classificata e segnata da un caratte-re preciso. L’idea che fa da cardine a tutti i progetti di linguauniversale rimane tuttavia la stessa: che esistano tre grandiordini di riferimento - l’ordine segnico-linguistico, l’ordinelogico-concettuale e l’ordine ontologico - e che tra di essidebba essere stabilito un isomorfismo totale. Nel passaggiodi Comenio che abbiamo citato poco sopra quest’idea eraesposta con grande chiarezza: vi deve essere “parallelismo”- o “armonia” come dirà altrove, utilizzando un termine cheLeibniz apporrà a motto della sua filosofia - tra le cose e iconcetti delle cose, e tra questi ultimi e le parole. A ben vede-re, dunque, il rapporto tra ordine segnico e ordine ontologi-co è essenzialmente garantito dalla mediazione dei concetti,ordinati in serie predicamentali, ed in questa mediazione èriposto il segreto del conoscere.
La filosofia moderna appare in gran parte occupata a per-fezionare questo tema, che trova nel dibattito sulle lingueuniversali un’ottima definizione e nei progetti enciclopediciun tentativo di risoluzione. Ma in realtà su questi argomen-ti aveva già detto l’essenziale Aristotele, inaugurando unatradizione che permane immutata per lo meno fino al perio-do che stiamo analizzando. Nell’apertura del Perì ermeneìas(16a) leggiamo infatti: “I suoni della voce sono simboli delleaffezioni che hanno luogo nell’anima e le lettere scritte sonosimboli dei suoni della voce. E come le lettere non sono lemedesime per tutti, così neppure i suoni sono i medesimi.Tuttavia suoni e lettere (grammata) sono anzitutto segni(semeia) delle affezioni dell’anima, che sono le medesime pertutti e costituiscono le immagini di oggetti (pragmata) giàuguali per tutti”. Come si vede, già Aristotele stabilisce chesuoni, lettere e ogni altro segno linguistico sono convenzio-nali, ma rinviano alle “affezioni dell’anima” - quelli che
modernamente sono detti concetti - le quali sono uguali pertutti, sono dunque immagini naturali degli enti reali, a lorovolta uguali per tutti. Che ci siano insomma tre entità episte-miche, denominate segni, immagini degli oggetti e oggetti,è stabilito in via definitiva in questo antico testo greco (anti-cipato dal Cratilo platonico in cui le cose, in verità, sono benpiù sfumate e intrecciate), mentre quello che risulterà opina-bile, come vedremo, è quell’”uguali per tutti” che vieneattribuito a immagini e cose. In epoca ellenistica, gli Stoici -latori di una logica raffinatissima e molto ‘moderna’ - defi-niscono con più precisione il problema: essi affermano chein ogni proposizione abbiamo tre elementi: il significante (lavoce, il puro segno vocale), il significato (“ciò che vieneindicato dalla voce e che noi apprendiamo come esistente indipendenza dal nostro pensiero”), infine la cosa esistente “làfuori”. Ora, di questi tre elementi, due sono corporei ( lavoce e la cosa), uno è assolutamente incorporeo, “ossia quel-lo che è significato e esprimibile (lektòn), e proprio questo èvero o falso” (così riporta il loro pensiero Sesto Empirico).12
Tutta la discussione sulla validità dei segni, sullo statutodella conoscenza, ruota dunque alla fine intorno a quest’en-tità aerea e incorporea, impossibile da indicare, ma determi-nante per ogni possibilità di conoscere, che è appunto ilsignificato, il lektòn. Questa grande invenzione della logicastoica si trasmette con tutta la sua carica espressiva al pen-siero moderno, che ancora in parte crede, come abbiamovisto, che il concetto rispecchi la cosa stessa e sia identico pertutti. Sarà solo con Locke, di fatto, che il significato verràvisto come un’immagine per nulla naturale, ma cultural-mente elaborata, in grado di riflettere solo l’ordine soggetti-vo dell’esperienza, quella che Locke definiva l’essenzanominale, contrapponendola all’essenza reale. Così, il gran-de empirista inglese traghetterà i suoi contemporanei dal-l’idea di convenzionalità del suono a quella di arbitrarietàdel significato13 . Grande passo in avanti, senza dubbio, mache non intacca per nulla la fiducia nell’esistenza e nella pos-sibile adeguazione tra i tre ordini gnoseologici dei quali par-lavamo prima.
Ma torniamo ai progettisti di lingue universali. Essi cre-dono dunque che l’ideografia sia in grado di preservare lachiarezza concettuale dall’incerta mediazione della vox,troppo spesso compromessa con eventi di ordine naturale.Si deve arrivare ad un’arbitraria e quanto più esatta possibi-le scrittura di idee, che sostituisca su base assolutamenteconvenzionale, la varietà molteplice e confusa del mondoreale. Scrivere le idee: questo è l’obiettivo dichiarato di tutti gliautori che abbiamo analizzato; fissare sul corpo cartaceoquell’incorporeo, che già agli Stoici sfuggiva nella sua essen-za propria. Il progetto è quello di liberare il linguaggio dallasua costante ambiguità e metaforicità, operare a piacimentosu quegli attrezzi pronti per ogni uso che sono i segni dellascrittura ed adeguarli artificialmente alle immagini mentali,strutturando previamente queste ultime sulla base di unpreciso ordine categoriale ed enciclopedico.
Dicendo questo abbiamo attraversato la struttura superfi-ciale, per dir così, di questi progetti. Ma vi è una ‘strutturaprofonda’, che va individuata, e li sottende tutti. Ad essiaccomuniamo il De arte combinatoria di Leibniz, del 1666, cheripropone l’idea di una scrittura razionale e universalecapace di esprimere la composizione e scomposizione deiconcetti primitivi, e il Sistema dei Grafi Esistenziali elabora-to a cavallo del ‘900 da Charles Sanders Peirce, che obbedi-sce senza dubbio, mutatis mutandis, ad esigenze di esposizio-ne analoghe. Peirce, ormai dotato degli strumenti della logi-ca formale e matematica, pensava che si potesse lavorare sualcuni simboli grafici principali reputandoli espressivi dialtrettante relazioni logiche e dunque di ogni possibile statodell’universo. Su di essi egli pensava possibile operare delletrasformazioni, creando così relazioni nuove e creative tra isegni utilizzati. Per l’autore questa sarebbe dovuta essere la
dovE Sta il pEnSiEro?
Chora N. 16, Settembre 2008
60
logica del futuro, un linguaggio universale, la cui contiguitàcon i progetti del ‘600 Peirce riconosceva senza timore. Ancheper lui vi era infatti un parallelismo totale tra il Fogliodell’Asserzione, la Mente, considerata come l’insieme di tutti isegni possibili e il Mondo, con tutti i suoi fatti. Scrivere un grafosignificava infatti decretarne l’esistenza, come se si trattasse diun fatto esistente in quel determinato universo dell’asserzione(per questo egli parla di grafi ‘esistenziali’).
Cerchiamo allora di comprendere cosa si trasmette intatto daLullo a Leibniz, e da Leibniz a Peirce, quale concezione delmondo e del conoscere sottenda tutti questi progetti (e, si notibene, come mette in risalto Umberto Eco alla fine della sua disa-mina della questione, che oggi sono i progetti di intelligenzaartificiale ad aver ereditato temi e nozioni dei sistemi di lingueuniversali del ‘600).
Proverei a sintetizzare le loro molte affinità nei seguenti ter-mini. Anzitutto, la cifra comune a tutti i progetti - e potremmodire, in senso lato, ad ogni tentativo di analisi logica - è l’aspira-zione all’ordinamento, alla sistemazione, alla classificazione, inuna parola alla costruzione di una rete concettuale e predica-mentale che copra e catturi il disordinato “miscuglio dellecose”. La logica è “trappola per la selvaggina”, scrive Leibniz,fatta per ingabbiare gli enti reali e i pensieri confusi.L’elaborazione di dati discreti e elementari, la loro combinazio-ne e simbolizzazione in un sistema perfettamente trasparente,è infatti aspirazione comune degli ideatori di lingue universali,da Lullo ai cibernetici. L’idea vincente è quella di riuscire, conpochi elementi di base, a ricostruire il mondo, così come esso ènella sua struttura schematica profonda, a ordinare e tradurrein simboli perfettamente iconici e adeguati l’universo. La chia-ve della conoscenza è l’arte della sostituzione, potremmo diresulla scorta di Leibniz: ma così, in vece del ‘reale’, ci troviamo inpossesso di una mappatura convenzionale e assolutamenteartificiale del mondo.
Ricostruire con pochi elementi di base il mondo: ma questogià lo fa l’alfabeto, grande modello per tutti questi autori. E’Johann Heinrich Bisterfield, citato sovente da Leibniz, ad auspi-care la nascita di un “alfabeto filosofico”, dopo aver raccolto eordinato in centinaia di tavole i termini tecnici e le definizioniimpiegate in ciascuna scienza, in modo che la stessa enciclope-dia possa formare un “pictum mundi amphiteatrum”. Questoteatro del mondo fungerà da foglio-mondo14 assolutamenteperfetto, rappresentativo di tutto il nostro sapere, e dunque ditutto ciò che esiste nella realtà. Come si vede il sogno enciclope-dico di Raimondo Lullo affascina ancora molti ‘moderni’.
L’idea di un ‘teatro iconico del mondo’ ha però radici ancorapiù profonde. E veniamo così ad un secondo punto comune atutti questi autori. Abbiamo detto che per essi la chiave dellaconoscenza è l’arte della sostituzione, l’arte caratteristica, comevoleva Leibniz, cioè l’arte che conduce alla costruzione di carat-teri, note, segni che sostituiscono (si scambiano con), sup-pon-gono (stanno per, come dicevano i medievali) qualcosa d’altrogenere. Essi perpetuano così l’idea che sta alla base di ogni siste-ma semiotico: che una cosa sia qui, in presenza, al posto diun’altra, assente, con cui intrattiene un legame ideale di rinvio.Tutti i progetti partono dalla fiducia di poter sostituire le cosecon le parole (o segni d’altro tipo): l’infinito brulichio del
mondo può essere rappreso in un numero finito e ordinato disegni. Ma si può davvero operare un’analogia totaleparole/cose, nominato/nominabile15 ? Si può davvero costruirecon le note un reticolato perfetto che copra interamente il tessu-to del reale? Quello che nessuno di questi autori vede è che cosìfacendo non si riproduce il mondo, ma si traduce la nostra per-cezione del mondo in una nuova lingua, cioè si produce toutcourt un mondo, se ne scrive uno nuovo, a nostra immagine esomiglianza. E, come aveva ben compreso Peirce, dove situarea quel punto il ‘mondo primo’, originale ?
Il problema sembra poter esprimersi anche in questi termi-ni: assunta la verità dell’esistenza dei tre ordini epistemici di cuiparlavamo – segni, concetti, cose - cosa si riproduce (si traduce,si trasporta) uguale e riconoscibile dall’uno all’altro? La formalogica, come diceva Wittgenstein, ricalcando inconsapevol-mente un’idea leibniziana? I segni ideografici, tanto auspicatidai progettisti logici, ci inducono innegabilmente ad interrogar-ci sul perché siamo abituati, cioè siamo nell’abito di vederesegni e intendere cose; di vedere corpi, corpi segnici e gramma-ticali, e riferirli a idee o pragmata,anzi di andare al di là dei segniverso le cose grazie alla mediazione di quell’incorporeo che èl’idea, il lektòn degli Stoici. Il nodo è certo quello rappresentatodal rapporto di rinvio, di rimando (potremmo dire, dallo spa-zio bianco tra ordine e ordine). Quando gli illuministi, e Kantcon loro (o più tardi i logici formali), ridicolizzeranno i proget-ti di lingue universali, scommettendo o sulla pura arbitrarietàdel segno o sulla superiore idealità del concetto, perderannoproprio di vista quello che, a mio parere, rende ancor oggi inte-ressante da un punto di vista teoretico il cammino secentesco:vale a dire, la domanda, che esso costantemente ripropone,sulla legittimità del rinvio, sulla possibilità della traduzione di unordine nell’altro, sul rimando tra segni e reale che, da sempre, ètema principe dell’interrogazione metafisica.
Infine, ciò che deve fare problema è la pacifica distinzionetra ordine segnico, ordine logico e ordine ontologico, sullaquale si sono esercitati generazioni di pensatori, a partiredalla radicale sistemazione aristotelica. Noi diciamo: segni,pensieri e reale, ma così facendo abbiamo già de-ciso, cioèritagliato lo spazio dell’esperienza, ordinandola arbitraria-mente secondo territori predefiniti. Partiamo invece da ciòche esperiamo, e chiediamoci: cosa si pensa quando si pensa?Di che materiale è fatto il pensiero? Si dice, ad esempio: mi èvenuta un’idea; ma da che luogo dovrebbe mai provenirequest’idea? Come pro-viene e come ‘sta’ nella mente?Perché usiamo queste metafore spaziali? E c’è poi un’ideafuori dalla sua trascrizione?
Come vedete, gli interrogativi intorno a questo tema sonoinfiniti. Posso solo far cenno al fatto che Leibniz, da unaparte, Peirce dall’altra, hanno a mio modo di vedere, impo-stato la questione nel modo più netto e iniziato a rispondereconvincentemente in tanti loro scritti. Ma l’enigma del ‘luogodi residenza’ del pensiero, per dir così, rimane: l’arte dellamemoria nei tempi passati, la scienza informatica, oggi, esal-tano la forza espressiva dei caratteri, il loro iconismo, l’im-portanza dei loro rapporti relazionali e spaziali, e conduco-no, ancora e sempre, a interrogarsi sulla natura della loro infi-nita potenza, cui siamo tutti soggetti.
12 Su questi temi ho lavorato nel corso universitario dell’a.a.2005/06: cfr. Costruzione del significato e orbita delle passioni, Milano, CUEM, 2006.13 Cfr per questa lettura il testo di L.Formigari citato nella nota 6.14 Per l’uso di questa nozione, mutuata da Peirce, si veda C. Sini, Teoria e pratica del foglio-mondo, Roma, Bari, Laterza, 1997.15 Su questa nozione ha lavorato C.Sini in L’analogia della parola, Milano, Jaca Book, 2004..
rossella Fabbrichesi leo insegna Ermeneutica Filosofica presso l’Università degli Studi di Milano Ha contribuito alla divulga-zione del pensiero di Peirce in Italia con alcuni testi, tra i quali Introduzione a Peirce, Roma-Bari, Laterza, 1993, oltre che con la pub-blicazione di alcune antologie dei suoi scritti. Si è in seguito occupata delle filosofie di Leibniz e Wittgenstein, cui ha dedicato Icorpi del significato. Lingua, scrittura e conoscenza in Leibniz e Wittgenstein, Milano, Jaca Book, 2000. Oggetto dei suoi interessi sono lanozione di segno nell’antica Grecia (La freccia di Apollo. Erotica e semiotica nel pensiero antico, Pisa, ETS 2006) e la genealogia dei con-cetti di forza e di azione nel pensiero antico attraverso l’interpretazione di Friedrich Nietzsche.
61paolo valorE
Chora N. 16, Settembre 2008
“L'uomo strutturale prende la realtà, la decompone e poi la ricompone”
(Roland Barthes)
Lavorare sui linguaggi artificiali (in qualche senso,non retorico, del termine) può sembrare solo un curio-so passatempo da glottomaniaco, per esercitare le pro-prie abilità interlinguistiche, o, al massimo, un modoper contribuire alla creazione, al perfezionamento o alladiffusione di un linguaggio ausiliario internazionale,qualora se ne senta il bisogno (etico, politico o d’altrotipo). Ma vi sono molti altri scopi, per i quali lo studiodi un linguaggio artificiale si rivela proficuo, oltreall’unificazione e alla generalizzazione (che spesso,negli intenti, coincide con la razionalizzazione) dellacomunicazione umana: 1) la correzione delle irregolari-tà delle lingue naturali, che rendono disagevole il loroapprendimento e il loro uso; 2) l’eliminazione di caren-ze linguistiche in relazione allo sviluppo delle scienzemoderne (polisemia, nomenclature e tassonomie,imprecisioni nella corrispondenza tra procedure lingui-stiche e rappresentazione scientifica del reale); 3) il col-legamento di una corretta costituzione degli enunciatiai loro valori di verità1.
C’è, però, almeno un altro livello di considerazione:l’esibizione della struttura dei linguaggi pianificati ecombinatori può fornire un modello di analisi che èparticolarmente suggestivo per il filosofo e non è forseun caso che i linguaggi artificiali si siano diffusi princi-palmente all’interno della comunità dei matematici edei filosofi, piuttosto che in quella dei filologi. Lo stu-dio di un linguaggio artificiale, infatti, più che dirciqualcosa sul funzionamento delle lingue, sembra esse-re utile soprattutto per investigare le modalità di mani-polazione di espressioni e di composizione sulla base diregole, attività tipiche di molta attività spiritualeumana. Se, con Cassirer, possiamo definire la produ-zione culturale nel suo insieme come un’attività simbo-lica, i modelli di costituzione e manipolazione dei sim-boli assumono un interesse intrinseco e indipendentedall’effettiva realizzazione di una comunità di parlanti(che, per inciso, nel caso che considererò, esiste).
In questo breve articolo mi propongo di valutare sin-teticamente la generazione del lessico nel casodell’Esperanto (Internacia Lingvo) di Zamenhof2. Lagenerazione del lessico in Esperanto è particolarmenteinteressante in quanto combinatoria (come avviene, talo-ra, anche in alcune lingue naturali, ad esempio il tede-
sco, seppure con bizzarie). Un linguaggio combinatorioconsente di manipolare costituenti atomici di base,mediante regole di costruzione, per ottenere espressio-ni molecolari. Un procedimento di questo genere, oltread essere logicamente trasparente, consente anche unanotevole parsimonia delle radici e delle espressioni ato-miche. Ad esempio, secondo una ricerca di VilkoSetälä3, risulta che per la comprensione di più del 99%di testi in inglese scelti a caso si richiede, all’incirca, unlessico di 10.000 vocaboli, mentre in Esperanto sonosufficienti 2.800 radici. Per ottenere questo risultato,l’Esperanto applica con regolarità una procedura digenerazione del lessico che consente una notevole par-simonia in ciò che dev’essere ricordato, raffigurandosi,concettualmente, una sorta di mappa delle relazioni trai termini, che nascono per combinazione e incastri.
1) Un primo strumento dell’Esperanto utile alla mne-motecnica è la rigidità delle terminazioni: in questomodo, la parola scritta o pronunciata suggerisce la cate-goria grammaticale di appartenenza anche se non se neconosce il significato. Questo di solito non avviene neilinguaggi naturali. In Esperanto, la medesima termina-zione indica la medesima funzione morfosintattica. Ciòconsente, naturalmente, proprio la parsimonia su cui hoinsistito, permette cioè di generare funzioni morfosintat-tiche diverse grazie ad operazioni su componenti di base(radici). Tale generazione è (per lo più) priva di irregola-
la chiMica dei terMini
di paolo valoreuniversità degli studi di Milano
un caso di mnemotecnica applicata alla generazione del lessico
1 Cfr. Auroux 1996, p.189.2 Cfr. Zamenhof 1887.3 Cfr. Setälä 1949.
la chimica dEi tErmini
Chora N. 16, Settembre 2008
62
rità, anche se non funziona esattamente come in unlinguaggio artificiale formalizzato (per il quale è pos-sibile fornire un materiale atomico di base e regolealgoritmiche di generazione). Anche se il lessico nonpuò essere generato da un algoritmo4, la regolarità è lanorma e il fatto che una lingua siffatta possa essereuna lingua viva, parlata e scritta da una comunitàvariegata come quella esperantista, non è forse privodi significato nei confronti della trita opposizione tranaturale e artificiale, che di solito tende a privilegiareil primo corno dell’antitesi, per lo più appellandosi adargomenti retorici ed emotivi. Un esempio di tale rigi-dità è data dalle terminazioni per i sostantivi (-o vor-toj)5, che terminano sempre in –o, per gli aggettivi (-avortoj)6 che terminano sempre in –a, per gli avverbi (e-vortoj)7 che terminano sempre in –e, per i verbi che,all’infinito, terminano sempre in –i8. Memorizzando laradice *am- è possibile generare 4 termini, come illu-strato nel diagramma.
In questo modo, memorizzate 100 radici, si ottengo-no 400 termini. Si noti che una lingua come l’italiano,che pure sembra rispettare una regola analoga, in real-tà ha notevoli complicazioni da mandare a memoria:la terminazione –o non è necessariamente indice di unsostantivo (quando, camminano, terzo, …), la termina-zione –e non è necessariamente indice di un avverbio(ingegnere, fredde, dorme) e così via. Altre lingue, comequelle del ceppo germanico, mancano completamentedi indicatori del genere (music, often, Vater, Zug, ... ); lostesso si può dire anche delle lingue classiche, chepure mostrano una certa rigidità dovuta alla flessione.
Anche altre lingue pianificate, come ad esempio ilVolapük di Schleyer9, introducono una regola analo-ga, ma, congiunta a inutili complicazioni morfologi-che, essa perde la sua immediata efficacia. È purvero, infatti, che il Volapük introduce alcune termi-nazioni rigide, ad esempio nel caso dell’avverbio(segnalato da –o) o dell’aggettivo (segnalato da –ik:se Gud è bontà gudik è buono) ed è pur vero che daLog (occhio) è possibile generare logön (vedere), logik(visibile), logiko (visibilmente). Eppure, in presenzadella flessione, la regola è vanificata dalle sovrappo-sizioni: non solo un sostantivo compare con diverseterminazioni (Cil= ragazzo, Cila= del fanciullo, Ciles=ai fanciulli), ma le terminazioni non sono sempreunivoche: Flol (fiore), lifol (tu vivi), Dom (casa), löfom(egli ama)10. In particolare, il nominativo singolareprivo di desinenze riporta anche il Volapük al casodelle lingue germaniche: pükob (io parlo) ma Doab(dollaro), binom (è) ma Vom (donna).
2) Un secondo strumento è il ricorso agli affissi (pre-fissi e suffissi), per alterare il campo semantico di unaradice mediante una regola. Un esempio di tale rego-la è la generazione del femminile: applicando –in–prima della terminazione del sostantivo11, possiamogenerare da amiko (amico) amikino (amica), da instrui-sto (insegnante) instruistino (insegnante di genere fem-minile), da koko (gallo) kokino (gallina). Casi simili, initaliano, si hanno, ad esempio, con re e regina.
Un altro esempio è la negazione del campo semanticomediante il prefisso mal– da premettere alla radice: ami(amare) malami (odiare), alta (alto) malalta (basso), juna (gio-vane) maljuna (anziano), abunde (abbondantemente), mala-bunde (scar-samente), warmo (il caldo), malwarmo (il fred-do). Casi simili, in italiano, si hanno, ad esempio, con fermoe malfermo. Se applichiamo la negazione del campo seman-tico, memorizzate 100 radici, si ottengono circa 200 termi-ni, ai quali applicare la regola del punto uno, raggiungen-do alcune centinaia di termini. In caso di presenza di gene-re femminile, il numero cresce ulteriormanete.Naturalmente, soltanto alcuni sostantivi ammettono unadistinzione di genere. Possiamo comunque ipotizzare (conun calcolo per difetto) che, memorizzate 100 radici e appli-cando simultaneamente la rigidità delle terminazioni e l’al-terazione del campo semantico, i termini triplicheranno.Un esempio di applicazione del prefisso mal- è mostratonel diagramma a lato.
3) La possibilità di ampliare il lessico, partendo da unosforzo mnemonico minimo, cresce in modo esponenzialeuna volta che applichiamo gli affissi per generare i deriva-ti di un campo semantico.
4 Ciò nonostante, vi sono progetti che cercano di usare l’Esperanto come linguaggio intermedio di traduzione automatica per i cal-colatori. Cfr. Schubert 1992.5 Cfr. Wennergren 2006, § 4.6 Cfr. Ivi, § 5.7 Cfr. Ivi, § 6.8 Cfr. Ivi, §§ 26-27. 9 Cfr. Schleyer 188010 Cfr. Mattei 1890.11 Cfr. Wennergren 2006, § 4.2.
63paolo valorE
Chora N. 16, Settembre 2008
Gli affissi andrebbero mandati a memoria (sono comunquein numero limitato) ma rappresentano dei tasselli applicabiliin moltissimi contesti e permettono di generare, ad esempio,derivati mediante la nozione di “medesimo” (*sam-): samlanda-no: connazionale (lando = paese); samurbano: una persona dellastessa città (urbo = città); saminsulano: una persona della stessaisola (insulo = isola); samlingvano = una persona che parla lastessa lingua (lingvo = lingua) e così via. Si noti che l’apprendi-mento degli affissi non costituisce una fatica mnemonicaaggiuntiva al lessico, dato che possono essere usati come radi-ci al pari delle altre: same (allo stesso modo), sama (medesimo)e così via. Esempi di affissi utili sono: re- (ripetizione), ek- (ini-zio di un azione), ad- (frequenza, azione prolungata), an-(membro di una comunità, di un insieme), dis- (dispersione),ebl- (possibilità), e così via. Inoltre, gli affissi possono esserecombinati liberamente tra loro.
È chiaro che l’applicazione degli affissi rappre senta una tec-nica molto potente e consente di avere moltissimi terminimemorizzando un materiale atomico di partenza estre -mamente limitato.
Se consideriamo l’esempio di par tenza, da *am-, applicandoalcuni esempi delle ope razioni che ab biamo illustrato, possia-mo generare automaticamente parecchi vocaboli, come illu-strato nel diagramma seguente.
Naturalmente, abbiamo offerto solo alcuni (pochi) esempi,perché rappresentare tutte le derivazioni possibili da una solaradice richiederebbe una mappa di alcune pagine (e non sem-pre l’italiano possiede il corrispettivo per tutto ciò che puòessere espresso in Esperanto)!
Partendo da un centinaio circa di radici da mandare amemoria, si può ottenere un numero straordinario di voca-boli. Una lingua combinatoria come l’Esperanto realizza inquesto modo l’antica tradizione della mnemotecnica, incor-porando, nelle regole del linguaggio, delle strategie per economizza-re al massimo l’attività di memorizzazione. Considerato che unalingua pianificata come l’Esperanto è una lingua praticamen-te senza grammatica, l’unica attività mnemonica che richie-de riguarda il lessico. Le strategie precedenti consentonodunque di ottenere, in modo razionale, risultati sorprenden-ti con uno sforzo di memoria assai ridotto.
Inoltre, acquisire maggiore competenza nella combinato-ria linguistica esemplificata dall’Esperanto consente di otte-nere maggiore abilità linguistiche in generale. Claude Piron,già psicologo all’Università di Ginevra e traduttore cinese-inglese-russo-spagnolo presso le Nazioni Unite ha sostenutoche una lingua combinatoria come l’Esperanto è molto più“brain friendly” dei linguaggi cosiddetti naturali.L’Esperanto, infatti, sfrutta i riflessi innati, in quanto consen-te al parlante di fidarsi sempre della sua tendenza a genera-lizzare gli schemi appresi, tendenza spesso frustrata dai lin-guaggi come, ad esempio, l’italiano: se “candeliere” è l’og-getto che regge le candele, “ferroviere” non è l’oggetto cheregge la ferrovia. In Esperanto, la legge di Piaget definita assi-milazione generalizzante si applica non soltanto alla grammati-ca, ma anche alla generazione del lessico12. La tesi di Piron el’utilità interlinguistica di un esercizio del genere trovanoriscontro in molti esperimenti didattici. Un noto esperimen-to è il cosiddetto “Insegnamento di Orientamento
la chimica dEi tErmini
Chora N. 16, Settembre 2008
64
Linguistico”13, condotto sotto il controllo scientificodell’Istituto di Cibernetica di Paderborn e dell’AccademiaInternazionale delle Scienze di San Marino (a partire dal 1993in classi sperimentali in Italia, Russia, Ucraina, Uzbekistan eKazakistan e dal 1994 in Slovenia, Austria e Ungheria). IImetodo “di Paderborn” utilizzato in questa fase sperimenta-le, ha testato la conoscenza dell’inglese in 2 classi della stessaetà. Gli alunni erano divisi in due gruppi concorrenti: ilprimo cominciava lo studio della lingua inglese nella terzaelementare, l’altro studiava Esperanto per due anni e comin-ciava lo studio dell’inglese solo nel quinto anno scolastico.Alla fine della sperimentazione, il secondo gruppo, cheaveva studiato l’inglese per molto meno tempo mostrava diconoscerlo meglio del primo gruppo14. Inoltre si è mostratoche i bambini tra gli 8 e i 10 che studiano Esperanto ottengo-no risultati migliori anche in matematica. Risultati analoghisono stati ottenuti in Giappone15.
Purtroppo, questa documentazione non riesce adinfrangere le resistenze psicologiche contro l’idea stessa diun linguaggio pianificato, come ha ben mostrato lo stes-so Piron: “Spesso si imputano gratuitamenteall’Esperanto caratteristiche che ne fanno una minacciadistruttiva o un mutante mostruoso […]. Si tratta chiara-mente della proiezione sulla lingua di un nucleo emotivo,come il Golem o l’Automa definito da Baudouin […].L’Esperanto viene a turbare l’immagine di un mondo incui a ogni popolo corrisponde una lingua, e in cui la lin-gua è ricevuta dai padri come un blocco che nessun indi-viduo sarebbe in grado di manomettere. […] Assumendoa criterio di correttezza non la conformità all’autorità,bensì l’efficacia comunicativa, l’Esperanto ribalta i rap-porti umani, sostituendo a un asse verticale un asse oriz-zontale. Il suo attacco colpisce troppe cose profonde sullequali nessuno vuole fare chiarezza”16.
12 Cfr. Piron 1994.13 Cfr. Frank 1983.14 Cfr. anche la relazione finale del Ministero della Pubblica Istruzione – Commissione della lingua internazionale detta Esperanto– Decreto interministeriale 29 aprile/5 ottobre 1993 [pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, anno 122,nn. 21-22 (25 maggio-1 giugno 1995)]. La bibliografia su esperimenti analoghi è molto ricca: sui primi esperimenti in questa direzio-ne cfr. Fisher 1929, Halloran 1952 e Williams 1965; per gli esperimenti condotti negli anni Settanta (i cosiddetti “First Five-CountryExperiment” e “Second Five-Country Experiment”) cfr. Szerdahelyi 1975 e Sonnabend 1979. Per una valutazione degli esperimenticfr. Maxwell 1988 e per alcune considerazioni generali cfr. Minnaja 1970.15 Cfr. Fukuda 1980.16 Piron 1988, pp. 113 e 138.
paolo valore è Ricercatore confermato (Professore aggregato) presso il Dipartimento di Filosofia dell’Universitàdegli Studi di Milano, dove insegna Storia della Filosofia contemporanea, e ha un corso di Filosofia teoretica pres-so il Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria Industriale. Paolo Valore si è occupato di filosofia del Novecento,specialmente in relazione alle tematiche del realismo e della rifondazione di una prospettiva trascendentale.Attualmente lavora principalmente a temi di ontologia formale e di teoria della verità. Si interessa anche dei pro-getti di linguaggi artificiali e di lingue ausiliarie.
nota bibliografica:Auroux 1996, S. Auroux, La philosophie du langage, Presses Universitaires de France, Paris 1996; trad. it. La filosofia del linguaggio,Editori Riuniti, Roma 1998.Frank, 1983 H. Frank, “Valeur propèdeutique de la langue internationale”, in Journée d’Etude sur l’Esperanto, (1983), pp. 121-136.Fukuda 1980, Y. Fukuda, “Zur rationalisierten Fremdsprach-Lehrplanung unter Berücksichtigung der (z.B. deutschen oder japani-schen) Muttersprache”, in Grundlagenstudien aus Kybernetik und Wissenschaft, 21 (1980), pp. 1-16.Mattei 1890, C. Mattei, Nozioni compendiose di Volapük, estratto da Dizionario Volapük-Italiano e Italiano-Volapük, preceduto dalle nozionicompendiose di grammatica della lingua del Prof. Carlo Mattei, Hoepli, Milano 1890, ripubblicato in A. Ferretti, Volapük ‒ C. Mattei,Nozioni compendiose di Volapük, Fara, Rimini 1993.Maxwell 1988, D. Maxwell, “On the Acquisition of Esperanto”, in Studies in Second Language Acquisition, 10 (1988), pp. 51-61.Minnaja 1970, C. Minnaja, Il valore educativo dell’insegnamento dell’Esperanto nelle scuole, Istituto Italiano di Esperanto e FederazioneEsperantista Italiana, 1970Piron 1988, C. Piron, “Psikologiaj reagoj al Esperanto”, in Esperanto-Dokumentoj, n. 26, UEA, Rotterdam 1988, trad. it. “Le reazioni psico-logiche all’Esperanto” di V. Latronico dalla versione francese Les réactions psychologiques à l’espéranto in Valore 2006, pp. 129-145.Piron 1994, C. Piron, “The Hidden Perverse Effects of the Current System of International Communication”, relazione letta all’in-contro “Interweek” del 15 maggio 1994 ad Akademgorodok/Novosibirsk (Russia) reperibile sul sito dell’autore: www.claude-piron.ch.Schleyer 1880 Schleyer, Volapük. Die Weltsprache. Entwurf einer Universalsprache für alle Gebildete der ganzen Erde, Tappen inKomm., Sigmaringen 1880, Ristampa: Olms, Hildesheim and New York 1982.Schubert 1992, K. Schubert, “Esperanto as an Intermediate Language for Machine Translation”, in J. Newton (ed.), Computers inTranslation: A Practical Appraisal, Routledge, London 1992, pp. 78-95.Setälä 1949, V. Setälä, “La Genio de Zamenhof: Efekta Lingvo”, in Esperantologio, vol. I, n. 1 (1949), ristampato in I. Lapenna (ed.),Memorlibro pri la Zamenhofjaro, UEA, London 1960, p. 43.Sonnabend 1979, H. Sonnabend, Esperanto: lerneja eksperimento. Raporto-analizo-konkludo, Edistudio, Pisa 1979.Szerdahelyi 1975, I. Szerdahelyi, “Pedagogiaj valoroj de instruado de Esperanto”, in Internacia Lingvistika Simpozio, Kumrovec 1975-Zagreb 1976.Valore 2006, P. Valore (a cura di), Materiali per lo studio dei linguaggi artificiali nel Novecento, Cuem, Milano 2006.Wennergren 2006, B. Wennergren, Plena manlibro de esperanta gramatiko, ELNA, El Cerrito 2006.Williams 1965 N. Williams, “A Language Teaching Experiment”, in Canadian Modern Language Review, 22 (1965), pp. 26-28.Zamenhof 1887, L. Zamenhof, Lingvo Internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro, Kelter, Varsavia 1887.
65a cura di maria michEla SaSSi
Chora N. 16, Settembre 2008
Monaci tibetani
Maria Michela Sassi a cura di , Tracce nellamente. Teorie della memoria da Platone aimoderni, Edizioni della Normale, Pisa, 2007.Pp. X + 265, 12 illustrazioni. (Atti del conve-gno – Pisa, Scuola Normale Superiore, 25-26settembre 2006)
Chi si confronti con il tema antico e difficiledella memoria nella riflessione filosofica trovain Platone il punto di partenza con cui necessa-riamente misurarsi. Così nel volume di Attiaccortamente curato da Maria Michela Sassi: condeliberata rinuncia a risalire più indietro finoalle esplorazioni preplatoniche, che pure qual-che attenzione ai processi percettivi e appercet-tivi avevano dedicato, per sottolineare invece laindiscussa primogenitura delle potenti immagi-ni platoniche. Su tutte quella, fruttuosa comepoche altre nella storia del pensiero, dellamemoria come blocco di cera in cui resta impres-sa, quasi fosse un sigillo, la traccia di quanto si èpercepito: metafora, questa, che si ritroverà insi-stentemente – che fosse aperto recupero o indi-retta allusione – nell’intero percorso seguitodalla nozione di memoria dagli antichi aimoderni. Così del resto anche l’altra raffigura-zione platonica, a sua volta altamente evocativa,dell’anima come libro, sul quale uno scriba inci-de discorsi, un pittore delinea immagini. Se neoccupa Giuseppe Cambiano (Problemi dellamemoria in Platone), rilevando l’interesse plato-nico per il tema, senza tuttavia forzarne l’inter-pretazione in direzione di una sistematicità cheè in realtà assente in Platone, e invece marcandoda un lato l’intenzionalità dell’operazione mne-monica, dall’altro la presenza di contenuti pro-posizionali nell’intero processo, quale si puòleggere nell’immagine del libro. Capire mnemesignifica in Platone capire aisthesis, mathema,doxa, ennoia, significa intendere la nozione dianima, di piacere: tra Teeteto e Filebo, il temadella memoria riemerge in relazione a temi dif-ferenti e tutti centrali, assumendo tratti diversi aseconda del contesto in cui ricorre – quello epi-stemologico nel Teeteto, quello della trattazionedel piacere nel Filebo.
Ambigua quanto evocativa sul piano dei pro-cessi gnoseologici, la nozione di traccia dà ilriuscito titolo, e dunque marca la linea dell’in-tero volume. Meno immediata può apparire laseconda componente del titolo: quella mente, lacui identificazione nel pensiero antico, e nonsolo antico, resta non univoca, così come non
univoco è il nesso tra mente e memoria: non èun caso, che il contributo che opportunamentechiude il volume si attenti a ripercorrere levicende della mutevole localizzazione fisiologi-ca delle funzioni mnemoniche all’interno dellamassa encefalica, con un succedersi di interpre-tazioni che si fanno partire da Galeno e dallasua dottrina della centralità dei ventricoli cere-brali, per arrivare, attraverso i ripensamentiattestati tra il XVI e il XVII secolo, alle teoriecontemporanee e al Brain imaging (ClaudioPogliano, Topografie e migrazioni cerebrali dellamemoria). Platone apre dunque il volume, lochiude Leibniz (Massimo Mugnai,Immaginazione e memoria in Leibniz): per il qualela memoria risulta componente di base dellaconoscenza, collocandosi però al primo stadio,comune anche agli animali non razionali. Essaha bisogno di supporto, per consentire il pas-saggio ai livelli più elevati della conoscenza efino a quel «regno delle ‘cose’ puramente men-tali» che rende possibile la conoscenza scienti-fica: tale supporto è garantito dalla facoltà del-l’immaginazione. Leibniz si confronta critica-mente, nella sua riflessione su conoscenza ememoria e nell ’elaborare una sua propriadistinzione tra l’uomo e gli altri animali, conl’esordio della Metafisica di Aristotele: passonoto quanto quelli platonici, sebbene menoevocativo, in cui Aristotele distingue i varilivelli di conoscenza connettendoli alla memo-ria e quest’ultima riconducendo alla percezio-ne, in particolare quella uditiva.
Proprio Aristotele è oggetto di una disaminanon convenzionale da parte della curatrice delvolume (Maria Michela Sassi, Aristotele fenome-nologo della memoria), che, soprattutto sulla basedello specifico trattatello da Aristotele dedida-to al tema, il De memoria et reminiscentia, ripren-de e sviluppa in senso positivo una letturadella teoria aristotelica in chiave fenomenologi-ca, attribuendo al processo mnemonico caratte-re di intenzionalità, e vedendo nella memoria«lo sguardo dell’anima» ovvero, con terminolo-gia fenomenologica, l ’ intenzionalità dellacoscienza. Centrale per Aristotele risulta ladimensione temporale dei processi psichici:nelle parole di Aristotele, «la memoria, dun-que, non è né una percezione né un giudizio,ma il possesso o affezione di una di questecose, quando sia trascorso del tempo» (p. 43), equesto rappresenta un elemento di sostanzialenovità rispetto alla riflessione precedente, in
tracce nella Mente teorie della MeMoria da platone ai Moderni
recensione a cura di lorenzo perilli
Maria Michela sassi
traccE nElla mEntE
Chora N. 16, Settembre 2008
66
particolare quella platonica. La presenza diPlatone è indubbia, e opportunamente l’autricerileva come l’intreccio di richiami alla concezio-ne e alle immagini platoniche della memoria nonvadano considerati quale indispensabile, maconcettualmente poco significativo corollariodell’argomentare aristotelico, ma possano rin-viare a un confronto teorico tra di due autori sultema della memoria come processo cognitivo.
Se Aristotele fa almeno in certa misura i conticon Platone, la filosofia degli stoici fa i conticon Aristotele e non solo con lui, mentre loscetticismo rimette in discussione proprio gliassunti elaborati dagli stoici (KaterinaIerodiakonou, The Stoics and the Skeptics onmemory, l’unico saggio in una lingua diversadall’italiano). Lo stoicismo recupera a fini gno-seologici la nozione aristotelica, presente nel-l ’esordio della Metafisica e alla f ine degliAnalitici secondi , del formarsi e del conservarsidella memoria di oggetti particolari nell’anima,mediante il ricorso al concetto di ‘impressione’,il cui ripetersi genera l’esperienza. Per la psico-logia filosofica di età ellenistica, il tema dellamemoria e del suo ruolo nella acquisizionedella conoscenza dell’uomo è oggetto di appro-fondite riflessioni, e spazio meriterebbe anchela concezione epicurea, che per quel temamostra un notevole interesse. Il concetto diimpressione è centrale per gli stoici in relazio-ne alla memoria: e, come la memoria, le impres-sioni hanno carattere corporeo. Ma è la nozionestessa di ‘impressione’, resa latina dovuta aCicerone del greco typosis, a dar luogo a unvero e proprio dibattito all’interno dello stoici-smo, né si può assumere per gli stoici il mede-simo significato che il termine aveva nell’im-magine platonica della cera. Gli scettici a lorovolta negano alcuni degli assunti stoici fonda-mentali, come facevano con ogni teoria dogma-tica: tra gli assunti da essi rifiutati, era l’ideadella memoria come deposito di impressioni,giacché, argomentavano, ogni impressione sisovrapporrebbe alla precedente cancellandola,così come accade ai diversi sigilli nella cera.Nel far questo gli scettici, e con loro Plutarco,trascurano (deliberatamente, è da credere)alcuni aspetti della dottrina stoica: ma è signi-ficativo che lo stesso Plotino ricorra ad argo-menti analoghi nel suo atteggiamento criticonei confronti della concezione stoica. laddovela memoria, per lui, non è costituita da affezio-ni dell’anima ma da sue attività, e l’anima, con-trariamente a quanto sostenevano gli stoici,non è corporea. Entrambe le ‘scuole’ filosofichefecero ricorso ad argomentazioni articolate sultema della memoria, che costituiva un elementoimportante nell’ambito del loro dibattito epi-stemologico.
Altre scuole si appropriarono delle argomenta-zioni stoiche e scettiche a sostegno di dottrinediverse: tra queste spicca il platonismo, e più inparticolare Plotino (Cristina D’Ancona, Plotino:memoria di eventi e anamnesi di intelligibili). Perlui, nel contrasto tra affezioni e attività, tra pathee energeiai, il ruolo della memoria si fa problema-
tico: se ci si attende, date le premesse, che essasvolga un ruolo attivo nel portare alla conoscen-za della vera natura delle cose, tuttavia questoruolo è in contrasto con la convinzione plotinia-na che la memoria delle cose scompaia con lamorte, quando l’anima si separa dal corpo, untema questo che tornerà in Spinoza. Alla memo-ria di cose e di eventi si aggiunge in Plotinol’anamnesi delle Forme: che viene intesa dall’au-trice come «il modello ispiratore e quasi la con-troparte epistemologica della dottrina dellacosiddetta ‘anima non-discesa’», l’anima mai deltutto immersa nel sensibile ma una cui parterimane in contatto cognitivo con il mondo intel-legibile: una dottrina, quest’ultima, centrale perPlotino ma più di una volta respinta da altri filo-sofi neoplatonici, la quale offrirebbe dunqueanche le coordinate per una migliore compren-sione della problematica della memoria; mentre,vicevera, intendere il funzionamento dellamemoria può aiutare ad intendere proprio quel-la controversa tesi plotiniana.
Al passaggio tra Antichità e Medioevo si poneAgostino (Beatrice Cillerai, Agostino: la memoriacentro dell’actio animae). Si fa qui più evidenteil passaggio dal ruolo passivo a quello attivo,l’accostamento della memoria a una forma dipensiero, e comunque l’interpretazione dellamemoria come una capacità attiva dell’animanel coordinare i processi psichici. La memoriaviene vista come implicata in attività tra loro inapparenza molto diverse, quali sono la forma-zione di immagini di oggetti percepiti (phanta-siai) e la successiva loro fissazione, processoche risulta associato e distinto dalla recordatioin quanto capacità di riportare alla superficiedati percepiti in passato, e dalla creazione delphantasma, l’immagine di qualcosa non diretta-mente percepito.
Un’opportuna apertura al mondo arabo nelsuo nesso con l’occidente fa da snodo verso glisviluppi posteriori e già moderni (Carla DiMartino, Memoria dicitur multipliciter .L’apporto della scienza psicologica araba al medioe-vo latino). Grandi autori arabi come Avicenna eAverroè vengono tradotti in latino tra il XII e ilXIII secolo, e producono un effetto tutt’altroche trascurabile sulla riflessione, a occidente,di un Alberto Magno o di un Tommasod’Aquino. La psicologia araba introduce nellariflessione anche occidentale distinzioni e con-cetti che erano stati invece trascurati, o appenaaccennati a partire da Aristotele, tra cui in par-ticolare il rapporto della memoria con le altrefacoltà, quali la percezione, l’immaginazione, ilpensiero – temi che, nel volume, emergono conmaggiore o minore enfasi in tutti o quasi tutti icontributi . Significativo è l ’ incontro dellariflessione araba con i testi di Agostino e conquello del De memoria aristotelico: e particolar-mente indicativo è il fatto, cui nel saggio siaccenna, che nella versione araba dei Parvanaturalia aristotelici i l tema della memoriaacquisti maggiore rilievo che non nell’originalegreco, a suggerire un rapporto critico e consa-pevole con i testi della tradizione occidentale.
Tra i momenti salienti della riflessione filoso-fica successiva, l ’accento è posto su Bruno(Nicoletta Tirinnanzi, L’occhio e la pagina scritta.Aspetti della riflessione di Bruno sulla memoria trail De umbris idearum e il De magia naturali),Hobbes, Cartesio (Alfredo Ferrarin,Immaginazione e memoria in Hobbes e Cartesio),Spinoza (Fil ippo Mignini, La dottrina del lamemoria in Spinoza). Notorio è l’interesse diBruno per la mnemotecnica: ma non solo inquegli specifici trattati il tema della memoriaviene in evidenza, bensì anche in altri scritti,da quelli e tra loro diversi. Le immagini plato-niche relative alla memoria vengono recuperateda Bruno, come in realtà accade sistematica-mente nella trattatistica sul tema: ed è in parti-colare il nesso tra memoria e scrittura cheacquista particolare rilievo, e viene osservatoanche nella prospettiva delle tecniche retorichecalibrate sul pubblico a cui le argomentazionisono di volta in volta destinate. Emerge qui unruolo tecnico della memoria, che non esauriscetuttavia il tema. Il pubblico è il lettore: e nellametafora della lettura, a cui Bruno dedica gran-de attenzione, va letto il tentativo dell’intellet-to di cogliere la verità, attraverso l’efficaciadelle lettere scritte attraverso le quali si tra-smette lo spirito di chi quelle lettere ha create.L’«occhio dell’intelletto, rappresentando a sé lacosa, scopre e decifra le lettere della memoria edella magia» (p. 157). Si comprende il ripetutoriferimento di Bruno agli Egizi, alla loro scrit-tura, resa incomprensibile dalla natura selvag-gia di chi l’ha eternata sulle pietre.
Di nuovo il nesso tra memoria e immaginazio-ne, canonizzato già da Aristotele, è ripreso aproposito di Hobbes, la cui trattazione funge inrealtà da introduzione alla complessa dottrinacartesiana. Hobbes identifica i due concetti diimmaginazione e memoria in quanto entrambiesprimono una medesima funzione, che assumenomi diversi per dire ora «la sensazione che siindebolisce», ora «l’indebolirsi della sensazionepassata» (p. 164s.): nel nostro rapporto conosci-tivo con il mondo è la sensazione a lasciare innoi delle tracce, e l’immaginazione si configuracome sensazione indebolita, che genera le pas-sioni della mente. Con Cartesio si ha un saltosignificativo: in lui il rapporto tra immaginazio-ne e memoria è indagato in relazione al «pensie-ro puro», ed è connesso al superamento dellaconcezione aristotelica del pensiero che procedeper immagini. Memoria e immaginazione sonoin Cartesio alternative, a differenza che inHobbes, ma si rileva in lui una evoluzione nelpassaggio dalle Regulae alle Meditazioni: dallamemoria come elemento debole e dalla immagi-nazione come mediatrice tra intelletto e cono-scenza dei corpi estesi, si passa a una immagi-nazione ridotta a raffigurazione sensibile, con-trapposta al concepire, e a una memoria artico-lata in corporea e intellettuale, concetto que-st’ultimo che era stato già almeno del platoni-smo e di Agostino. In Cartesio, la memoriaintellettuale, se pure può riferirsi a immaginicorporee, è altro da esse, e diventa funzione
interna al cogito, che non può rinunciarvi. Se anche in Cartesio non mancano riferimenti
alle concezioni antiche e ormai classiche dellamemoria, in lui più che altrove si osserva unoscarto deciso, un salto in avanti: egli diventasua volte fonte e motivo di confronto per i suoisuccessori, qui per Spinoza. Anche in Spinoza,come in Cartesio, sembra possibile individuareuna evoluzione, nel passaggio dal Tractatus (lacui datazione si vuole qui anticipata) all’Ethica,che si fa evidente proprio grazie al ricorrere nelprimo trattato di motivi cartesiani che successi-vamente si attenuano fino a scomparie. Inentrambe le opere Spinoza fornisce definizioniformali del concetto di memoria. Questa diven-ta un processo regolato da leggi conoscibili e, inquanto concatenazione di immagini, essa, comequelle, viene meno al venir meno del corpo – untema già della filosofia ellenistica. Non si dàmemoria dopo la morte: destinato all’eternità è,tra le componenti della mente, soltanto l’intel-letto. Al contrario, immaginazione e memoriasono legate al destino del corpo, hanno funzio-ne funzione puramente strumentale che, inquanto tale, non è destinata a permanere. Ilvolume si chiude con Leibniz e con la topogra-fia della memoria, a cui si è accennato.
Pur nelle inevitabili e in realtà stimolanti dif-ferenze di un contributo dall ’altro, allaCuratrice va l’ulteriore merito di aver saputoriunire dapprima in un Convegno e poi in unelegante volume (sia dato il dovuto riconosci-mento alle Edizioni della Normale, che hannoacquistato negli ultimi anni rinnovato slancio)trattazioni che fruttuosamente si integrano traloro e permettono di ricostruire un filo che,senza improbabili forzature, guidadall’Antichità greca al pensiero moderno e allacontemporaneità a proposito di un tema nonsolo suggestivo, ma in più di un caso finora nonadeguatamente approfondito.
Sia consentito invece di rimpiangere l’assenzadi indici, che vadano oltre quello dei soli nomi.
67a cura di maria michEla SaSSi
Chora N. 16, Settembre 2008
il nichiliSmo E il problEma dEl nulla
Chora N. 16, Settembre 2008
68 QuantoèvEritiEraEStabilElamEmoria?
I ricordi: frammenti della realtàL’inaffidabilità o la parzialità della memoria
sono un aspetto ricorrente di numerosi romanzipolizieschi: spesso un testimone ricorda una partedella verità o addirit-tura è in contrastocon altri testimoni inquanto non soltantoha percepito undiverso aspetto dellascena del delitto magli ha anche dato unsignificato diverso,cosicché il suo ricor-do non è una fotogra-fia della realtà mauna sua rielaborazio-ne. Questa selettivitào parzialità dei ricor-di non riguarda peròsoltanto la letteraturama anche la vita quo-tidiana, come indicaun originale studioeffettuato per contodel Museum of ModernArt di New York. Inquesta ricerca vennechiesto a una partedel personale delmuseo di descrivere amente alcuni quadriche erano stati alungo esposti sullepareti e che eranostati rimossi a causadi prestiti o restauri. Irisultati dell’inchie-sta indicarono cheogni persona, che puraveva “visto” quelquadro quotidiana-mente per settimaneo mesi, ne ricordavaun aspetto particola-re e generalmentedissonante rispetto alricordo dei colleghi:chi ricordava un colo-re, chi una forma specifica, chi l’atmosfera, i per-sonaggi, lo sfondo e così via. La ricostruzioneverosimile del quadro non emergeva che dalledescrizioni di un esiguo numero di addetti al
museo. La mente, insomma, appare ben diversa daun computer o da una macchina fotografica, puòincamerare dettagli ma selezionarne solo alcuninel suo lavoro di ricostruzione. Spesso non si trat-
ta nemmeno di detta-gli verosimili, deipezzi di un puzzleche, messi insieme,consentono di rico-struire la vera imma-gine o il vero ricor-do, ma di indizi chepossono esser utiliper il “lavoro” dellamemoria.
Questo aspetto dellavoro di ricostruzio-ne della memoria,cioè la ricostituzionedelle esperienze, è alcentro di una paginaautobiografica dellascrittrice MargueriteYourcenar che, ormaiadulta, tenta di rico-struire il propriopassato e storia fami-liare a partire daalcuni indizi o stimo-li: “[…] sono costret-ta, proprio come losarei per un perso-naggio storico chetentassi di ricreare,ad appigliarmi aschegge di ricordi diseconda o di decimamano, a informazionitratte da frammentidi lettere o da foglidi taccuino che si ètrascurato di gettarenel cestino dei rifiutie che la nostra avidi-tà di sapere spremeal di là di quantopossono dare […] Soche tutto questo èfalso o vago come
tutte le cose reinterpretate dalla memoria di trop-pi individui diversi…”1. Gli psicologi hanno spes-so utilizzato simili metafore per indicare che lamemoria parte da frammenti, magari irrilevanti,
Quanto è veritiera e staBile la MeMoria?
di alBerto oliveriouniversità “la sapienza” di roMa
1984 - Il Grande Fratello
69albErto olivErio
Chora N. 16, Settembre 2008
per ricostituire un ricordo; ma poiché questiframmenti possono essere ambigui, il lavoro diricostruzione del ricordo può comportareinsuccessi, come avviene nelle difformi descri-zioni del teatro di un assassinio ad opera deidiversi testimoni interrogati da Hercule Poiroto dal commisario Maigret…
La nostra consapevolezza della fragilità e pre-carietà della memoria risale a Sigmund Freud cheutilizzò una metafora archeologica legata alla suaammirazione per l’archeologo HeinrichSchliemann, che scoprì le rovine di Troia quandoil giovane Freud aveva 18 anni. Nell’analisi di unnoto caso, quello di Miss Elizabeth, Freud utiliz-za “un processo di svuotamento strato per strato,che ci piace paragonare alla tecnica del dissotter-rare una città sepolta” 2. Per accedere a memoriesepolte l’analista, o chicompie un viaggio nellapropria memoria, devequindi scavare: a volteperò non si trova unatraccia completa ma soloframmenti. Un esempiodi questo lavoro di scavoe di incompletezza dellamemoria ci viene fornitaancora una volta daMargherite Yourcenarnella sua autobiografia.Nel tentativo di ricostrui-re il proprio passato, valea dire il significato dellapropria vita, la scrittriceva alla ricerca di testimo-nianze, fotografie, ricordidi famiglia, storie raccon-tate da chi ha condiviso alcune fasi di quel passa-to: “Per gli anni più recenti mi baso sui ricordi diFernande riportati da Michel. La storia del mioambiente paterno, del quale conosco meglio iparticolari, e quella di mio padre, che intravedoattraverso i ricordi frammentari che lui mi hafatto e rifatto, sono già più vicine alla mia, cosìcome la descrizione dei luoghi e dei paesi in cuiho passato la mia prima infanzia. Esse sono inse-parabili dai miei ricordi personali e verranno inseguito. Ciò che sto per raccontare qui mi è inve-ce in gran parte estraneo” 3. La difficoltà di sepa-rare i ricordi reali da quelli immaginari risultachiaramente da un brano delle Memorie diAdriano, forse l’opera più nota della Yourcenar:“Mi studio di ripercorrere la mia esistenza perravvisarvi un piano, per individuare una vena dipiombo o d’oro, il fluire di un corso d’acqua sot-terraneo, ma questo schema fittizio non è che unmiraggio della memoria. Di tanto in tanto, credodi riconoscere la fatalità di un incontro, in unpresagio, in un determinato susseguirsi degliavvenimenti, ma vi sono troppe vie che non con-ducono in alcun luogo…”4.
In questo suo lavoro di ricostruzione autobiogra-fica la scrittrice si serve di memorie “non sue”: ciòsignifica che la memoria autobiografica è una
costruzione di dubbia verità? In realtà l’accuratezzadelle nostre memorie è fuori discussione se ne conside-riamo gli aspetti generali: numerosi particolari edaspetti specifici possono invece essere più dubbi, modi-ficarsi lentamente col passare del tempo. Ad esempio,sono stati condotti studi in cui alcuni volontari doveva-no annotare su un diario eventi critici della loro vitaquotidiana. A distanza di tempo uno psicologo rilegge-va loro brani del diario che avevano scritto chiedendose ricordavano gli avvenimenti descritti. In alcuni casilo psicologo modificava ad arte il testo (dattiloscritto),anche in modo sostanziale: più lungo era l’intervallo ditempo trascorso, maggiore era la possibilità che le per-sone riconoscessero come propri ricordi gli eventi -falsi- descritti nel “loro” diario.
L’incapacità di cogliere la differenza tra i propriricordi “veri” e “falsi” dipende in gran parte dal-
l’oblio cui va incontro lamemoria autobiografica.Gli studi della psicologaMarigold Linton testimo-niano in modo molto chia-ro l’entità di questo feno-meno: nel 1972 la psicolo-ga americana cominciò adannotare in modo conciso,ed utilizzando uno stesso“modulo” di diario dicirca tre righe, diversieventi quotidiani. Giornoper giorno, annotava gliavvenimenti, uniforman-doli per lunghezza attra-verso le usuali tre righe,per evitare di dare unospazio diverso ai differen-ti ricordi e quindi facilita-
re la registrazione di alcuni anziché di altri. Lintontrascriveva almeno due eventi al giorno e, una voltaal mese, estraeva a caso le schede relative a due fatti,le rileggeva, cercava di stabilirne la data e di rievo-carli. Nel momento in cui gli eventi erano annotati ein quello in cui venivano riletti essi venivano anchevalutati in termini della loro rilevanza, delle emozio-ni coinvolte, dei significati ecc. Attraverso questaprocedura un po’ ossessiva, in cui la psicologa era adun tempo soggetto ed oggetto sperimentale, Lintonarrivò a stabilire che i ricordi vanno incontroall’oblio al ritmo di circa il 5-6% l’anno, un ritmo checomporterebbe la scomparsa di circa la metà deiricordi di specifici eventi se questi non venisseroincamerati nell’ambito del più vasto sistema dellamemoria autobiografica relativa a fatti a caratteregenerale o ai periodi della nostra vita: i singoli mat-toni di cui sono costruiti questi contenitori più vasti,possono infatti disgregarsi, mentre invece permanela percezione del flusso delle memorie e del lorosignificato globale.
Un altro aspetto dell’affidabilità delle memorie auto-biografiche riguarda la nostra capacità di datarle conuna qualche precisione. Per studiare questo aspetto chefa parte di quella che viene definita come la psicologiadel tempo, gli psicologi possono porre domande deltipo “quando è stata l’ultima volta che” (sei andato al
Kennet Bianchi Foto segnaletica della polizia
1 Marguerite Yourcenar, Care memorie. In Opere, Saggi e memorie, vol. 2, Bompiani, Milano 1992, pp. 819-820.2 Sigmund Freud [1886-1938], Opere, voll. 1-11, Boringhieri, Torino , 1966-1979, vol.1 p.2933 Marguerite Yourcenar, Il giro dei castelli. In Opere, op. cit. p.871.4 Marguerite Yourcenar (1951) Memorie di Adriano, op. cit., p.25.
QuantoèvEritiEraEStabilElamEmoria?
Chora N. 16, Settembre 2008
70
cinema, dal medico, fuori città per il week-end ecc.)oppure “quante volte hai” (indossato un determinatovestito, comperato un particolare prodotto ecc. nel-l’arco di tempo di una settimana, un mese ecc). Ingenere, abbiamo la sensazione che gli eventi si sianoverificati tanto più frequentemente quanto più validaè la nostra memoria. Perciò gli eventi più recenti ven-gono –ovviamente- datati con maggior precisione, evengono considerati più frequenti, quelli più lontanidel tempo vengono datati in modo approssimativo eritenuti più rari di quanto si siano verificati nella real-tà. Gran parte degli errori di datazione derivano dalfatto che il nostro “tempo interiore” e il tempo fisiconon coincidono: se siamo attivi e impegnati in nume-rose attività, gli eventi relativamente vicini ci sembra-no più lontani mentre il contrario avviene quandosiamo inattivi o poco impegnati, come spesso si veri-fica negli anziani che giudicano più lontani avveni-menti che hanno avuto luogo pochi giorni prima. Unodei meccanismi che regolano la “precisione” delladatazione dei nostri ricordi è l’associazione tra lememorie individuali e i punti di riferimenti collettivo.Ad esempio, possiamo ricordare bene qualcosa che ciè accaduto “nel momento in cui”, “il giorno che”,“l’anno in cui”, si è verificato un fatto memorabile cuiè agganciato il nostro ricordo. In mancanza di questipunti di riferimento la datazione dei nostri ricordipuò essere molto imprecisa, il che contribuisce a smi-nuire la loro “fedeltà”, sino a suscitare in noi stessidubbi sull’affidabilità di alcuni eventi della nostravita, come vedremo nel prossimo capitolo.
False memorieWinston, il protagonista di 1984, il celebre romanzo
di George Orwell che descrive con un mondo cupo eprivo di libertà, viene sottoposto a un “interrogatoriopolitico” da parte di O’Brien che fa parte del sistemadi potere assoluto esercitato dal “Grande Fratello”. Ilpotere implica che i ricordi della gente siano “allinea-ti” con le interpretazioni del regime, in modo che nonvi siano conflittualità tra memorie individuali e la“memoria storica” imposta dal Grande Fratello. A uncerto punto, nel corso dell’interrogatorio condotto daO’Brien, Winston comincia a dubitare della veridicitàdei propri -reali- ricordi mentre presta sempre piùfiducia ai “fatti” –immaginari e grotteschi- che glivengono presentati come realtà:
“L’Oceania è in guerra con l’Estasia. Ricordi, adesso?”“Sì”.“Undici anni fa, tu hai inventato una storia su certi
uomini, tre erano, che furono condannati a morte per tra-dimento. Tu ti sei messo in testa di aver venduto un pezzodi carta che provava, invece, la loro innocenza. Un talpezzo di carta non è mai esistito. Tu l’hai inventato e inseguito sei stato indotto a crederci come a una cosa vera.Ricordi, ora, il momento in cui hai formulato l’invenzioneper la prima volta? Ricordi?”
“Sì”O’Brien tese le dita della mano sinistra, tenendo nasco-
sto il pollice.“Ci sono cinque dita. Vedi cinque dita?”“Sì.”E le vide, infatti, per un attimo, prima che mutasse la
scena che si presentava in quale punto alla sua mente.Vedeva cinque dita e non c’era nessuna deformazione.5
Dunque Winston crede a quanto gli viene sugge-rito: non soltanto dubita dei propri ricordi maanche dei propri sensi. La sua memoria, comequella di tanti suoi altri concittadini, è stata“assassinata”, un termine utilizzato dagli storiciper indicare quel processo attraverso cui il potereha spesso tentato di cancellare, emendare la veri-tà, inserire verità parziali, costringere il pensieroentro un’immagine irrigidita ed artefatta delmondo. Così avvenne ai tempi dellaControriforma, ai tempi del nazismo o dello stali-nismo quando non soltanto vennero contraffattigli archivi ma anche manipolati i testi di storia e lostesso materiale fotografico: da una fotografia sto-rica, poteva “sparire” un personaggio in disgrazia,comparirne uno in auge o, per dirla con MilanKundera, restarne soltanto il cappello6.
Spesso l’oblio del passato è utile per liquidareuna parte della storia e, di conseguenza, per rifon-darla ex novo. Perciò non si tratta soltanto di can-cellare o di distruggere simbolicamente le memo-rie del passato –si pensi agli incendi dei libri,all’abbattimento delle statue e dei monumenti,all’imposizione di nuovi nomi a strade o a piazze-ma anche di alterarle. È quanto si verifica nelromanzo di Orwell sia a livello collettivo, attra-verso le direttive del partito, sia a livello indivi-duale attraverso l’uso di interrogatori oppressiviche mirano a “riprogrammare” e “rieducare” la
Il cinema e la memoria - Locandina del thriller ricavatodalla storia dello strangolatore di Bel Air
5 George Orwell 1984. Mondadori, Milano 1981 pp. 287.6 M. Kundera, Il libro del riso e dell’oblio, Adelphi Milano 1980, pp. 13-14.
71albErto olivErio
Chora N. 16, Settembre 2008
vittima, convincendola che la sua memoria è erra-ta. Ma senza giungere agli estremi descritti daOrwell, è possibile che qualcosa di simile accadanella realtà, che noi riteniamo che alcuni nostriricordi siano reali –mentre in realtà non lo sono-oppure che ciò che ci viene riferito a proposito diun qualche avvenimento modifichi la memoria chenoi abbiamo di quel fatto? È insomma possibileche la memoria sia molto -o totalmente- infedele?
Questo tema, al centro della teoria psicoanaliti-ca, è stato affrontato dallo stesso Sigmund Freudnel 1897 quando il padre della psicoanalisi si sof-fermò sul significato dei ricordi di presuppostitraumi e violenze sessuali risalenti all’infanzia delpaziente. Freud, inizialmente, ritenne che questiricordi che affioravano sotto ipnosi o nel corsodell’analisi, fossero veritieri e che bisognasseprestare loro fiducia; ma in seguito egli giudicòche si trattasse di confabulazioni fantastiche eche le memorie dei –presupposti- abusi sessualirisalenti all’infanzia fossero in realtà delle“memorie schermo”, distorsioni o proiezioni che,attraverso immagini visive “inventate” raffigura-vano i desideri o i conflitti inconsci del pazienteoppure facevano in modo di non fronteggiarequanto sui era realmente verificato. Ad esempio,secondo Freud il riaffiorare di (false) memorierelative a (presunti) abusi sessuali nel corso del-l’infanzia poteva dipendere da non esplicitate oesplicitabili pulsioni erotiche nei confronti dellapersona responsabile del presunto abuso.
Freud non chiarì mai in che modo l’analistapotesse separare le memorie reali o attendibili daquelle false o “di schermo” mentre altri studiosidella psiche hanno cercato di separare queste duediverse componenti dei ricordi. Uno degli studipiù approfonditi è stato effettuato dallo psicologoinglese Frederic Bartlett che si è servito di un’anti-ca leggenda indiana che ben si presta a interpreta-zioni e proiezioni soggettive: Bartlett raccontòquesta storia a un gruppo di volontari che doveva-no raccontarla nuovamente in diverse occasioni.Egli notò che i partecipanti a questo esperimentonon si attenevano alla storia: ne omettevano parti,adottavano “scorciatoie”, inserivano parti che piùche altro rispecchiavano le loro aspettative e valu-tazioni individuali. Man mano che passava iltempo, la storia si modificava e veniva “contami-nata” da ricostruzioni che non erano tanto dovutea dimenticanze quanto a modifiche. Servendosidei risultati di questo e di altri studi, Bartlett nededusse che molte memorie sono ricostruzioniimmaginarie del passato che rivelano le aspettati-ve di chi ricorda e le sue conoscenze generali,“regole” che vengono applicate a fatti specifici.Senza ricostruzioni, aspettative e regole, cioèsenza un canovaccio su cui disporre i singoli ricor-di, questi si presentano come eventi fluttuanti,imprecisi e confusi. Ciò implica che le memoriepossono essere ricostruzioni immaginarie del pas-sato? Il ricordo può essere completamente defor-mato o indotto ad arte?
Quanto sono affidabili le testimonianze?Per affrontare questo aspetto della memoria con-
sideriamo un classico caso della realtà quotidiana:immaginate di essere testimone di un crimine e diascoltare un secondo testimone che fornisce unadescrizione verbale di quell’avvenimento. Ilsecondo testimone viene ascoltato dalla polizia
per primo e chi stende il verbale vi enuncia alcunidei punti-chiave della sua testimonianza, ritenen-do di aiutarvi a fissare la vostra deposizione nel-l’ambito di una trama ben precisa: “Il colpevoleera un ragazzo di media statura, capelli castani,occhi scuri, giubbotto jeans. Il ragazzo avevaun’espressione provocatoria e ha colpito con unpugno la vittima che è caduta a terra, battendo lafronte”. Il poliziotto, normalmente, non dovrebbeagire in questo modo in quanto, dandovi una trac-cia verbale dell’accaduto, altera la vostra memoriavisiva: le parole hanno il potere di generareun’immagine del colpevole e della scena del crimi-ne che compete con l’immagine che ne avevate e lasposta dalla vostra memoria. Lo stesso meccani-smo può modificare non soltanto memorie visivema anche olfattive o gustative. Se dopo averassaggiato un vino (ed esservene fatta una memo-ria gustativa) ascoltate la descrizione di quel vinofatta da una terza persona, c’è il rischio che ilvostro ricordo venga pregiudicato: il linguaggioha il potere di sostituirsi a una parte del vostroricordo gustativo o visivo. Altrettanto avvienequando la descrizione di un fatto specifico vienefiltrata attraverso le conoscenze generali cheabbiamo sui tipi di dinamiche in cui ricade quelfatto: nell’ascoltare la descrizione che ci vienefatta siamo portati a “correggere” inconsciamentegli errori che cogliamo in quel racconto e a codifi-care la descrizione di quel fatto in modo “rivedu-to e corretto” , lo alteriamo rispetto alla realtà. Unamico, ad esempio, ci racconta in modo dettaglia-to l’incidente che gli è capitato mentre usciva daicancelli dello stadio insieme ai tifosi della squadra
Marguerite Yourcenar
QuantoèvEritiEraEStabilElamEmoria?
Chora N. 16, Settembre 2008
72
locale: “La partita era appena finita e mentre i tifo-si dell’altra squadra lanciavano mortaretti perfesteggiare la vittoria io e i soliti amici siamo usci-ti dai cancelli della curva nord per raggiungere iparcheggi. Appena usciti ci siamo imbattuti in ungruppo di tifosi dell’altra squadra…”. È probabileche nel visualizzare la descrizione fattavi dal-l’amico abbiate corretto, senza stare a farlo notare,la “curva nord” con “curva sud”, poiché è da quel-l’uscita che escono sempre i tifosi della vostrasquadra. La correzione non verrebbe inveceapportata da un tifoso di un’altra città o da chinon conosce la situazione e le regole dello stadioche frequentate normalmente. È un esempio bana-le, ma in numerose situazioni la nostra mente“corregge” autonomamente le cronache parlate oscritte di un fatto particolare quando è esperta diquella realtà. In altre parole, la conoscenza dellasituazione induce inferenze sul modo in cui rece-piamo l’informazione e la codifichiamo sottoforma di memorie.
Il fatto che la nostra memoria possa venireingannata in modi diversi implica che le testimo-nianze non sono affidabili? La risposta a questadomanda, che riveste una notevole importanzaper diversi aspetti della vita quotidiana e sociale,non è né si né no: dipende dalle circostanze e dalmodo in cui la testimonianza viene raccolta eorientata. Per affrontare questo tema, partiamo dauna delle prime ricerche effettuate in questocampo da Elisabeth Loftus, una psicologa dellaWashington University7. La Loftus era partita daun famoso caso giudiziario degli anni Settantache, a quei tempi, era ben noto come “il caso dellostrangolatore di Bel Air”. Dopo una serie di delit-ti che avevano tenuto in scacco la polizia di LosAngeles, lo “strangolatore” era stato finalmentearrestato e aveva confessato di aver strangolatonumerose donne californiane e due donne delloStato di Washington. Lo strangolatore, taleKenneth Bianchi, sembrava però poco affidabile: avolte diceva di aver strangolato una vittima sulsedile della propria automobile mentre il cugino,Angelo Buono, guidava. Ma in seguito disse diricordare di essere entrato in una casa e di avervisto il complice che strangolava la donna.Un’altra volta raccontò agli avvocati e agli psi-chiatri che lo interrogavano che non era ben certodi essere stato lui a strangolare le sue vittime e cheaveva l’impressione di aver tratto i particolari che“ricordava” dai verbali e dagli interrogatori dellapolizia. Bianchi mentiva? Era uno psicopaticoaffetto da turbe della memoria? Simulava per otte-nere l’infermità mentale? Venne chiamata in causaElisabeth Loftus, che aveva già una notevole famanel campo della memoria, e le fu chiesto se erapossibile che la memoria dello “strangolatore”vacillasse e che un assassino dimenticasse unaserie di omicidi. La psicologa rispose che una talepossibilità era tutt’altro che remota “in quanto lamemoria di chiunque può essere manomessa”. Ilcaso suscitò notevoli polemiche e la Loftus precisòin seguito che in casi simili bisogna tenere contodi vari fattori legati sia alla personalità individua-le sia alle condizioni in cui è stata resa la primatestimonianza. Nel caso specifico, Bianchi presen-tava indubbiamente disturbi della personalità chepotevano più facilmente “convincerlo” del fatto
che le condizioni in cui si erano svolti gli omicidierano diverse dalla realtà ma, date le sue caratte-ristiche psichiche, anche il ruolo svolto dalla poli-zia poteva aver “alterato” i suoi ricordi.
Anche cittadini “onesti”, sostenne Loftus, possonoavere la testa piena di falsi ricordi. Se, per esempio,una persona vede un individuo sospettato di omici-dio con occhiali e capelli lisci e poi qualcuno parladei “capelli ricci” del sospetto omicida, nel maggiornumero dei casi il testimone “ricorda” un colpevoledai capelli ricci, generalmente senza occhiali. Così,in altri esperimenti sulla memoria dei testimoni, iparticolari forniti da altre persone potevano conta-minare il ricordo: i testimoni potevano esser indottia ricordare capannoni che non avevano mai visto, atrasformare automobili gialle in rosse e, soprattutto,a modificare le testimonianze sulla base del modo incui venivano loro presentata la situazione. Ad esem-pio, testimoni oculari possono valutare più grave unincidente d’auto quando viene loro richiesto come ledue automobili si sono “fracassate” anziché “urtate”in quanto diverse parole possono evocare diversilivelli di gravità dell’incidente.
Se la manipolazione verbale di un ricordo può alte-rare la memoria dell’ascoltatore, la manipolazionedelle memorie visive ha un effetto decisamente supe-riore, come indicano alcune recenti ricerche suglieffetti di contaminazioni e falsificazioni di “docu-menti” fotografici, attuate attraverso semplici softwa-re, ormai a disposizione di tutti: in particolare, comehanno indicato gli psicologi cognitivi, le false imma-gine che si riferiscono alla nostra infanzia possonogenerare false memorie, essere cioè incorporate nellamemoria autobiografica e convincerci che un partico-lare evento si è veramente verificato. Le immagini,infatti, possono ingannarci più delle parole, ad esem-pio più di un racconto con cui si cerca di impiantarenella mente di una persona una falsa memoria. Annior sono, una delle maggiori studiose della memoriaautobiografica, Elizabeth Loftus, ha fatto un esperi-mento in cui dei volontari dovevano leggere delle sto-
Joseph LeDoux
7 E.F. Loftus, Eyewitness testimony. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1979.
73albErto olivErio
Chora N. 16, Settembre 2008
rie della loro infanzia scritte da membri della propriafamiglia: una di queste, d’accordo coi parenti, era falsae narrava, ad esempio, di quella volta in cui il volonta-rio, da bambino, si era perso in un supermercato.Interrogati su questo “evento” della propria infanzia,circa 1/3 dei volontari ne “ricordava” numerosi partico-lari, ovviamente indotti dalla propria fantasia. Oggi unesperimento simile è stato condotto utilizzando fotomanipolate, fornite da parenti compiacenti, d’accordocioè con lo sperimentatore. Una delle foto più utilizza-te riguardava un’improbabile ascensione in un palloneaerostatico, effettuata nella prima infanzia dal gruppofamiliare: in questo caso più della metà delle personesottoposte al test si è convinta di aver effettuato quelviaggio ed ha aggiunto, nel “ricordarlo” una serie diparticolari, congrui con la situazione ma totalmenteinventati…
Memorie ristrutturateGli studi più recenti sulla memoria indicano come i
ricordi non siano soltanto instabili ma vengano anchecontinuamente ristrutturati, come mostrano le ricerchecondotte dallo psicologo Larry R. Squire sugli effettidell’elettroshock. È ben noto che questo trattamento,usato ancora dagli psichiatri in casi di grave depressio-ne nervosa, ha un effetto negativo sulla memoriaumana e animale. Se esso viene somministrato subitodopo un’esperienza, prima cioè che avvenga il consoli-damento della memoria a breve termine nella forma alungo termine, si verifica un’amnesia retrograda, vienecioè cancellato il ricordo di quell’esperienza in quantol’elettroshock disturba i fenomeni elettrici che caratte-rizzano la memoria a breve termine e questa non si con-solida. Squire ha però indicato come l’elettroshock nonagisca soltanto sul processo di consolidazione dellamemoria, cioè sulla trasformazione da memoria breve amemoria lunga, ma anche sulle memorie già consolida-te. Ciò contraddice in qualche misura un vecchiodogma sul consolidamento della traccia della memoria:infatti, gli psicobiologi ritenevano che, una volta conso-lidata, la memoria non potesse essere più turbata daquei trattamenti, come l’elettroshock, che provocano undissesto dei fenomeni elettrici che sono alla base dellamemoria breve e da cui si passa alla memoria a lungotermine. Il fatto che l’elettroshock agisca anche a
distanza di mesi sia su memorie di tipo associativo chesu vere e proprie memorie di tipo cognitivo, cancellan-do parte dei ricordi già registrati, indica che la memo-ria è suscettibile di rimaneggiamenti e rielaborazioni.Oggi non si parla tanto o soltanto di “consolidamento”della memoria, cioè di una codifica stabile dell’espe-rienza, ma di “ri-consolidamento”, un continuo proces-so di rimpasto della memoria che è tutt’altro cheobbiettiva.
Il ri-consolidamento viene considerato come una stra-tegia per integrare i nuovi apprendimenti nelle espe-rienze precedenti che sono soggette a ristrutturazioni,come hanno indicato Joseph LeDoux e Karim NaderSusanne Sara in una serie di risultati sperimentali chehanno indicato come la memoria non sia una fotografiastabile del passato. Nei classici esperimenti sul bloccodel consolidamento della memoria da una fase labile auna stabile, gli animali ricevevano un’iniezione intrace-rebrale di un antibiotico al termine della seduta diapprendimento: quando l’inibitore della sintesi protei-ca veniva somministrato immediatamente dopo l’espe-rienza questa non veniva consolidata: la somministra-zione dell’antibiotico era invece inefficace quando essaavveniva alcune ore dopo, cioè quando aveva avuto giàluogo il processo di consolidamento. Nader e LeDouxhanno invece dimostrato che se gli animali, dopo averconsolidato una particolare esperienza o stimolo, sononuovamente sottoposti a una breve esperienza simile aquella precedente e subito dopo vengono iniettati conl’antibiotico, il ricordo è in buona parte cancellato: inaltre parole la loro memoria da stabile diventa instabi-le quando essi rivivono la prima esperienza8. Il termineri-consolidamento sta perciò a indicare che l’atto diricordare qualcosa rende la traccia mnemonica flessibi-le, soggetta a rimanipolazioni e ristrutturazioni.
La memoria, quindi, anziché essere stabile è dinami-ca, il che getta un ponte tra biologia e quelle “terapiedella parola” che sostengono che focalizzarsi su alcuneesperienze traumatiche sia essenziale per poterle modi-ficare, per ri-consolidarle in forma accettabile. Negliesseri umani, suggerisce Erik Kandel9, la terapia dellaparola ristrutturerebbe le esperienze rivissute, cosìcome avviene per la memoria degli animali, suscettibi-le di cambiamenti quando essi rivivono un’esperienzagià nota.
8 Nader, K. Memory traces unbound, Trends in Neuroscience 26, 63, 2003.9 Kandel E. Psichiatria, psicoanalisi e nuova biologia della mente. Raffaello Cortina, Milano 2007.
alberto oliverio (Catania, 1938) è uno dei più importanti neurobiologi italianied è conosciuto al grande pubblico per la sua intensa attività divulgativa. Dopoessersi laureato nel 1962 a Roma in Scienze naturali, ha lavorato in diversi cen-tri di ricerca italiani e stranieri, tra cui il Karolinska Institutet di Stoccolma (dal1964 al 1965), l’Università di California a Los Angeles (dal 1965 al 1967), ilJackson Laboratory del Maine (Usa). È stato direttore dell’Istituto diPsicobiologia e psicofarmacologia del CNR di Roma dal 1976 al 2002 e docentedi Psicobiologia presso la facoltà di Scienze della Sapienza, Università di Roma.Si interessa, in particolare, dei rapporti che intercorrono tra lo sviluppo e il fun-zionamento cerebrale e i fattori genetici e dei processi di apprendimento ememoria. Ha, inoltre, elaborato un modello che spiega la dinamica dello stress.Fa parte del comitato editoriale di numerose riviste scientifiche e collabora alCorriere della Sera, al Messaggero e alla rivista Mente e Cervello. È autore di circa400 pubblicazioni scientifiche e numerosi libri, tra cui ricordiamo: Il tempo ritro-vato: la memoria e le neuroscienze, Theoria, Roma, 1990; Ricordi individuali, memo-rie collettive, Einaudi, Torino, 1994; L’arte di ricordare, Rizzoli, Milano, 1998;Memoria e oblio. Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003; Le età della mente (con AnnaOliverio Ferraris), Rizzoli, Milano; Istruzioni per restare intelligenti. Rizzoli,Milano 2005; Come nasce un’idea. Rizzoli, Milano 2006.
lo Spazio dElla mEmoria
Chora N. 16, Settembre 2008
74
Premessa: spazio, memoria, immaginazione[Chora] Professor Berthoz, leggendo i suoi libri, e ascol-
tando le Sue lezioni al College de France, siamo rimasticolpiti dal modo in cui le ha affrontato il tema dellamemoria, esibendo la stretta relazione che esso intrattienecon la facoltà dell’orientamento nello spazio. Abbiamoconstatato altresì la presenza, nel Suo discorso, di fre-quenti riferimenti alle antiche arti della memoria, basatesul principio della costruzione (o “emulazione”) di unaspazio immaginario artificiale e sulla conseguente asso-ciazione dei contenuti mnestici ai luoghi e alle regioni con-tenute in questa architettura di finzione. Le domande chevorremmo rivolgerle sono dunque incentrate sul rapportodi stretta implicazione che sembra sussistere tra le facol-tà della memoria, dell’immaginazione e dell’orientamentonello spazio.
1. Una domanda introduttiva, relativa alla Sua bio-grafia intellettuale e professionale: le neuroscience ela fenomenologia
Professor Berthoz, attraverso alcuni brillanti saggi, epoi con l’insegnamento presso il College de France, Lei haofferto anche al pubblico dei non specialisti un’importan-te occasione per apprezzare la ricchezza di un approcciotransdisciplinare dedicato allacomprensione dei meccanismidella mente. In particolare nel suolavoro è possibile constatare lapresenza di un confronto attento eminuzioso con la filosofia e con isaperi umanistici. Pensiamo inparticolare all’ultimo saggio cheLei ha pubblicato presso OdileJacob, Phenomenologie et philo-sophie dell’action, che si è giova-to della collaborazione di ungrande fenomenologo già datempo impegnato sul terreno delleneuroscienze, Jean-Luc Petit.Questo saggio prosegue una tradi-zione di interazione tra le scienzenaturali e la fenomenologia che èda tempo viva in Francia (pensia-mo ad esempio al libro-dialogotra Paul Ricoeur e Jean-PierreChangeux, La natura e la regola,pubblicato in Italia da RaffaelloCortina, nella collana Scienza e Idee). Vorremmo chieder-le, sulla base della sua esperienza e dell’orizzonte teoriconella quale si muove la sua ricerca scientifica, quali sianole prospettive per una interazione profonda tra le scienzecognitive e la fenomenologia; quali istanze conoscitiveabbiano determinato un progressivo avvicinamento tra
gli studiosi di fenomenologia e i ricercatori impegnati sulterreno delle scienze sperimentali, e quali sono stati imotivi del suo personale percorso di ricerca e della suamaturazione professionale che l’hanno spinto ad avvici-narsi a una prospettiva come quella husserliana, di matri-ce trascendentalista e incarnata.
[Alain Berthoz] Il progetto interessante del movimentodelle scienze cognitive consiste precisamente in un avvici-namento tra, da un lato, le neuroscienze e, dall’altro, l’in-sieme delle scienze e delle discipline umane e sociali chehanno come oggetto il funzionamento delle facoltà piùsemplici e di quelle più elevate del cervello umano.Rispetto a ciò, la collaborazione tra gli specialisti delle neu-roscienze e della psicologia sperimentale e i filosofi è unodegli elementi essenziali di questo programma. Fin daquando abbiamo creato questo programma e fin dal primogrande convegno orientativo, che ho presieduto negli anni‘80 e che ha tentato di definire in Francia l’ambito dellescienze cognitive, è stato chiaro che la collaborazione, ilconfronto delle teorie e delle idee tra le scienze del cervel-lo e i filosofi erano uno degli assi fondamentali. Perché lafenomenologia nell’ambito degli approcci nelle scienzecognitive?
Almeno in Francia, i primi par-tner filosofici degli psicologi e deineurologi che si sono interessati afondare questo movimento sonostati i nostri amici e colleghi appar-tenenti alla scuola della filosofiaanalitica. Cioè i primi che, quindicio vent’anni fa, hanno lavorato inFrancia con i neurofisiologi e i mate-matici che hanno voluto creare que-sto movimento sono stati PierreJacob, Dan Sperber, FrançoisRecanati (che è un linguista), cheerano una testa di ponte delle scuo-le di filosofia analitica americana(vorrei peraltro precisare, all’iniziodi quest’intervista, che non preten-do di essere un filosofo). Alla secon-da corrente, che è stata nostro par-tner dal lato della linguistica, appar-tengono degli studiosi comeJacques Mehler che erano ancheloro, in fondo, delle teste di ponte
della grammatica generativa, in un momento in cui, inFrancia, la linguistica era orientata piuttosto verso la diver-sità delle lingue ecc. Durante i primi dieci anni abbiamoavuto delle interazioni assai scarse con i fenomenologi. Insostanza, con l’eccezione di Jean Petitot, matematico mafilosofo per passione e per vocazione e di Francisco Varela,
lo spazio della MeMoria: il senso del MoviMento e i ricordi in azione
college de France - parisa cura di MassiMiliano cappuccio, eMiliano trizio, Martino incarBone, lodovica Maria zanet
intervista ad alain Berthoz
Alain Berthoz
75alain bErthoz
Chora N. 16, Settembre 2008
che non era neanche lui un filosofo ma un neurofi-siologo eccezionale, non abbiamo avuto molta eco.Soltanto recentemente si è verificato questo avvici-namento con dei fenomenologi.
Per me tutto è cominciato con l’apparizione del mio libro Ilsenso del movimento1 che ha suscitato l’interesse di almeno duefenomenologi: da una parte, Jean-Michel Roy e, dall’altra,Jean-Luc Petit, specialisti di Husserl, che, ciascuno a modo suo,fin dall’apparizione de Il senso del movimento mi hanno propo-sto delle collaborazioni su questo argomento. Mi hanno spie-gato che ero un fenomenologo inconsapevole e che le idee cheho sviluppato ne Il senso del movimento erano una formulazio-ne che si avvicinava alle idee fenomenologiche. È vero che erostato molto influenzato dagli scritti di Sarte e di Merleau-Ponty. In realtà, a parte questi sviluppi recenti che mi hannoriguardato personalmente, c’era e c’è un bisogno profondod’avvicinamento tra la fenomenologia e le scienze cognitive,poiché la filosofia analitica, e credo che la mia posizione sianota, parte da un presupposto teorico che accorda una premi-nenza al linguaggio e alla logica, mentre le neuroscienze e lapsicologia moderna hanno rivelato fino a che punto, comedice Faust, “in principio non era il verbo, ma l’atto” (che è laprima frase che ho messo nel mio libro Il senso del movimento).
Le scoperte delle neuroscienze moderne hanno rivelatoche non c’è percezione passiva, che il cervello proietta lesue intenzioni, che l’atto è all’origine di una selezione delleinformazioni ecc. quindi che non si poteva sperare dicostruire un programma scientifico sulla comprensionedel cervello unicamente con una teoria filosofica che davacome fondamento, in ultima analisi, il linguaggio o la logi-ca, mentre bisognava anche cercare, e si badi che ho detto“anche”, il fondamento delle funzioni cognitive più eleva-te nell’atto e nel vissuto. È questo ribaltamento di paradig-ma che è stato necessario.
Ma vi sono motivi ancora più profondi. Penso che il ven-tesimo secolo, e, in particolare la sua seconda parte, siastato dominato, in Francia soprattutto, da un pensiero stra-ordinariamente astratto in tutti i campi (ma è una vecchiastoria, visto che si dice che la Francia è cartesiana, ecc.). Inmatematica ciò risulta evidente dalla vittoria di Hilbert suPoincaré, con il notevole successo della matematica assio-matica contro l’approccio di Poincaré che ancorava la geo-metria nei movimenti, nelle sensazioni muscolari. PersinoEinstein diceva: “Poincaré ha ragione, bisogna ancorare lageometria all’esperienza sensibile”. Ma ciò è vero anchenel teatro: si vede dominare il teatro della parola contro ilteatro del corpo vissuto. Per un rinnovamento del corposensibile al teatro, avevamo nominato al Collège de FranceJerzy Grotowski, che aveva del resto il suo teatro in Italia.Era uno dei grandi rappresentanti di quest’altra concezio-ne del teatro che è il teatro delle emozioni (come Strehler,anche lui a voluto farne la sintesi e, in Francia, dei grandiregisti di teatro come Marianne Mnouchkine, che rappre-sentava Shakespeare con la messa in scena di Kabuki e cheha voluto recuperare il teatro dell’emozione, del corpo vis-suto di contro al teatro della parola). Ma ciò è vero anchein economia, dove ha dominato una concezione dellamodellizzazione basata sulla razionalità, sull’uomo che sipoteva rappresentare con dei processi logici. Lo stesso èsuccesso, sempre in Francia, con la psicoanalisi. Si manda-vano i bambini autistici dagli psicoanalisti e si accusava lamadre morbosa di avere dei deficit di comunicazione ver-bale, quando la causa è in realtà genetica, anche se dei fat-tori psicosociali possono forse risultare aggravanti. Permodificare questo punto di vista ho organizzato presso ilCollège de France un grande convegno sull’autismo in cui
abbiamo riunito tutte le tendenze su questo argomento2. Innumerosi ambiti del pensiero, della scienza e della cultura,dominava questa visione astratta. Credo che una partedella disattenzione iniziale per gli approcci fenomenologi-ci sia stata dovuta in parte a questo. A ciò si aggiunge uncerto disprezzo (che io ho percepito) nei confronti dell’ap-proccio fenomenologico, giudicato come fondamental-mente triviale e aneddotico come la folk-psychology. Poichéio lavoro sull’azione e sulla percezione e poiché sono statotra coloro che, a partire dai dati sperimentali, hanno sco-perto a qual punto l’azione giochi un ruolo essenziale nellapercezione, era naturale che mi avvicinassi alla fenomeno-logia. Oggi la battaglia è in parte vinta, tutti parlano diembodiment, d’incarnazione, del corpo in atto, di sistemispecchio; ma non era così dieci anni fa!
Un’altra ragione che corrisponde al mio percorso perso-nale è che sono stato ammesso all’esame di maturità di filo-sofia nello stesso momento dell’esame di matematica esono passato perché ho avuto molta fortuna. Una mia cugi-na mi ha fatto leggere l’Etica a Nicomaco di Aristotele. È suc-cesso che, per un colpo di fortuna inaudito, all’orale di filo-sofia il professore mi ha domandato se avessi letto l’Etica aNicomaco. Ho detto di sì e mi ha interrogato. Era uno deipochi filosofi che avessi letto. L’altro filosofo che ho lettomolto all’epoca dell’Ecole de mine, è Merleau-Ponty, per-ché era uno dei pochi che potessi comprendere (sono unospirito semplice…). Ho letto molto La struttura del comporta-mento ecc., ma anche le opere di Cassirer (che non è un feno-menologo) man mano che sono state pubblicate presso leEditions de Minuit (sapete che è stato pubblicato molto tardi)e Sarte, di cui ho letto molte cose e soprattutto la teoria delleemozioni; eppure non conoscevo per nulla l’opera diHusserl, avevo letto gli epigoni. Quindi ho avuto, in fondo,una cultura naif da filosofo naif grazie alla lettura di filoso-fi come Sartre, Merleau-Ponty, Cassirer. Ho sempre letto eriletto i libri di Merleau-Ponty, perché ci ho sempre trovatoun’eco rispetto ai lavori che facevamo sul comportamentoe la percezione; it was ringing in my brain, leggevo delle frasie qualcosa risuonava nel mio cervello. È un processo un po’strano che avviene alla frontiera tra le discipline.
Vi racconterò un aneddoto per farvi vedere l’impattoche hanno avuto dei fenomenologi come Merleau-Pontysui neurologi. Un giorno ero in Giappone e bevevo un tècon un grandissimo neurofisiologo, Hideo Sakata, che èstato il primo a scoprire nella corteccia parietale dei neu-roni che codificano la forma degli oggetti. In generale,era una proprietà conosciuta per i neuroni della cortecciainferotemporale, proprio in fondo alla catena di ricostru-zione degli oggetti. Sakata mi disse: «le faccio vederequalcosa». Estrasse un libro di Merleau-Ponty e mimostrò un paragrafo che aveva sottolineato. Quindidisse: « ciò è stato predetto da Merleau-Ponty, ed èMerleau-Ponty che mi ha dato l’idea dell’esperimento:sono stato un allievo di Merleau-Ponty, perché sonovenuto in Francia e ci ho passato due anni, e ho seguito icorsi di Merleau-Ponty. Un giorno, rileggendo il suolibro, ho avuto l’idea di questo esperimento.»
Quindi vi è una ragione profonda, teorica, ma non sonosicuro che si possa dire che c’è un avvicinamento progres-sivo tra i fenomenologi e gli specialisti di scienze speri-mentali. La mia sensazione è che si andasse a interrogare ilcervello di un certo numero di psicologi, di neuroscienzia-ti, in particolare in Francia, ci si renderebbe conto del fattoche, come per caso, hanno letto dei lavori di fenomenologi,ma è un’indagine che resta ancora da fare. Ciò è vero in par-ticolare di quei fenomenologi che hanno scelto di parlare
1 A. Berthoz, Le sens du mouvement, Odile Jacobe, Paris: 1997. Trad. It : Il senso del movimento, Mc Graw-Hill, Milano1998.2 Si veda, A. Berthoz ed. L’Autisme, de la recherche à la praitique, Odile Jacob, Paris: 2005.
lo Spazio dElla mEmoria
Chora N. 16, Settembre 2008
76
un linguaggio comprensibile, poiché non è così per tutti ifenomenologi. Potrebbe essere interessante per la vostra ricer-ca vedere non solamente cosa ha determinato un avvicina-mento progressivo, ma anche in quale misura un linguaggiooscuro di un certo numero di filosofi, esegeti della fenomeno-logia, abbia impedito il contatto con gli scienziati. In effetti,per fare questi accostamenti interdisciplinari, bisogna comun-que fare dei compromessi; non bisogna trincerarsi in una fra-seologia che fa sì che non si possa comunicare con una cultu-ra comune, e questo è uno dei problemi. Un altro problemache esiste in Francia, di cui forse siete a conoscenza, un pro-blema importante anche se oggi, forse, meno cruciale, è che,quando abbiamo dato vita al movimento delle scienze cogni-tive, circa quindici anni fa, i giovani filosofi che volevano fareuna carriera in filosofia erano formati soprattutto negli studidi storia della filosofia. Cioè si proponevano loro delle tesi sulgiovane Heidegger, ilvecchio Kant, ecc. e nonsugli oggetti mentali. Sirichiedeva loro insommanon di filosofare sullefunzioni cognitive, maun lavoro da storici dellafilosofia. Non so se siacosì in Italia, ma inFrancia questa era la dif-ficoltà. Io ero al consigliodell’Ecole NormaleSupérieure, dove abbia-mo avuto dei dibattitiinteressanti a questo pro-posito e, fortunatamente,all’ENS, per esempio, epresso un certo altronumero di altre cattedredi filosofia, poco a poco siè potuto dare spazio agiovani filosofi chehanno preso come ogget-to della filosofia il funzionamento del cervello (hanno corsoun rischio). Ciò ha prodotto forse anche dei riavvicinamenticon la fenomenologia. Quindi, in tutto ciò, ci sono degli aspet-ti teorici, ma anche degli aspetti che riguardano la politica e lasociologia della scienza.
2. Categorie ed esperienza, tra prima e terza personaI suoi esperimenti dedicati ai riferimenti ego/allocentrici
della codifica spaziale hanno segnato un decisivo passo inavanti per la comprensione della categorizzazione a livellocognitivo. Ci sembra inoltre che questi dati possano essereinterpretati nell’ottica della dottrina fenomenologica dellecinestesi, intese come sequenze di adombramenti intenzio-nali possibili che sono alla base della costituzione dello spa-zio intersoggettivamente condiviso. È allora possibile par-lare di un meccanismo biologico che sia alla base della cate-gorizzazione intellettuale dello spazio geometrico, intesocome spazio astratto delle operazioni logiche superiori,oppure è unicamente al progresso scientifico e intellettualeche dobbiamo le categorie euclidee? Che ruolo gioca, a suoavviso, la percezione del corpo proprio e dei suoi confinisomatosensoriali per quanto riguarda la costituzione dellospazio puro della geometria, con le sue relazioni metricheesatte e le sue forme idealmente perfette? In che misura leneuroscience ci autorizzano a parlare di “fondamenti cogni-tivi delle scienze geometriche”?
Ho tenuto ben due corsi su questi temi al Collège deFrance. Qualche hanno fa ho tenuto un primo corsosui fondamenti cognitivi della geometria: questo benprima di pubblicare il mio libro sul «Senso del movi-mento», ma anche prima di conoscere Jean-Luc Petit edi lasciare che egli mi iniettasse massicce dosi di filo-sofia husserliana. In questo corso avevo sostenuto, alpari di Poincaré e di Einstein, che i fondamenti dellageometria non potevano trovarsi negli aspetti pura-mente assiomatici delle teorie, ma piuttosto che i fon-damenti cognitivi della geometria andavano rintraccia-ti nell’esperienza vissuta, negli atti e nei meccanismicerebrali di quella che io chiamo ora la perc-azione,ovvero la cinestesi interpretata in senso lato, l’azionedel corpo proprio sul suo mondo ambiente (Umwelt).Avevo dunque iniziato con il proporre questa idea e,
dal momento che nonsono né una geometrané tanto meno un filo-sofo, quello che avevofatto era stato di correreun rischio. Avevo invi-tato un matematico egeometra molto famo-so, Bernard Teissier3, ilquale mi aveva dettouna cosa che mi avevafatto molto piacere:«Berthoz ha ragione,quando mi trovodavanti a una lavagna evoglio spiegare una for-mula, talvolta un gestopermette di comunicareil messaggio altrettantobene di quanto lo possafare una formula». E finqui ero contento, maegli poi aveva aggiun-
to: «Il mio cervello di primate parla al cervello da pri-mate del mio collega e gli spiega il teorema», quanto adire che Teissier ammetteva sì che a un livello prima-rio l’azione e il gesto potessero in un certo senso tra-smettere un messaggio, ma che egli riconosceva ancheche lo spirito del matematico fa soprattutto riferimen-to a quell’universo astratto del quale parla ancheAlain Connes4. Sapete che Alain Connes ha una con-cezione molto platonica della matematica. All’epocaaveva dunque preso avvio un dibattito estremamenteinteressante sui fondamenti cognitivi della geometriache aveva dato conseguentemente vita a una serie diriunioni chiamate “GeoCo” e animate sia da JeanPetitot sia da Giuseppe Longo presso l’Ecole NormaleSupérieure. Questa serie di riunioni sono poi sfociatein un libro5 che riunisce i contributi dati in quellasede. Devo proprio a Giuseppe Longo il fatto di averepotuto apprendere molto su questi problemi, in parti-colare su ciò che concerne le discussioni su quell’intui-zionismo francese che ebbe Largeault tra i suoi rap-presentanti. Lo scorso anno accademico ho invecetenuto un corso sullo spazio nel quale ho affrontato divolta in volta ognuno dei problemi evocati in questasede – ed è perciò molto difficile rispondere in cinqueminuti a tutte le domande, dunque l’unica cosa che sipuò fare è di dare risposta a una o due di esse.
Attivazioni neuronali durante le saccadi oculari
3 Bernard Teissier è un matematico francese contemporaneo, impegnato tra l’altro nel centro di ricerca della Equipe Géométrie etDynamique dell’Institut Mathématique de Jussieu (Paris).4 Matematico francese attualmente professore al Collège de France.
77alain bErthoz
Chora N. 16, Settembre 2008
Concentriamoci allora su di un caso classico, quello del-l’orientamento nello spazio. Quali tipi di memoria sonochiamati in causa e quale tipo di strategie cognitive ven-gono coinvolte?
Grazie ai dati fornitici dal brain imaging, dalla neurofisio-logia e dalla neuropsicologia, e in particolare grazie allericerche che facciamo con le équipes di Roma (Prof.Pizzamiglio, Prof. Guariglia) e di Chieti (Prof. Commiteri eProf. Galati) oggi sappiamo che il cervello manipola egestisce lo spazio con almeno due meccanismi, i quali sonoda una parte meccanismi di natura ego-centrata e, dall’altra,meccanismi di natura allo-centrata. Che cosa significa que-sta affermazione? Se io chiedessi al lettore di questo artico-lo di ricordarsi del percorso compiuto dalla propria abita-zione fino all’ufficio, egli potrebbe svolgere questo compi-to adottando determina-te strategie cognitive.Può ricordarsi i movi-menti del proprio corpo,le associazioni di questimovimenti con degliindici visivi, degli inci-denti, degli episodi(memoria episodica); ciòchiama in causa in modoego-centrato la compo-nente vissuta, i movi-menti del corpo, le cine-stesi: è questa la strategiache preferiscono ledonne, ma che è anche laprima strategia ad essereutilizzata dai bambini,come ci hanno mostratogli studi di Piaget. Vi è tuttavia anche una seconda strate-gia cognitiva, quella che rende possibile al medesimo letto-re di individuare il proprio tragitto ricostruendolo sullacarta, cosa che egli fa ogni volta che debba per esempioprogettare le proprie vacanze. Oggi sappiamo che ci sonoappunto queste due differenti strategie cognitive: l’una chesi fonda sul vissuto considerato in relazione ai movimenticorporei, l’altra contraddistinta dal passaggio a ciò chepotremmo chiamare una astrazione, una prospettiva dalbasso, un cambiamento del punto di vista che permette diprogettare il ritorno e che è a mio avviso (e senza alcundubbio) uno dei fondamenti cognitivi della geometria, per-mettendo appunto di manipolare lo spazio, di mutarepunto di vista, di individuare uno short-cut. Sappiamo chequeste due strategie utilizzano nello stesso tempo sia areecerebrali comuni sia sistemi cerebrali differenti. La strate-gia ego-centrata ricorre a un’area parieto-frontale che, peresempio, si riscontra essere lesa nei casi di deficit spazialitanto studiati dai nostri colleghi italiani: strutture coinvoltesia nella percezione del corpo proprio sia nella costruzionedella rappresentazione corporea, etc. L’altra strategia coin-volge strutture di tipo diverso come l’ippocampo e le areetemporali. Nel nostro cervello adulto noi abbiamo dunquecompresenti questi due meccanismi che sono dati sì insie-me, ma anche in competizione. Basta provare a consultareuna cartina mentre si guida un’auto per rendersi conto cheè possibile utilizzarli entrambi contemporaneamente.
Non vi è dunque opposizione, bensì complementarietà:la sfida della scienza contemporanea sta nel tentare dicomprendere in che modo questo processo si generi nel
corso dell’ontogenesi. Sapete che Piaget ha formulatol’ipotesi che il bambino cominci con una comprensionetopologica dello spazio per passare solo in un secondomomento a nozioni di tipo euclideo. Al giorno d’oggi noistiamo lavorando con dei matematici sull’idea che, in real-tà, non si debba nemmeno opporre l’acquisizione dellageometria euclidea astratta alla pura percezione cinesteti-ca del corpo, e che il cervello possa funzionare facendoimplicitamente riferimento a geometrie che non sono geo-metrie euclidee bensì geometrie loro affini. Personalmenteritengo di poter affermare – anche se compiendo questaaffermazione mi sbilancio sicuramente su una posizioneun po’ troppo radicale – che le geometrie che l’uomo ècapace di inventare non siano altro che quelle “nelle” e“con” le quali funziona il suo cervello, non essendo dopotutto il cervello altro che una parte del mondo fisico: oggi
le ricerche portate avantinel mio laboratorio e neilaboratori con i quali col-laboriamo hannoappunto la tendenza arimettere in discussioneche il cervello si basisolo su un tipo di geo-metria euclidea.
È dunque chiarissimoche ciò che voi chiamatela soggettività corporeae il vissuto dell’attosiano modalità essenzia-li di percezione dell’im-maginazione, di memo-rizzazione dello spazio,perfino di percorsomentale nei «palazzi
della mente», come dicono Frances Yates e Mary J.Carruthers. Sappiamo però che vi sono strutture implica-te sull’altro versante: quello della creazione di una geome-tria astratta. Noterete che sto evitando il termine “rappre-sentazione” – da buon merleau-pontiano! Malgrado tutto,lo scarto tra il concreto vissuto cinestetico e la costruzionedi un’idealità astratta resta comunque per me un mistero.
Quale spazio hanno occupato questi temi nei Suoilavori più recenti?
Pensiamo al libro su «Fenomenologia e fisiologia del-l’azione6» scritto con Jean-Luc Petit. Esso è nato nelseguente modo: per cinque anni Jean-Luc ed io abbia-mo organizzato degli atelier nei quali fisiologi, matema-tici, filosofi, etc. hanno avuto modo di intervenire suidifferenti aspetti del tema “azione” come l’anticipazio-ne, i modelli interni, i punti nei quali sembrava essercisintonia con la proposta fenomenologica di Husserl. Aun certo punto abbiamo deciso di iniziare a lavorareinsieme sul tema della cinestesi, tema che io non cono-scevo, ma che Petit conosceva invece molto bene. Hoesposto il metodo di ricerca da noi seguito nell’introdu-zione al testo: Petit preparava dei testi che non eranotanto di Husserl quanto piuttosto di un Husserl letto edinterpretato da Petit, me li sottoponeva e io reagivo. Siè fatto, sul modello degli Changeux-Connes / Ricoeur-Changeaux7, un testo-dialogico nel quale mi era data lapossibilità di reagire e di protestare. Sono intervenutosoprattutto sul problema dell’idealità, perché nutrivo
Attivazioni cerebrali associate all'esecuzione della memoria di sequenze di saccadi ocualari apprese come nuove (A) o già famigliari (B)
5 Si veda G. Longo (a cura di), Géométrie et Cognition, in «La Revue de Synthèse», n. 124 (num. speciale), Editions de la rue d’Ulm,Paris 2003.6 A. Berthoz, J.-L. Petit, Phénoménologie et physiologie de l’action, Odile Jacob, Paris 2006.
lo Spazio dElla mEmoria
Chora N. 16, Settembre 2008
78
molte resistenze nel lasciarmi trascinare in questo saltoverso il trascendentale e verso l’ideale, anche se i nostriconfronti-scontri sono poi stati notevolmente smussatigrazie alla sapiente mediazione del nostro editore,Odile Jacob. Questo punto, al quale anche Lei facevariferimento, è dunque un cantiere aperto, nessuno oggiha una risposta. Ciò non toglie che si tratti di un magni-fico soggetto di dibattito, a partire dal fatto che ognunadelle parole di cui si componeva la Sua domandapotrebbe essere sottoposta a critica.
In primo luogo, non vi sono spazi puri in geome-tria. Pensiamo al libro, che amo particolarmente, diGilles Châtelet, Les enjeux du mobile8: esso mette pre-cisamente in dubbio la possibilità di uno spaziopuro, schierandosi su posizioni riconducibili a quel-le di Poincaré: il movimento si trova al fondamentodi ogni geometria. In secondo luogo, non vi sonorelazioni metriche esatte: una parte della geometriadi Alain Connes, la geometria non commutativa, èuna geometria che avvicina la geometria alla fisicastatica. Oggi vi sono dunque nuove frontiere tra geo-metria e probabilità.
Un aspetto interessante è quello dell’implicazione dellastrategia ego-centrata nella costituzione di un sapere geo-metrico.
Si tratta di un punto di fondamentale importanza. Peresempio, nell’ippocampo si trovano dei neuroni detti«neuroni di posizione (neurons de place)». Questi neuroni siattivano quando il topo, forse anche la scimmia, si trovanoin un luogo, in un posto del mondo ambiente. Alcunihanno così avanzato l’ipotesi che sia l’ippocampo il fonda-mento di quel che si chiama «mappa cognitiva»: ipotesiche prende il nome di «cognitive map»9.
Solo che questa selettività spaziale dei neuroni dell’ippo-campo non può né darsi né dirsi acquisita a meno che iltopo non si sposti nell’ambiente. Lo stesso accade per altrineuroni che sono stati scoperti da una decina d’anni appe-na, detti «neuroni di direzione» (les neurons de direction de latête). Questi neuroni hanno una primaria importanza, li siritrova in tutta una serie di strutture ed essi non si attivanose non quando la testa dell’animale si orienta in una certadirezione dello spazio, indipendentemente dal luogo nelquale l’animale si trovi in quel dato momento. Si tratta diuna codifica in un certo senso perfettamente astratta, trat-tandosi di una bussola neuronale.
Darwin del resto l’aveva predetto dicendo che gli eschi-mesi devono sapere dove si trovano, e che nella nostra testadebba esservi qualche cosa che presiede a questa funzio-ne. Sappiamo del resto che, di notte e al buio, noi sappia-mo perfettamente come è orientato il nostro corpo. È dun-que un sistema basato non sui luoghi, ma sulle direzioni.Ebbene, non è forse la stessa cosa che accade quando ineuroni di direzione costruiscono (guardate come sonoprudente, non ho usato il termine «costituiscono», ma misono invece espresso come i neurofisiologi) la loro geome-tria a patto che il topo possa esplorare attivamente il terre-no? Se il topo non può usare le proprie capacità cinesteti-che questi neuroni non hanno più le stesse proprietà.
Sembra dunque che l’esplorazione attiva del mondo siauno degli elementi fondamentali della capacità di accede-re allo spazio. Ciò non vuol dire, come invece tentano di
mostrarlo alcuni lavori degli antropologi, che noi nonabbiamo anche nelle strutture del sistema visivo unaorganizzazione neuronale innata che renda il cervellocapace di operare un’analisi astratta delle proprietà delmondo. Per esempio, le ricerche fatte nel nostro laborato-rio dal Dr. Jacques Boulez mostrano che il cervello del-l’uomo ha delle griglie d’analisi le quali fanno sì che egliricerchi la simmetria. Alla base di questo ruolo senzadubbio fondamentale dell’esperienza vissuta corporeastanno dunque dei meccanismi innati che rendono possi-bile un tipo di analisi astratta.
Il gioco tra le due dimensioni coincide con l’oggettodelle neuroscienze contemporanee. Non si tratta più diun dibattito tra scuole di pensiero: senza dubbio alcuno ilcervello possiede contemporaneamente entrambe le pro-prietà. Molte ricerche sullo sviluppo del bambino mostra-no per esempio che vi sono degli operatori – consideratida Piaget precoci sì, ma non poi così tanto – che sono inrealtà già presenti al momento della nascita anche seancora inutilizzati. Ciò significa che non è dunque per ilfatto che si manifestino tardi che alcune proprietà diastrazione non debbano esistere già precocemente. Ilfatto che la manipolazione dei punti di vista e le manipo-lazioni mentali delle quali abbiamo parlato supponganolo sviluppo della corteccia prefrontale, la quale non appa-re nella sua forma completa se non tra i sette e i quattor-dici anni (epoca questa nella quale fa appunto la sua com-parsa il pensiero astratto), non vuol dire che questi ope-ratori non esistano, ma solo che è la corteccia prefrontalea permettere di porli in relazione.
3. Lo spazio costruito nella memoria: questione dipunti di vista
Vorremmo approfondire la nozione, da lei proposta, di unamemoria “topocinestesica”, che svolge un ruolo importante neicompiti visuo-spaziali di tipo egocentrico così come in quelli di
7 Per il primo punto si rimanda al seminario Sur la nature et le statut ontologique des mathématiques tenuto al CREA (Centre deRecherche en Epistémologie Appliquée) dell’Ecole Polytechnique di Parigi. Per il secondo punto al testo J.-P. Changeux, P. Ricoeur,Ce qui nous fait penser. La nature et la règle, Odile Jacob, Paris 1998.8 G. Châtelet, Les enjeux du mobile: mathématique, physique, philosophie, Seuil, Paris 1993.9 Cfr, J. O’Keefe, L. Nadel, The Hippocampus as a Cognitive Map, Oxford University Press, Oxford 1978.
alain Berthoz, Il senso del movimento, (trad. dalpra e., rodighiero a.), Mcgraw-hill companies,1998, ISBN-13: 9788838637087, € 25,50
Il senso del movimento, sostienel’autore di questo libro, è unasorta di sesto senso che è in gradodi anticipare ciò che sta per acca-dere nella realtà dello spazio cir-costante. Il nostro cervello non èdunque un calcolatore che siadatta al mondo esterno, funzio-na piuttosto come un simulatorein grado di escogitare ipotesi,creare modelli e inventare solu-zioni che proietta sul mondo.
Questa ipotesi “filosofica”, che via via si arricchiscedi implicazioni che mettono in evidenza la prodigio-sa architettura del cervello, viene presentata dall’au-tore come una proprietà fisiologica, per cui diventadi fondamentale importanza comprendere da unpunto di vista scientifico i meccanismi che sono allabase del funzionamento del cervello e in particolarequelli direttamente legati al senso del movimento.
79alain bErthoz
Chora N. 16, Settembre 2008
tipo allocentrico. Gli esperimenti mostrano infatti che que-sto tipo di memoria si attiva quando viene chiesto a un sog-getto di ricostruire mentalmente un determinato tragittonoto: l’attivazione risulta essere la stessa sia quando il sog-getto deve immaginare di attraversare l’itinerario in primapersona, sia quando gli viene chiesto di orientarsi in unospazio impersonale attraverso una prospettiva di “sorvo-lo”. Questo particolare tipo di memoria sembra dunqueessere capace di operare l’interscambiabilità dei molteplicipunti di vista soggettivi, cosicché lo spazio famigliare al sin-golo soggetto cognitivo deve essere pensato sempre come ilnodo virtuale di una serie infinita di prospettive potenzial-mente assumibili. Possiamo allargare questo discorso nelladirezione della successiva costituzione dello spazio inter-soggettivo/interpersonale? È corretto affermare che lo spa-zio cartografico oggettivo all’interno dei quali interagisconosolidalmente i diversi soggetti cognitivi, sia il risultato diuna negoziazione tra percezione e immaginazione, resa pos-sibile dalla memoria “topocinestetica”?
Per prima cosa grazie di aver sottolineato l’affermazioneche ho fatto relativamente alla memoria “topo-cinestesica”.Quando ho cominciato a lavorare a questo tema, otto annifa, si parlava di “memoria topografica”. La memoria spa-ziale era stata studiata soprattutto grazie a test di disegnosu carta o test quali il test di Corsi, cioè ancora con quelli chesi chiamano “test de table”. Ho inventato questa espressio-ne, semplicemente per render conto di questi due meccani-smi che esistono allo stesso tempo nel cervello e nell’espe-rienza comune, cioè il fatto che si possa ricordarsi di un per-corso sia ricordando in maniera egocentrata la strada, imovimenti, l’azione, gli episodi, sia il fatto che si possa farloanche immaginando una cartina e prendendo un punto divista allocentrato. Insieme al mio giovane collega medicoSimon Lambrey, abbiamo proposto una teoria, secondo cuila memoria geocentrata della successione di avvenimentiche noi incontriamo nel nostro percorso è una proprietà delcervello e in particolare dell’ippocampo sinistro, mentre ilcervello destro sarebbe maggiormente coinvolto nellavisione globale dello spazio.
Questa distinzione è stata proposta dallo psicologo S.Kosslyn che suggerisce che il cervello sinistro è coinvoltonegli aspetti “categoriali” e il cervello destro negli aspetti“metrici”. Oggi, è utile operare questa grande distinzione,ripresa dall’autismo, dalla schizofrenia e dall’agorafobia. Inogni caso, il problema maggiore con cui ci dobbiamo con-frontare è quello di sapere come il cervello manipola idiversi referenziali ed effettua dei cambiamenti di punto divista. Piaget mostra, grazie al famoso esperimento delle tremontagne che il bambino non è capace di cambiare puntodi vista mentalmente, se non a partire da sette-otto anni. Ilcambiamento di punto di vista, è la capacità di sfuggire adun referenziale ego centrato. È un’azione mentale attraver-so cui si colloca il proprio corpo nello spazio. La questionedei referenziali spaziali oltrepassa di gran lunga il proble-ma limitato alla memoria spaziale. Essa è, a mio modo divedere, una delle componenti fondamentali dell’intersog-gettività. Io ho proposto, nel libro di cui abbiamo parlatocon Gerard Jorland su “L’empathie” (pubblicato in Franciada Odile Jacob, si veda box in queste pagine, NdR) che que-sto meccanismo di cambiamenti dei punti di vista spazialisono coinvolti nell’empatia come avevano intuito alcunigrandi filosofi tedeschi come Ficher. Lavoro attualmentecon molti gruppi di clinici in Italia, in ospedali dove si ria-bilitano bambini affetti da infermità mentale motrice(Cerebral Palsy). In realtà questi bambini hanno dei proble-mi percettivi, e, io penso, una difficoltà a costruire una per-cezione coerente del proprio corpo e delle sue relazioni conil mondo e di manipolare i referenziali spaziali. È una viso-ne completamente nuova.
Una ipotesi che vorrei proporre e che ho già presentato nelmio libro su “La scienza della decisione” (pubblicato in Italiada Codice, si veda box in queste pagine, NdR) e ripreso dellaparte sull’intersoggettività nel libro con Jean Luc Petit èappunto che nel mio cervello è presente un doppio di memedesimo. Quindi se volessi cambiare punto di vista, potreiimmaginare di restare egocentrato, ma con il mio doppio,senza per forza avventurarsi nello spazio astratto della carta.Un grande interesse è accordato oggi alla questione dell’em-patia. In particolare è interessante distinguere tra empatia esimpatia. Per noi la simpatia è il fatto di provare le emozionialtrui ma senza cambiare punto di vista. È il contagio emoti-vo. Come dire: tu piangi, io resto al mio posto, io piango. Èquello che fa il bambino quando fa una imitazione senzacambiare il punto di vista. Invece l’empatia è infinitamentepiù complessa, perché nell’empatia, la nostra ipotesi è che iomi metto al tuo posto, e quindi cambio punto di vista, sia per-ché posso avere una visione dall’alto, sia perché posso utiliz-zare il mio doppio per mettermi al vostro posto, e dunque ioproverò gli stessi sentimenti che avete voi, ma con il vostropunto di vista sul mondo. Ciò significa che io percepisco ilmondo come lo percepite voi, ed è per questo che io diventocapace di percepire le vostre emozioni. Ma nell’empatia, faròciò restando al mio posto. E siamo anche capaci, proprio per-ché restiamo al nostro posto, di non provare le emozioni cheprovate voi. E questa è la tesi di Gerard Jorland.
La questione dell’empatia è anch’essa di grande attualitàperché non riguarda solamente la vita di tutti i giorni, essaè centrale nella psichiatria, è pertinente anche per questionicome la criminalità, il terrorismo, etc. Ma io penso che, inrealtà, la maggior parte degli articoli che oggi sono pubbli-cati sui grandi giornali scientifici che parlano di empatiasiano delle imposture. Perché in realtà una parte degli studiche vanno sotto il capitolo dell’empatia riguardano inveceil contagio emozionale. L’empatia è un processo dinamicostraordinariamente complesso, caratteristico dell’uomo,all’interno del quale si fanno cambiamenti di referente, simanipola la percezione di sé e dell’altro, cioè si costruiscel’intersoggettività.
alain Berthoz, La scienza della decisione, (trad.Federica niola), 2008, isBn 88-7578-007-2, € 28.
Le teorie della decisione sembra-no a molti un ambito riservato amatematici austeri, economisti,psicologi fumosi e filosofi astrusi.Se è vero che l’intelligenza consi-ste nell’elaborare un gran numerodi dati complessi per trarne con-clusioni semplici, allora il libro diAlain Berthoz si adatta perfetta-mente a questa definizione. Lascienza della decisione ci offre unadescrizione eccellente del funzio-
namento del nostro cervello come stratega e comeinterprete dei contesti, una sintesi che permette difare chiarezza su noi stessi e di comprendere meglioil modo in cui agiamo. Le nostre preferenze e lenostre avversioni, le nostre rappresentazioni e lenostre speranze, il modo in cui percepiamo e ci muo-viamo nel mondo: tutto concorre a farci prenderedecisioni ogni giorno, buone o cattive, decisioni chesono altrettante scommesse sul futuro. Capire megliociò che ci spinge a fare una scelta piuttosto che un’al-tra è in sé una piccola conquista di libertà. Ognunopotrà trovarvi qualcosa che lo riguarda rispetto allapropria personalità.
lo Spazio dElla mEmoria
Chora N. 16, Settembre 2008
80
4. La memoria costruita nello spazio: tra biologia e culturaGli studiosi della memoria hanno costatato una differen-
ziazione delle modalità cognitive attraverso le quali questafacoltà è stata sviluppata nelle diverse civiltà. In particola-re, se è evidente che i popoli alfabetizzati hanno preferitocostruire nello spazio un’impalcatura cartografica per collo-care l’edificio dei loro ricordi e delle conoscenze, è altrettan-to vero che i popoli dell’oralità primaria, ad esempio i grecidell’epoca di Omero, hanno elaborato una concezione dellamemoria su basi sostanzialmente acustiche e ritmiche, vistoche il principale metodo che essi possedevano per conserva-re i ricordi era la produzione musicale e poetica. Alla luce diqueste evidenze, fino a che punto possiamo spingere la vali-dità di una rappresentazione meramente spaziale dellamemoria? Esiste una base transculturale, forse biologica einnata, per la facoltà della memoria spaziale, e in che modola cultura può aver influito sul suo successivo sviluppo e sulsuo progressivo addestramento? Ritiene possibile che, inqualche misura, la nostra stessa concezione scientifica dellafacoltà della memoria sia influenzata dal primato che lanostra cultura ha da sempre attribuito al senso della visio-ne per quanto riguarda la conservazione delle informazionie dei saperi?
Non credo che l’oralità sia la questione primaria.Prendete per esempio gli Irlandesi. Si sa che gli Inglesihanno impedito loro di avere una storia scritta per 400 anni.Di conseguenza, tutta la storia degli Irlandesi è stata tra-mandata attraverso i racconti e la loro musica. Questi rac-conti di molte migliaia di parole che i bardi potevano rac-contare senza cambiare una sola virgola, sono trasmessi dipadre in figlio, di generazione in generazione, attraverso isecoli. In questo caso, si può dunque dire che la tradizioneorale è fondamentale, ma che non necessariamente essa èprimitiva. Si dice che i popoli con tradizione orale nonhanno Storia, ma sarebbe meglio dire che alcuni, i popolioppressi, hanno una storia orale. Altri la conservano per ilmezzo della danza. Nei racconti come nella danza c’è lareale possibilità di spazializzare il discorso. Il fatto di noncomprendere il ruolo del linguaggio nella memoria dellospazio e la manipolazione dei punti di vista, è uno dei puntipiù deboli delle nostre ricerche attuali sullo spazio.
Circa invece il secondo punto della vostra domanda, - esi-ste una base transculturale e anche volendo biologica inna-ta, della facoltà di memoria (spaziale) - io sarei tentato dirispondere “si”, e si tratta di ciò che noi cerchiamo oggi gra-zie all’aiuto dei lavori più recenti fatti dagli antropologiriguardo a questo tema. Consideriamo l’uso dello spazioper la strutturazione delle relazioni sociali, e leggiamo atitolo di esempio gli scritti di Stephen Levinson sulle scim-mie. Questo grande psicologo ed antropologo ha postoqueste questioni confrontando i casi di popolazioni umanedi culture completamente diverse (dagli Olandesi agli abi-tanti del Madagascar) e applicando gli stessi test sul cam-biamento del punto di vista a cinque categorie diverse discimmie per scoprire i punti comuni ad esse. Le sue conclu-sioni sono le seguenti, in maniera molto concisa: anche i pri-mati non umani hanno espressioni proto-culturali e posso-no trasmettere da una generazione all’altra forme compor-tamentali complesse intersoggettivamente sviluppate econdivise, ma gli esseri umani, a differenza delle scimmie,
sono in grado di variare in età precoce le proprie categoriecognitive spaziali sulla base delle caratteristiche specifichedel linguaggio che apprendono.
Per quello che riguarda la visione, è certo che essa gioca unruolo maggiore nelle nostre culture iconografiche, e senzadubbio spesso è un freno per risolvere dei problemi. Peresempio quando ho pubblicato il mio libro su “Il senso delmovimento”, sono stato contattato da un movimento france-se ispirato al pedagogo Lagarandrie che mi spiegò che eragiunto alla seguente conclusione: spiega la geometria ad unbambino, presentandogliela sotto forma di un disegno cheassomiglia ad una sorta di mappa (si ritorna alla memoriatopografica); si constaterà che il bambino trova la rispostaimmediatamente. Quando si presenta al bambino un dise-gno, esso attiva nel suo cervello alcune aree visuali, ma nongli permette di risolvere il problema. In seguito, lo invito a“mettere il disegno sulla sua testa“; e allora il bambino trovasubito la risposta. La mia interpretazione di osservatore è laseguente: quando presentiamo il disegno, esso attiva nel cer-vello del bambino aree visuali, ma non gli permette di risol-vere il problema. Mettendo invece il disegno sulla testa, egli èportato a riformulare la questione in altri termini, forse impli-cando la gestualità o alcune competenze motorie che consen-tono di risolvere il problema facilmente. Si pensi qui adEinstein che diceva “Passeggio sui fotoni”.
Vi posso anche portare un esempio personale: ero unafrana in algebra, non riuscivo a risolvere le equazioni. Unavolta, c’era una domanda molto difficile - era una domandasull’intersezione tra un iperboloide e un paraboloide. I mieiamici, che erano matematici, hanno risolto la questione condelle equazioni. Noi avevamo anche un metodo di risolvereil problema tramite la geometria descrittiva, facendo disegnisecondo un metodo che consisteva nel prendere punti imma-ginari. Prendendo questi punti immaginari la soluzionedivenne semplice e riuscii a capire tutto con il mio cervello,che era incapace di risolvere le equazioni. Riguardo questidue esempi, si può effettivamente dire che la nostra culturaattribuisce alla vista una certa preminenza, ma che è necessa-rio certamente completare e integrare la visione con altre stra-tegie. È necessario considerare la topo-cinestetica in rapportoalla topo-grafia, è necessario riabilitare il corpo in azione, lecinestesi in tutti i sensi che la parola porta con sé.
Recentemente il Premio Nobel della fisica GeorgesCharpak ha lanciato un grande movimento “Le main à lapâte” che sostiene che sia necessario un apprendistato dellafisica attraverso la sperimentazione diretta, ma le personefanno fatica ad accettarlo: è come per la fenomemologia, dellaquale si dice che sia triviale, che non sia altro che esperienzavissuta. C’è voluto un premio Nobel per la fisica per accetta-re l’idea che la fisica possa essere insegnata attraverso l’espe-rienza vissuta - e dunque l’azione, e non solamente attraver-so la vista e le formule. In principio era l’azione.
alain Berthoz è uno dei più importanti neuroscienziati francesi. Studioso di motricità e di funzioni cognitive legate alla spazialità,dal 1993 è professore di “Filosofia della percezione e dell’azione” al Collège de France, ed è membro dell’Accademia delle Scienzeparigina; dal 1989 dirige il Laboratoire de physiologie de la perception et de l’action (CNRS-Collège de France). Autore di numerosi artico-li su riviste internazionali e quotidiani su temi legati al senso del movimento e più in particolare sulle diverse componenti della suapercezione, esercita una intensa attività come conferenziere presso università e centri di ricerca di più di 20 paesi. In Italia ha pubbli-cato il saggio Il senso del movimento (McGraw-Hill, 1998) e La scienza della decisione (Codice, 2008). È stato uno dei principali promoto-ri in Europa di un avvicinamento tra le scienze cognitive e la fenomenologia e, insieme al fenomenologo husserliano Jean-Luc Petit,ha prodotto un importante contributo che ben rappresenta questa sintesi, Physiologie de l’action et phénoménologie (Odile Jacob, 2004).
Jean-luc petit, alain Berthoz, Physiologie de l’ac-tion et phénoménologie, odile Jacob, 2007, isBn-13 9782738117410, € 36,80
alain Berthoz, gérard Jorland (a cura di),L’empathie, odile Jacob, 2004, isBn: 9782738114853, € 27,00
81lorEnzo altiEri
Chora N. 16, Settembre 2008
Avevo notato, un po’ discosti dal tratto di stra-da a schiena d’asino che stavamo percorrendo, tre
alberi che dovevano segnare l’inizio di un vialecoperto e formavano un disegno su cui i miei
occhi non posavano ora per la prima volta (…).Guardavo i tre alberi, li vedevo bene, ma dentro di
me sentivo che essi coprivano qualcosa su cui lamia mente non riusciva a far presa (…). Non
erano che un’immagine staccatasi dal sogno dellanotte precedente, del tutto nuova ma già così sbia-
dita da darmi l’impressione di piangere da moltopiù lontano? Oppure li vedevo per la prima volta
e celavano dietro di sé come certi alberi, certi ciuf-fi d’erba veduti dalla parte di Guermantes, un
senso altrettanto oscuro, altrettanto difficile daafferrare quanto un lontano passato, in modo che,
sollecitato per loro tramite ad approfondire unpensiero, io credevo di dover riconoscere un ricordo?
(M. Proust, All’ombra delle fanciulle in fiore)
Incontriamo qui il punto più difficile, cioè il legamedella carne e dell’idea, del visibile e dell’ossatura interio-re che esso manifesta o nasconde. Nessuno si è spinto piùlontano di Proust nella fissazione dei rapporti del visibilee dell’invisibile, nella descrizione di una idea che non è ilcontrario del sensibile, ma che ne è il risvolto e la
profondità.(M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile)
Sulla spinta di recenti scoperte in ambito neurologi-co, il tema della memoria ha riacquisito una grandeattualità nel dibattito contemporaneo. Le ricerchecognitive possono senz’altro gettare nuova luce suimeccanismi neuronali che presiedono al funziona-mento dell’apparato mnemonico e sono in grado dimostrarci, con crescente precisione, quale sia l’effetti-vo coinvolgimento delle diverse aree cerebrali nellaconservazione dei ricordi. Tuttavia, il punto di vistache vogliamo assumere in queste pagine è diverso, esi colloca in una prospettiva specificamente filosofica:che cosa può dirci la filosofia per quanto riguarda lastruttura dell’esperienza del ricordo? Il “piccolomiracolo” della memoria, come lo definiva Bergson,
può esaurirsi nel suo trattamento puramente neurolo-gico? Oppure ci nasconde qualcosa di più? Che cosaassicura la conservazione del ricordo attraverso iltempo e lo spazio? Perché alcuni ricordi antichi, adispetto della loro lontananza, sembrano più vividi dialtre memorie più recenti? Che ruolo giocano le sen-sazioni – e dunque la corporeità – nella riattivazionedi queste memorie? Approfondiamo questo temanella certezza che una descrizione fenomenologicadella memoria – un’analisi, cioè, della memoria comevissuto in prima persona – possa avere il valore diuna guida anche per chi affronta il problema dellamemoria da un’angolatura completamente diversa,ossia attraverso una descrizione naturalistica in terzapersona. Ci concentreremo in particolare sulle rifles-sioni di Merleau-Ponty sull’oblio e sull’inconscio,ancora inedite in Italia, accompagnate da quel grandeaffresco poetico e fenomenologico della memoria cheè la Recherche di Marcel Proust1.
I manoscritti merleau-pontiani sull’istituzione e lapassività costituiscono a nostro avviso una delle piùprofonde descrizioni di fenomenologia della memo-ria. In queste pagine vorremmo riprendere quelleanalisi cercando di mostrare, seppur per brevi tratti,come esse s’inseriscano nel più vasto progetto di
coMe l’intervallo deglialBeri Fra gli alBeri
di lorenzo altieriuniversità degli studi di napoli “Federico ii”
Memoria, inconscio e oblio nella fenomenologia di Merleau-ponty
1 Peraltro le stesse neuroscienze sembrano accordare, proprio in questi ultimi tempi, un grande credito anche scientifico all’opera proustiana. E’ direcente pubblicazione in America un volume intitolato significativamente Proust was a neuroscientist ad opera di Jonah Lehrer (2007). Il giovane scien-ziato, fugando ogni sospetto d’ironia nel titolo, sostiene con convinzione che l’autore della Recherche (insieme ad altri grandi artisti del passato, daWoolf a Cézanne) ha anticipato alcune fondamentali scoperte delle moderna scienza del cervello, giungendo a delle conclusioni che solo alcunirecenti studi sui meccanismi della visione o sulle strutture del linguaggio sono stati in grado di confermare sperimentalmente. Ad esempio nel 2003Rachel Herz, una psicologa della Brown University, ha dimostrato che gli odori e i sapori sono i più potenti evocatori di memorie (questa era, comevedremo meglio nelle pagine seguenti, la tesi fondamentale dell’opera proustiana). Tale potere risiederebbe nella connessione diretta dei nervi gusta-tivi ed olfattivi all’ippocampo, che pare essere il centro della memoria a lungo termine. Ma questo Proust non poteva saperlo.
comE l’intErvallo dEgli albEri...
Chora N. 16, Settembre 2008
82
“riabilitazione ontologica del sensibile” che ha occu-pato Merleau-Ponty negli anni della maturità. Nelrievocare questo scenario filosofico vedremo che leindagini sulla memoria sono intrecciate a quelle sulsogno, e che entrambe fanno parte a loro volta di unfenomeno ancora più originario: la latenza, un con-cetto cardine nell’articolazione chiasmica del visibi-le e dell’invisibile.
Nel corso di questa esplorazione la figura diProust, con cui Merleau-Ponty ha intessuto un dialo-go intensissimo, ciaccompagnerà lungo imisteriosi viali dellamemoria, tra filari dimeli e siepi di bianco-spini. Questa passeg-giata diventerà alloraun vero e proprio“invito al viaggio”baudelairiano in queiluoghi lontani in cui ifiori più rari e gliodori diversi simischiano ai vaghisentori dell’ambra, inquel paese che ci asso-miglia, là dove tuttoparla la lingua nataledell’infanzia: “Laparte di Méséglise coni suoi lillà, i suoi bian-cospini, i suoi fiordali-si, i suoi papaveri, i suoi meli, la parte di Guermantescon il suo fiume popolato di girini, le sue ninfee e i suoibottondoro, hanno formato per me l’eterno volto delpaese dove amerei vivere” (Proust 2006, I p. 224).
1. Il colore del tempo: per una riabilitazione onto-logica del Sensibile
La tesi di fondo che ci piacerebbe provare è laseguente: le descrizioni merleau-pontiane del sognoe della memoria poggiano su un’unica idea, quella diun inconscio sensibile il quale, nella sua dialettica colvisibile, costituisce la trama della realtà fenomenica.In poche parole, l’intento ultimo di Merleau-Ponty èquello di gettare i lineamenti di una fenomenologiadell’incarnazione in cui il piano dell’idea e dell’im-maginario sia radicato nel cuore stesso dell’esperien-za sensibile. È per questo che, per quanto sorpren-dente possa sembrare, egli non cercherà l’originedella memoria nel Tempo, bensì nello Spazio. Il lavo-ro cui si è dedicato negli ultimi anni della sua vitaconsiste fondamentalmente nel radicare l’idealità e ilpensiero logico-scientifico nel cuore del mondo-della-vitapensato come carne; questo radicamento prende ilnome di chiasmo. Pertanto le essenze non sono la“cosa” ultima, ma sono a loro volta prelevate su unessere “selvaggio” più originario, avvolto nella fatti-vità ante-predicativa: rivelare questa verità fonda-mentale non significa affatto ripiombare nel vecchiorelativismo sofistico, bensì superare la tradizionaledicotomia del fatto e dell’essenza.
Su questa separazione iniziale si è giocata granparte della storia della filosofia e ha potuto svilup-parsi la metafisica come il pensiero di tale separa-zione. È per aver cominciato con questa antitesi, conla scissione del tempo e dello spazio, con la fratturatra il senso e il sensibile, che siamo in fondo condan-nati a scegliere tra il mondo e il suo significato. Cosìla filosofia ha ostinatamente cercato le essenze al di
là dei fatti, immaginando variazioni eidetiche edispezioni dello spirito capaci di purificare le cose –ciò che Merleau-Ponty definisce come “un impossi-bile lavoro dell’esperienza sull’esperienza che laspoglierebbe della sua fattività come di una impuri-tà” (Merleau-Ponty 1993, p. 132). Tale operazione –che ai nostri occhi appare come una vera e propriaperversione dell’esperienza (nel senso appunto diun’inversione del senso naturale) – è possibile, inlinea di principio, solo ad una condizione: che si
creda di poter usciredal mondo e di guar-dare l’Essere dal difuori. Merleau-Pontyè stato uno dei primipensatori a tentare diribaltare questo rap-porto, e nel lungo iti-nerario che va dallaFenomenologia dellapercezione ai mano-scritti del Visibile el’invisibile egli havoluto operare ungesto radicalmentea n t i - m e t a f i s i c o ,ancorando nell’oriz-zonte prassico sensi-bile la genesi delsenso e dell’idealità.Questa nuova “archi-tettonica del sensibi-
le” poggia sul corpo nella misura in cui il corpone è sorretto: ecco il chiasmo originario cheMerleau-Ponty chiama chair.
Giungiamo così alla questione dello spazio edella memoria. Lo spazio, leggiamo nel Visibile el’invisibile, è il rapporto della nostra carne e dellacarne del mondo: pertanto dobbiamo ripensarloalla luce di questo Essere carnale intessuto di sen-sibile. Al posto della sublimazione a-topica dellametafisica tradizionale, Merleau-Ponty prova aconcepire qualcosa come una Intra-ontologia, unEssere inglobante-inglobato, dimensionale, oriz-zontale. Questo mondo, questo Essere da cui nonpossiamo uscire, è al tempo stesso un universo dipossibilità e di virtualità: non è fatto di puri ogget-ti o di mere attualità, ma è piuttosto una strutturaontologica che contempla molteplici varianti. In unquadro così mobile e complesso s’inserisce la que-stione della memoria. Nella Fenomenologia della per-cezione il lontano spaziale e il lontano temporalesono già pensati insieme; di più, si tratta d’imma-ginare il nostro radicamento spazio-temporalecome l’inverso di una onni-spazialità e di unaonni-temporalità della nostra coscienza carnale, lafinitudine come l’altra faccia dell’eternità: “Non sideve scegliere tra l’incompiutezza del mondo e lasua esistenza, tra la presenza e l’ubiquità dellacoscienza, tra la trascendenza e l’immanenza (…).Ciò che bisogna comprendere, è che la stessa ragio-ne mi rende presente qui ed ora e presente altrovee sempre, assente qui ed ora e presente in ogniluogo e in ogni tempo. Questa ambiguità non èun’imperfezione della coscienza o dell’esistenza,ne è la definizione” (Merleau-Ponty 2005, p. 383).Merleau-Ponty prova a mostrarci che, lungi dal-l’essere geometricamente distesi su una linea senzasbavature, passato presente e futuro si mescolanonell’intreccio della nostra esistenza.
83lorEnzo altiEri
Chora N. 16, Settembre 2008
Un’impresa simile è stata tentata da Proust nella suaRicerca del tempo perduto: attraverso l’evocazione deiricordi involontari e la distanza instaurata dall’oblio,egli ha cercato di dare corpo e forma sensibili alTempo2. Quasi come in un procedimento chimico, incui un odore o un sapore particolare fungono da rea-genti e innescano una speciale reazione nel precipitatodella nostra memoria, così il Narratore arriva a goderedi epifanie estemporanee e sfuggenti, in cui quella rea-zione chimica riesce a far apparire, come in una cartinadi tornasole osservata in controluce, il colore del Tempo:“Odori ancora naturali, certo, e color del tempo comequelli della vicina campagna, ma già casalinghi, umanie claustrali, gelatina squisita, industriosa e limpida ditutta la frutta dell’anno che ha lasciato l’orto per ladispensa” (Proust 2006, I p. 61).
Accanto a questa cristallizzazione del tempo dellecose, Proust aspira ad incarnare nei corpi dei perso-naggi il tempo degli uomini: i volti, gli sguardi, ilineamenti degli amici del Narratore saranno la rap-presentazione stessa della temporalizzazione.Parimenti, Merleau-Ponty afferma: “Il corpo non èstrumento ma organo, pertanto il tempo vi è incorpo-rato, sedimentato e questo in virtù del fatto che essonon è soltanto una massa di dati einmalig, ma unastruttura temporal-spaziale” (Merleau-Ponty 2003, p.256). Inoltre, negli attori che sfilano sul palco dellaRecherche si manifestano impressioni profonde, quasiinconsce, che ne rivelano la natura prismatica e flui-da. Ed è per questo che lo stesso Proust, in una cele-bre intervista a Le Temps apparsa il 13 novembre1913, alla vigilia della pubblicazione di Du côté dechez Swann presso Grasset, accorda a definire la pro-pria opera un “Romanzo dell’Inconscio” – non insenso bergsoniano ma, diremmo noi, anacronistica-mente, in senso merleau-pontiano3. Non a caso leriflessioni di Merleau-Ponty sulla memoria si intrec-ciano a doppio filo con quelle sui sogni e sull’incon-scio: si tratta sempre di figure della passività cheinsieme compongono un unico quadro, il ritrattocomposito della nostra identità, che adesso dobbia-mo cercare di ricostruire e comprendere.
2. La fiamma della veilleuse di vetro di Boemia: lamemoria del corpo tra sogno e veglia
A prima vista si potrebbe pensare che i sogni – e lapsicoanalisi – con la memoria non c’entrino poitanto. In realtà chiunque abbia con Freud una mini-ma dimestichezza, non inquinata da pregiudizi eresistenze di varia natura, può rendersi agevolmenteconto che le cose sono assai più complicate di comesembrano. Il fenomeno onirico si presta in effetti aduna descrizione fenomenologica molto interessante,utile anche nell’ottica di una descrizione dellamemoria e del suo funzionamento4.
L’intuizione merleau-pontiana consiste nel ribal-tare il punto di vista tradizionale: il rebus oniriconon fa che rappresentare in altra forma l’ambiguità
originaria dell’esistenza, che è già simbolica, anchedurante la veglia. È particolarmente interessanteche, come abbiamo anticipato, Merleau-Ponty anco-ri queste riflessioni nella dimensione spaziale e car-nale della vita del soggetto; è per questo che, adesempio, il movimento verso l’alto nello spazio fisi-co e quello del desiderio verso il suo scopo sonosimbolici l’uno dell’altro, “perché esprimonoentrambi la medesima struttura esistenziale delnostro essere come essere situato in rapporto con unambiente, e, come si è già visto, solo questa struttu-ra dà un senso alle direzioni dell’alto e del basso nelmondo fisico” (Merleau-Ponty 2005, p. 373). Lediverse sfere dell’esistenza sensibile sono comeattraversate da quelle che Binswanger chiama “dire-zioni di significato”, che danno senso ai sogniintrecciandoli alla trama della vita dei sognatori –un senso che, appunto, non è un senso nozionale,ma una direzione dell’esistere di ciascuno5.
A questo punto, però, una volta ristabilita questacon-fusione tra il sogno e la veglia, ci si potrebbechiedere: chi o che cosa permette il passaggio a dop-pio senso dal reale all’onirico? Il vero trait d’union,insiste Merleau-Ponty, è il corpo – e non la coscien-
2 “Le temps sensible”, prima di essere il titolo di una complessa monografia proustiana, erano le ultime parole del manoscritto della Recherche, poicancellate nell’ultima versione del romanzo (v. Kristeva 1994).3 Ciò che ritorna nei personaggi, spiega Proust, sono delle “impressioni profonde, quasi inconsce”, le sole capaci di “riportarci le cose in un esattodosaggio di memoria e di oblio” e di farci “gustare la stessa sensazione in una circostanza affatto diversa, liberandola di ogni contingenza, donan-docene l’essenza extratemporale” (Proust 1988, pp. 452-453).4 Come è detto perentoriamente in un frammento del Visibile e l’invisibile: “Una filosofia della carne è condizione senza la quale la psicoanalisi rima-ne antropologia” (Merleau-Ponty 1993, p. 278).5 Sarebbe interessante confrontare queste intuizioni fenomenologiche di Merleau-Ponty con le analisi semantiche di certa Linguistica Cognitiva –pensiamo soprattutto ai lavori sulla metafora di Lakoff e Johnson e alle loro descrizioni delle cosiddette “metafore d’orientamento”. Un tentativo,molto esplorativo, è stato fatto da chi scrive (Altieri 2006).
comE l’intErvallo dEgli albEri...
Chora N. 16, Settembre 2008
84
za: “Dunque il corpo in quanto messa a punto percetti-va, in quanto rapporto con delle situazioni di dramma,è il soggetto del sogno, e non la ‘coscienza immaginati-va’” (Merleau-Ponty 2003, p. 196). In altre parole, la vitapercettiva e affettiva del soggetto corporeo producesenso nell’incontro coi fenomeni, ed è tale senso cheanima la scena onirica. Ciò non significa, ovviamente,Sinngebung nell’accezione husserliana, poiché non è lacoscienza che dà senso al mondo – meno che mai nelcaso del sogno, che per definizione è assenza dellacoscienza: ciò significa che vi è un “campo del sogno”intessuto della stessa trama sensibile dell’esistenza6.
Allora l’inconscio diventa quasi un altro nome diquell’invisibile di cui è fatta la nostra vita, e che è ilmodo di essere del Sensibile: ora e sempre, qui e in ogniluogo. È per questo che Merleau-Ponty può dire che le“associazioni” della psicoanalisi sono in realtà dei“raggi” di tempo e di mondo, là dove s’intrecciano iricordi e le percezioni: “Il percepito conserva e salva lanostra dualità, a cui Freud tiene e che egli crede di sal-vare mediante l’idea d’inconscio (a torto, perché il dua-lismo inconscio-coscienza la sopprimerebbe rendendoesplicito l’inconscio, creando due soggetti). Esso salva‘ciò che l’anima conserva d’indomito e d’indistruttibile’(indistruttibile: allusione a presenza di tutto il passato,memoria non centrifuga)” (Merleau-Ponty 2003, p.213). L’invisibile – il non-visibile, ma anche il rimosso eil dimenticato, ossia l’invisibile pronto a rivelarsi –avviluppa l’apparire e ne costituisce in fondo la logicasegreta. Al tempo stesso, esso è il sigillo della nostrafinitezza, della nostra spazialità e della nostra con-tin-genza carnale. Mentre per Husserl l’invisibile era unavera e propria mancanza ontologica della cosa a frontedella pienezza della coscienza, per Merleau-Ponty, alcontrario, l’invisibile è la cifra dell’inesauribile ricchez-za di senso del sensibile nonché la forma stessa dellanostra temporalità.
Così ogni percezione è, secondo la bella espressio-ne del filosofo, una “vibrazione del mondo”: essatocca ben al di là di quello che tocca, e risvegliadelle eco che diventano simboli, e poi ricordi. Ciòaccade perché le percezioni delle cose e degli even-ti sono correlative di uno schema corporeo prassico epatico, fisico e affettivo, che organizza il drammadella vita secondo direzioni di senso diverse. Inquesta prospettiva l’inconscio non è che una moda-lità della corporeità, del nostro essere-corpo. In unanota del febbraio 1959 troviamo una definizionequasi struggente di questo inconscio: “Questoinconscio da cercare, non in fondo a noi, dietro lanostra ‘coscienza’, ma davanti a noi, come articola-zioni del nostro campo. Esso è ‘inconscio’ per ilfatto che non è oggetto, ma è ciò grazie a cui deglioggetti sono possibili, è la costellazione in cui silegge il nostro avvenire – L’inconscio è fra di essicome l’intervallo degli alberi fra gli alberi, o come illoro livello comune (…). Sono questi esistenziali aformare il senso (sostituibile) di ciò che diciamo e diciò che udiamo” (Merleau-Ponty 1993, p. 197).
Poco a poco capiamo perché, nella riflessione mer-leau-pontiana, il confronto con Freud è essenzialeper introdurre un discorso articolato sulla memoria:l’inconscio che emerge in queste note è in fondo unaltro modo di indicare quell’invisibile inteso in ulti-ma istanza come latenza. La latenza è in effetti unconcetto cardine nella fenomenologia dell’ultimoMerleau-Ponty: regione atopica, increspatura, pieganella trama del sensibile, la latenza è appunto ciò che
presiede ai sogni e ai ricordi, all’onirico e al memo-riale. Nelle note su Freud degli anni Cinquanta,infatti, l’inconscio viene definito come “l’avere nelmodo del non avere”: tali sono anche la memoria e ilsuo doppio, l’oblio, intesi appunto come traccia,sedimentazione, latenza, virtualità.
Tale è anche il mondo della Recherche, in cui Proustcelebra al contempo la seducente bellezza delle cose e laloro ineluttabile caducità. Ma cosa assicura il senso diqueste pieghe nel tessuto, di queste tracce sul selciato?Il corpo, naturalmente: “il corpo è il nostro complessooriginario, il complesso il nostro corpo secondario.Ricordarsi è ricordarsi della corporeità precedente eavere un corpo significa anche avere un passato dellacorporeità: c’è un tempo del corpo, una struttura tem-porale della corporeità” (Merleau-Ponty 2003, p. 261).Negli stessi termini Proust parla di una vera e propriamemoria del corpo, descrivendo così il celebre momentodel risveglio nelle prime pagine della Recherche: “Eprima ancora che il mio pensiero, esitante sulla sogliadei tempi e delle forme, identificasse la casa mettendouna accanto all’altra le circostanze, lui – il mio corpo –ricordava per ciascuna di esse il tipo di letto, la colloca-zione delle porte, l’esposizione delle finestre, l’esisten-za di un corridoio, e in più le cose che avevo pensateaddormentandomi e ritrovate al risveglio (…); e il miocorpo, il fianco sul quale ero appoggiato, custodi fedelidi un passato che il mio spirito non avrebbe mai dovu-to dimenticare, mi ricordavano la fiamma della veilleu-se di vetro di Boemia, a forma d’urna, sospesa al soffit-to con delle catenelle” (Proust 2006, I p. 9).
Abbiamo infine trovato il terreno comune su cui s’in-contrano il fenomeno onirico e quello mnestico, ilsogno e il ricordo, la rimozione e l’oblio: si trattaappunto di questo inconscio corporeo che lega insieme latrama concreta della vita di ciascuno. Per questoMerleau-Ponty può affermare, in un testo inedito del1960: “Fenomenologia e psicoanalisi non sono paralle-le; anzi, ancora di più: esse si dirigono entrambe versola medesima latenza” (Merleau-Ponty 2000, p. 283).
A questo punto dovrebbe essere chiaro in che termi-ni la rilettura di Freud conduca Merleau-Ponty a ripen-sare diversamente la fenomenologia del tempo e dellamemoria. Il confronto con la psicoanalisi s’inserisce inquel progetto più vasto di riabilitazione ontologica delsensibile di cui parlavamo in apertura e che si configu-ra sempre più come una dialettica tra il visibile e l’invi-sibile. Il ricordo e l’oblio sono parte integrante di que-sta dialettica, e Merleau-Ponty sentiva l’urgenza delcompito: “Una teoria della memoria è da realizzare,come quella della cosa e del sorvolo percettivo: non sicapisce niente né della cosa né del ricordo se si riducela cosa alla formula, alla legge di questo o quel materia-le: ciò che è preso di mira. Il ciò che è solo la membranadell’esistenza. E l’affermazione del passato nel suomodo proprio si confonde con quella di una memoriadel mondo, di un luogo dove tutto ciò che è stato nonpuò ormai smettere di essere stato” (Merleau-Ponty2003, p. 247).
3. Quella piccola conchiglia di pasticceria, così gras-samente sensuale: estetica ed erotica della memoria
In una nota tardiva dell’aprile 1960 Merleau-Pontystabilisce una correlazione tra, da un lato, l’idea freu-diana dell’indistruttibilità dell’inconscio e del passatoe, dall’altro, l’idea di un superamento del concetto tra-dizionale (anche fenomenologico) del tempo come diuna serie di vissuti. Al suo posto bisognerebbe pensare
6 Un’analisi illuminante su questo punto si trova in Richir 1998.
85lorEnzo altiEri
Chora N. 16, Settembre 2008
appunto la temporalità come una “architettonica” insenso proustiano, nella quale il corpo vivo, il Leib, ren-derebbe possibile la giunzione fra i diversi livelli sensi-bili. Così, ad esempio, una fatica spossante provata nelpresente – riflette giustamente Merleau-Ponty – puòricondurci al livello spazio-temporale delle fatiche del-l’infanzia, e restituirci quell’epoca della nostra esisten-za. Il ricordo, insomma, si materializza sempre lungo ilfilo del sensibile: non è mai una pura immagine rappre-sentazionale, ma coinvolge necessariamente la nostrastoria e la sua coloritura emotiva.
Nella sua rilettura del celebre Sogno premonitore diFreud (1899), il filosofo cita spesso la frase di Proustsecondo cui è sempre lo stesso cuore che ama e cheserve per tutto, al fine di riaffermare ancora questa“promiscuità” che costituisce l’essenza della nostracoscienza e che fa la coesione della nostra vita. Se ilnostro inconscio stabilisce una connessione tra due per-sone apparentemente diverse e distanti, non è per asso-ciazione meccanica né per sintesi teorica, ma perchéevidentemente quelle persone evocano in noi duemomenti analoghi della nostra vita, due momenti in cuila nostra corporeità è stata sollecitata in modi simili. Sicrea così una zona sensibile che diventa matrice simbolicae che crea un legame fra epoche distanti. Il soggettodella memoria, ribadisce Merleau-Ponty, non è unsecondo io penso che agisce alle spalle del cogitocosciente: questo pregiudizio proviene dalla supposi-zione per cui ci sarebbe bisogno di un atto sintetico checolleghi tra loro i momenti temporali e i ricordi. Per noi,invece, si tratta di un soggetto corporeo, di un io paticoe prassico che ha vissuto un passato senza averlo perforza pensato. Bisogna dunque che ciò che non è piùcontinui ad essere nella forma della latenza, capace inogni momento di riaffiorare tra le pieghe della nostrastoria: “Ci vuole una presenza del passato che siaassenza, bisogna che esso sia un certo tipo di assenza(…). Riassumendo, è necessario che esso non sia in sé eche non sia solamente per me, che non sia Vorstellung”(Merleau-Ponty 2003, p. 252). Questo è uno dei puntichiave della fenomenologia della memoria proposta daMerleau-Ponty: ilsuperamento di unateoria rappresentazio-nale che intende lamemoria come merostoccaggio di datidiscreti.
Ora, per compren-dere meglio il passato– e con esso la dina-mica memoriale –dobbiamo definirediversamente il pre-sente: ecco un altromomento innovativodell’approccio merle-au-pontiano. Poiché ilpassato è ciò che èstato presente, nonpossiamo cogliere correttamente la modellizzazionedel “prima” se concepiamo l’“ora” in termini errati. Losbaglio più grande consiste di nuovo in una concezionespettacolare e razionalistica della percezione e dell’esi-stenza: in altre parole, non dobbiamo concepire il pre-sente come un quadro statico, dotato di proprietà fisi-che oggettive. Se al contrario immaginiamo il presentenon come uno spettacolo dispiegato davanti ai mieiocchi, bensì come una variazione dinamica della miapresa sul mondo, come una certa postura del mio corpo
fisico e sociale, allora saremo in grado di ritrovare ilmio rapporto pratico e simbolico con il Sensibile. Comelo spazio incarna una determinata polarizzazione delmio schema prassico, così un evento è insieme espressoe iscritto in una certa postura del mio corpo: per questola sintesi temporale non è operata da un supposto “iopenso” ma dal mio corpo stesso che è tale sintesi.Pertanto ricordarsi di qualcosa “è ricordarsi del modoin cui avevamo accesso a quella cosa. Abbiamo vistoche ciò avviene attraverso il corpo, dunque è ricordarsidi una certa maniera di essere corpo” (Merleau-Ponty2003, p. 252).
Ma come ci si ricorda di qualcosa come una “corpo-reità precedente”? Ce ne si rammenta come di un pos-sibile del corpo attuale, risponde Merleau-Ponty: il pas-sato del mio corpo è presente a quello come il suoavvenire, ossia, come una polarizzazione della suapossibilità. In ultima istanza, la presenza del tempo ècarnale quanto quella dello spazio: ricordarsi, allora,è proprio operare, nella trama del sensibile, la con-versione di un momento spaziale nella memoria diquel gesto. Come ci insegna Proust, la memoria delcorpo conserva il passato non alla maniera di unacronologia, ma attraverso delle regioni qualitative: “Sesapori, odori, contatti, rumori di condotte d’acqua,movimenti degli alberi, la manipolazione di uno sti-valetto, madeleines, pavés, mediano una memoriaautentica, è perché le percezioni marginali, pre-obbiettive, non distanti, quelle che ricoprono lacoscienza più che esserne degli oggetti, tali percezio-ni esprimono il nesso carnale corpo-mondo (…): illegame col passato si opera per generalità di struttu-ra o per essenza alogica della percezione carnale (…).Fondamento dell’associazione è la corporeità e piùgenericamente la prassi” (Merleau-Ponty 2003, p.255). Questo passaggio assai denso ci svela un’ulte-riore proprietà del Leib: il corpo che si muove e chesente è il fondamento dell’analogia mnemonica. È nellacarne viva della nostra corporeità che si annodano ilegami mnestici in grado di stabilire delle reti senso-riali attraverso lo spazio e il tempo.
È in fondo quelloche descrive appuntoProust, e che ha il suoesempio più perfettonel fin troppo famosoepisodio della made-leine: “E tutto a untratto il ricordo èapparso davanti ame. Il sapore, eraquello del pezzetto dimadeleine che ladomenica a Combray(perché nei giorni difesta non uscivo dicasa prima dell’oradella messa), quandoandavo a dirle buon-giorno nella sua
camera da letto, Zia Léonie mi offriva dopo averlointinto nel suo infuso di tè o di tiglio. La vista della pic-cola madeleine non m’aveva ricordato nulla prima chene sentissi il sapore; forse perché spesso dopo di allorane avevo viste altre, senza mai mangiarle, sui ripianidei pasticceri, e la loro immagine s’era staccata di queigiorni di Combray per legarsi ad altri più recenti; forseperché, di ricordi abbandonati per così lungo tempo aldi fuori della memoria, niente sopravviveva, tutto s’eradisgregato; le forme – compresa quella della piccola
comE l’intErvallo dEgli albEri...
Chora N. 16, Settembre 2008
86
conchiglia di pasticceria, così grassamente sensualesotto la sua pieghettatura severa e devota – erano scom-parse, oppure, addormentate, avevano perduto la forzad’espansione che avrebbe permesso loro di raggiun-gere la coscienza. Ma quando di un lontano passatonon rimane più nulla, dopo la morte delle creature,dopo la distruzione delle cose, soli e più fragili mapiù vivaci, più immateriali, più presenti, più fedeli,l’odore e il sapore permangono ancora a lungo,come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare,sulla rovina di tutto, a sorreggere senza tremare –loro, goccioline quasi impalpabili – l’immenso edifi-cio del ricordo” (Proust 2006, I p. 58)7 . Propriocome per Merleau-Ponty, anche qui non è lacoscienza ad azionare la memoria, ma il corpo e isuoi sensi – in particolare il gusto e l’olfatto, non acaso i sensi meno intellettuali e più “fisici”, i piùsensuali, i più erotici. Un’estasi estetica ed erotica èquella descritta da Proust nel momento folgorantedella rimemorazione, in cui “l’edificio del ricordo”viene issato in un istante da quell’antico sapore, eriappare dal mare dell’oblio come le cattedralidipinte da Monet, acquose e irreali, suadenti eimmense nel tremolare cangiante della luce.
Il problema della memoria appare dunque ribalta-to: non sono più laconservazione dell’im-magine o una retro-spezione cosciente afar sì che si formi unpassato. Il passato sisedimenta nel corpo,sul corpo, così come iricordi si conservanonell’oblio: è l’oblio aconservare, affermaMerleau-Ponty, nongià l’oblio assoluto,naturalmente, bensìl’oblio come latenza,capace di evocare ilpassato grazie alle sueanalogie col presente,un oblio insomma chescava il tempo attraverso le pieghe orizzontali delsensibile. La concezione merleau-pontiana del pas-sato è quindi carnale come quella del presente. Lodimostra questo brano tratto da un corso del 1958:“Il passato non come ricordo puro (immateriale), nécome ricordo immagine (conservato o ricreato nelpresente), ma come passato-ombra, visibilità iscrittaper sempre, carne divenuta essenza. Il passato è unadiversa invisibilità del visibile (c’è l’invisibilità dilatenza presente: ciò che è dietro di me – Ciò che ètra i visibili). Il passato è ciò che è stato visto comeuna variante dello stesso essere col quale abbiamoancora a che fare o quest’ultimo come lo stesso di
quell’essere con cui abbiamo avuto a che fare”(Merleau-Ponty 1996, p. 202). Qui si afferma dinuovo la nostra appartenenza quasi spaziale altempo, quest’ultimo non essendo altro che un pas-saggio del sensibile con il quale abbiamo sempre a chefare. Parrebbe profilarsi una sorta di eternità delloSpazio quale Essere di carne o anche, com’è detto inseguito, una simultaneità del tempo come coesistenza insé di presenti incompossibili. L’autentica eternità, allo-ra, è quella del sensibile: come visibile in atto ecome visibile virtuale. Con una coerenza fenomeno-logica assoluta, Merleau-Ponty anziché ridurre lafenomenalità alla coscienza del tempo, deduce lacoscienza del tempo dalla fenomenalità.
È in questo quadro teorico che s’inserisce quellache potremmo definire la fenomenologia di Proust: ununiverso, cioè, che celebra una vera e propria riabili-tazione ontologica del Sensibile al modo merleau-pontiano. Si è parlato di un “platonismo” di Proust,il che sembrerebbe inficiare le nostre analisi. Ma nonè corretto, avverte Merleau-Ponty, poiché le ideeevocate nella Recherche sono “senza un sole intelligi-bile, e apparentate alla luce visibile: una membranadel visibile. Essenze segrete, velate e svelate, ‘alogi-che’ (Scheler), le une indirizzandosi al corpo estesio-
logico, le altre alcorpo libidinale”(Merleau-Ponty 1996,p. 194). Si trattainsomma di “matricisimboliche”, “poli divita carnale” cheesprimono la presen-za-assenza di un invi-sibile che prende aprestito le proprieessenze ad un Visibile“più che empirico”.Nel mondo dellaRecherche le idee e leessenze s’incarnanototalmente nei profu-mi, negli odori, nellesensazioni provate
dal protagonista: è un’incarnazione assoluta, senzaresto. È una metafisica completamente fagocitata dalSensibile; l’Estetica come Filosofia Prima. Esteticaintesa nella sua duplice accezione di scienza del Belloe dell’Arte e di scienza della Sensazione: nel mondoproustiano, “il vero, l’essenza non sarebbero nullasenza ciò che vi conduce. Vi è sublimazione, nonoltrepassamento vero un altro ordine. Il λέκτον nonpoggia su un λόγος indipendente dal ‘mondo esteti-co’” (Merleau-Ponty 2003, p. 90). Merleau-Pontygiunge a parlare di “ricordo ontologico” in Proust:come per il liceo di cui parla Heidegger, il cui sempli-ce odore ci evoca memorie di gioventù, così nella
7 Come accennavamo nella nota iniziale, molte delle ricerche psicologiche recenti sembrano in effetti confermare questa teoria, al punto che gli stes-si neuroscienziati sono giunti a parlare di un “principio di Proust”, secondo cui alcune percezioni sensoriali sono in grado di riattivare circuiti neu-ronali connessi ai ricordi by-passando altre aree cerebrali. Come spiega Owen Flanagan, un esperto di teoria della mente (TOM): “Il ricordo è dispo-sto in modo distribuito. Si attiva nel momento in cui le connessioni tra l’ippocampo e le varie aree su cui esso si proietta vengono rafforzate sullapressione, ad esempio, di una richiesta di ricordare. Una volta che il ricordo è predisposto e soprattutto dopo che è stato sollecitato, entra in gioco il‘principio di Proust’. Il ricordo può essere riattivato tramite l’attivazione di ogni giuntura importante, quale ad esempio la forma o il colore di unoggetto atto allo scopo, o anche un odore o un suono, senza che questa debba essere attivata direttamente dall’ippocampo” (Flanagan 1992, p. 19).Questa teoria, aggiunge Flanagan, è credibile e assai illuminante, giacché spiega, ad esempio, perché alcuni vecchi ricordi possono sopravvivereanche nel caso in cui l’ippocampo sia danneggiato o addirittura distrutto (il loro deposito è stato assicurato dalla neocorteccia).8 In questo senso abbiamo provato a intendere anche il Cogito ermeneutico di Ricoeur e il suo homme capable: un uomo capace non solo di agire e didonare, ma anche di ricevere – una capacità, appunto, intesa in senso quasi-fisico come capacità di contenere le molteplici forme dell’alterità e la varie-tà inesausta dei fenomeni (Si veda Altieri 2004, in cui si trovano anche alcune delle analisi del testo proustiano qui riprese).
87lorEnzo altiEri
Chora N. 16, Settembre 2008
Recherche i souvenirs ontologiques disvelano “un’unitàanteriore alla distinzione essenza-esistenza” (Merleau-Ponty 1996, p. 105).
Per questo i ricordi germogliano negli interstizi diquesta realtà sensibile, proprio come il vecchio cam-panile di Combray appare nell’intervallo degli alberidi Méséglise: “Tutto il giorno lo passavo nella miacamera, che dava sul bel verde del parco e i lilla del-l’ingresso, le foglie verdi dei grandi alberi in rivaall’acqua, scintillanti di sole, e la foresta diMéséglise. Tutte queste cose, in fondo, le guardavocon piacere solo perché me dicevo: ‘È bello vederetanto verde dalla finestra della mia camera’, fino almomento in cui nel vasto quadro verdeggiante nonriconobbi – dipinto, invece, lui, d’azzurro cupo, perla semplice ragione che era più lontano, il campaniledella chiesa di Combray. Non una raffigurazione diquel campanile, proprio il campanile stesso che, met-tendomi in tal modo sotto gli occhi la distanza nellospazio e negli anni, era venuto, in mezzo al verdeluminoso e in un tono affatto diverso, talmente scuroche sembrava quasi soltanto disegnato, a inscriversinel riquadro della finestra” (Proust 2006, IV p. 338).
Come nell’episodio dei tre alberi, tra i quali esitavaun ricordo, così in questa pagina, che non a caso aprel’ultimo volume della Recherche, il ricordo si materializ-za in tutta la sua potenza evocatrice “nell’intervallodegli alberi tra gli alberi”, e ci permette di ritrovarequel tempo che pareva perduto: l’apparizione quasi-sensibile del passato nel presente – il campanile (“ilcampanile stesso”, die Sache selbst) tra gli alberi delbosco – riavvolge le pieghe del tempo spazializzato, efa coincidere, in uno stesso sguardo, due momentidistanti l’uno dall’altro. Che Proust abbia in mentequalcosa di molto prossimo all’Intra-ontologia non-rappresentativa di Merleau-Ponty, lo conferma un altropasso, tratto dalle ultime pagine dell’opera, allorché ilNarratore riascolta il rumore di una tubatura d’acqua:“Ciò che il rumore della tubatura dell’acqua avevasuscitato in me non era, d’altronde, soltanto l’eco, ilduplicato di una sensazione passata, ma la sensazionestessa” (Proust 2006, IV p. 552). Ancora una volta, ilricordo appare come quell’elemento che inceppa l’in-granaggio del Sensibile e rivela la natura spaziale, cor-porea della nostra esistenza: la memoria ci mostrainsomma quell’eternità del visibile su sfondo d’invisibileche è la vita stessa.
4. E quasi subito la riconobbi, era Venezia:l’oblio e il tempo ritrovato
“La realtà si forma solo nella memoria”, diceProust, e Merleau-Ponty amava citare questa frase;ma è vero anche il contrario, e cioè che la memoriasi forma solo nella realtà: realtà e memoria, perce-zione e ricordo sono i due nomi di una stessa dialet-tica inscindibile. L’esperienza si forma nel ricordo,certo, ma è d’esperienza che il ricordo si nutre: leimmagini, le sensazioni che animano i ricordi sonoevocate da altre immagini, da altre sensazioni, in ungioco inesausto di rimandi, in cui il Sensibile river-bera se stesso e il proprio Senso. Non è un caso chequando la realtà smette di parlarci, la memoria siarresta: “Alberi, non avete più niente da dirmi”,pensa malinconicamente il Narratore in un momen-to di sconforto, prima di ricevere la rivelazionedella propria vocazione. Di fronte ad una fila ditronchi illuminati dal sole al tramonto, egli si con-vince di non poter essere Poeta: quegli stessi alberiche altre volte avevano evocato memorie e sensazio-ni profonde, stanno ora di fronte a lui fissi e muti, edecretano la sua impotenza. Nel loro intervallo nonsi disegnano né parole né emozioni, il visibile e l’in-visibile tacciono insieme.
Viceversa, allorché inciamperà sul selciato nelcortile del palazzo di Guermantes, egli sarà invasodalla struggente felicità della memoria, e tutte lepieghe della sua vita avranno finalmente un senso:“Ma nel momento in cui, recuperando l’equilibrio,posai il piede su una selce che era un po’ meno altadella precedente, tutto il mio avvilimento svanìdavanti alla stessa felicità suscitatami, in periodidiversi della mia vita, dalla vista d’alberi chem’era sembrato di riconoscere durante una passeg-giata in carrozza nei dintorni di Balbec, dalla vistadei campanili di Martinville, dal sapore di unamadeleine intinta in una tisana (…). E quasi subitola riconobbi, era Venezia, di cui i miei sforzi perdescriverla e le sedicenti istantanee scattate dallamia memoria non m’avevano mai detto niente, eche la stessa sensazione provata un tempo su duelastre ineguali del battistero di San Marco m’avevarestituita assieme a tutte le altre sensazioni colle-gate quel giorno ad essa e rimaste in attesa al loroposto” (Proust 2006, IV pp. 543-544).
Riassumendo, speriamo di aver mostrato che lostudio della memoria s’inserisce nel piùampio progetto merleau-pontiano di confuta-zione dell’idealismo trascendentale sullabase di una diversa valorizzazione delSensibile. Una filosofia della coscienza tradu-ce e deforma la nostra relazione con ciò che èinvisibile e assente, poiché essa riconducetutto alla presenza rappresentativa (altro nonè la riduzione che la presentazione del vissu-to dinanzi allo sguardo trascendentale); se,invece, il presente non è più Vorstellung maposizione dell’indice dell’essere al mondo, ese il nostro rapporto col presente è mediatoda uno schema corporeo che detiene una seriedi posizioni e di possibilità temporali, alloranon v’è più un’alternativa radicale tra lamemoria e l’oblio, la veglia e il sonno, la real-tà e l’immaginario, e queste dimensioni pos-sono essere comprese insieme nella loro dia-lettica sim-bolica. Come anticipato all’inizio,è nella figura della passività che si annodanoi sogni e i ricordi: “Che si tratti di compren-dere come la coscienza possa dormire, come
comE l’intErvallo dEgli albEri...
Chora N. 16, Settembre 2008
88
possa essere ispirata da un passato che apparente-mente le sfugge, o infine come possa riaprirsi unvarco verso tale passato, in ogni caso la passività èpossibile solo a condizione che ‘avere coscienza’non sia ‘attribuire un senso’ che si possiede ad unamateria di conoscenza inafferrabile, ma che sia piut-tosto realizzare un certo scarto, una certa variantein uno spazio d’esistenza già istituito” (Merleau-Ponty 2003, p. 276).
In conclusione, un’indagine fenomenologicasulla passività – sia essa sogno, memoria od oblio– ci riconsegna un Cogito radicalmente trasforma-to: un soggetto non più donatore di senso ma recet-tore di un evento, capace a sua volta di ricreare ilegami simbolici che intrecciano il visibile e l’invi-sibile8. Un soggetto che è anche, sempre, Narratoredella propria Ricerca del Tempo e della Felicitàperduti; un soggetto, dunque, che s’innamora dellecose, che si ciba delle loro essenze sensibili, che sinutre d’eterno – quell’eterno che una semplice sen-sazione può restituirci: “Ma basta che un rumore,un odore, già sentito o respirato un’altra volta, losiano di nuovo, a un tempo nel presente e nel pas-sato, reali senza essere attuali, ideali senza essereastratti, ed ecco che l’essenza permanente e abi-tualmente nascosta delle cose è liberata, e il nostrovero io che (da molto tempo, a volte) sembravamorto, ma non lo era del tutto, si sveglia, si animaricevendo il nutrimento celeste che gli viene offer-to” (Proust 2006, IV p. 550).
E ci ritroviamo così a cibarci di questa ostia burro-sa intinta nel tè, che la memoria e l’oblio elargisco-no secondo liturgie misteriose a chiunque vorràpartecipare all’eucaristia pagana dell’eternità, nelsublime miracolo della transustanziazione estetica.
5. DissolvenzaMa cosa sono allora quest’oblio e questa memo-
ria? Come dobbiamo chiamarli? Chi dobbiamo rin-graziare per questi attimi di gioia?
In mancanza di meglio, conclude Merleau-Ponty,continueremo a fare i conti con quell’inconscio chedispensa sogni e ricordi, che confonde i piani delpresente, del passato e del futuro, e che ci lascia difronte al tempo e all’oblio come bambini in riva almare: “Fintanto che la nostra filosofia non ci avràfornito i mezzi per esprimere meglio questo intem-porale, questo indistruttibile dentro di noi che è,dice Freud, l’inconscio stesso, allora forse è megliocontinuare a chiamarlo inconscio – alla sola condi-zione di sapere che il vocabolo è l’indice di unenigma – poiché conserva, come l’alga o il sassoche recuperiamo, qualcosa del mare in cui è statoraccolto” (Merleau-Ponty 2000, p. 283).
E per un attimo il Tempo sembrerà dissolversi,proprio come una madeleine si dissolve in una tazzadi tè, in un grigio pomeriggio d’inverno, o come siscioglieva il profumo delle foglie, tanti anni prima:“Il ridestarsi dei ricordi introduceva in mezzo allarealtà materialmente percepita una parte di realtàevocata, pensata, inafferrabile, sufficiente a infon-dermi, per ogni regione che attraversavo, più cheun sentimento estetico, un desiderio fuggevole, maesaltato, di vivere ormai per sempre. Quante volte,l’aver semplicemente sentito un odore di fogliefaceva sì che starmene seduto su uno strapuntinodi fronte a Madame de Villeparisis, incrociare laprincipessa di Luxembourg che indirizzava unsaluto dalla sua carrozza, rientrato per pranzo alGrand-Hôtel, mi apparisse come una di quelle feli-cità ineffabili che né il presente né il futuro posso-no restituirci e che si gustano una sola volta nellavita!” (Proust 2006, I p. 874).
In quell’attimo, per quell’attimo, finalmente èritrovata.
Che? – L’eternità.E’ il mare andato con il sole. E noi restiamo a
guardare, con quel sasso tra le mani.
nota bibliograficaAltieri L. (2004), Le metamorfosi di Narciso. Il Cogito itinerante di Paul Ricoeur, La Città del Sole, Napoli.- (2006), “Le parole, come fiori. La metafora viva tra retorica, fenomenologia e linguistica cognitiva”, in Bonfiglioli e Marmo 2006, pp. 361-373.Bonfiglioli S. e Marmo C. (2006, a cura di), Retorica e scienze del linguaggio. Teorie e pratiche dell’argomentazione e della persuasione,Aracne Editore, Roma.Barbaras R. (1999), Le désir et la distance. Introduction à une phénoménologie de la perception, Vrin, Paris.Barbaras R. (1998), Le tournant de l’expérience. Recherches sur la philosophie de Merleau-Ponty, Vrin, Paris.Flanagan O. (1992), Consciousness Reconsidered, Bradford, MIT Press, Cambridge-London.Kristeva J. (1994), Le Temps sensible, Gallimard, Paris.Lehrer J. (2007), Proust was a neuroscientist, Houghton Mifflin, Boston.Merleau-Ponty M. (2005), Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano.- (1993), Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano.- (2003), L’institution. La passivité. Notes de cours au Collège de France 1954-1955, Belin, Paris.- (1996), Notes de cours 1959-1961, Gallimard, Paris.- (2000), Parcours deux 1951-1961, Verdier, Lagrasse.- (1998), Notes de cours sur L’origine de la géométrie de Husserl, PUF, Paris.Proust M. (2006), Alla ricerca del tempo perduto, Meridiani Mondadori, Milano.- (1988), Du côté de chez Swann, Gallimard, Paris.Richir M., “Le sensible dans le rêve”, in Merleau-Ponty 1998, pp. 239-254.
lorenzo altieri, dopo aver completato il suo dottorato di ricerca a Parigi, presso la Sorbona, collabora conle cattedre di Filosofia teoretica e di Filosofia del linguaggio presso il Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta”dell’Università di Napoli “Federico II”. Svolge ricerca nell’ambito della tradizione fenomenologica ed erme-neutica. Ricopre l’incarico di segretario nazionale della Rete Euromediterranea di Fenomenologia per ilDialogo Interculturale. E’ autore del volume Le metamorfosi di Narciso (La Città del Sole, Napoli 2005);insieme a Umberto Eco e Marco Santambrogio è inoltre autore di Tradurre e comprendere. Pluralità dei linguag-gi e delle culture (Aracne, Napoli 2006).
89angElo rEcchia-luciani
Chora N. 16, Settembre 2008
Gli organismi svolgono due cose distinte: vivono e si riproducono.Niles Eldredge (1999)
Se usiamo la categoria di sostanza, la cultura non esiste. La cultu-ra non ha massa, non ha energia. Non esiste strumento di laborato-
rio che permetta di distinguere una cultura da una non-cultura. Mase la scienza è lo studio delle configurazioni stabili di valori, allora
l’antropologia diventa un campo scientifico per eccellenza. Una cul-tura può essere definita come una rete di modelli di valore sociali.
Robert M. Pirsig (1991)
IntroduzioneIn un’ottica evoluzionistica, gli organi o dispositivi (devices)
mentali sono strutture geneticamente determinate e seleziona-te in relazione al vantaggio, in termini di sopravvivenza e suc-cesso riproduttivo, che hanno comportato per gli antenati dicoloro che li presentano. Fodor (1983) definì i ‘moduli cogniti-vi’ come “specifici per un dominio particolare, determinatigeneticamente, preprogrammati, autonomi”, dalle operazioni“obbligate” e “rapide”, “incapsulati informazionalmente”(ovvero specifici per tipo di informazione) e “associati adun’architettura neuronale fissata”. (ed. it. 1988 p. 53). MerlinDonald, nel suo L’evoluzione della mente (2001), ipotizza diffe-renti stadi di sviluppo, connotati da “un mutamento struttura-le nell’organizzazione cognitiva accompagnato da un profon-do rivolgimento culturale, e un com plesso di nuovi moduli”con interi ‘livelli’ di proprietà emergenti , e moduli cognitivipiù recenti “fisicamente presenti in qualche luogo, che spesso èun locus della memoria esterna”. Nel suo aderire al modellodel funzionalismo computazionale, questo autore assimila lamemoria simbolica esterna ad un “cambiamento di hardwarenella struttura mentale umana, quantunque l’hardware nonsia biologico” (Ed. it. p. 27). A questi moduli cognitivi fodoria-ni ‘perfettamente reali’ -nonostante il loro situarsi all’esterno delcervello, a configurare una sorta di ‘hardware di rete’- Donaldaffida la possibilità, insieme all’avvento della cultura teoretica(successiva alle fasi mimica e mitica) della terza e ultima dellesue transizioni fondamentali nell’evoluzione della mente.
Segni, metafore e cultureGli organi mentali che hanno reso possibile una nuova orga-
nizzazione della memoria, permettendo l’utilizzo di dispositi-vi esterni alla nostra biologia, sono gli stessi che hanno consen-tito l’adozione sistematica e non esclusivamente accidentale distrumenti protesici, e la loro trasmissibilità anche a coloro chenon ne avevano compreso l’uso direttamente, nelle formedella sensomotricità. Sono dispositivi mentali idonei a trattare“tropi”, la cui implementazione richiede non solo cervelli, magruppi di organismi organizzati in forme sociali, e quella specia-lissima protesi che è un linguaggio scritto basato su di un alfa-beto fonetico. La capacità della mente di comprendere qualcosanei termini di qualcos’altro è all’origine non soltanto del linguag-gio, ma di tutti i sistemi di segni. L’organizzazione dei segni è
metaforica. Scopo della metafora è la comprensione. Essa ne èanche il solo mezzo. Al Vico che già descrive l’origine “umanae corpulentissima” di ogni concetto, fino al più astratto, attra-verso “grappoli di metafore” si ricollega la ricerca sistematicache con la linguistica cognitiva di Lakoff e Johnson identificauna vera e propria semantica trasformazionale, lavoro moderna-mente preceduto di solo pochi anni dal monumentale sforzodel Jaynes del Crollo della mente bicamerale (1976). È la metaforala funzione essenziale alla comprensione, ciò che ha permessoil pensiero, il linguaggio e un “accumulo percettibile di saperesovraindividuale” (Lorenz 1973, it. 272). Come l’etologia hariccamente documentato, la cultura non è un’invenzione del-l’uomo. Ogni complesso di nozioni e di pratiche che sia patrimo-nio di un gruppo socialeè infatti definibile come una cultura. Solo,a oggi, non conosciamo specie diverse da homo sapiens sapiensin cui le”tradizioni culturali” non siano costantemente legateall’oggetto, ovvero regolarmente spezzate quando gli oggetti cui siriferiscono non compaiano per tutto il lasso di tempo che comprendeun’intera generazione (adattato da Lorenz, ibidem). L’intuizioneche fenomeni evolutivi ineriscano non solo la biologia maanche la cultura è quasi coeva al darwinismo nella sua formu-lazione originaria. Già nel 1880 Huxley pensava le teorie come‘specie’ di pensiero, sottoposte a selezione naturale; DanielSchacter (2001) ci riferisce dell’opera del biologo tedescoRichard Semon (già noto per il concetto di engramma) Diemnemischen Empfindungen in ihren Beziehungen zu denOriginalempfindungen, tradotta in inglese nel 1921 col titolo TheMneme. A partire almeno dagli anni 1970, in molti hanno cer-cato di comprendere i continui mutamenti del comportamen-to umano nello schema di una evoluzione culturale, anch’essabasata su fenomeni di selezione (Cavalli-Sforza e Feldman1973, Cloak 1975, Boyd e Richerson 1985, Calvin 1996).Dawkins (1976, 1982) rese celebre il concetto di un replicatorenon genetico, analogo al gene in quanto unità biologica del-l’ereditarietà. Parafrasando Dennet (1996) l’ “idea pericolosa diDarwin” è concetto di potenza tale da poter ‘corrodere’ qua-lunque disciplina con cui venga a contatto; di universalità taleda far ritenere la teoria di Darwin sull’evoluzione biologicacome un semplice “caso speciale”. Come egli stesso afferma(Dennet 1999), che le culture evolvano, nella sua assoluta ovvie-tà, può essere addirittura considerato un truismo.
Se già con Eraclito tutto scorre (pánta rhêi), è solo la nostranecessità di rapportare ogni cosa, e innanzitutto le nostre sen-sazioni e percezioni, alla durata relativa della nostra esistenza,a farci percepire ‘cose’ oltre che ‘processi’. Non esiste davveronulla di immutabile: anche gli ‘oggetti’ hanno ‘storie’, solo chesono caratterizzate da mutamenti così lenti da non essere facil-mente percepiti. Rispetto alle più familiari tra le categorie delreale, le culture sono certamente assimilate più a eventi che nona entità. E le culture evolvono grazie ai memi: pattern informa-zionali, di tipo cognitivo o comportamentale, contenuti inmemorie individuali, in grado di essere copiati nella memoriadi altri individui, nella loro qualità, analoga a quella dei geni,
MeMorie oltre le generazioni
di angelo recchia-lucianiuniversità degli studi della Basilicata
Memi, segni e neuroscienze cognitive per un’ipotesi evolutiva della cultura
mEmoriE oltrE lE gEnErazioni
Chora N. 16, Settembre 2008
90
di unità di replicazione, o replicatori. Colui da cui il patternviene copiato, così come colui che ne conterrà la copia, sonoveicoi (carrier). Su queste basi nascerebbe la memetica.Nell’ipotesi dawkinsiana, focalizzata sulla replicazione, esem-pi classici di pattern informazionali memetici sono motivi ecanzonette, filastrocche e leggende metropolitane, ‘tormento-ni’ e ‘frasi celebri’ tratti da testi e soprattutto dai media; poemiepici e racconti ma anche barzellette, proverbi e aforismi.Nell’accezione che verrà proposta qui, in cui i criteri di fedeltàdella copia, fecondità e longevità verranno riferiti al contenutosemantico del pattern informazionale piuttosto che alle suecaratteristiche formali e sintattiche, esempi più calzanti sonocostituiti da norme e leggi. Che accolgono, formalizzandole,nuove ipotesi interpretative del reale, condivise, e potenzial-mente connotate da valore adattativo,validato da selezione. Un modello efficaceè costituito dai sistemi che hanno porta-to alla nascita della meritocrazia. Nel suorecente saggio, Abravanel (2008) ne indi-vidua luogo e data di nascita: l’universi-tà di Harvard, nel 1933. Alla celebre uni-versità, culla dei futuri leader statuniten-si, accedevano sino ad allora solo ram-polli di famiglie ricche. Dal 1933 l’acces-so fu regolato da un test che cercava dirilevare conoscenze e capacità possedu-te, senza alcun riguardo per criteri fami-liari o di casta, di ceto o di status econo-mico. Tracce precedenti di questo pat-tern sono certamente evidenti: ciò checostituì gran parte della forza diNapoleone fu la sua capacità di rivolu-zionare – prima che lo stato - la suagestione della leadership (non solo milita-re, come dimostra la rifondazione del 1808 della rivoluziona-ria école normale supérieure, nata nel 1794 e soppressa un annodopo). Ispirandosi, peraltro, a modelli della classicità antica.Così, un criterio di ‘efficienza’ sorto in un contesto bellico (sce-gliere per capacità piuttosto che per nascita o appartenenza,come in parte accadde a Roma anche per l’imperatore),‘dimenticato’ e ‘resuscitato’, viene acquisito e ‘traslato’ in ambi-to civile, ove rivela la possibilità di generare nuove tipologie diclassi dirigenti. Che attraverso innovazioni economiche, scien-tifiche e tecnologiche producono uno sconvolgimento presso-ché totale della struttura sociale. Quel che conta, qui, è il conte-nuto informativo più che la sua forma esteriore: contenuto cheoggi dimostra impressionanti fedeltà, longevità e soprattuttofecondità, nella sua capacità di modificare tradizioni culturalimillenarie e affatto differenti, come quelle che stanno cambian-do l’india, la cina e le altre realtà asiatiche, il brasile...
L’attacco della semiotica e i limiti del fondamentalismodarwinista
La semiotica ha giustamente contestato al meme d’esserpoco più che un abbozzo primitivo di segno, pre-saussuriano epre-peirciano, privo com’è persino della classica tripartizionein icona, analogia e simbolo (cfr. Deacon 1997, Kull 2000 eBenitez-Bribiesca 2001). Meno radicale ma non meno impor-tante l’obiezione di Henson (1987), sulla necessità della meme-tica di assimilare integralmente il paradigma della psicologiaevoluzionistica, per comprendere le conseguenze psicologichee comportamentali che i pattern informazionali replicantihanno sui loro veicoli. Di maggior peso risulta, peraltro, l’osta-colo principale: l’incompiuta definizione dello statuto ontologi-co dei memi, oltre che di alcune delle loro proprietà essenziali.Memi come ‘fotocopie’ (neppure ‘traduzioni’!) che ‘ saltano’daun cervello all’altro: può bastarci? È questa un’interpretazionedel meme verosimilmente originata dall’uso peculiare che neha fatto Dawkins e, più in generale, la corrente che Eldredgedefinisce ‘ultradarwinismo’. Attribuire intenzionalità ad un pat-
tern informazionaleequivale a utilizzare la classica ma impropo-nibile ‘metafora del canale di comunicazione’, che da un latoenfatizza il messaggio, dall’altra equipara tutto il resto delsistema ad un semplice contenitore passivo, non ‘determinatostrutturalmente’ ma in cui invece le interazioni sono di tipoistruttivo. “Il fenomeno della comunicazione non dipende daquello che si trasmette, ma quello che accade con chi riceve”(Maturana e Varela 1992). Geni o memi di per sé non sonoinformazioni: sono segnali configurati in pattern, che assurgo-no al ruolo di informazione solo all’interno del sistema che li uti-lizza. Se la cultura si presta par excellence ad analisi storiche,supporre l’esistenza di enti in grado di configurarne le qualitàdi sistema ereditario (che ne garantiscano cioè sia una forma dimemoria, intesa come costanza attraverso le generazioni, che la
variabilità indispensabile all’adattamento)è anch’esso un truismo. Prima ancora diassumere il punto-di-vista-del-meme,importanti problemi ineriscono la siste-matica adozione del punto-di-vista-del-gene. La stessa definizione di replicatore fariferimento ad una struttura il cui unicoscopo e interesse consiste nel produrrecopie di un determinato pattern di infor-mazione. È questo che induce a conside-rare assolutamente centrali, nella storiadell’evoluzione, i parametri di fedeltà dellacopia, fecondità e longevità. Naturalmente,la mancata definizione di uno statutoontologico dei replicatori produce pro-blematiche imponenti: e genera l’accusadi non scientificità. Scienza equivale acapacità di descrizione, talora di spiegazione(con la ricostruzione di concatenazionicausali) e predizione: se non di eventi spe-
cifici, di pattern. Obiettivo impossibile da raggiungere senzauna conoscenza della natura dei processi studiati.
Ma non definire il meme, né delucidare i rapporti tra esso emondo esterno, tende a produrne un profilo piuttosto povero.Che a propria volta porta da un lato ad adottare modelliminimi, dall’altro a incontrare difficoltà insormontabili. Imemi vengono assimilati a virus, per la loro capacità di strut-turare informazione finalizzata esclusivamente alla propriareplicazione, in grado di “infettare” il cervello: ma in ambitobiologico un virus non è una struttura vivente, non essendoconnotato da autopoiesi. In assenza di un sistema di com-plessità infinitamente maggiore, la cellula vivente, i virusnon sono in grado di riprodurre se stessi, poiché non dispon-gono di una rete autonoma di processi di produzione ingrado di ricostruire gli elementi stessi, né ovviamente ingrado di mantenere invariata l’organizzazione. In questosenso, virus e memi così definiti sono più delle repliche chenon dei replicatori (Deacon 1999), repliche di cui ignoriamonatura e dimensioni, caratterizzate da una fedeltà di copiacosì scarsa da impedire i processi evolutivi (Dawkins, intro-duzione a Blackmore 1999), e addirittura dall’impossibilità,relativamente alla analogia genetica, di comprendere sesiano assimilabili al genotipo, oppure al fenotipo.
La semiotica accusa la memetica di essersi occupata dinull’altro che di segni: in alcuni casi più radicali, di veicolidi segni (i peirciani representamen), depauperati della sco-perta oramai antica intorno alla loro natura triadica eimmiseriti (an underdeveloped special version; Kilpinen, instampa; a degenerate sign; Kull 2000) nella duplice perditada una parte del proprio rapporto con ciò che rappresenta-no (l’oggetto cui si riferiscono), dall’altro con l’interpretante(il soggetto che interpreta: che comprende, conferendosignificato al segno). Un segno non si caratterizza per lesue caratteristiche fisiche. Qualche fotone nella gammadel visibile può non avere alcun significato “di per sé”:può averne uno molto preciso per voi, se viene emesso
Richard Dawkins
91angElo rEcchia-luciani
Chora N. 16, Settembre 2008
dalle luci posteriori che segnalano la frenata improvvisadi quell’auto che procede veloce, pochi metri davanti almuso della vostra. All’origine delle difficoltà inerenti il concetto di meme, nelleforme in cui è stato definito dai suoi propugnatori sino a oggi, staun’accezione ‘fondamentalista’, analoga a quella attribuita algene, e alle difficoltà di questa e della cosiddetta sintesi moder-na tra genetica ed evoluzionismo, ad esaurire lo spazio dellaspiegazione. Quando Stephen Gould (1997) definì fondamenta-listi darwiniani i paladini dell’egoismo del gene - o del meme! -mostrò tutti i limiti di una concezione antisemiotica dei conte-nuti informativi. Enfatizzare il ruolo di un replicatore senzauna eccessiva considerazione del suo ruolo in un sistema com-plesso, che sia quello della biologia o quello della cultura, equi-vale a negarne il significato e, con esso, le possibilità di com-prensione del ruolo. Sottolinearne esclusivamente la possibili-tà di copia (re-presentazione; rappresentazione), tra l’altro senzaalcun riferimento né ai meccanismi di sicurezza che ne proteg-gono il contenuto, né a quelli che ne possono garantire la varia-bilità, significa poi tradirne la funzione più profonda, interpre-tativapiù che replicativa, che è quella di guidare i processi di svi-luppo nella realizzazione del vivente: non solo nella realizza-zione d’un fenotipo (più o meno esteso!), ma nella sua derivastrutturale ontogenetica: “finché rimane vivo, ogni organismo
compone una storia di cambiamenti strutturali e di posizione, finalizzata alla conservazione della propria organizzazione edell’adattamento” (Maturana 1987). Riprodursi sarà interes-sante, ma non è la sola cosa che connota il vivente, soprattuttosuperata la soglia monocellulare! Come lucidamente prevedeDeacon (1999), alcune idee portanti la proposizione della
Terrence Deacon
cenni di storia della memeticaPiù autori hanno contribuito a diffondere un approccio evoluzionistico a discipline non strettamente biologiche. Dennet innan-zitutto: non esclusivamente in riferimento al funzionalismo computazionale, come è accaduto per esempio nell’ambito del suolavoro curato insieme a Hofstadter (1981), ma anche in ambiti più vasti, ove egli ha difeso una prospettiva radicalmente daw-kinsiana, in cui al meme (il replicatore), e non al suo portatore (il carrier) si deve attribuire l’atteggiamento intenzionale, il cuibono, l’egoismo che già Dawkins attribuì al gene su cui esso viene modellato: le analisi costo-beneficio (che nell’approccio den-netiano costituiscono la struttura di pensiero tratta dall’economia classica, a configurare la metafora portante di tutte le disci-pline che si occupano di cultura: non solo economia ma anche storia, antropologia, psicologia e infine biologia) che identifica-no agenti (razionali) capaci di azioni e reazioni sulla base di ragioni (intenzioni e motivazioni; credenze e desideri). Come il gene, è ilmeme l’agente cui davvero riferirsi. Capace di una qualche non meglio precisata versione della istanza intenzionale: verosimilmen-te, differente da quella connotata dalle ragioni che attribuiamo alle persone, ma proprio per questo definita in modo piuttostovago. Plotkin e Heyes hanno sviluppato l’originale impostazione di Donald Campbell definendo non solo l’ambito d’una epi-stemologia ma anche quello della psicologia evoluzionistica; Hull ha proposto la selezione delle teorie come meccanismo essen-ziale alla spiegazione, nella storia della scienza. Dibattiti importanti hanno avuto luogo su quale metafora dovesse essere sele-zionata per spiegare alcune delle caratteristiche dei replicatori memetici: assimilabili a veri e propri geni, a parassiti, ad orga-nismi simbionti (commensali o mutualisti) o a “virus della mente” come recitano i titoli di un libro di Brodie, e di un articolodi Dawkins; se non a viroidi addirittura, elementi informazionali assimilabili a materiale genico quasi privo di un corrispon-dente fenotipo. Un Symposium on Memetics, organizzato nel 1998 nell’ambito della quindicesima International Conference onCybernetics, si concluse con una mozione che metteva fine ai dibattiti sulle definizioni, e alle infinite polemiche tra “internalisti“(per i quali le unità che trasferiscono informazione sono interne al cervello) ed “ esternalisti“ (secondo cui le unità che conten-gono informazione sono costituite dalla totalità di artefatti e comportamenti). In Hull, alla replicazione si affianca il ruolo del-l’interazione, a darci conto di importanti fenomeni evolutivi sia in biologia che nella storia della scienza; qui, peraltro, il rico-noscimento di essenziali aspetti evoluzionistici è tra i pochi tratti che accomunano il lavoro dei due maggiori epistemologi delsecolo appena trascorso, Popper e Kuhn. Studi specifici, tesi ad un resoconto anche quantitativo di fenomeni evolutivi ineren-ti le culture, sono nei lavori di Cavalli-Sforza, Boyd and Richerson, Csanyi; su scale temporo-spaziali ampie e diversificate siesercitano i fenomeni selettivi descritti da Calvin, e quelli – celebri - tra popolazioni neuronali della TSGN (la Teoria dellaSelezione dei Gruppi Neurali) di Gerald Edelman, mentre in altri ambiti (dallo studio dell’evoluzione del linguaggio agli algo-ritmi genetici nei calcolatori) le metafore della biologia hanno esercitato influenze importanti. Il testo di Brodie insieme al volu-me del filosofo e matematico Aaron Lynch (nel 1996) rinnovarono l’interesse per l’ “ipotesi memetica”, come poi tornò ad acca-dere nel 1999 con la pubblicazione della Macchina dei memi da parte della Blackmore. Nel 1996, nell’ambito del PrincipiaCybernetica Project (PCP: http://pespmc1.vub.ac.be/), più partecipanti espressero un interesse specifico verso l’ambito dellanascente protoscienza, e questo generò dapprima un gruppo di discussione, poi una vera e propria rivista scientifica, peer-revie-wed grazie ad un editorial board e ad un advisory board in cui trovavano posto pressoché tutti gli autori di riferimento della disci-plina. La rivista, il Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission (familiarmente il JoM-EMIT) ha pubbli-cato 14 numeri in otto anni di attività, con un impact factor prossimo a 0.7, dal Maggio 1997 al primo e unico volume del 2005:ma in quel numero finale, persa l’ospitalità del Centre for Policy Modelling alla Manchester Metropolitan University, la rivista hapubblicato una piccola collezione di necrologi dedicati a questa giovanissima scienza, si direbbe deceduta prima d’un vero eproprio atto di nascita. Uno dei membri fondatori, Francis Heylighen, ha però raccolto questa eredità, trovando una nuova‘casa’ virtuale per la rivista (http://www.jom-emit.org/), che ad oggi non ha ancora ricominciato le pubblicazioni, ma (nel2007) è tornata ad accettare articoli per la valutazione. Nella nuova ‘reincarnazione’ l’enfasi viene posta più sulle prospettivedella memetica come scienza sociale ed umanistica, che sulle sue radici nella biologia e nella ‘computer science’: ma qui la sfidaconsisterà nel prendere atto di alcune obiezioni assolutamente essenziali. Prima tra queste è di certo quella proveniente dallasemiotica, cui evidentemente seguirà quella delle teorie evolutive post-Sintesi Moderna.
mEmoriE oltrE lE gEnErazioni
Chora N. 16, Settembre 2008
92
memetica potrebbero comunque permettere alla semiotica diinterrogarsi sulla causalità e sulla generazione delle forme e deisistemi rappresentazionali, con relazioni che emergono a parti-re da processi evolutivi di tipo competitivo/cooperativo a deter-minarne selettivamente la forma e la persistenza, oltre che lepossibili variazioni. Non considerando i segni nel loro isolamen-to: ma nei loro complessi effetti sistemici; nel rispetto sì della pos-sibilità di copia, ma nella più alta considerazione della funzionerappresentativa e dell’intrinseca possibilità interpretativa (Kilpinen,ibidem). Perché “i segni evolvono, hanno conseguenze pratiche,in virtù delle quali sono selettivamente favoriti per rimanere incircolazione, oppure eliminati col tempo. È in virtù dell’analogiamemetica all’evoluzione genetica che possiamo scoprire la logi-ca dinamica tuttora necessaria ad una completa teoria dellasemiosi, piuttosto che ad una semplice tassonomia semiotica”(Deacon 1999, traduzione mia). Ricordate le norme di ammis-sione ad Harvard a partire dal 1933? E, verosimilmente, è la lorocomparsa, nella forma di relazioni di ordine superiore al primo, afare una gran differenza per la speciazione di Homo; più che nonla comparsa di un LAD (Language Acquisition Device: Chomsky,1957). Prima che una grammatica universale, è una semantica uni-versale a connotare la specie umana: Deacon (1997) ne parla rife-rendosi a Lakoff e Johnson, noi qui rifacendoci al vecchioGiambattista Vico (1744).
Biologia semioticaAl cuore della semiotica, più che lo studio dei segni, sta quel-
lo del processo stesso della semiosi (Deacon, ibidem), ed è quila salvifica promessa della memetica. Che consiste nella indi-viduazione dei pattern ripetitivi, che permettono l’individua-zione di ciò che genera senso, in sistemi strutturati secondo ordi-ne stratificato, a partire dalla biologia per arrivare poi alla psico-logia, degli individui e dei gruppi, sino allo studio dei compor-tamenti che regolano le società, l’economia, gli ecosistemi glo-bali che interessano il pianeta nella sua totalità. Qui ci si riferi-sce senza equivoci ad un modello di ordinamento nell’orga-nizzazione del reale che l’approccio sistemistico ha introdottonell’ambito scientifico a partire dal secolo scorso, innanzituttograzie a Herbert Simon (1962), che con Dobzahnsky e la suagerarchia genealogica ha rinnovato profondamente il pensierodarwiniano ‘riordinando’ i rapporti tra informazione e trasfe-rimento materiale ed energetico nell’ambito del vivente; perapprodare con Eldredge, celebre autore (con Gould) della teo-ria degli equilibri punteggiati, ad una gerarchia ecologica (indi-cata anche come economica) che riporta i processi che governa-no la storia evolutiva della vita nel loro alveo naturale: la sto-ria della terra. Una teoria della gerarchia in analogia alla qualesi sviluppano i livelli di apprendimento di Gregory Bateson,apprendimento che Baldwin un secolo fa ha dimostrato poterguidare i processi evolutivi. Ciò che accomuna le scienze dureche si occupano delle cose, e quelle morbide, storiche, che si occu-
Imagine a world full of brains, and far more memes than can possibly find homes
animali e pensiero astrattoGli studiosi di psicologia comparata hanno appro-fondito l’argomento del confronto tra la capacità dicostruzione concettuale di classi in diverse specie discimmie, negli scimpanzé, e nella specie umana, sianell’infanzia che in età adulta. Gli studi vengonoeseguiti preferibilmente attraverso l’esecuzione ditest di somiglianza o corrispondenza rispetto ad uncampione (match ing-to-sample task, MTS), e suggeri-scono che già nelle scimmie rhesus (Macaca mulatta)esiste la possibilità di una classificazione basatasulla condivisione di caratteristiche invarianti,attraverso l’utilizzazione di semplici strategie pro-cedurali di tipo associativo. In esse, però, non esistealcuna prova della capacità di percepire relazioni-tra-relazioni, mancanza che le fa definire ‘paleo-logiche’ (Thompson 2000). Le scimmie identificanosomiglianze e differenze tra oggetti singoli, ma laloro classificazione viene ristretta ad elementi diuna singola classe (first-order classifying): gli scim-panzé (Pan troglodytes) possono farlo con un livellopiù astratto, raggiungendo una classificazione ele-mentare di secondo ordine (è possibile identificaresomiglianze e differenze in più di una class e, il chepermette loro di distinguere tra coppie di oggetti:oltre a poter mettere insieme un mazzo di chiavi,riconosco la somiglianza tra una chiave reale ed unadi plastica colorata). Questa capacità concettuale,correttamente definita come analogica, è rintraccia-bile esclusivamente negli scimpanzé e negli umani,ma - in entrambi! - esclusivamente dopo una fase diistruzione. Questa capacità emerge infatti nellaforma di una conoscenza esplicita solo dopo l’adde-stramento ad un sistema simbolico (il linguaggio oun sistema di gettoni), che rende le rappresentazio-ni proposizionali suscettibili di codifica e manipola-zione. In questo modo, uno scimpanzé di cinqueanni diviene capace di selezionare oggetti, raggrup-pandoli in due insiemi diversi tra loro, ma all’inter-no dei quali i singoli conten uti sono simili o identi-ci. Altre tipologie di esame (test basati sulla reazio-ne comportamentale alla novità: preference-for-novel-ty tasks) mostrano che la somiglianza nelle relazio-ni, benché non misurabile esplicitamente nelleprove MTS, viene percepita sia nei piccoli umaniche nei piccoli scimpanzé prima dell’addestramento:ma non nelle scimmie Rhesus, anche adulte, nono-stante la loro capacit à di percepire l’identità fisica.In studi più avanzati (Sousa e Matsuzawa 2001), incui i gettoni venivano utilizzati come premio per lacorretta esecuzione di un compito, e successiva-mente come merce di scambio rispetto al cibo, gliscimpanzé mantenevano, con i gettoni, un livelloprestazionale quasi equivalente a quello raggiuntocon i premi in cibo (in uno degli scimpanzé in cor-rispondenza perfett a, ad indicare l’equivalenza deidue stimoli). Di più, cominciavano a “risparmiare”gettoni! Bambini e scimpanzé esibiscono la capacitàdi comprendere le relazioni causali; addestratiall’utilizzo di un sistema simbolico (il linguaggio oun sistema di etichette: gettoni ad esempio) posso-no dimostrare la capacità di etichettare le compo-nenti rispettivamente come attore, oggetto e strumen-to, o di scegl iere la corretta conclusione di una suc-cessione incompleta che rappresenti una sequenzacausale. La celeberrima Sarah (Premack e Premack,1994), oltre l’etichettatura, riusciva a completarerappresentazioni incompiute di azioni che coinvol-gevano trasformazioni multiple.
93angElo rEcchia-luciani
Chora N. 16, Settembre 2008
pano dei processi è esattamente questo: l’individuazione dipattern invarianti, di quelle che a lungo abbiamo chiamato leleggi immutabili della natura. Come nascono i segni? Comecominciamo a superare l’ambito delle relazioni di primo ordi-ne (quelle tra oggetto e segno) per percepire prima, manipolarepoi le relazioni-di-relazioni?
Le scimmie percepiscono somiglianze e differenze ogget-tuali; gli scimpanzé sanno produrre associazioni indicative disecondo ordine ma – come nei bambini – solo dopo un perio-do di apprendimento, il cui ruolo non deve in alcun modoessere sottovalutato. Come spessissimo avviene e come è statoformalizzato negli studi sull’effetto Baldwin, un pattern genicodifficilmente può essere considerato più che una sorta di‘disposizione’; oltre agli effetti di regolazione epigenetica, compor-tamento e apprendimento possono mutare drasticamente il risul-tato dello sviluppo: la realizzazione del fenotipo, anche se nonmodificano direttamente ciò che viene copiato e trasmessoattraverso le generazioni. È dalla interazione del fenotipo conl’ambiente che dipende la fitness: è l’ambiente il giudice ulti-mo del grado di adattamento, ciò che alla fine decide dellacapacità di sopravvivere e riprodursi. Se questo non basta aresuscitare né gli esempi né la lettera diLamarck, non può non ricordarne lo spi-rito: i mutamenti dell’organismo prece-dono quelli nel suo codice genetico, e sel’assetto assunto dal primo si mantienestabile (per molte generazioni!) eventiaccidentali possono rendere fissi i secon-di. Nella classificazione di Deacon(1997), se l’icona tipicamente implica unaclassificazione di primo ordine, gli indicisono costituiti da relazioni tra icone, il cheli rende re-appresentazioni indirette; isimboli sono costituiti da relazioni traindici, a renderli re-appresentazioni dop-piamente indirette.
I preference-for-novelty tasks dimo-strano che bambini e scimpanzé perce-piscono la somiglianza nelle relazioni,ma non sono in grado di manipolarla, eanche questa capacità percettiva, noncoltivata, resta sterile. Deacon sottoli-nea l’importanza di questi elementi,ricordando anche (similmente aMichael Tomasello) la rilevanza deifenomeni di condivisione dell’attenzione edella intenzionalità.
La mente non somiglia a un computer, ma a un testoL’epistemologia culturalista replica al modello di mente
come computer, “Information Processing System”, l’analogiadella mente con il testo, ritenuti entrambi degli “InformationContextuali zing Systems” (Mininni 2008). Ma – direbbe Peirce -nulla è intrinsecamente significativo, senza una interpretazio-ne, e l’interpretazione spetta al sistema che ‘riceve’ l’informa-zione, non al sistema che la genera. Le molecole, elementidel’informazione biologica, sono immerse in un pluriverso diinformazione (oltre che di segnali): se quella ‘elettrica’ è tenutacostante, a cambiare il comportamento del modulo può inter-venire la chimica ambientale, attraverso molecole che hannofunzioni complesse in più sistemi. Senza fughe metafisiche:l’informazione ‘guida’ concreti trasferimenti di materia ed ener-gia (lo sviluppo produce corpi, che respirano, mangiano, lotta-no...), trasferimenti a propria volta dipendenti, nella realtàdella deriva strutturale ontogenetica, da solidissime moltepli-ci trasformazioni ambientali in tutti e tre i domini, nella realtàdegli ecosistemi locali , “arena reale dove si svolge il giocodella vita” (Eldredge 1999). Tutta l’informazione necessita la con-testualizzazione: più specificamente, ogni testo sarà attivato daun pre-testo, retto da un ipo-testo, realizzato nell’inter-testo, pro-
iettato nel dia-testo, realizzato come iper-testo, e utilizzabilecome meta-testo (Mininni 2008). Jablonka e colleghi (1998; citin Kull 2000) fanno riferimento a quattro sistemi ereditari: epige-netico (Epigenetic Inheritance System, EIS), genetico (Genetic I S),comportamentale (Behavioral I S), e linguistico (Linguistic I S),sistemi il cui trattamento dell’informazione implica rispettiva-mente la rigenerazione di strutture cellulari e reti metaboliche(EIS), la replicazione del DNA (GIS), l’apprendimento sociale(BIS, LIS), questi ultimi due per mezzo di simboli. La vita comin-cia con la realizzazione delle prime reti metaboliche autono-me e capaci di autoreplicazione: fenomeni complessi tipica-mente emergenti, sistemici, strutturati gerarchicamente.L’enfasi totalizzante sui processi di replicazione ha portato,come abbiamo visto, ad un modello di informazione “epidemiolo-gico” (cfr. Dawkins, Brodie e Sperber 1996): ma la deconte-stualizzazione dell’informazione virale, così come la “perditadel contatto col sistema” che porta le cellule maligne alla iper-replicazione sono esempi di patologia (rispettivamente virale etumorale), non certo eventi tipici del normale funzionamentodel sistema (Kull 2000). Nella identificazione che MaynardSmith e Szathmáry (1997, 1999) fanno delle maggiori transi-
zioni dell’evoluzione, un ruolo fonda-mentale viene attribuito ai sistemi a eredi-tarietà illimitata, caratterizzati innanzitut-to dalla modularità, definita in base acomponenti fondamentali, “in numeroridotto, [ma che] possono essere assem-blati in differenti sequenze per esprimereun numero indefinitamente grande disignificati diversi” (Maynard Smith eSzathmáry 1999, it. Pag. 16, corsivo mio).Ne conosciamo solo due esempi: codicegeneticoe linguaggio, essi sostengono; codi-ce genetico e alfabeto fonetico scritto, sosten-nero autori come Bynumin, Havelock,Jaynes, Lord, Luria, Milman, Ong, Parry,Vygotskij (in ordine alfabetico!): perché imemi non infettano un cervello dopol’altro, ma sono pattern di informazionestrutturati, essenziali inquell’”Information Contextuali zingSystem” che chiamiamo coscienza.
Il ruolo delle neuroscienze cognitivePossiamo ipotizzare la possibilità di un
rapporto assai proficuo dall’incontro trale ipotesi della memetica e la realtà dellasemiotica. Non prescindendo però dal
paradigma generale delle neuroscienze cognitive, in cui aduna definizione di funzione e alla individuazione delle struttu-re ad essa correlate può seguire lo studio di una alterazionestrutturale, indotta sperimentalmente o comprovata clinica-mente, e in entrambi i casi ritenuta responsabile di una alterazio-ne della funzione.
Lo spazio non consente, in questa sede, di tornare ad argo-mentare nel dettaglio la proposizione di una ipotesi teoreticasulla conoscenza negli umani, e della corrispondente infra-struttura neurale, avanzata in un saggio recente dedicato allabiologia della coscienza, cui rimandiamo (Recchia-Luciani inMaldonato 2007).
Ci limiteremo a segnalare la peculiare definizione di coscien-za cui lì ci si riferisce, coscienza che, riprendendo le caratteristi-che identificate da Julian Jaynes (1976), presenta specifichecaratteristiche funzionali: Spazializzazione, Selezione, Analogo“io”, Metafora “me”, Concordanza, Soppressione, Concentrazione.In questo modello la metaforizzazione genera me e io, costante-mente impegnati in una narratizzazione. È una definizione chesi discosta da quella di consapevolezza, definibile come ‘sempli-ce’ presenza di un oggetto all’interno del dominio sensoriale-percettivo-motorio (e vegetativo, ormonale e immunitario) di
Memi come virus
mEmoriE oltrE lE gEnErazioni
Chora N. 16, Settembre 2008
94
un individuo. Consapevolezza e coscienza condividono lefunzioni di spazializzazione, selezione e concordanza; sponta-nea è la tendenza della consapevolezza alla concentrazione ealla soppressione, anche estreme. Ma analogo ‘io’, metafora‘me’ e narratizzazione, sono costrutti metaforici esclusivi dellacoscienza propriamente detta. Una definizione funzionale ci per-mette di definire gli elementi sostanziali di cui abbiamo bisogno:l’infrastruttura neurale. In un contesto di segregazione funziona-le, individuiamo più dispositivi neurali – più moduli cerebrali- di cui abbiamo individuato come indispensabile l’attività. Inun contesto di connettività neurale (non solo anatomica, maanche funzionale ed effettiva) ipotizziamo – e cerchiamo didocumentare – le modalità con cui i moduli cerebrali coopera-no all’emergere di nuove proprietà funzionali. Su questa base,possiamo ipotizzare una piccola collezione di moduli e retineurali ‘necessari’ (‘sufficienti’?) alla coscienza: che consiste-ranno certamente in un sistema di relazioni sociali, il cui model-lo ‘allo stato dell’arte’ è quello dei Mirror Neurons (Gallese2006); e in un sistema di marcatori somatici (Damasio 1994), chefornisce un vitale contributo valoriale. Oltre a questo, il model-lo individua come necessario un dispositivo metaforico, definitodall’avvento evolutivo e dalla cooperatività di uno o più siste-mi segnici (la cui perdita progressiva viene documentata dallaclinica della Degenerazione Lobare FrontoTemporale, e specificata-mente dalla variante a localizzazione temporale, la demenzasemantica); di un sistema interprete (identificato grazie al lavorodi Gazzaniga sui pazienti split brain; 1992) idoneo a produrrele funzioni di narratizzazione e metaforizzazione, e infine diuno o più sistemi per la percezione dell’asimmetria.
Definire ‘coscienza’ e ‘consapevolezza’ ci permette infatti diindividuare ciò che, nell’ambito del mentale e dei suoi riflessisul comportamento, svolge un ruolo cognitivo, benché noncosciente né consapevole. Inconscio è uno stato mentale che haluogo fuori dal focus della coscienza, oppure uno stato menta-le che comporti un apprendimento avvenuto implicitamente,ovvero uno stato psico-fisico complesso, spesso mediato dalsistema nervoso autonomo (SNA, talora qualificato con il vec-chio termine di ‘vegetativo’) e/o da peptidi a funzioni organi-smiche complesse (neuroimmunoendocrine).
Le possibili definizioni di inconscio spalancano anch’esse lapossibilità di indagine d’una corrispondente infrastrutturaneurale, ma pure quella dello studio di specifiche modalità di ela-borazione cognitiva. Qui il modello è ripreso dalla monumenta-le opera del grande psicoanalista cileno Ignacio Matte Blanco,che usò strumenti di logica formale, derivati dalla matematicadegli insiemi, per ricondurre le molteplici proprietà dell’incon-scio freudiano a due principi fondamentali: il principio di sim-metria e il principio di generalizzazione.
È questo che rende così importante la presenza di uno o piùsistemi per la percezione dell’asimmetria. In relazione al principio disimmetria, l’inconscio opera una ‘simmetrizzazione delle rela-zioni asimmetriche’. Logica simmetrica e logica asimmetricacoesistono così come coesistono coscienza e inconscio: ciò checambia, a seconda dei compiti cognitivi, è la proporzione in cuii due elementi della bi-logica si combinano. Il modo di genera-zione del mondo tipico dell’inconscio tratta ogni relazione comefosse simmetrica.
In una relazione simmetrizzata l’assenza di asimmetria (nonci sono destra e sinistra, sopra e sotto, avanti e indietro…) rendeimpossibile la concettualizzazione dello spazio.
L’assenza di spazializzazione rende impossibile la concettua-lizzazione del tempo (che è sempre una operazione di spazia-lizzazione). Un apprendimento privo di spazio e tempo èdotato di spazio e tempo infiniti: è ovunque, per sempre.Non ha storia: non è più processo, ma ente statico: ente cogni-tivo di governo del comportamento. Un apprendimento privodi storia e di contesto non è suscettibile di cambiamenti: èun pattern di informazione strutturato per essere destina-to a ripetersi, ed ha caratteristiche di stabilità e di protezio-ne dal mutamento.
Di nuovo, ripensate alla catena di conseguenze di un ‘picco-lo’ cambio normativo, come quello introdotto nell’ammissio-ne ad Harvard dal 1933.
Un tale pattern di informazione, inconscio sin dall’origine, odivenuto tale, è in grado di indurre comportamenti, rispetto aiquali si pone a un più elevato livello logico. Il principio di sim-metria si accompagna al principio di generalizzazione, in cui larelazione inversa di qualsiasi relazione è per l’inconscio iden-tica alla relazione stessa; così tale membro individuale, e la suaclasse di appartenenza, sostanzialmente coincidono, comeavviene nella metonimia, in cui identifichiamo la parte con iltutto. Il principio di generalizzazione appare evidentemente,anche a un’analisi superficiale, come basilare per funzioni dicategorizzazione da parte della mente. La modalità di elabora-zione cognitiva dell’inconscio per ciò ‘automaticamente’ gene-ra classi e categorie. Pattern di informazione semantica insorti gra-zie a meccanismi di variabilità, sottoposti a selezione, protettidai mutamenti ‘accidentali’ grazie alla loro stabilità, in gradodi indurre, attraverso il comportamento, trasferimenti mate-riali ed energetici. In una parola, memi.
L’ontologia dei memi e una proposta di semiotica biologicaLa conquista - filogenetica e ontogenetica - dei sistemi
segnici comporta un doppio ampio vantaggio evolutivo:una emulazione di realtà di capacità e potenza enormementesuperiore rispetto a quelle che l’hanno preceduta; e il supe-ramento dei limiti connessi al possesso di sistemi di memoriacostretti a elaborare esclusivamente input sensoriali. Allaloro genesi iniziale (ma non all’ulteriore sviluppo) è neces-saria una variazione nell’ambito biologico e genetico; laloro evoluzione successiva (per esempio nel passaggio daun sistema a base iconico-analogica ad un sistema piena-mente simbolico) potrebbe invece essere avvenuta tutta neldominio evolutivo culturale, in cui i pattern informaziona-li sono memetici piuttosto che genetici.
I geni sono replicatori importanti non solo per il suppor-to materiale che utilizzano, ma soprattutto perché sonoentità utili alla codifica, al deposito e al recupero di pattern diinformazione biologica. Come i memi nella memoria.Pattern di informazione questi che: a) necessitano di unmeccanismo trasformazionale per la variabilità, e dunque diuna generazione (che all’origine è individuale o espressio-ne di un piccolo numero di soggetti); b) quando siano statigenerati, vengono sottoposti a selezione, in base al propriovalore adattativo, attraverso meccanismi che trovano unesempio applicativo nei dispositivi di validazione intersogget-tivi governati da norme di razionalità locale; e che c) quan-do siano stati selezionati, necessitano di stabilità, e dunquedi un meccanismo di protezione dalla variabilità accidentale.Tutte queste caratteristiche sono valide sia per i replicatoridell’evoluzione biologica, che per i replicatori dell’evoluzio-ne culturale: sono aspetti tipici dei geni, come dei memi.
Qui avanziamo la proposta che il meccanismo preposto allaprotezione dal cambiamento, alla stabilità dei pattern informa-zionali memetici sia il loro divenire inconscio. Che un comporta-mento sia perfettamente adattativo, “eccellente” e meritevoledi imitazione, o che sia disadattativo e fonte di notevoli soffe-renze, conta la sua natura di comportamento basato su apprendi-mento procedurale-implicito, fuori dalla coscienza e dalla consa-pevolezza, e soprattutto altamente ripetitivo.
Il pattern di informazione che costituisce il livello logico superioreche controlla i comportamenti è “protetto”, difeso dai cambiamenti,stabile e non ulteriormente evolutivo. È un apprendimento senzatempo né spazio, “infinito”. Massimamente replicativo. Senzaquesta ripetitività, non siamo di presenza di un “pattern”. Chesia ‘di eccellenza’ o ‘di sofferenza’. E ‘contiene’ l’apprendimento.Cosa impedisce il cambiamento degli apprendimenti procedu-rali-impliciti? Gli apprendimenti procedurali-impliciti sonofuori dalla consapevolezza cosciente, e dunque sottoposti allemodalità di elaborazione cognitiva dell’inconscio, e innanzi-
tutto alla simmetrizzazione delle relazioni asimmetriche. Il fonda-mentale valore biologico di tale meccanismo funzionale, inun’ottica evoluzionistica, consiste nel privare dei connotati dispazialità e temporalità pattern informazionali che costituisconoforme di adattamento, idonee alla conservazione dell’organiz-zazione di esseri viventi, proteggendole con l’impedirne l’ul-teriore evolutività. Questo è lo statuto ontologico dei memi:pattern informazionali di natura segnica, a organizzazione rela-zionale metaforica, a generazione individuale e selezione sociale, lacui stabilità è garantita dal loro divenire inconsci (negli individui,nei gruppi o nelle istituzioni), ovvero a-storici. Per tornare allaanalogia genetica: in una delle modalità essenziali diapprendimento non cosciente, la corticalizzazione, gliapprendimenti diventano procedurali, impliciti, inconsa-pevoli. Ciò risulta in effetti protettivi del contenuto infor-mativo, in analogia a quanto avviene ai geni quando ven-gono arrangiati nelle strette maglie cromosomiche, al finedi renderli meno suscettibili alle influenze ambientali.Come accade all’intero patrimonio della memoria semanti-ca. Geni e cromosomi configurano la modalità specifica attra-verso cui viene garantita la generazione, la mutabilità incondizioni controllate, e la conservazione di quanto è statoselezionato per quanto concerne i pattern di informazioneper la conservazione e l’adattamento biologici; analogamen-te, i segni all’interno delle relazioni metaforiche - sottoposti aiprincipi di simmetria e di generalizzazione - costituiscono pat-tern di informazione per la generazione, la mutabilità incondizioni controllate, e la conservazione di quanto è statoselezionato nelle culture umane, culture non più campo- néoggetto-dipendenti, sia all’interno del singolo individuo
che delle organizzazioni sociali, configurazioni entrambeassimilabili a unità di terzo ordine nella classificazionedegli esseri viventi della teoria di Santiago (Maturana eVarela 1985). Tali pattern di informazione fondamentali,fondati su segni e di natura metaforica, sono generativi,attraverso il meccanismo dei ‘grappoli di metafore’ deluci-dato in epoca moderna in particolare dalla linguisticacognitiva, della struttura del carattere e della personalità, siadelle forme individuali che delle organizzazioni sociali. Sein ambito biologico la meiosi è fase strutturalmente deter-minata e finalizzata alla generazione di ulteriore varietà,(mentre mitosi e produzione di proteine garantiscono lo‘status’), in ambito culturale individuale ruolo analogosvolgono i periodi dell’infanzia e dell’adolescenza; in ambi-to sociale, lo sono le fasi di transizione. Come le Kuhnianerivoluzioni scientifiche; o le trasformazioni storiche.
Dare ai segni connotati vitali, comprendere come possa-no davvero essere assimilati a forme di vita, suscettibili digenerazione, sviluppo e morte; come guidino la strutturaevolutiva delle culture sembra poter configurare un’ipotesiteorica generale sulla conoscenza. Teoria che giunge, graziead un contributo assolutamente centrale della linguisticacognitiva, a porsi come proposta epistemologica, grazie allapossibilità, offerta dalla metafora come ente cognitivo deputatoalla comprensione, di una misurazione del grado di verità(Lakoff e Johnson 1980), capace di valutare il grado di atten-dibilità raggiunto da ogni affermazione possibile, indipenden-temente dallo specifico campo del sapere cui ci si riferisce:scientifico o umanistico, tecnico o artistico piuttosto che poe-tico, come forse insisterebbe Giambattista Vico.
95angElo rEcchia-luciani
Chora N. 16, Settembre 2008
nota bibliograficaAbravanel R, (2008). Meritocrazia. Quattro proposte concrete per valorizzare il talento e rendere il nostro paese più ricco e più giusto. Garzanti,Milano 2008.Arsuaga Ferreras, JL (1999). El collar del neandertal, en busca de los primeros pensadores. Ediciones Temas de Hoy, Madrid. (Ed. It. I primi pensa-tori e il mondo perduto di Neandertal, Feltrinelli, Milano 2001).Blackmore S (1999). The Meme Machine , Oxford and New York, Oxford University Press (Ed. It. La macchina dei memi. Perché i geni non basta-no, Instar Libri 2002).Benitez-Bribiesca L (2001). Memetics: A dangerous idea. Interciecia 26: 29–31, p. 29.Boyd R, Richerson PJ (1985). Culture and the evolutionary process. University of Chicago Press. Brodie R (1996). Virus of the Mind: The New Science of the Meme by– An introduction to the field of memetics. Integral Press, Seattle.Calvin W (1996). The Cerebral code: thinking a thought in the mosaics of the mind, MIT Press.Campbell DT (1965). Variation and selective retention in socio-cultural evolution. In: Barringer HR, Blanksten GI and Mack RW (eds). Social changein developing areas, a reinterpretation of evolutionary theory. Schenkman Publishing Co.Campbell DT (1974). Evolutionary epistemology. In: Schlipp PA (ed). The Library of Living Philosophers, Vol. XIV: The philosophy of Karl Popper.LaSalle: Open Court.Cavalli-Sforza L, Feldman M (1973). Cultural versus biological inheritance: phenotypic transmission from parents to children. Human Genetics 25:618-637. Cloak FT (1975). Is a cultural ethology possible? Human Ecology 3: 161-182.Csanyi V (1989). Evolutionary systems and society. A general theory of life, mind and culture. Duke University Press.Damasio AR (1994). Descartes’ Error Emotion, Reason, and the Human Brain, Avon Books, (Ed. It. L’ errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervel-lo umano. Adelphi, Milano 1995).Deacon TW (1997). The symbolic species. The coevolution of language and the brain, W. W. Norton, and Co., 1997 (Ed. It. La specie simbolica. coe-voluzione di linguaggio e cervello. A cura di Silvio Ferraresi. Roma: Giovanni Fioriti Editore; 2001).Deacon TW (1999). Editorial: Memes as Signs. The trouble with memes (and what to do about it). The Semiotic Review of Books 10(3). 1-3.Dawkins R (1976). The Selfish Gene, New York: Oxford University Press (Ed. It. Il gene egoista, Mondori Milano 1994).Dawkins R (1982). Organisms, groups and memes: replicators or vehicles? P. 97-117, in: The extended phenotype. Oxford University Press (Ed. It. Ilfenotipo esteso, Zanichelli, Bologna 1986).Dawkins R (1993). “Viruses of the Mind” in: Free Inquiry, summer 1993, vol 13 nr 3 (http://phenom.physics.wisc.edu/~shalizi/Dawkins/viruses-of-the-mind.html )Dawkins R (1995). River Out of Eden, HarperCollins, New York (Ed. It. Il fiume della vita. Cos’è l’evoluzione, Sansoni Editore, Firenze 1995).Dennett DC (1995). Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. Simon &Schuster, New York 1995 e (Ed. It. L’ idea pericolosa diDarwin. L’evoluzione e i significati della vita, Bollati Boringhieri Torino 1997).Dennett DC (1996). Kinds of Minds: Towards an Understanding of Consciousness. BasicBooks, New York (Ed. It. La mente e le menti. Rizzoli, Milano2000).Dennett DC (1999) The evolution of culture. The Charles Simonyi Lecture, Oxford University, Feb 17, 1999. EDGE 52 — March 28, 1999.Donald MW (2001). A Mind So Rare: The Evolution of Human Consciousness, W. W. Norton & Company, New York, (Ed. It. L’evoluzione dellamente. Per una teoria darwiniana della coscienza, Garzanti, Milano 2004.Edelman M. Gerald (1992). Bright Air, Brilliant Fire. On the Matter of The Mind. (Ed. It. Sulla materia della mente, Milano, Adelphi, 1993).
mEmoriE oltrE lE gEnErazioni
Chora N. 16, Settembre 2008
96
Flemminga TM, Beranb MJ, Washburn DA (2007). Disconnect in Concept Learning by Rhesus Monkeys (Macaca mulatta). Judgment of Relationsand Relations-Between-Relations. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, Volume 33, Issue 1, January, Pages 55-63.Fodor JA (1983). The modularity of mind: an essay on faculty psychology, Cambridge, MA, MIT Press, 1983. (Ed. It. La mente modulare. Saggio dipsicologia delle facoltà, Il Mulino Bologna 1988).Fodor JA (2000) The mind doesn’t work that way; the scope and limits of computational psychology. MIT Press (Ed. It. La mente non funziona così.La portata e i limiti della psicologia computazionale, Laterza, Roma-Bari, 2001).Gallese V, Fadiga L, Fogassi L e Rizzolatti G (1996). Action recognition in the premotor cortex, Brain, Vol. 119, No. 2, 593-609, 1996.Gallese V (2006). La molteplice natura delle relazioni interpersonali-la ricerca di un comune meccanismo neurofisiologico, in Chora, numero 12, anno5 (primavera 2006). Dossier: alterità, empatia, intersoggettività.Gazzaniga MS (1992). Nature’s Mind-Biological Roots Of Thinking, Emotions, Sexuality, Language, And Intelligence, Basic Books, New York (Ed.It. La mente della natura, Garzanti, Milano 1997).Boxer AL, Trojanowski JQ, Lee VY-M, Miller BL (2005). Frontotemporal lobar degeneration, Chapter 34 of Textbook of Neurodegenerative Diseases,M. Flint Beal, A. Lang and A. Ludolph (Eds). Cambridge University Press, Cambridge, UK.Henson K (1987) Memetics and the Modular-Mind Analog, Aug.Heyes CM, Plotkin HC. (1989). Replicators and interactors in cultural evolution. In: Ruse M (ed). What the philosophy of biology is; essays dedicat-ed to David Hull. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.Hofstadter DR, Dennett DC (1981) The Mind’s I (Ed. It. L’io della mente, Fantasie e riflessioni sul sé e sull’anima. Adelphi, Milano 1992)Hofstadter, DR (1983) “On Viral Sentences and Self-Replicating Structures” in: Scientific American, vol. 248, January 1983; reprinted in: “MetamagicalThemas” (Basic Books, 1985).Hodgson G (1993). Economics and evolution. Bringing life back into economics. Polity Press.Hull DL (1982). The naked meme. In: Plotkin HC (ed). Learning development and culture, essays in evolutionary epistemology. John Wiley andSons. Hull DL (1988). Interactors versus vehicles. In: Plotkin HC (ed). The role of behavior in evolution. MIT Press.Hull DL (1988). Science as a process: An evolutionary account of the social and conceptual development of science. University of Chicago Press.Jablonka E, Lamb M, Eytan A (1998). ‘Lamarckian’ mechanisms in darwinian evolution. — Trends in Ecology and Evolution 13(5). 206–210.Jaynes J (1976). The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Houghton Mifflin Company, Boston 1976, 1990 (Ed. It. ll crol-lo della mente bicamerale e l’origine della coscienza, Adelphi Milano 1984).Kuhn TS (1962-1970). The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, Chicago (tr. it. della II ed. ampliata, 1970, a cura di A.Carugo, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1978.Kull K (2000). Copy versus translate, meme versus sign: development of biological textuality. European Journal for Semiotic Studies 12(1). 101–120.Kilpinen E, Memes versus signs On the use of meaning concepts about nature and culture. In stampa; citato da manoscritto, conautorizzazione dell’autore. Lakoff G e Johnson M (1980). Metaphors we live by. University of Chicago Press. Chicago. (Ed. It. Metafora e vita quotidiana, Bompiani, Milano,1980-1998).Lynch A (1991). Thought contagion as abstract evolution. Journal of Ideas 2: 3-10.Lynch A (1996). Thought contagion. How Belief Spreads Through Society. The New Science of Memes. Basic Books New York, N.Y.Maturana H, Varela F, (1985). El Árbol del Conocimiento: Las bases biológicas del entendimiento humano. Editorial Universitaria, Santiago, 1985(Ed. It. L’albero della conoscenza, Garzanti Milano 1992).Maynard Smith J, Szathmáry E, (1997). The Major Transitions in Evolution. New York: Oxford University Press.Maynard Smith J, Szathmáry E, (1999). The Origins of Life: From the Birth of Life to the Origin of Language. Oxford: Oxford University Press. (Ed.It. Le origini della vita. Dalle molecole organiche alla nascita del linguaggio, Einaudi Torino 2001).Matte Blanco I (1975). The unconscious as infinite sets : an essay in bi-logic. Duckworth, London (Ed. It. L’inconscio come insiemi infiniti: saggio sullabi-logica. Einaudi, Torino 1981).Matte Blanco I (1988). Thinking, feeling, and being : clinical reflections on the fundamental antinomy of human beings and world. Routledge,London ; New York (Ed. It. Pensare, sentire, essere: riflessioni cliniche sull’antinomia fondamentale dell’uomo e del mondo. Einaudi, Torino 1995).Mininni G (2008). La mente come orizzonte di senso, in Mauro Maldonato (a cura di) L’Universo della Mente, Meltemi Roma.Nadel L, O’Keefe J (1978). The Hippocampus as a Cognitive Map, Oxford University Press, Oxford.Phillips WA (1974). On the distinction between sensory storage and short term visual memory, Perception and psychophisycs, 16:283-290.Popper KR (1972). Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, Oxford, Clarendon Press (Ed. It. Conoscenza oggettiva, Roma,Armando, 1975).Recchia Luciani ANM(2007) Biologia della cultura, in Maldonato M (a cura di). La coscienza: come la biologia inventa la cultura, scritti di MaldonatoM, Mininni G, Montuori A, Recchia Luciani ANM. Guida, Napoli.Simon HA (1962). “The architecture of complexity” in Proc. Amer. Phil. Soc., 106, pp 467-482.Schacter D (2001) Forgotten Ideas, Neglected Pioneers: Richard Semon and the Story of Memory Philadelphia: Psychology Press.Spinozzi G (1996). Categorization in monkeys and chimpanzees. Behavioural Brain Research. Volume 74, Issues 1-2, January, Pages 17-24Tomasello M, Call J, Hare B (2003). Chimpanzees understand psychological states: The question is which ones and to what extent. Trends inCognitive Science, 7, 153-156.Tomasello M (2003). Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition. Harvard University Press. Tomasello M, Carpenter M, Call, J, Behne T, Moll H (2005). Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition. Behavioral andBrain Sciences, 28, 675 – 691.Vico G (1744). Principj di una scienza nuova; Principi di una scienza nuova In Opere, t. I, a cura di Andrea Battistini, Mondadori, Milano, 1990.
angelo recchia-luciani è nato a Bari nel 1960. Medico, Neurologo e Radiodiagnosta, dal 1997 è responsabile per le neuroimmagini in unodei maggiori gruppi ospedalieri privati italiani. Profondamente attento al rapporto mente-corpo, se ne è interessato in relazione all'infor-mazione, alla psicoterapia, all'ipnosi medica. Autore di lavori in ambito neuroradiologico, su applicazioni dell'informatica alla medicina,sulla metafora come dispositivo cognitivo, per Infomedia ha pubblicato (con Di Lecce) "Medicina e Informazione" e curato (con Claudatus)l'edizione italiana di "Mente e Metafore" di J. Lawley e P. Tompkins; per Guida, ha pubblicato il saggio "Biologia della Coscienza" nel volu-me "La Coscienza", curato da Mauro Maldonato.
Circa sessant’anni fa, in Italia, precisamente a Milano,cominciava la sua brillante carriera di studioso di ciberneticaSilvio Ceccato. Pensatore radicale e prolifico saggista, riscosseun buon successo di pubblico grazie ad alcune opere divulga-tive tuttavia, il suo insegnamento, rimase sempre ai marginidell’accademia. Tra le tante cose di cui s’è occupato v’è anchela memoria, e proprio della teoria ceccatiana del funzionamen-to mentale in generale, e della memoria in particolare, ci occu-peremo in questo contributo.
Forse il lettore si starà chiedendo: perché riproporre qui edora una teoria della memoria vecchia di quarant’anni quandofuori c’è una selva rigogliosa di ipotesi moderne ed avanzate?Perché occuparsi del fantasioso tentativo di costruire una mac-china ricordante fatta di legno e acciaio (si fa per dire) quandofuori si parla di reti neurali e cervelli quantistici? Perché dareascolto ad un cibernetico poco conosciuto degli anni ’50 che siè occupato un po’ di tutto quando fuori ci sono schiere di spe-cialisti agguerriti e preparatissimi?
Una risposta non ce l’ho. Però posso proporre due meta-rispo-ste, sulla cui natura il lettore avrà presto delucidazioni. Dapprima,perché l’unico modo per ricordare una cosa è farla una secondavolta; poi, semplicemente, perché fuorinon v’è alcunché.
L’errore più grande della filosofia è stato quello del “rad-doppio del percepito”, cioè il tentativo di basare una teoriadella conoscenza sul confronto tra la cosa da conoscere, reale,esterna e la rappresentazione della stessa all’interno dellanostra testa, percepita attraverso i nostri sensi, talvolta ingan-nevoli. Per dirla con lo stesso Ceccato, “alcune ovvie conside-razioni di ingombro ed anche le più rozze nozioni di anatomiaimpediscono che si pensi che i percepiti esterni al corpo possa-no venire raddoppiati senz’altro al suo interno. Questo è giàpieno di cose sue, ed in nessun caso riuscirebbe poi a contene-re un monte, una casa, un cavallo” (Ceccato, 1972). Del restonon si capisce come possa essere attuato il confronto tra la cosaconosciuta (interna) e la cosa reale (esterna), dato che la prima,frutto della percezione sensoriale rappresentata all’internodella nostra mente, è l’unica ad essere presente al soggetto,mentre la seconda resta, per definizione, inconoscibile. Aquale livello di conoscenza può dunque portare il confrontotra due termini, di cui uno incognito?
Il raddoppio del percepito comporta una spazializzazionedel processo di conoscenza foriero d’una rappresentazione deiprocessi mentali basata su metafore irriducibili che ne impedi-scono l’effettiva comprensione. Il processo metaforico è benvisibile se pensiamo alla parola conoscere.
Scrive Ceccato: “Quando noi facciamo qualcosa, può essereche sia la prima e l’ultima volta che la facciamo, ma per lo piùsi tratta di un fare che, attraverso la memoria, ripete un giàfatto, o, sempre attraverso la memoria, viene ricordato peressere ripetuto.” (Ceccato, 1972)
Dunque ci può capitare di visitare Londra, studiare l’ingle-se e di essere presentati alla Regina Elisabetta. In seguito ilnostro rapporto con Londra, la lingua inglese e la Regina sarà
diverso, proprio a causa di ciò che è avvenuto, di ciò che si è giàfatto. Per designare questo nuovo rapporto si utilizza propriola parola conoscere: conoscere Londra, conoscere il francese,conoscere la Regina, oppure sapere quando si allude specifica-mente all’attività ripetuta: saper orientarsi a Londra, saper par-lare l’inglese, sapere chi è la Regina.
Nell’accezione operativa, antirappresentazionista diCeccato, quindi, conoscere rimanda sempre (a) ad un rappor-to tra attività, (b) distribuite nel tempo e svolte dallo stesso sog-getto, (c) attività egualmente presenti e pertanto confrontabilitra loro. Mentre in quello che Ceccato chiama “linguaggio filo-sofico”, conoscere si tratterebbe sempre di (a) un rapporto tracose date come già fatte, (b) distribuite nello spazio, (c) di cuisoltanto l’una presente alla cognizione del soggetto, all’inter-no, e l’altra assente alla sua cognizione, all’esterno in quel certoposto. Il confronto, come già detto, dovrebbe quindi avveniretra una cognita e un’incognita.
In questo modo, sostiene Ceccato, opera da sempre la filoso-fia occidentale “ mettendo in circolazione i due «conoscere», perdesignare due situazioni strutturate in modo vagamente simile,in quanto costituite con i termini di un rapporto di ripetizione;ma sotto un certo aspetto opposte, irriconducibili l’una all’altra,in quanto nella seconda [accezione], quella filosofica, non solo ilrapporto temporale viene sostituito con un rapporto spaziale,ma il rapporto di ripetizione ha quale primo termine qualcosache è destinato a rimanere assente.” (Ceccato 1972)
Di conseguenza, la nuova accezione del termine conoscerediventa irriducibilmente metaforica, poiché non è possibileuna sua traduzione letterale, indicando cioè “le cose con i ter-mini loro propri” (Ceccato 1972), senza ricorrere ad ulteriorimetafore o cadere in vere e proprie contraddizioni.
Si delinea quindi la necessità di una concezione non rappre-sentazionalista della mente e della scienza tutta, che VonGlasersfeld saprà poi riproporre nel suo “costruttivismo radi-cale”, che molto deve alle intuizioni di Ceccato, con il qualelavorò durante la sua permanenza in Italia.
Secondo Ceccato, per la vita mentale (che egli distingue daquella fisica e psichica) sono fondamentali tre meccanismi, osistemi, quello dell’attenzione, quello della memoria e quellocorrelazionale o di pensiero. L’attenzione non è più soltantouno strumento per selezionare ciò che ci interessa ma è ciò checostruisce i nostri pensieri. Essa è pulsante, spezzettata, discre-ta e quando applicata al funzionamento di altri organi (visivo,acustico, tattile..) tal funzionamento viene reso “mentale” eadeguatamente frammentato. In questa prima modalità dilavoro, l’attenzione, rende semplicemente presente al sogget-to l’attività dell’organo, fatto che il lettore può sperimentareprestando ora attenzione al contatto dei vestiti sulla propriapelle.
Nell’altro modo di operare, invece, l’attenzione non si appli-ca al funzionamento di altri organi, ma a se stessa. La combi-nazione di più stati attenzionali, resa possibile dalla funzionecorrelazionale del pensiero, porta alla formazione di categorie,
di roBerto Bottinice.r.co. - università degli studi di BergaMo
soluzioni fin troppo ben localizzate di un antilocalizzazionista
97robErto bottini
Chora N. 16, Settembre 2008
silvio ceccato e la Meccanizzazione della MeMoria
Silvio cEccato
Chora N. 16, Settembre 2008
98
quali possono essere ad esempio: singolare/plurale;tempo/spazio; caldo/freddo, etc. Secondo Ceccato: “Nella con-cezione fisicalistica della mente, queste categorie e la loroapplicazione ad altro non potevano che derivare dalla loropartecipazione alle cose fisiche, come condizione alla percezio-ne, dalle quali le otterremmo «per astrazione». In altri termini,noi le troveremmo sulle cose fisiche e le separeremmo dallealtre proprietà e soprattutto dalla fisicità (la mancata consape-volezza delle operazioni costitutive delle categorie mentali, siapure che applicate, è stata anch’essa insieme una premessa eduna conseguenza dell’errore fisicalistico)”. (Ceccato, 1972)
Così, sgombrato il campo delle vestigia fisicaliste, è possibilecomprendere come l’associazione categoriale più semplice, cioèquella composta da due singoli stati attenzionali, darà luogo allacategoria di Cosa, nella sua accezione più vasta, per esempio la«cosa» delle domande:
‘Che cosa è...?’, quando appunto non facciamo altro che richia-mare l’attenzione sull’oggetto della domanda. Combinazioni piùcomplesse daranno luogo a tutte quelle categorie di cui ci servia-mo quotidinamente.
Tuttavia, applicata l’attenzione e formate le più svariate catego-rie, non si è ancora giunti al pensiero; le unità costituite rimarreb-bero fra l’altro di ben piccole dimensioni, quelle cioè che si ottengo-no nel secondo, secondo e mezzo (per Ceccato la durata massimadelle pulsazioni dell’attenzione); mentre l’uomo compone unitàindefinitamente lunghe “sino ad abbracciare con un solo arco lasua vita intera” (Ceccato 1972). Questa è l’opera del pensiero, per-messa grazie non soltanto al sistema attenzionale, ma anche ad unaltro dei sistemi che si sono riconosciuti fondamentali per la vitadella mente, cioè quello della memoria.
A suo tempo Ceccato, riconoscendo la fondamentale importan-za della memoria, sosteneva si trattasse di un meccanismo larga-mente inesplorato e del quale se ne sapeva ben poco. Non molti,dopo trent’anni di neuroscienze, vorrebbero affermare lo stesso,tuttavia non si conosce ancora un modello esauriente della memo-ria, e molti suoi aspetti restano ancora oscuri. Ottimisticamente,Ceccato pensava che la difficoltà non fosse insita nell’oggetto d’in-dagine, misterioso e inaccessibile, ma dovuta alla “problematicapovera con cui si è indagato sulla memoria, una problematica che,ormai sappiamo, cerca di correre subito sull’osservativo, cioè sullecose che si vedono e si toccano, prima di aver condotto una indivi-duazione, analisi e descrizione delle operazioni di cui identificarela base organica”. (Ceccato, 1968)
Forse, anche alcuni dei moderni tentativi di comprensione dellamemoria restano portatori, più o meno sani, di quest’approccioosservativo e fisicalista. Il quale conduce a metafore irriducibilidalle quali (nonostante tutto il costruttivismo del mondo) sembradifficile scappare (prima fra tutte, quella del “magazzino”).Nell’illustrare l’analisi Ceccatiana della memoria e il tentativo, forseanacronistico, di concepire un marchingegno meccanico capace diricordare, si spera quantomeno di solleticare qualche mente fanta-siosa che voglia prendervi spunto per rompere le fila gregarie dellaricerca normale e spiccare un salto al di là delle metafore irriduci-bili che a volte la caratterizzano.
Ceccato, da par suo, individua ben sette funzioni della memo-ria. La prima è la ben nota funzione della memoria cosiddetta let-terale, la quale ci consente di ripetere esattamente quello che si èfatto. La utilizziamo recitando a memoria una poesia che si è piùvolte letto, suonando a memoria un pezzo musicale o semplice-mente ricordando un numero di telefono. La seconda funzionedella memoria è per Ceccato quella di mantenimento, funzione checi consente di mantenere presente quanto è avvenuto anche quan-do il corrispondente fenomeno fisico o psichico è già finito. In que-sta funzione la memoria si accoppia col sistema attenzionale, poi-ché l’attenzione, dal fenomeno, si sposta sul ricordo mantenuto diquesto. Altre due funzioni consistono rispettivamente nell’associa-reciò che si è già fatto, in epoche più o meno lontane e nel seleziona-reciò che verrà ricordato.
La sesta funzione della memoria è quella riassuntiva. Si intendequi la capacità di riprendere in forma riassuntiva operazioni men-
tali che in passato occupavano un lasso di tempo più o menolungo, in modo da poter ricordare il “già fatto” più agevolmente.La settima funzione della memoria è quella propulsiva,ovvero: ciò che abbiamo già fatto ci sospinge in unadirezione piuttosto che un’altra.
Prima di descrivere il meccanismo mnemonico proposto daCeccato, riporto alcune sue riflessioni rispetto ai modelli dellamemoria esistenti all’epoca ed al loro scarso funzionamento:
“Si è immaginata la traccia, ispirata al cilindro o disco del fono-grafo, al nastro magnetico del registratore o semplicemente allascrittura; od anche una specie di rete da costruirsi connettendo ele-menti già esistenti, o con particolarità legate alle connessioni, otarando in modo particolare questi elementi, sicché ad essi giunga-no e partano per esempio solo determinati impulsi. Per la memo-ria letterale indubbiamente questi schemi non solo funzionano,ma un qualsiasi registratore batte la più forte memoria umana.Nastri magnetici, pellicole cinematografiche, etc.., non dispongonoperò di memoria riassuntiva e propulsiva, ed è anche di queste cheil sistema fisico deve dar ragione, oltre che della memoria comemantenimento di presenza, come continua modificazione, comeassociazione e come selezione.” (Ceccato, 1968)
Ricapitoliamo ora le tre principali funzioni dell’attenzione, pri-madonna dell’attività mentale e, quindi, mnemonica.
Applicandosi al funzionamento degli altri organi, l’attenzionerende mentale ciò che altrimenti resterebbe situato solo sul pianofisico (per rendersene conto basterà che il lettore pensi al contattodelle pagine di questa rivista con i polpastrelli delle sue dita; ora chevi presta attenzione tale contatto e le sue caratteristiche gli sono pre-senti, cioè sono divenuti un fatto mentale)
Oltre a rendere mentale il funzionamento di altri organi, essa loframmenta, lo spezzetta e lo suddivide in piccole porzioni. Questoavviene poiché l’attenzione stessa è pulsante e non continua.
Infine l’attenzione si focalizza su se stessa, secondo diverse com-binazioni, alle quali dobbiamo le categorie mentali, adoperate siaisolatamente, sia applicate (per esempio nell’osservazione, quandoil singolare applicato ci da “alber-o” o “bosc-o”, ed il plurale “alber-i” o “bosch-i”)
Nel caso della memoria ci interessa soprattutto la funzione fram-mentatrice, in quanto mette a disposizione un insieme discreto dielementi (quelli resi presenti dall’attenzione a partire da un flussocontinuo, non discreto di stimoli interni ed esterni) del quale siavvale il sistema combinatorio del pensiero per costruire le suecaratteristiche correlazioni. Inoltre, “questo rende plausibile che ilsistema fisico responsabile della memoria possa registrare le nostreesperienze, sia come un continuo fluire, cioè quale funzione mono-tona, sia come tante unità isolate e ripetute, cioè quale funzioneciclica”. (Ceccato, 1968)
Al cibernetico, dunque, non resta altro da fare che progettare unmeccanismo in grado di svolgere al meglio tutte le funzioni dellamemoria. Una volta individuate queste funzioni, infatti, il compi-to dello scienziato è di renderle concepibili come funzioni d’organo,in un modello fisico plausibile che possa in seguito guidare, nellesue ipotesi, lo studioso del sistema nervoso umano.
Lasciamo ora che sia lo stesso Ceccato a guidarci nella descri-zione della sua macchina per ricordare: “Si immagini un segui-to di corde in grado di vibrare che si tarino al loro primo funzio-namento come unità attenzionali. Sarebbe come se il pezzo dimusica suonato sul violino, strumento a note non fisse, lascias-se tante corde della lunghezza di cui di volta in volta, quellesono state ridotte facendone uno strumento a note fisse, come ilpianoforte o l’arpa. Ma ogni corda si troverebbe raddoppiatafigurando, da un lato, nel seguito continuo delle corde, precedu-ta o seguita quindi da quelle certe corde, o contesto, e dall’altro,isolatamente, separata, in modo da poter venire eccitata ad ogninuovo presentarsi di una unità eguale. Si può anche immagina-re che quando una unità attenzionale sia costituita da altre unità,in luogo della corda unica essa sia rappresentata da un gruppodi corde. Per esempio, l’unità ‘smeraldo’ potrà contenere piùcorde, una delle quali ‘accordata’ come quella che risponde iso-latamente del ‘verde’.
99robErto bottini
Chora N. 16, Settembre 2008
Il passaggio, la connessione tra le unità attenzionali nel flussocontinuo e quelle isolate, dato il tipo di fisicità del sistema scelto, èassicurato automaticamente dal mezzo fisico, l’aria, nel quale essesono immerse.
Alle corde presenti separatamente bisogna però aggiungere unacaratteristica o grandezza fisica, che segni in esse le volte in cui sonostate eccitate; e sempre per restare fra le nostre rozze immagini, sipensi per esempio ad un’astina che accompagni ogni corda ed allaquale si sommi un segmento ad ogni nuova eccitazione, o ad unaserie di anelli concentrici e sempre maggiori, come si vede nei tron-chi degli alberi.
Questo sistema ricorda, sul piano fisico quello ben noto di chicompila l’indice per soggetto, per argomento, di un volume ove leparole figurano come centri di raccolta e di rimando appunto deisingoli soggetti, attraverso i numeri delle pagine indicati, e l’am-montare di questi numeri corrisponde all’altezza dei segmentidelle astine od alla grandezza e posizione dei cerchi concentrici.
Ecco ora come il sistema assolverebbe le varie funzioni dellamemoria.
Intanto, esso associa le nostre esperienze, sia perché dalle unitàisolate si irradia un richiamo, una sollecitazione alle unità corri-spondenti nel flusso continuo, e così anche ai contesti di queste, siaperché alcune unità figurano tanto isolatamente quanto comecomponenti di unità più ricche (è il caso del ‘verde’ nello ‘smeral-do’, nell’ ‘erba’). Ma così al tempo stesso seleziona, cioè rimandan-do solo a certe cose non rimanda ad altre. Per non ricordare, insi-stendo sulla particolare natura fisica del sistema scelto, gli effettidelle risonanze dovuti ai vari possibili suoni armonici.
È poi un sistema propulsivo e condizionante, in quanto ogninuova esperienza finisce con il trovare un elemento stabilizzantenel centro di raccolta e perché, raggiungendo le unità corrispon-denti nel loro flusso continuo, ne suscita anche i contesti, che ci por-tano a ripetere il già fatto.
L’attività riassuntiva, condensatrice della memoria è dovutaalla possibilità di cogliere negli intervalli voluti le unità atten-zionali per la loro frequenza maggiore o minore, attraverso lavariabile grandezza fisica aggiunta nelle corde vibranti, cioè leastine o i cerchi. Si noti che su queste unità così raccolte, sia ilmeccanismo attenzionale che quello correlazionale del pensie-ro possono operare come su un qualsiasi materiale fresco,seguendo cioè le stesse regolarità o dipendenze, ponendo leunità negli stessi rapporti per cui risulteranno legate una voltacon una ‘e’, un’altra con un ‘con’, una terza con un ‘anche’, aseconda che siano state presenti entro o fuori un certo interval-lo di tempo, oppure insieme, etc., o figurare come soggetti ocome oggetti di un’attività, o venire legate nel rapporto disostanza o accidente, ‘statua marmorea’, o con un ‘di’, ‘statuadi marmo’, e simili.
Per la memoria come mantenimento di presenza, basteràricordare che ogni processo fisico né inizia, ne termina proprioin un istante.” (Ceccato, 1968)
Nulla di tutto ciò è realmente presente nella nostratesta, sottolineava lo stesso Ceccato. Tuttavia, per quan-to grezzo e sbrigativo, questo tentativo di ingegneriamentale rende merito della complessità delle funzionidella memoria, complessità che un semplice “magazzi-no neurale” più o meno localizzato può difficilmentesoddisfare. Inoltre, se il positivismo è in crisi, così comesuo figlio minore il localizzazionismo, sarebbe bello chese ne accorgessero anche i positivisti localizzazionisti,cosa che in effetti non avviene ancora in vaste aree delmondo scientifico. Che abbiano forse delle buone ragio-ni? Come si insegna in alcuni corsi di comunicazione, seil messaggio non viene ricevuto o compreso, è semprecolpa dell’emittente, il quale deve cambiare strategiacomunicativa. Forse, parlare di costruttivismo utilizzan-do ancora termini rappresentazionalisti, se all’inizio nefacilita la comprensione, rischia poi di creare paradossi,incomprensioni o metafore irriducibili. Il linguaggionella scienza non è solo importante, ma costitutivo; l’im-portanza che Ceccato da al significato delle parole e allaloro possibile traduzione in operazioni mentali non è unvezzo o un passatempo intellettuale, ma una strategiaben precisa nel tentativo fondare una scienza costrutti-vista, rigorosa e, per quanto possibile, non contradditto-ria. Una scienza complessa, si, ma comprensibile.
Nota bibliografiaCeccato S., 1985, L’ingegneria della felicità, (Rizzoli, Milano)Ceccato S., 1972, La mente vista da un cibernetico, (ERI, Torino)Ceccato S., 1970, Cibernetica per tutti, 2, (Feltrinelli, Milano)Ceccato S., 1968, Cibernetica per tutti 1, (Feltrinelli, Milano)Ceccato S, 1964, Un tecnico fra i filosofi. Vol. I, Come filosofare, (Marsilio Editori, Padova)Ceccato S., 1964, Un tecnico fra i filosofi. Vol. II, Come non filosofare, (Marsilio Editori, Padova)
silvio ceccato nacque a Montecchio Maggiore nel 1914. Studiò giurisprudenza, violoncello e composizione musicale. Negli anni ’50 conVittorio Somenzi e Giuseppe Vaccarino fondò la Scuola Operativa Italiana che coinvolse studiosi di varia provenienza disciplinare, italia-ni e stranieri, intorno al tentativo di modellizzare l’attività mentale ed i rapporti fra questa e il linguaggio. Fu tra i primi in Italia ad occu-parsi di traduzione automatica e nel 1949 fondò (insieme a Vittorio Somenzi e Giuseppe Vaccarino) la rivista internazionale Methodos, checontinuò le pubblicazioni fino al 1964. Nel 1956 progettò e costruì Adamo II, il primo prototipo di cervello elettronico, il progetto fu poiabbandonato per carenza di finanziamenti. Fu libero docente di filosofia della scienza a Milano. Nel 1957 fondò il Centro di cibernetica e diattività linguistiche dell’Università di Milano, che diresse fino alla metà degli anni sessanta. Autore instancabile, pubblicò una ventina dilibri e più di cento articoli, collaborando con numerose riviste e quotidiani. Morì a Milano il 2 dicembre del 1997.
roberto Bottini è allievo alla Scuola di Dottorato in Antropologia e Epistemologia della Complessità all’Universitàdegli Studi di Bergamo.
Silvio Ceccato
FiloSoFi a milano
Chora N. 16, Settembre 2008
100
Professor Papi, lei è stato per molti anni allievodi Banfi. I suoi scritti intorno al pensiero del mae-stro e la fondamentale monografia dedicata allaScuola di Milano restano una autentica testimo-nianza del magistero banfiano oltre che del suopercorso filosofico, come testimonia ancora il suorecente lavoro Antonio Banfi. Dal pacifismo allaquestione comunista (Ibis, Como – Pavia 2007).Oggi, dopo cinquant’anni dalla scomparsa diBanfi, quale eredità teoretica possiamo riscopri-re? Se lei dovesse proprio scegliere una tematicache maggiormente ha influito sulla sua formazio-ne e che ancora oggi resta al centro della suaattenzione, quale indicherebbe ai più giovani?
Alla prima domanda preferi-sco rispondere con una rifles-sione teorica nella quale è faci-le vedere quali temi banfiani, ecome, abbiano proliferato nelmio modo di “fare filosofia”.Se mi collocassi all’esternosarebbe una descrizione, inquesto testo vi è, nei suoi limi-ti, una prova.
Il titolo che nel 1956 diedeBanfi alla raccolta dei suoiscritti filosofici nel corso di tre
decenni e oltre, fu La ricerca della realtà.Intuitivamente il significato delle due parole
sembra ripetere quella che è una grande tradizio-ne filosofica impegnata a tradurre nel suo lessicoe nel suo sapere lo spazio indefinito e oscurodella realtà che abbiamo imparato a considerareteoricamente con gli occhi della metafisica greca,ma che anche abbiamo imparato a sentire, perce-pire, toccare, così come ne siamo sentiti, percepi-ti, toccati. Come si vede possono essere differen-ti, anzi molto distanti, gli sfondi filosofici in cuila proposizione può avere senso, anche se il sin-tagma “ricerca della realtà” conduce in questocaso nella significazione sintetica che era nel-l’antico deposito dell’esperienza che Banfi avevaavuto con i suoi classici e con alcune linee filoso-fiche fondamentali dell’inizio del Novecento.Qui, tuttavia, non darò il complicato tracciatogenealogico con i classici moderni, Spinoza,Kant, Hegel e i filosofi contemporanei, più omeno, a Banfi, Simmel, Cassirer, Natorp e ladiscendenza neokantiana marburghese, i razio-nalisti francesi, viennesi, berlinesi, infine ilprimo Husserl conosciuto all’inizio degli anniVenti nelle sue fondamentali opere a stampa.
Comincerò invece con una domanda che proble-matizza su un concetto centrale - realtà - tutto ilgioco teoretico dei sedimenti teorici e della lorocomposizione. La realtà come si presenta per laricerca? Il tentativo di trovare la “realtà” nella“esperienza pura” che possa darsi nella sua origi-nalità alla coscienza secondo una percezione pre-categoriale rispetto a quelle minime categorizza-zioni che appartengono al tessuto linguistico cheoccorre neutralizzare per poter percepire una rela-zione diretta all’origine, è estraneo a Banfi. Nelsaggio sul razionalismo critico del 1943 che riassu-me teoreticamente l’esperienza filosofica di più divent’anni ed apre, problematicamente, verso lametamorfosi successiva, Banfi scrive: «Questaesperienza lungi dall’essere pura è determinatadalla singolare situazione compromessa in unaserie di valutazioni e reazioni implicite e affiorasul piano dell’esistenza vissuta e non della ragio-ne. Piuttosto la ragione ha già attraversato i varigradi del sapere, elaborato l’esperienza nel sensodi toglierla da tali forme e tali sensi individual-mente determinati, di disporla in sintesi che rap-presentino sensi di coordinazione e di aggruppa-mento». Posso tradurre questa proposizione in unlinguaggio diverso, ed essa potrebbe suonare così:non c’è nessuna immaginazione che non sia dettain una forma di linguaggio e ogni forma di lin-guaggio ha il suo codice. Si può dire anche, inmodo hegeliano, secondo le pagine dellaFenomenologia sul sensibile: ogni esperienza sensi-bile è condannata all’hic et nunc, e quindi noncostituisce sapere.
Se la realtà non può manifestarsi come esperien-za indeterminata, relazione sensibile e immagina-tiva con il mondo secondo già una sua dimensionedi senso, come si presenta invece per chi abbia unatteggiamento teorico alla Banfi? Banfi è al di quao al di là di qualsiasi forma di filosofia della per-cezione o del “mondo della vita”. E’ kantianoquanto al processo di costituzione della conoscen-za poiché l’immaginazione deve concettualizzarsi;è hegeliano in quanto alla forma della esperienzache si presenta sempre come un compimento sim-bolico, un linguaggio organizzato che stabilisce iconfini di un mondo. È fin troppo ovvio obiettareche siamo in un mondo della trasparenza, unaripetizione a vari livelli della composizione sim-bolica, dove il linguaggio non mostra residui inso-lubili quanto alla esperienza e, uscendo dal circui-to di Banfi ma anche di Husserl, il ricordo non hada cimentarsi con un fondo oscuro che giungeall’immagine, ma non trova la parola. In Banfi,
antonio BanFi dal paciFisMo alla Questione coMunista
a cura di alessandro sardi
tre domande al professor papi
Antonio Banfi
101alESSandro Sardi
Chora N. 16, Settembre 2008
come nel suo straordinario allievo Preti, la razio-nalità certamente può scivolare nell’indeterminatointuitivo come avviene nel parlare comune, ma hasempre la possibilità di una sua trasparenza. Cosìdi “realtà” si può parlare nella comunicazionepragmatica più semplice, quella che trasporta unaserie di certezze inglobate nelle esperienze e cherendono possibile, in una intersoggettività data, lavita quotidiana. Chiunque, comunicando con ilprossimo, distingue e fa distinguere ciò che è realee ciò che non lo è. Ma il problema non è, teorica-mente, il distinguere, ma il criterio del distinguere.
E non appena si abbandona il ricchissimo campodi certezze dove la nostra vita trascorre in sintoniacon la realtà condivisa e si apre una domanda filo-sofica che chiede teoricamente conto della realtà,l’orizzonte muta. Qui muta il luogo del discorso,le procedure di significazione sono diverse, e que-sto comporta che la realtà, non supportata da unaunivocità pragmatica, è molte realtà che hanno unloro ordine di immanenza e stabiliscono continen-ti che, dal punto di vista della loro intellegibilità,mostrano modalità molto differenti di organizza-zione della esperienza. Noi attraversiamo sempre,senza tematizzarle, esperienze che, sviluppatenella loro possibilità, condurrebbero a una cono-scenza tecnica, esprimiamo giudizi morali che,argomentati, conducono nell’orizzonte morale coni suoi conflitti le sue risoluzioni, diamo giudizi difatto che, se approfonditi, dovrebbero condurre aforme di sapere scientifico argomentato. Chiparla, bene o male, è sempre connesso, sia, percosì dire, in quanto entra in queste direzioni sim-boliche e quindi apprende una sua confidenza conuna forma di realtà, sia in quanto ne esce, cioèquando cerca di dire qualcosa che deforma la pre-cedente stabilità simbolica con un proprio spazioenunciativo. Il che avviene in poesia con un sog-getto individuale, nella scienza certamente con unsoggetto collettivo o con un sistema tecnologiconel quale è depositato un sapere scientifico condi-viso. Questo per dire che la realtà non è mai un“oggetto totale” definibile staticamente con ungesto intellettuale (questa storia, per la verità, èfinita per sempre nella triade hegeliana essere –nulla – divenire della Logica), piuttosto essa è sem-pre agìta, determinata, compresa nei suoi varilivelli di organizzazione discorsiva. E, rispetto adessi, la ricerca è sempre una distanza perché nonpuò coincidere mai con una ipotetica realtà ogget-tiva costruita intuitivamente, ma solo con unarealtà che ha già ottenuto una sua selezione. C’èdel resto un raddoppio tra trascrizione simbolicadel mondo e ricerca filosofica, un raddoppio checonduce in una dimensione più complessa, cioè alrapporto filosofia-sapere, un raddoppio che ripetea suo modo le classiche dicotomie filosofiche, doxaed episteme, retorica e logica, divenire e essere,apparenza ed essenza, linguaggio e metalinguag-gio. Con una differenza fondamentale, che il rad-doppio non è mai un sapere con un suo contenuto,ma solo una forma necessaria per non deformare“dogmaticamente” quello che è dato nella doxa,nella retorica, nell’apparire, nel linguaggio. Il rad-doppio è vuoto, ma il vuoto trascendentale è ilmodo critico per non categorizzare nell’universalel’esperienza simbolica che mostra sempre processidi auto comprensione. Si evitano così forme diimpoverimento concettuale, geografie della cultu-ra, giudizi valutativi che tendono a generalizzarsi.
C’è la gloria della forma, ma anche il suo deperi-mento. Si tratta di un’implicita critica alle filosofieche sostengono il proprio primato e sottintendonola convinzione che ogni manifestazione simbolica,l’arte come la scienza, se interrogata in modoappropriato, possa avere la sua piena traducibilitàfilosofica. Siamo in un luogo della comprensione edell’ascolto, tace la nostra vita, immaginiamo latrasparenza dell’ascolto. Siamo molto lontani siadalla possibilità scientista di controllare un lin-guaggio con un altro linguaggio, sia dalla fugaindefinita dei significati, della loro indecidibilitànella proliferazione indefinita dei testi. Siamofuori dalla positività delle metafisiche, ma neconosciamo il movimento razionale. Siamo in unaregione vuota, ma, inevitabilmente, in un tempoprivilegiato che, tuttavia, vale solo per la formafilosofica. Vediamo la trasparenza della culturasenza dettarne alcuna legge, ma certi della suapossibile comprensione, il finito non svanisceprima del suo segno nella comprensione. E la vitava verso la sua materia sottile, fede, passione, spe-ranza, liberazione.
Ma la vita, per lo meno per il Banfi che parla infilosofia, non è mai l’elemento irrazionale, fatale,invalicabile, quella tempesta che il modo filosofi-co non riesce a cogliere nella sua “realtà”. Come igrandi allievi di Banfi rimproveravano al maestro,talora persino con la tragicità della loro esistenzae di quella dei compagni vicini. Certo la vita inBanfi assomiglia più a una fioritura che ad unaincognita, poiché essa è in attesa dello spirito edella forma. E se il male non può essere tolto poi-ché il trascendentale non è la stessa cosa del nonscrutabile disegno di Dio, allora la risposta è quel-la di Spinoza: l’uomo libero non si occupa dellamorte ma della vita. Questo è lo sfondo valutativonascosto nell’apparente silenzio del pensiero.
Il problema di Banfi è teoretico: ogni realtà ha lesue forme, nessuna ricerca scientifica comincia dacapo, una morale non può scegliere il suo conte-sto, una pratica artistica è una presa di posizionema è anche una relazione. Non c’è mai inizio e nonc’è fondamento. Ma non c’è alcun nihilismo, poichénon si tratta di mancanze metafisiche, ma diimpossibilità che appartengono a un pensiero edu-cato. La filosofia non può che prendere la distan-za, ma questa distanza estingue tutte le categorieche appartengono al “realismo concettuale”, nonc’è parola che abbia un “al di là” realistico, oltre ilproprio senso che interagisce nel mondo.
Questo stile teoretico ne fa una “filosofia rigoro-sa”, non è di certo una “concezione del mondo” èsolo un sistema formale, il minimo del linguaggio,il gelo concettuale del significato. E tuttavia lafilosofia a queste condizioni è una pratica cheporta alla comprensione, secondo la loro imma-nente intenzionalità, i mondi plurali del simboli-co, dà sempre la parola all’altro della culturaaffinché non subisca semplificazioni, categorizza-zioni, verità che lo sovrastino. Se tornassi allaFenomenologia di Hegel, che è la prima lettura delgiovanissimo Banfi, direi che è come se il “sapereassoluto” non alla fine, ma sul momento desse ladimensione di temporalità e di figuratività (in tra-slato rispetto al senso letterario in Auerbach) adogni costruzione simbolica, l’arte, la morale, lascienza, l’educazione.
E così per Banfi la metafisica (il filosofo fu quasiobbligato ad occuparsene, auspice l’ottimo filoso-
FiloSoFi a milano
Chora N. 16, Settembre 2008
102
fo e amico Bontadini, proprio nel 1944 in unaMilano in macerie e con il cuore e la mente nellaResistenza) non ha alcuna storia lineare costituitadalla sua forma di pensiero. Vi sono molte metafi-siche, fondamentali quelle della modernità dove irisultati della scienza moderna vengono trascrittinel linguaggio della tradizione filosofica che,spesso con una loro contaminazione teologica,tenta una costruzione intellegibile del mondo.Spinoza, in primo piano, dove il concetto disostanza incarna, nella sua obiettività, la modalitàteoretica della ragione.
E’ tutto un altro ambiente, ma quando un filoso-fo contemporaneo di grande valore come Badioudice che i filosofi non hanno a che vedere con l’es-sere, che è dei matematici, ma con ciò che si orga-nizza come verità e soggetto, e cioè le procedureche sono proprie dell’amore, dell’arte, della scien-za e della politica, non mi pare che la distanza siainfinita, specie perché anche per il filosofo france-se la filosofia è vuota. La filosofia parla soltanto diquesti oggetti.
Mi rendo ben conto che sino a qui ho letto fedel-mente l’esperienza teoretica di Banfi trascrivendolatuttavia in un linguaggio che, dopo una lunga sto-ria, “lui”, il linguaggio, padroneggiame, più di quanto “io” non padroneggilui. E tuttavia due esempi testuali e unaconclusione. Molte volte Banfi parla di“sistematica aperta”. Detto così pareuno ossimoro, e tuttavia ha un suosenso. Lo “spirito di sistema” non è lageografia del mondo con i suoi paesag-gi segnati sulla carta, è, invece, il mododi considerare l’orizzonte della culturacome un processo indefinito, autono-mo, imprevedibile, autointerpretativoche, nel suo insieme e, contemporanea-mente, nella sua autonomia, può essereconsiderato secondo criteri di ordineformale. E’ del tutto ovvio fare riferi-mento al mondo della conoscenza chenegli ultimi due secoli ha assunto unaquantità di direzioni, di specializzazio-ni, di saperi di cui nessuno sarebbe ingrado di dare una grammatica dei con-tenuti. Anche se a livello eidetico si possonocostruire le condizioni formali per nuove forme diconoscenza, (la geometria del percettivo, per esem-pio) così come conoscenze consolidate possonoritrovare le loro condizioni di possibilità formaleattraverso l’analisi epistemologica.
Per quanto riguarda Banfi, dagli anni Trentain avanti, la “sistematica aperta”, da comprensibi-le ossimoro, diventerà nella realtà testuale unametafora per dire quale sia lo stile del fare filoso-fia che corrisponda ad una teoretica criticità. Lafilosofia è “il luogo della unità formale della espe-rienza custodita nel suo senso trascendentale”. Lafrase, un po’ criptica, è mia, ma il suo senso, incerta misura, gravava sui grandi allievi di Banfiche vi vedevano il fantasma del panlogismo. Certoera chiara la funzione anti-dogmatica del vuoto, lacondizione trascendentale della criticità, la libera-zione da ogni seduzione di metafisiche oggetti-vanti (gli “enti”), l’educazione al mondo per sape-re, la terapia delle illusioni filosofiche, dei raccon-ti tragici o edificanti, ma anche un cielo cherischiava di mostrarsi lontano rispetto agli squili-bri del vivere e del linguaggio che li rappresenta.
Il mio modo di pensare filosofico che qui non èpertinente, ha questo retroterra fondamentale e daqui si sviluppa tutta una storia.
La prima parte del suo libro ripercorre mezzosecolo di storia italiana, fino ad intrecciarsi conle posizioni critiche della questione comunista,relativamente alla rivoluzione ungherese del 1956.Ammettendo che il tema e il suo svolgimento, allaluce delle critiche odierne, è estremamente delica-to, ha trovato difficoltà a ripercorrere alcuniaspetti delle posizioni politiche banfiane? Comevisse lei, da assistente di Banfi, la difficile sceltadel maestro di difendere hegelianamente (il comu-nismo come “storia che si costruisce nella sto-ria”), con un saggio apparso su “NuoviArgomenti” nel 1957, la linea dura dell’UnioneSovietica nei confronti della vicenda nazionaleungherese?
Non ho avuto alcun problema a ripercorrere iltracciato politico di Banfi. La sua adesione al par-tito comunista allora poteva sembrarmi solo comeandare alla “verità storica”. Con il passare deglianni mi parve chiaro che per il filosofo la militan-
za nella Resistenza e nel partito comu-nista doveva essere letta anche comeun capitolo importante della sua storiapersonale che veniva da lontano: dalpacifismo che fu la sua posizione, deltutto originale nella cultura italiana,durante la prima guerra mondiale.L’adesione al partito comunista diveni-va una sorta di compimento oggettivodi se stesso, una certezza di sé che lafigura di maestro universitario potevarealizzare solo in parte, nel preziosoapartheid dello “spirito” al quale man-cava l’appartenenza al momento stori-co. Un umanesimo della cultura, nondella vita. Per il resto Banfi non è maistato omogeneo al gruppo dirigentedel partito comunista, né per cultura,nè, tanto meno, per la storia propria.Ma Banfi, se si fa eccezione per l’ulti-mo anno quando in privato manifestò
qualche riflessione problematica intorno all’impe-gno radicale della propria militanza, e in pubblicomostrò il proposito di riprendere a pieno il lavorofilosofico, fu sempre molto attivo e generoso rela-tivamente agli obblighi che gli assegnava il parti-to. E anche con un giovanile entusiasmo, soprat-tutto a contatto con i militanti di base. Questoatteggiamento aveva il più ampio consenso neiprimi anni Cinquanta in tutta l’area della sinistra,dove appariva preziosa quella che allora si chia-mava l’unità politica della classe operaia. Dalcanto mio vi univo la considerazione che uno sco-laro ha per il suo maestro.
Contrariamente a quello che si possa pensarevissi il dissenso con Banfi sulla repressione sovie-tica della rivoluzione ungherese, nell’ottobre-novembre del 1956, con molta serenità. I carriarmati sovietici a Budapest erano un colpo diforza leggibile ormai nelle forme autoritarie e vio-lente dei regimi comunisti dell’Est europeo, inglo-bati nel blocco sovietico nato dopo la fine dellaguerra con la divisione delle “zone di influenza”.Questo giudizio maturava chiaramente in un’areasocialista di maggioranza alla quale appartenevo.
Rivoluzione ungherese 1956
103alESSandro Sardi
Chora N. 16, Settembre 2008
Non fu una decisione facile, soprattutto per i rap-porti tra socialisti e comunisti, ma assolutamentenecessaria, che vissi con quell’equilibrio interioreche si deve a una verità politica. Su questi temicon Banfi non ebbi alcuno scambio di opinioni chesuppongo mi avrebbe creato qualche problemaemotivo. E dopo i fatti di Ungheria il maestro, inuna occasione di discorso, sembrava più interessa-to a conoscere qualche mia opinione, del resto,nell’occasione, molto generica, piuttosto che aparlare delle sue. Per quanto riguarda il suo sag-gio su «Nuovi argomenti», tutto sulla linea delladirezione del partito comunista, lo lessi nella pri-mavera quando la situazione politica assumevanuovi assestamenti. Mi parve un documento di untempo diverso che non aveva alcun peso sull’es-senza del mio rapporto filosofico con il maestro. Adistanza di anni penso che il saggio su «Nuoviargomenti» avesse un destinatario privilegiato: icento (uno più o uno meno) intellettuali del parti-to comunista che si dissociavano dalla dirigenzapolitica sui fatti di Ungheria. Per chi - come Banfi- avesse una profonda eredità hegeliana apparivamolto semplice opporre la “effettualità” alle“anime belle” che contemplavano la propria virtùal di fuori dalle condizioni del mondo. Tuttaviaallora non mi sentivo affatto “anima bella”: sup-ponevo di avere argomentazioni empiriche validerispetto all’”ottimismo tragico” (l’espressione è diGuido Neri) di una filosofia della storia.Argomentazioni che del resto, nel mio stesso par-tito, venivano respinte da un altro grande perso-naggio intellettuale come Cesare Musatti, il qualesull’Ungheria, anche se dette in altro modo, nonaveva opinioni diverse da Banfi.
Interessante, nuova e inconsueta è l’intersezionetra Banfi e Rebora: spesso la storia delle ideeaccosta il filosofo al poeta, come un’unità simbo-lica. Potrebbe giustificare la scelta di inserirequesta vicenda umana nel suo libro (una sorta dicifra, visto l’afflato religioso che accompagnacerti scritti banfiani e l’amore di Banfi per la let-teratura)?
Il caso di Banfi-Rebora si può spiegare in tremodi. L’uno riguarda la reciproca giovanile amici-zia tra il poeta e il filosofo che durò dai tempidella Accademia scientifico-letteraria di Milano(dal 1906-7) sino ed oltre la metà degli anni Venti.Banfi allora aveva venature di religiosità laica efilosofica che gli venivano da Martinetti. Reboraera percorso da una religiosità che assumeva tona-lità differenti, ma nel profondo con una prevalen-za cristiana. La radice fondamentale era nella suaesistenza inquieta e tormentata.
Non c’è alcuna corri-spondenza tra filosofia epoesia, tra Banfi eRebora, anzi Reboraspesso vedeva nella spe-culazione filosofica diBanfi una astrazione unpoco olimpica e quindiquasi indifferente alleprove dell’esistenzaBanfi, dal canto suo, avràconsiderato le poesie diRebora come un prezioso“sentire” la vita senza
avere il problema di rappresentarne l’idealità (intermini filosofici).
Il secondo motivo appartiene alla microstoriapersonale. Durante la guerra ero stato, al CollegioRosmini di Stresa, allievo di Rebora senza sapere,allora, chi fosse il personaggio che ogni tanto cifaceva difficili lezioni sulle religioni. Poi con glianni le due esperienze magistrali si sono unitenella memoria.
Il terzo argomento appartiene al mio modo diinterpretare quella generazione milanese deglianni Dieci: quale che fosse il loro destino perso-nale, storico o religioso, era una generazionefortemente impegnata intorno a un propriosenso ideale, a un “se stesso” rappresentabile inun Altro-da sé nel quale trovava consistenza unadirezione fortemente simbolica. Si potrebberoportare anche altri esempi, ma questo stile diesistenza, con tutte le differenze, valeva perBanfi e per Rebora.
alessandro sardi (Busto Arsizio, 1972) si è laureato presso l’Università degli Studi di Milano in filosofia teoretica con Carlo Sini,con una tesi su Enzo Paci e ha conseguito la specializzazione per l’insegnamento di filosofia e storia. Attualmente insegna nellascuola media superiore, lavora come educatore sul territorio milanese e collabora all’organizzazione di “Filosofarti” (festival di filo-sofia, comune di Gallarate, Varese). Con la cattedra di Estetica II, presso l’Università degli Studi di Milano, ha curato la “bibliogra-fia aggiornata di Enzo Paci” per “Quaderni di Materiali di Estetica” (Cuem, Milano 2006). Ha inoltre curato, con MassimilianoCappuccio, le raccolte di saggi Filosofi a Milano. Enzo Paci (Cuem, Milano 2006) e Filosofi a Milano. Remo Cantoni (Cuem, Milano 2007);ha pubblicato diversi saggi, in Italia, sul pensiero di Paci e sulla “scuola di Milano”, come Ricerche sul pensiero italiano del Novecento(Bonanno, Roma 2007), Ad Antonio Banfi cinquant’anni dopo (Unicopli, Milano 2007) e all’estero la Paci entry, per il doppio volumeHandbook of Whiteheadian Process Thought (Frankfurt – Lancaster 2008).
Fulvio papi è stato allievo di Antonio Banfi e assistente alla cattedra dal 1955 alla scomparsa del filosofo. Ordinario di filosofia teo-retica all’Università di Pavia ha insegnato anche morale ed estetica tra il 1965 e il 2000. Ora professore emerito. Ha diretto le riviste“Materiali filosofici” e “Oltrecorrente”, collane filosofiche; vice presidente della Casa della Cultura di Milano e presidente del comi-tato scientifico della Fondazione Corrente. Il suo pensiero si è sviluppato come continuità dalla “scuola di Milano” (neocriticismo,marxismo, fenomenologia, empirismo critico) nel clima della filosofia (dall’ontologia al decostruzionismo) e della cultura contem-poranea (antropologia, psicoanalisi, semiologia). Considera il fare filosofico come un sapere relazionale, conoscitivo e sociale: un“configurare” con le risorse del linguaggio per “far vedere” tratti di mondo e figure umane. Sembra una prospettiva del tutto diver-sa dal trascendentalismo critico dell’opera di Banfi. Nel 1961 ha pubblicato Il pensiero di Antonio Banfi che gli valse il premio Pozzaleper la critica. Le sue opere più recenti sono: Lezioni sulla “Scienza della logica” di Hegel (Milano, 2000); Filosofia e architettura (Como -Pavia, 2000); Cinque scherzi filosofici (Milano, 2001); Figure del Tempo (Milano, 2002); Dacci oggi il nostro pensiero quotidiano (Milano,2003); La memoria ostinata (Milano, 2005); Sull’ontologia (Milano, 2005); Il lusso e la catastrofe (Como - Pavia, 2006); Antonio Banfi dalpacifismo alla questione comunista (Como - Pavia, 2007). Voci dal tempo difficile (Como – Pavia, 2008). Nel 2006 è stata pubblicata laseconda edizione dell’opera di storia della filosofia Antropologia e civiltà nel pensiero di Giordano Bruno (Liguori, Napoli).
Clemente Rebora
FiloSoFi a milano
Chora N. 16, Settembre 2008
104
“Indicato dal maestro Piero Martinetti fra icandidati ad ereditare la sua cattedra di filoso-fia teoretica, quando il “rivale“ Antonio Banfiera stato destinato all’insegnamento di Storiadella filosofia, Barié si è distinto come una frale figure di maggior talento speculativo dellasua generazione, rilevante anche sul piano sto-rico in quanto esponente dell’ultimo atto del-l ’ idealismo italiano, vicino a f igure comePantaleo Carabellese e al suo maestroBernardino Varisco, oltre al già citatoMartinetti, la cui frequentazione rimase costan-te anche dopo il celebre abbandono della catte-dra nel 1931. Ciò nonostante il pensiero diBarié non ha praticamente avuto diffusione nénegli ambienti filosofici del suo tempo, né inquelli successivi, per due ragioni innanzitutto:da un lato il suo temperamento “attivistico”che certo non gli ha agevolato le relazioni acca-demiche, dall’altro l’anacronismo del suo stileriflessivo legato ad una concezione formaledella filosofia certamente in contrasto con lasensibilità culturale che si era ormai affermatain tutto il Continente e che aveva penetratoanche la sua Università. Eppure Barié non fuinsensibile al pensiero del suo tempo; nelle sueopere, in maniera crescente, un posto rilevanteha il confronto con le più recenti correnti filo-sofiche. Oggi che quel paradigma pare entratoirrimediabilmente in crisi ed ha mostrato esso
stesso i propri l imiti speculativi, non paresuperfluo rileggere le critiche rivoltegli daGiovanni Emanuele Barié, con la convinzionedi ritrovare nei suoi testi utili vie per la futuraricerca filosofica.”
(dall’Introduzione di Davide Assael)
FilosoFi a Milano 3: giovanni eManuele Barié
annuario 2007-2008 dell’associazione degli studenti diFilosoFia dell’università degli studi di Milano
a cura di davide assaelcueM, Milano, 2009
indice del volume
Davide Assaelintroduzione 7Ottavio Bariéun ricordo di emanuele Barié 11Carlo Sinineotrascendentalismo e logica hegeliana 21Davide Assaell’itinerario filosofico di giovanni emanuele Barié 29Geri Cerchiailetture vichiane di Barié 57Egidio MeazzaFilosofia e fisica: giovanni emanuele Bariée la difesa della filosofia dallo scientismo 73intervista all’on. pierantonino BertéA cura di Davide Assael 97intervista al prof. carlo siniA cura di Davide Assael 105Bibliografia 113appendice fotografica 119
105oSSErvatorio SullE riviStE
Chora N. 15, Gennaio/Febbraio 2008
[Chora] Professor Rossetti, fino a qualche anno fa Lei avevala rara caratteristica di coltivare insieme la filosofia antica el’informatica, mentre ora sembra dividersi tra la filosofia anti-ca e la filosofia con i bambini. Accostamenti tutti e due sorpren-denti, ammetterà.
[Livio Rossetti] Beh, comincio col dirle che, avendo toccato isettanta, ho creduto che fosse il caso di chiudere il capitolo infor-matica: nel 2006 sono usciti Un Eutifrone interattivo e il DVD Oraapienai. È tempo di andare (sul processo e morte di Socrate) e conquesti lavori ho provato a giocare la carta dell’ipertesto metaco-gnitivo. Adesso vediamo se si fa avanti qualcuno per raccogliereil testimone, ed è tutto. Quanto alla filosofia con i bambini - unamore recente, ma pervasivo - posso dire che ho creduto diaccompagnare la costituzione di un’associazione, Amica Sofia, colproposito di far uscire questo settore allo scoperto e di istituire unterritorio comune per tutti coloro che praticano la filosofia con ibambini in forme anche molto diverse.
In effetti uno sguardo al vostro sito (www.amicasofia.it)mi fa notare un ventaglio di iniziative molto ampio e artico-lato: la rivista omonima, una newsletter mensile, una sessio-ne estiva, una collana di libri e un laboratorio annuale deno-minato “Siamo... in pensiero” che viene associato al festivalper bambini “Fantasio”; vi è poi la prestigiosa manifestazio-ne “Eleatica”, che Lei dirige come responsabile scientifico eora come primo cittadino onorario della città Elea, e altroancora. Mi aiuti a capirci qualcosa.
Volentieri. L’associazione Amica Sofia è stata fondata nel gen-naio 2008 (quindi... ha giusto cominciato a camminare in modotraballante) e si è subito data un passo piuttosto spedito, ma soloperché era la forza delle cose a richiedere un certo dinamismo.
Possiamo dire che ha preso il via una bella routine? Chisono gli interlocutori privilegiati delle vostre iniziative, comevi prefiggete di stimolarli e di coinvolgerli? E qual è stata larisposta, per ora?
Come può immaginare, non abbiamo un ufficio stampa e pro-mozione, quindi aspettiamo che la gente scopra la nostra esisten-za e se ne interessi. Constato con piacere il periodico arrivo dinuovi associati e una certa molteplicità delle iniziative. Ma, comesempre in casi del genere, ci vuole tempo e non rimane che gua-dagnarsi i galloni sul campo.
E come va con i filosofi di professione? Posso immaginare chele vostre “maestre di filosofia” riescano a esprimere in manieraoriginale la passione per la conoscenza e per l’insegnamento,impostando la loro attività su un piano che vuole essere comple-tamente diverso, e non inferiore, rispetto a quello dei filosofi diprofessione.
Mi limito a riferirLe che, dopo una prima fase, si è capito chenon c’erano le condizioni per costituirci come articolazione inter-na della Società Filosofica Italiana. Non tanto per via delle purprevedibili esitazioni di chi avrebbe dovuto aprirci le porte dal-l’interno della SFI...
La interrompo: noi non conosciamo la situazione alla quale fariferimento ma, essendo stato Lei per diversi anni presidentedella SFI perugina, sono sicuro che ne parlerà con cognizione dicausa. Ma continui, La prego.
D’accordo, continuo. Non tanto per quel motivo lì, quanto peril prevedibile imbarazzo di chi, nel caso, avrebbe dovuto presen-tarsi alla SFI con il cappello in mano (“sa, io sono una semplicemaestra di filosofia”, “sa, io insegno lettere alle Medie”...). Esoprattutto perché l’ipotetico gruppo di insegnanti difficilmenteavrebbe trovato gli stimoli giusti nella normale attività di sezioneSFI. Un socio prof di liceo, per esempio, potrebbe non esprimereun particolare interesse per ciò che di filosofico si fa nella scuoladell’obbligo, con connesso desiderio di capire; un altro forse ten-derà ad esibire le sue molte letture... In tutti e due i casi si dovreb-be mettere in conto il rischio di un apparentamento che non fun-ziona e non ha futuro, le pare?
Da qui, se capisco bene, una indicazione per mettervi in proprio?
Esattamente. Ben presto si avvertì il bisogno di creare uno spa-zio non disturbato dal confronto con altri modi di interpretare laparola “filosofia”.
Penso che questo sia il punto di maggiore interesse teorico epratico in questa nostra conversazione. C’è una filosofia tipicadei professori di filosofia che, tuttavia, non è quella dei “maestridi filosofia”. Cosa è che fa la differenza, e verso quale obiettivodeve puntare la seconda a Suo avviso?
Tenga presente che i filosofi speculativi li si incontra solo nelleuniversità, mentre nei licei abbiamo dei prof di storia della filoso-fia. Già con questo si delinea una differenza di impostazione. In
a cura di MassiMiliano cappuccio
la FilosoFia torna a scuolaaMica soFia, una rivista per insegnare e apprendere la FilosoFia
intervista a livio rossettiuniversità degli studi di perugia
oSSErvatorio SullE riviStE
Chora N. 16, Settembre 2008
106
linea di massima, il prof di liceo insegna, vuole che i suoi studen-ti imparino, che apprendano. Meglio se oltre ad apprendere per-vengono anche a capire, certo; ma prima di tutto si deve appren-dere, perché il sistema poi accerta se lo studente colloca Aristoteleprima o dopo Platone, se e come connette le parole organon e sil-logismo, se si orienta fra paralogismi della ragion pura e postu-lati della ragion pratica. All’università, poi, non si fa che intensifi-care la domanda di conoscenze specifiche, di letture e osservazio-ni competenti. Invece a nove anni tutto questo apparato cogniti-vo non può che essere messo tra parentesi in quanto ai bambinisi possono solo offrire delle occasioni per provare a dire, magarinotando che altri bambini esprimono vedute differenti, e comin-ciare - solo cominciare - a riflettere su un determinato tema.
Certo che, visti in quest’ottica, sono due mondi lontanissimi.Quella richiesta di competenza che regna in un caso è del tuttoassente nell’altro. Dalla vostra esperienza sembra appurato cheil cammino dei maestri di filosofia possa e debba procedere inautonomia; ma vogliamo provare a immaginare se questa espe-rienza originale, e sicuramente innovativa, possa riuscire a for-nire almeno qualche stimolo di arricchimento e di riflessioneanche a chi frequenta l’insegnamento e la ricerca in un diversocontesto istituzionale e professionale?
Guardi, la questione è delicata, perché non si tratta di ‘conso-larsi’ pensando che, grazie alla filosofia con i bambini, ci sarannoragazzini e maestri che non si sarebbero mai avvicinati ai libri difilosofia e invece d’ora in poi ne leggeranno sempre più spesso,fino a sviluppare un decente approccio amatoriale alla disciplina.Ci vuol poco a capire che, se si trattasse unicamente di questo, lacosa potrebbe solo perdere gran parte del suo sapore, col rischiodi scadere a divulgazione di bassa lega. In realtà c’è dell’altro, iocredo, e mi fa piacere che Lei mi dia modo di misurarmi con unaquestione del genere. E non si offenda, caro Cappuccio, secomincio col criticare un poco il modo in cui è stata formulata laSua domanda. Dire che almeno qualche stimolo potrà ben arri-vare anche ai filosofi di professione equivale (o potrebbe equiva-lere) a dire: che i principianti imparino qualcosina può anche farpiacere, può far bene, ma questo è tutto; che qualche stimolo arri-vi anche ai professionisti della filosofia, invece, sarebbe già unguadagno maggiore.
E cosa ci sarebbe di male a ragionare in questo modo, di grazia?
Direi che in gioco siano i fini del filosofare, quindi alcune coordi-nate, se non l’idea stessa del filosofare. Su un versante abbiamo lacomunità filosofica che sviluppa un sapere e continua a inseguireuna particolare idea di filosofia, la filosofia intesa come sapere.Dalla sua ha il conforto di una tradizione millenaria, l’immensosapere connesso al corpus dei testi filosofici (storia della filosofia,con i due versanti del venire-a-sapere-che e del capire come e per-ché), una diffusa capacità logico-argomentativa e la stessa istituzio-nalizzazione della competenza in filosofia sotto forma di svariatemigliaia di cattedre universitarie sparse nei cinque continenti, dipubblicazioni, riviste, congressi eccetera. Questo è un mondo vastoe vario, mediamente prospero, mediamente professionale, deditoa scrivere una sua storia. Ma non costituisce l’universo della filoso-fia. Rispetto a quell’universo, esso rimane pur sempre un’area, unsettore e non il tutto. Qualcosa rimane regolarmente ‘fuori’.
Continui, La prego.
Se ci chiediamo che altro è o possa essere filosofia, oltre alla filo-sofia dei filosofi, viene facile cominciare con delle analogie: la reli-gione si risolve nella sola religione dei preti? E la musica si esau-risce nell’eccellenza raggiunta dai grandi compositori ed esecu-tori? Evidentemente no. È importante che i bambini venganoavviati per tempo alla musica (a farsi un po’ di orecchio, senzaforzarli) così come ha senso coltivare il potenziale religioso che èin loro (e lo stesso si può dire della filosofia), ma non è menoimportante che in una società ci siano, in forme diverse, sensibi-lità e cultura musicale diffuse, non è meno importante che unqualche accesso alla musica – e così pure alla filosofia – ci siaanche in chi si trova ai margini della società, come per esempio idetenuti, perché l’alternativa sarebbero forme di abbrutimento,un peggioramento sostanziale della qualità media del vivere.Ora Le chiedo: i filosofi di professione sono abituati a pensareall’importanza che possono avere forme diffuse del filosofare?Probabilmente, prima dei successi del festival di Modena i filoso-fi di professione erano, da questo punto di vista, ancora piùdistratti.
Ma anche i festival della filosofia hanno (o sviluppano) aspet-ti inequivocabilmente consumistici, sia pure senza raggiungeregli eccessi del divismo musicale.
Beh, è inevitabile. Però ora chiediamoci qual è il guadagno filo-sofico di chi si avvicina a festival, caffè e altre occasioni in cui sidelineano delle opportunità per philosophein. Sono forse i rudi-menti, un’infarinatura di Aristotele, Kant o Wittgenstein?Possiamo seriamente pensare che siano pillole di cultura filosofi-ca europea? Certamente no, perché bambini e detenuti, profes-
Amica Sofia [Anno II, numero 1. Aprile 2008]Amica Sofia è un periodico non registrato
dell’Associazione di promozione sociale AMICASOFIA, che ha la sua sede legale presso ilDipartimento di Scienze Umane e della Formazione,Università degli Studi di Perugia, 06100 Perugia -www.amicasofia.it | [email protected]
Indice: Abbiamo della strada da fare insieme | LivioRossetti; I bambini si divertono “pensando” | AdrianaPresentini; La parola ai genitori… e ai collaboratori; Untema scottante: cartoni animati pericolosi? | Intervista aClaudia Mazzeschi; Forum sul bisogno di filosofi aPaolo Cervari, Fabio D’Andrea, Rosella DeLeonibus, Floriana Falcinelli, Giuseppe Ferraro,Carlo Nanni, Neri Pollastri, Furia Valori.
La lettera di AMICA SOFIA 2008/1: Dall’Italia.Contributi da Marino (RM), Marcianise (CE), Alba(CN), Spoleto (PG), Verbania e Napoli; Un P.O.F.molto, molto filosofico, intervista a Francesco Valecchi;Devo informarmi meglio, intervista a Rosalia Mazzara;Dall’estero. Philosopher à l’école élémentaire? | OscarBrenifi; E ora parliamo di alcuni libri… Le «piccolegrandi domande» di Brenifi er | Chiara Chiapperini;Mondi diffi cili… ma possibili | Betty Sabatino; Letteraai Pallini Blu | Ghirlando, il filosofo giramondo.
107oSSErvatorio SullE riviStE
Chora N. 16, Settembre 2008
sionisti e casalinghe raramente andranno oltre una serie diassaggi nozionisticamente poveri. E allora dov’è il guadagno?Dov’è la formazione di una sensibilità paragonabile a un po’di ‘orecchio’ e di gusto musicale? Il guadagno è, io direi, emi-nentemente metacognitivo. E ora mi permetta una segnala-zione di passaggio. Sembra che nessuna, dico nessuna dellemolte enciclopedie filosofiche in circolazione includa unavoce “metacognizione”. Eppure la filosofia è eminentemente“meta”, prova ne sia la frequenza con cui, via via che si è costi-tuito un qualche sapere specifico, quel sapere si è messo inproprio, si è dato un altro nome, ed è andato a collocarsi‘fuori’ dalla filosofia.
Intende dire?
È semplice: il capire si nutre di conoscenze, ma non si risol-ve nelle conoscenze. È piuttosto una competenza sistemicacapace di gestire o auto-produrre conoscenza ed enunciati. Ilcapire ha a che fare con l’elaborazione di criteri (ed è tantofacile ritrovarsi dotti ma scriteriati). Dunque ha senso dedicar-si, per esempio, ad assicurare ai bambini opportunità per pen-sare, agitare quesiti, provare a dire ‘sciocchezze’ infantilisenza inquietudini incongrue, perché poi accadrà loro di con-tinuare a non saper nulla di filosofia, e tuttavia di sapersi giàguardarsi attorno, soppesare, interrogare, argomentare, nonfermarsi alla prima osteria. Ma formare bambini non è inse-gnare, bensì esercitare l’arte dell’ascolto ed eventualmente faraffiorare qualche problema, in modo che essi abbiano l’agiodi diventare un pochino più avvertiti. Per ragioni analoghe hasenso dedicarsi a praticare l’ascolto dei detenuti, offrire loro ilprivilegio di qualcuno che senta la loro opinione o aspetti ildelinearsi di una loro opinione. Vivranno meglio anche senon avranno appreso un’Acca della filosofia dei professori difilosofia. E, per converso, pensi a cosa accade se per caso ilcorpo docente è fatto di gente che spiega, insegna, interroga,sollecita l’apprendimento, ma si limita a questo: si rischial’inaridimento in primis perché non c’è ascolto, non c’è scam-bio e la comunicazione viene mantenuta su binari troppo rigi-di. Per cui il cognitivo finisce col prevalere sul metacognitivo.
A questo punto si profila come necessario il confronto con iltema favorito dagli antichi, quello della paideia, della formazio-ne dei cittadini da parte dei filosofi, e questo anche indipenden-temente dal Suo essere uno specialista di filosofia antica.Orbene, nel vostro progetto è presente una sensibilità di qualchetipo per quanto riguarda la cosiddetta funzione sociale e civiledella filosofica?
Insisto: una delle idee nuove che mi sembra si stiano affaccian-do nel nostro mondo pluralista è che i filosofi dovrebbero preoc-cuparsi non di formare gli altri, ma di creare le condizioni perchégli altri si formino, ossia non di iniziare alla filosofia ma di spen-dersi per ottenere che il potenziale filosofico della gente non
venga soffocato e spento ma piuttosto coltivato, proprio comela cultura musicale. Quindi metterei da parte l’idea – che puòben dirsi, in ultima istanza, paternalistica –dell’irraggiamentodella filosofia. Al suo posto metterei l’idea che tutti dobbiamocercare di essere un po’ filosofi, fermo restando che alcunidedicano addirittura una vita e una carriera a questo obietti-vo (così come altri studiano musica per una vita).
Questa è la precondizione, io direi, per fare in modo che lafreschezza della riflessione dei più non venga prematura-mente incanalata in (e ricondotta a) modelli già disponibili. Seci pensiamo bene (e senza alcun bisogno di “buttarla in poli-tica”), in gioco è la possibilità di prevenire gli eccessi di unasubalternità intellettuale diffusa di fronte ai media e ai padro-ni dei media.
Posso immaginare. Ma… ci sarà anche un guadagno per lafilosofia dei filosofi?
Certo. Come minimo ciò si tradurrebbe in aiuto contro ilrischio di ritrovarsi chiusi nelle loro belle torri d’avorio. C’èpoi la prospettiva – che a me pare liberante – di provare a reg-gere certi discorsi con chi sia totalmente estraneo a determina-te mode filosofiche, perché magari capita di vederli crollare (ilche sarebbe indizio illuminante di costruzione artificiosa).Ricorderei infine il bacino delle idee vergini: chi è acculturatosi trova a suo agio dentro binari che in qualche misura acco-glie senza più discutere. Invece chi non ha un backgroundstrutturato va a tentoni, comincia con le idee che trova giàpronte sul suo cammino (es. i bambini ciò che hanno sentitodire a casa, in chiesa…), ma poi osa di più di chi è educato-e-istruito, di chi è inserito nel sistema, di chi ormai si è dichiara-to pubblicamente per una certa idea, di chi ha un maestro colquale mantenere buone relazioni… Mi pare di poter dire chec’è una bella differenza. Sbaglio?
Livio Rossetti è professore all’Università di Perugia, socio dell’Accademia Marchigiana e presidente dell’associazione Amica Sofia. I suoi studisono concentrati sulla fase prearistotelica della filosofia antica. Tra le sue pubblicazioni: Introduzione alla filosofia antica (Bari 1998; trad. portoghese SãoPaulo 2006), Un Eutifrone interattivo. Tentazioni esegetiche dissociate (Perugia 2006, con CD interattivo), Socratica 2005 (in coll. con A. Stavru, Bari 2008),I sophoi di Elea: Parmenide e Zenone (in coll. con F. De Martino, Bari 2008). Da alcuni anni è responsabile scientifico dei convegni denominati ELEATI-CA e SOCRATICA. Dirige o condirige diverse collane presso la casa editrice tedesca Academia Verlag e la casa editrice italiana Morlacchi. Il suosito web: www.rossettiweb.it/livio
organo uFFiciale dellasocietà italiana per la psicopatologia
coMprendrearchive international pour l’anthropologie et la
psychopathologie phénoMénologiQues
oSSErvatorio SullE riviStE
Chora N. 16, Settembre 2008
108
E' uscito il numero 16-17-18, numero specialeofferto dagli amici per festeggiare gli 80 anni diArnaldo Ballerini. L’indice e i contenuti delnumero sono anche disponibili all’indirizzo:
http://www.rivistacomprendre.org/rivista/
Riportiamo l’indice
PRESENTAZIONE; E. Borgna FENOMENOLO-GIA E PSICHIATRIA IN ARNALDO BALLERINI;A. Ales Bello THE LANGUAGE OF OUR LIVINGBODY; F. Barison
OPINIONI DI UNO PSICHIATRA DI ISPIRA-ZIONE HEIDEGGERIANA SULLA PSICOTERA-PIA; S. Besoli SULL’AMBIGUITÀ DEL COM-PRENDERE. IN MARGINE AD ALCUNE CONSI-DERAZIONI BINSWANGERIANE; B. Call ieriL’INVECCHIAMENTO
FRA EMARGINAZIONE E CREATIVITÀ; L.Calvi RISPOSTA AD UNA LETTERA DI ARNAL-DO BALLERINI ALLA REDAZIONE DI COM-PRENDRE; L. Cappellari IL MONDO MANIA-CALE; M. Cappuccio VERSO UNA GENEALOGIADEL CERVELLO. ATTRAVERSO LA RIFLESSIO-NE DI E. HUSSERL ED E. PACI; A. Civita FENO-MENOLOGIA E PSICOANALISI; P. ColaveroALICE. LA SOGLIA; R. Dalle Luche, P. IazzettaWHEN OBSESSIONS ARE NOT BELIEFS: SOMEPSYCHOPATHOLOGICAL-GROUNDED OBSER-VATIONS ABOUT PSYCHOTHERAPY WITHSEVERE PHOBIC-OBSESSIVE PATIENTS; L. DelPistoia Per capire la psicopatologia fenomenologica;A. De Luca L’attimo poetico tra la ripresa e la testi-monianza; A. Dentone TECNICA: UOMO NATU-RA ANIMALI; G. Di Petta SUBSTANCESABUSE, TWILIGHT CONSCIOUSNESS ANDBASIC SYMPTOMS: A PSYCHOPATHOLOGI-CAL PERSPECTIVE; G. Di Piazza ELOGIO…DELL’INDISCIPLINATEZZA; B.M. d'Ippolito
DIMENSIONI DELL’ESISTENZA SECONDO L.BINSWANGER; G. Gozzetti
MODESTE RIFLESSIONI SU COMPRENSIONE,ERMENEUTICA E SCHIZOFRENIA; A. Kraus
MELANCHOLIC DEPERSONALISATION; F.Leoni IL LUOGO DEL SIGNIFICATO E LO SPEC-CHIO DEL SENSO. NOTE PER UN’ARCHEOLO-GIA DELLE NEUROSCIENZE; F. Madioni Unateoria del soggetto in Freud, tra Brentano eHusserl ; C. Muscel l i , G. Stanghell ini PERUN’ESTETICA DELLO SPAZIO VISSUTO. LAMODALITÀ OSSESSIVA; A. Pagnini FREUDDOPO WITTGENSTEIN; V. Quaranta IDENTITÀ E ALTERITÀ: DAL TYPUS MELANCHOLICUS ALTIPO AMBIGUO; P. Rossi CHI ERANO GLI ARTI-STI DELLA MEMORIA?; M. Rossi Monti
PSICOANALISI E PSICOPATOLOGIA. CON-TROTRANSFERT E SENTIMENTO PRECOCE DISCHIZOFRENIA; M.L. Rovaletti NARRATIONAND TEMPORALITY. TOWARDS AN ETHICS OFMEMORY; P. Scudellari, V. Spigonardo, C.F.Muscatello WHAT CAN PSYCHOPATHOLOGYEXPECT FROM PHILOSOPHY?; AUTORI PUB-BLICATI (COMPRENDRE 1/18); LIBRI RICEVUTI.
109oSSErvatorio SullE riviStE
Chora N. 16, Settembre 2008
L’ult imo numero della r ivista è dedicatointeramente ad Arnaldo Ballerini nell’occasio-ne del suo ottantesimo compleanno. ArnaldoBallerini è Psichiatra e studioso della filosofiafenomenologica. E’ Presidente della SocietàItaliana per la Psicopatologia e docente di psi-copatologia presso la Scuola di psichiatriadell 'Università di Firenze. Ha scritto studiimportanti sul tema della costituzione dell’al-tro e di tutte le condizioni psicopatologicheche impediscono la formazione e lo sviluppodella persona nell’età adolescenziale. Ha col-laborato con Vittorio Gallese agli studi sulleforme di autismo infantile. Descrivendo ledifficoltà e le conseguenze delle forme manca-te o interrotte di comunicazione, la sua ricer-ca ci ha portato ai nodi dello sviluppo delleforme più gravi del le malat t ie mental i .Riport iamo l ’autorevole test imonianza diEugenio Borgna, contenuta nel suddettonumero di Comprendre, che ne tratteggia effi-cacemente gli aspetti umani e professionali :
“Nell’area della psichiatria fenomenolo-gica italiana, i lavori di Arnaldo Ballerinisi sono venuti svolgendo nella scia inizialedi una neurologia (quel la del le afas ie ,delle agnosie e delle aprassie) virtualmen-te aperta ai suoi possibili sconfinamentipsico-patologici, e nel solco poi di una psi-chiatr ia fenomenologica mai chiusa neilabirinti di un’astratta teoresi fi losofica,come talora è avve-nuto in Germania, einvece immersa nei mari sconfinati dellac l inica : nutr i ta del l ’osservazione deipazienti e della partecipazione emozionaleal loro destino: alla loro soggettività e allaloro vita interiore. Questa connotazioneclinica di una psichiatria fenomenologicadia-lettica – e il primato della clinica nonpuò mai venire meno in psichia-tria, comediceva Kurt Schneider – si snoda, direi,come Leitmotiv dei suoi l ibri e dei suoilavori. […] La radicale originalità del pen-siero psicopatologico e clinico di Ar-naldoBallerini si realizza, nell’associare rifles-s ioni r igorosamente fe-nomenologiche ariflessioni che nascono dalla sua culturafilosofica e letteraria, e anche da una cul-tura neurobiologica aggiornata che gli con-sente di seguire e di rielaborare conoscen-ze e acquisizioni, quelle delle neuroscien-ze, quasi del tutto estranee ad una forma-
zione fenome-nologica tradizionale. Ma,del resto, la sua amplissima cultura psi-chiatrica non è solo nutrita di cultura tede-sca, come quella che si co-glieva nel magi-s tero indimenticabi le (certo) di Dani loCargnello, ma anche di cultura francese eanglosassone: che si sono amalgamate nelfuoco ardente di una modalità di esperien-za fenomenologica e psicopatologica deltutto personale, e inconfondibile nella suacifra ermeneutica.”
Redattore capo: Lorenzo Calvi;Comitato Scientifico: L. Cappellari, R. Dalle
Luche, R. De Monticelli, F. Leoni, C. Muscatello, M.Rossi Monti, P. Scudellari, G. Stanghellini, L.Calvi;
Editor: Giuseppe Riva;Redazione: Piazzetta SS. Maurizio e Lazzaro, 2 I-
23827 Lierna (LC) Tel. 0341.710312
La rivista Comprendre nasce nel 1988 per iniziativa delProf. Lorenzo Calvi – neurologo, psichiatra e psicotera-peuta - con l’intento di collegare tra loro i vari esponentidell’antropologia e della psicopatologia fenomenologiche edi allargare la conoscenza del loro lavoro ad un uditoriopiù vasto. Dal 2008 (numero 16-17-18) la rivista esceanche on-line. La proposta culturale e scientifica dellarivista si giova, nella sua articolazione, e nella scansionedelle sue uscite monografiche, della riflessione e dell’espe-rienza di Lorenzo Calvi, Presidente della Società diPsicopatologia, libero docente in clinica delle malattienervose e mentali e in psichiatria, nonché primario neu-rologo ospedaliero. Calvi è uno dei più influenti rappre-sentanti del movimento antropologico-fenomenologico inpsichiatria, ed è autore di numerosi studi clinici. Ha con-tribuito con un capitolo specifico al Trattato italiano dipsichiatria (Masson Italia ed.). Nel 2005 ha pubblicatoper Mimesis “Il tempo dell’altro significato” e, nel 2007,“Il consumo del corpo. Esercizi fenomenologici di unopsichiatra sulla carne, il sesso, la morte”.
Andrea Sangiacomo, Scorci. Ontologia e verità nellafilosofia del Novecento, Il Prato (collana I cento talle-ri) 2008, p. 252, ISBN: 9788863360097
Dopo venticinque secoli di cammino, il pen-siero sembra esser giunto ad una svolta decisi-va, che ad un tempo mostra con la massimalucità l'essenza e il senso della strada compiu-ta, e da cui pure inizia ad affacciarsi qualcosadi quello che potrebbe dirsi il futuro del filoso-fare stesso. E' allora necessario soffermarsi ariflettere sul significato di questa svolta, nonsolo per tentare di tratteggiarne i contorni, maanche per cercare d'intendere la direzioneverso cui s'incammina. Gli orizzonti che da quisi intravedono, infatti, anche se sono ancorasolo in scorcio, rivelano già qualche tratto diquel sentiero che da sempre già riporta ciascu-no all'Essere e alla sua Verità: e percorrerlo,esserne capaci, si mostra ormai oggi come ilDestino non solo della filosofia futura, ma ditutti noi. Andrea Sangiacomo (Genova, 1986),laureatosi in Filosofia presso l’Università diGenova e conseguito il diploma in pianofortepresso il Conservatorio della stessa città, èattualmente iscritto al corso di LaureaSpecialistica in Filosofia presso l’UniversitàVita-Salute San Raffele di Milano. Nel 2007 hapubblicato con il prato, un volume dal titolo Lasfida di Parmenide. Verso la Rinascenza. I suoiinteressi filosofici si orientano verso l’appro-fondimento delle tematiche proprie dell’ontolo-gia fondamentale.
Natalie Depraz, Lire Husserl en phénoménolo-gue - Idées directrices pour une phénoménologie(I), PUF, Série Philosophie, Paris 2008, p. 246,ISBN: 978-2-13-057105-6
Il y a un pari d'envergure, presque une provo-cation, à montrer l 'ampleur et l 'acuité desméthodes pratiques qui tissent le propos deHusserl dans un texte qui a été considéré parses interprètes comme le livre le plus "méta-physique", à savoir celui où l'auteur prendparti pour une thèse philosophique souventjugée éculée: l'idéalisme. Tout le destin de laphénoménologie s'est joué autour d'une prisede position contre son "tournant idéaliste" en1913, Heidegger ayant ouvert les hostilités,suivi par Sartre, Ricœur, Derrida et Levinas. Arebours de cette herméneutique constitutive dela critique philosophique, l'auteur cherche ici àfaire voir un Husserl "praticien", "épistémolo-gue", c'est-à-dire peu soucieux de défendre uneposition métaphysique. Cette épistémologiepratique de la phénoménologie peut être carac-térisée comme un "empirisme transcendantal".Par là, un sens de la vérité émerge, qui puise savalidité dans l'expérience native du lecteur,c'est-à-dire dans son aptitude à vérifier par lui-même l'accord du concept en relation avec sonvécu. La lecture expérientielle proposée prendalors un tour pragmatique, à l'horizon d'unrenouvellement de la phénoménologie commepratique. Natalie Depraz, spécialiste deHusserl , est professeur de philosophie àl'Université de Rouen.
in librEria
Chora N. 16, Settembre 2008
110
111in librEria
Chora N. 16, Settembre 2008
Marco Bastianelli, Oltre i limiti del linguaggio. Ilkantismo nel Tractatus di Wittgenstein, Mimesis,Milano 2007, p. 266 ISBN: 9788884837226
Ponendo la questione dei limiti della ragioneumana, Kant ha ribadito la via percorsa dallaf i losofia moderna f ino ai giorni nostr i .Wittgenstein ripropone il problema kantianonella forma di un’indagine sui limiti del lin-guaggio. Questa vicinanza generale tra le dueprospettive filosofiche rivela conseguenze teo-retiche che non si riducono ad una mera rifor-mulazione del problema kantiano, bensì apro-no sviluppi decisivi per la riflessione filosofi-ca contemporanea. Nel Tractatus logico-philo-sophicus Wittgenstein individua i limiti dellinguaggio dall’interno del linguaggio medesi-mo. Si pone così una questione che, nella pro-spettiva kantiana, restava nell’ombra, vale adire quella dell’autoriferimento della proble-matica trascendentale e, dunque, del suo supe-ramento. Lungi dal risolversi in una sorta diaporia, la tendenza ad oltrepassare i limiti dellinguaggio assume in Wittgenstein un essen-ziale significato etico: gli permette di sottoli-neare che la possibilità stessa della conoscenzasi radica in una originaria domanda di sensoche si impone all’uomo e alla quale egli nonpuò sottrarsi, in quanto si trova aperto ad unarealtà che gli si dà originariamente e gratuita-mente. Si dischiude così la possibilità di inten-dere i l trascendentale come un’apertura alsenso oltre i limiti del linguaggio.
Roberto Marchesini, Intelligenze plurime. Manuale discienze cognitive animali, Oasi Alberto Perdisa, 2008, p. 384,ISBN: 9788883724435
Parlare di mente animale è difficile; nell’ambi-to della divulgazione ci si scontra con tabù e cre-denze popolari, in quello scientifico si corre ilrischio di fare affermazioni difficili da compro-vare. In questo saggio "Intelligenze plurime -Manuale di scienze cognitive animali", con lasolita competenza e chiarezza, Marchesini ciindica come discostarci da un approccio antropo-logico, per arrivare a chiarire cosa sono, e comefunzionano, la mente e la conoscenza animale,evitando di utilizzare l’uomo come metro diparagone. Una sorta di rivoluzione copernicanadell’etologia cognitiva, per impostare un corret-to rapporto uomo-animale che avrà sostanzialiriscontri positivi nella convivenza quotidiana.Roberto Marchesini (Bologna), studioso di scien-ze biologiche e di epistemologia, scrittore e sag-gista. Presidente della Società italiana di ScienzeComportamentali Applicate e direttore dellaScuola di Interazione Uomo Animale, insegnaScienze Comportamentali Applicate in alcuniatenei italiani. Tra i saggi pubblicati: Post-human (Bollati Boringhieri, 2002), Nuove pro-spettive nelle attività e terapie assistite daglianimali, (Edizioni Scivac, 2004), Canone diZooantropologia Applicata (Alberto PerdisaEditore, 2004), Fondamenti di Zooantropologia(Alberto Perdisa Editore, 2005), Attività e terapieassistite dagli animali. L’approccio zooantropo-logico alla pet-therapy (con Laura Corona,Alberto Perdisa Editore, 2007).
collaborare con chora
per informazioni: [email protected]
articoli - La redazione invita i lettori di Chora a collaborare alla realizzazione dei prossiminumeri, inviando i propri contributi scritti: articoli, recensioni di libri o schede di lettura, tesine oestratti di tesi di livello universitario e di argomento scientifico-filosofico.
criteri di selezione - Gli articoli hanno una lunghezza approssimativa di 25000-35000 caratteri(spazi inclusi), le recensioni di 8000-10000 caratteri e le schede di lettura di 2500-5000 caratteri.Non saranno pubblicati testi di narrativa o poesie. La selezione dei testi da pubblicare sarà opera-ta dalla Redazione in base al valore scientifico degli articoli pervenuti, alla pertinenza nei confron-ti dell’argomento del dossier monografico, in base alla disponibilità degli spazi e alla data di con-segna. Oltre a quello dedicato al dossier monografico, nel prossimo numero Chora potrà riserva-re dello spazio per articoli indipendenti.
Sito internet - Gli articoli che non potranno trovare posto sulla rivista cartacea potranno esse-re pubblicati in forma elettronica sul sito dell’editore Symposium: www.symposium.too.it
collaborazioni - Invitiamo chiunque voglia partecipare attivamente allo sviluppo del nostroprogetto editoriale a contattarci per esprimere commenti e proposte. Presentando un curriculumvitae è possibile proporre la propria partecipazione alla conduzione editoriale della rivista daparte della Redazione. Chora cerca inoltre giovani artisti e grafici, per i quali mette a disposizio-ne i suoi spazi per ospitare illustrazioni, disegni o composizioni grafiche in grado di accompagna-re i testi che normalmente pubblica.
nei prossimi numeri
La preparazione dei prossimi numeri di Chora è già cominciata. Vi invitiamo a scrivere sui seguenti argo-menti, ma anche a proporre scritti su altri temi da voi approfonditi, o in risposta a lavori da noi già pubblicati.
apollineo e dionisiaco - Questo numero intende prendere spunto dai due concetti di “apollineo” e “dioni-siaco”, elaborati da Friedrich Nietzsche in uno dei suoi primi scritti, La nascita della tragedia dallo spirito della musi-ca. Partendo dallo sfondo mitopoietico che rimanda a riti e culti ancestrali in onore delle divinità greche diDioniso e Apollo, si tratterà da una parte di ricostruire un percorso storico-filosofico ed estetologico volto amostrare la genesi di tali categorie che fungono non solo da potenti strumenti ermeneutici ma soprattutto dastrutture ontologiche della vita stessa, e dall’altra di ricostruirne la fortuna e la storia degli effetti nel Novecento,attraversandone gli sviluppi in ambito filosofico, psicologico, letterario e artistico.
logica e fenomenologia dell’intero - La mereologia è la scienza che studia i rapporti necessariamen-te sussistenti tra l'intero e le sue parti. Ma da quale pre-condizione del pensiero emerge la possibilità diun intero compreso in quanto tale, e su che principi riposa la sua capacità di essere analizzato in parti? Sitratta, essenzialmente, di studiare il senso, la legittimità e il valore che in filosofia può avere il porre la que-stione dell’intero; ciò sia da un punto di vista schiettamente ontologico, sia – e correlativamente – da unpunto di vista descrittivo. E insomma chieder conto della pregnanza e la cogenza che l’intero ha comeproblema filosofico, ed anche (eventualmente) per un problema filosofico in generale che domanda qualerapporto sussita tra l'analisi e la sintesi.
la filosofia del ‘68, quarant’anni dopo: la dialettica generazionale - Il 1968 ha segnato un evento crucia-le per la definizione di una nuova coscienza generazionale. Oltre a rappresentare un periodo di forti conte-stazioni, si è trattato di un anno che ha offerto notevoli contributi creativi allo sviluppo di un pensiero filo-sofico originale e impegnato. Approfondiamo nella chiave di una retrospettiva filosofica il significato di quelperiodo per la storia e per la crescita intellettuale italiana; ne affrontiamo la memoria attraverso una ricostru-zione storiografica e un confronto critico con i testi e gli autori che hanno segnato lo sviluppo del successi-vo dibattito filosofico.






















































































































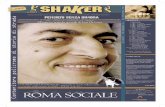
!['Generale e particolare' ['General and Particular'], in Chora V, 14 (2007): 27-36](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633eeee69fa33b2a320f90f5/generale-e-particolare-general-and-particular-in-chora-v-14-2007-27-36.jpg)