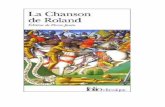Verso la costruzione di un diritto pubblico cittadino. Introduzione a: La Summa Trium Librorum di...
Transcript of Verso la costruzione di un diritto pubblico cittadino. Introduzione a: La Summa Trium Librorum di...
RICERCHE DELL’ISTITUTO STORICO GERMANICO DI ROMA8
Collana fondata da Michael Matheusdiretta da Thomas Hofmann, Lutz Klinkhammer,
Michael Matheus, Andreas Rehberg e Kordula Wolf
Emanuele Conte Sara Menzinger
La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca
(1195-1234)Fisco, politica, scientia iuris
viella
Copyright © 2012 Istituto Storico Germanico di Roma & Viella S.r.l.Tutti i diritti riservatiPrima edizione: luglio 2012ISBN 978-88-8334-498-5
viellalibreria editricevia delle Alpi 32I-00198 ROMAtel. 06 84 17 75 8fax 06 85 35 39 60www.viella.it
Ringraziamenti IXAvvertenza XI
Introduzione. Diritto pubblico tra Impero e città nel pensiero di Rolandus Guarmignani iudex XIII
I. Il testo e l’autore XV 1. I diversi volti di un testo del XII secolo. La Summa
di un giudice fra aule universitarie e tribunali di Emanuele Conte XV1.1. Rolando da Lucca e la sua Summa Trium Librorum (p. XV). 1.2. La circolazione scolastica della Summa (p. XVIII). 1.3. La cir-colazione professionale e politica (p. XXIII).
2. Profilo biografico di Rolandus/Orlandus Guarmignani iudex di Veronica Bagnai Losacco e Frank Theisen XXVII
2.1. Identificazione di Rolando autore della Summa Trium Libro-rum (p. XXVII). 2.2. Il profilo sociale dei Guarmignani (p. XXIX). 2.3. La carriera pubblica di Rolando (p. XXXV). Scheda genealo-gica dei Guarmignani (p. XLII). Appendice documentaria (a cura di Veronica Bagnai Losacco) (p. XLIII).
3. La biblioteca di Rolando di Emanuele Conte LI3.1. La composizione della Summa (p. LI). 3.2. Il Corpus iuris ci-vilis (p. LII). 3.3. Il Decretum e le decretali (p. LVI). 3.4. La lette-ratura giuridica (p. LVII). 3.5. La letteratura classica e tardoantica (p. LIX). 3.6. La letteratura medievale (p. LXI). 3.7. La cultura di Rolando (p. LXIII).
II. Rolando e il diritto pubblico nel XII secolo di Emanuele Conte LXV 1. Roma communis patria. Il modello dell’Antico
e la costruzione di un diritto pubblico nel mondo comunale LXV1.1. Roma: archeologia monumentale e nostalgia istituzionale nel XII secolo (p. LXV). 1.2. Translatio e renovatio nell’età sveva (p. LXVIII). 1.3. La Chiesa, Bulgaro e il rinnovamento della proce-dura (p. LXIX). 1.4. Pisa Roma altera (p. LXXI). 1.5. La mentalità dei giuristi bolognesi insensibili al fascino degli spolia (p. LXXV).
Indice
VI La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca
1.6. I Tres Libri e Rolando da Lucca (p. LXXVI). 1.7. Il modello imperiale in Rolando: Roma communis patria (p. LXXXII). 1.8. Il diritto pubblico romano nella cultura del XII secolo (p. LXXXIV).
2. I glossatori e l’Impero medievale LXXXV2.1. Il rapporto fra il diritto romano e l’Impero svevo: un tema clas-sico della storiografia (p. LXXXV). 2.2. Le fonti (p. LXXXIX). 2.3. La partecipazione dei giuristi bolognesi alla Dieta di Roncaglia (p. XCII). 2.4. Fiscalità imperiale (p. XCVII). 2.5. Ego quidem mun-di dominus (p. XCIX).
3. Autorità imperiale e legalità CV3.1. Esaltazione dell’Imperatore: il modello della maiestas giustinia-nea (p. CV). 3.2. Prerogative del principe e limiti del suo dominium mundi (p. CX). 3.3. L’esenzione dell’Italia dai tributi (p. CXV). 3.4. Il diritto di resistenza e l’Imperatore arbitro della legalità (p. CXVIII). 3.5. Il riconoscimento del carattere pubblicistico delle città (p. CXX).
III. Verso la costruzione di un diritto pubblico cittadino di Sara Menzinger CXXV 1. Trasformazione del quadro fiscale cittadino:
alla ricerca di legittimità CXXVIII1.1. Fiscalità e militia: compiti e privilegi dell’aristocrazia cittadina (p. CXXVIII). 1.2. Imposte e bene pubblico: giustificazione teorica del prelievo (p. CXXXVIII). 1.3. Fiscalità imperiale/fiscalità co-munale: osmosi e separazione (p. CXLIX).
2. Questioni di diritto fiscale CLII2.1. “Cessante causa cessat et effectus”: vantaggi e limiti della ca-ducità del prelievo (p. CLII). 2.2. Prelievi sulle cose e non sulle persone (p. CLVIII). 2.3. La tassazione dei beni ecclesiastici: fonti antiche, interpretazioni nuove (p. CLXXI).
3. Riflessi teorico-politici dei nuovi dibattiti sulla fiscalità CLXXXIX3.1. Dalla fiscalità alle teorie del consenso: il contributo dell’espe-rienza politica comunale (p. CLXXXIX). 3.2. Cittadinanza, fisca-lità, giurisdizione: tre sfere interconnesse (p. CXCVIII). 3.3. La donna medievale nella sfera pubblica: alcune riflessioni in tema di cittadinanza (p. CCIX).
IV. Prolegomena al testo e descrizione dei manoscritti CCXIX 1. Criteri di edizione CCXIX 2. Descrizione dei manoscritti di Valentina Longo e Sabina Magrini CCXX
Fonti e bibliografia CCXLIII
Indice VII
Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (testo). Edizione critica a cura di Emanuele Conte e Sara Menzinger 1
Indice delle citazioni 527
Il lavoro di edizione della Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca è iniziato oltre quindici anni fa ed è stato agevolato dal sostegno di molte istitu-zioni e dalla collaborazione di generosi studiosi.
Un finanziamento della fondazione Thyssen, ottenuto grazie alle cure di Frank Theisen, ha consentito l’avvio dei lavori negli anni Novanta del seco-lo scorso. Un progetto finanziato dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft e ospitato dall’Istituto Storico Germanico di Roma ha consentito a Sara Men-zinger di portare a termine il lavoro di trascrizione dei manoscritti. Anche il Max-Planck-Institut di Francoforte ha offerto borse di studio in periodi di-sparati. La Robbins Collection ha ospitato Emanuele Conte durante due mesi nel 1999. Il Dipartimento di Storia e Teoria Generale del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre” ha offerto assegni di ricerca a più riprese, grazie a finanziamenti PRIN e in ultimo grazie ad un finanziamento FIRB che ha consentito il lavoro di Veronica Bagnai Losacco alle ultime revisioni del testo. Questi mezzi finanziari hanno reso possibile il lavoro appassionato, intelligente e accurato di collaboratori i cui nomi compa-iono come autori di alcune parti dell’introduzione, ma che hanno in alcuni casi contribuito in modo determinante a stabilire il testo della Summa: dapprima Valentina Longo e Sabina Magrini, poi Francesca Macino, poi Veronica Ba-gnai Losacco, che ha anche collaborato con Frank Theisen per ricostruire sui documenti la biografia di Rolando.
La generosità di Michael Matheus permette di coronare questo lavoro complesso, nel quale tante Istituzioni tedesche hanno mostrato di credere, con la pubblicazione nella collana dell’Istituto Storico Germanico di Roma. A lui e a Kordula Wolf, che ha curato la redazione, vanno i nostri ringraziamenti.
Ringraziamenti
In alcune parti dell’introduzione si riprendono testi già pubblicati altrove, aggiornandoli e riorganizzandoli. Si segnalano qui una volta per tutte:
Emanuele C o n t e, Federico I Barbarossa e il diritto pubblico giustinia-neo, in: Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Mu-ratoriano 95 (1990), pp. 237-259.
I d., ‘De iure fisci’. Il modello statuale giustinianeo come programma dell’impero svevo nell’opera di Rolando da Lucca (1191-1217), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 69 (2001), pp. 221-244.
I d., I diversi volti di un testo del XII secolo. La Summa di un giudice fra aule universitarie e tribunali, in: Juristische Buchproduktion im Mittelalter, a cura di Vincenzo Colli, Frankfurt a. M. 2002, pp. 351-366.
I d., ‘Ego quidem mundi dominus’. Ancora su Federico Barbarossa e il diritto giustinianeo, in: Studi sulle società e le culture del Medioevo per Giro-lamo Arnaldi, a cura di Ludovico Gatto e Paola Supino Martini, Firenze 2002, pp. 135-148.
I d., Archeologia giuridica medievale. Spolia monumentali e reperti istitu-zionali nel XII secolo, in: Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte 4 (2004), pp. 118-136.
I d., Diritto romano e fiscalità imperiale nel XII secolo, in: Bullettino dell’Istituto Storico per il Medio Evo, 106/2 (2004), pp. 169-206.
I d., La biblioteca di Rolando da Lucca (1195-1234), in: Liber amicorum Ditlev Tamm. Law, History, Culture, a cura di Per Andersen, Pia Letto-Vana-mo, Kjell Ade Modéer, Helle Vogt, Copenhagen 2011.
Sara M e n z i n g e r, Fisco, giurisdizione e cittadinanza nel pensiero dei giuristi comunali italiani tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, in: Quel-len und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 85 (2005), pp. 36-86.
Frank T h e i s e n, Rolandus von Lucca. Bemerkungen zu seiner Bio-graphie, in: Juristische Buchproduktion im Mittelalter, a cura di Vincenzo Colli, Frankfurt a. M. 2002, pp. 385-394.
Avvertenza
III. Verso la costruzione di un diritto pubblico cittadino
di Sara Menzinger
Se la nascita dei Comuni italiani è stato uno dei temi più indagati dalla sto-riografia italiana e straniera, risulta a tutt’oggi straordinariamente trascurata la questione degli stimoli intellettuali che contribuirono alla realizzazione di quel fenomeno. Quali modelli vennero presi a riferimento dalle città italiane? In che misura le prerogative statali, che svilupparono le nuove forme di governo ur-bane dell’Italia centro-settentrionale, furono il frutto di una riflessione astratta sul tema delle istituzioni, dell’interesse collettivo, della cosa pubblica? Quanto contribuirono, alle innovazioni politiche dei secoli XII e XIII, sollecitazioni provenienti dallo studio del diritto colto e, in particolare, romano?
L’attenzione relativa prestata a questi interrogativi ha avuto come conse-guenza una scarsa partecipazione dell’Italia al grande dibattito internazionale sviluppatosi attorno alle origini del diritto pubblico e del pensiero costituzio-nale, temi che hanno da sempre appassionato la storiografia medievale inglese e francese, e riscosso invece, da noi, un interesse al più episodico. È come se la lunga assenza di un coordinamento territoriale unitario non avesse sempli-cemente stimolato meno gli studiosi del Medioevo italiano a confrontarsi con il problema della nascita dello Stato prima del Quattrocento,1 ma comportato anche una svalutazione dell’esperienza italiana nell’ambito delle discussioni teoriche inerenti ad aspetti vitali di questa questione. Dell’esperienza italiana, certo, secolare e comunale. La precoce formazione di uno Stato ecclesiastico e il costante interesse internazionale suscitato dalla produzione canonistica come patrimonio religioso-culturale di tutta la Cristianità hanno viceversa in-fluito molto sulla valorizzazione del contributo che, a partire almeno dal XII secolo, provenne dagli intellettuali della Chiesa in materia amministrativa e di diritti della collettività. Il risultato è stato un dibattito scientifico a due voci, i
1. A fronte invece di una robusta tradizione di studi storici che ha valorizzato l’esperienza del potere pubblico in Italia fin dai primi secoli dell’Alto Medioevo: basti il richiamo ai lavori di Giovanni T a b a c c o e Cinzio V i o l a n t e. Per l’epoca rinascimentale, si veda da ulti-mo l’importante lavoro comparativo: L a z z a r i n i /G a m b e r i n i (a cura di), The Italian Renaissance State.
CXXVI Diritto pubblico tra Impero e città
regni nazionali dal canto laico, la Chiesa dall’altro, nell’ambito del quale sono stati messi a fuoco alcuni capisaldi che ancora oggi orientano il nostro baga-glio di conoscenze. L’idea, per esempio, di un’origine prevalentemente cano-nistica del concetto di bene pubblico, di rappresentanza, di amministrazione, di burocrazia, e di un’influenza che in questi campi il diritto canonico eserci-tò sugli stati laici nei primi secoli della loro formazione, grazie all’azione di autori e divulgatori ecclesiastici di diversa provenienza nazionale che, a loro volta, svilupparono, ampliarono e adattarono tutto questo materiale alle esi-genze dei regni secolari.2 In tal senso si indirizza ancora, per citare il lavoro più recente, il bel volume di atti di un convegno francese su Les origines ca-noniques du droit constitutionnel, dove il mondo laico è sostanzialmente rap-presentato dalla monarchia inglese e francese.3
Ma una certa marginalità dell’Italia comunale in questi discorsi non è do-vuta solo alla frammentazione politica di quei secoli XII-XV. L’idea infatti di una scarsa aspirazione statale, di un superamento della parcellizzazione terri-toriale di cui erano manifestazione le città-stato, è sembrato avere come natu-rale corollario il complessivo disinteresse degli intellettuali comunali italiani nei confronti di temi pubblicistici, di questioni cioè politiche e giuridiche ine-renti al funzionamento di uno Stato. Questo corollario trovava un’apparente conferma nella produzione giuridica del mondo cittadino, una produzione, si è a lungo ripetuto, tutta orientata, fino al Trecento inoltrato, in senso privatisti-co, che nella mastodontica impresa di rivitalizzazione dell’antico diritto roma-no aveva trascurato le pur cospicue sezioni di quel diritto dedicate, appunto, allo Stato. Ho parlato al passato ma potrei parlare anche al presente, conside-rato che l’ultima iniziativa scientifica intrapresa in questo campo, gli atti di tre convegni dedicati al tema degli Inizi del diritto pubblico,4 pur essendo co-promossi da un’istituzione italiana e co-curati da importanti studiosi italiani, valorizzano l’Italia medievale soprattutto nell’esperienza della sovranità: la sovranità imperiale di Federico I e II da una parte, quella pontificia dall’altra. In altre parole, non contemplano nel complesso le città, né come soggetti pub-blicistici, né come laboratori culturali e terreno di elaborazione scientifica di questioni pubblicistiche.5
2. Questo cruciale processo di interscambio che nel Medioevo centrale avvenne tra “ec-celsiology” e “political theory” è stato magistralmente teorizzato da T i e r n e y, Religion, pp. 1-12, dove l’Autore non solo dimostra l’apporto dei secoli XII e XIII al pensiero costituzionale occidentale – retrodatandone la nascita di almeno due secoli rispetto al tradizionale terminus a quo assunto dalla storiografia in materia –, ma invita significativamente a cogliere l’importanza delle interazioni, prima che delle opposizioni, tra i massimi poteri secolare ed ecclesiastico.
3. C h a g n o l l a u d (a cura di), Les origines canoniques.4. D i l c h e r /Q u a g l i o n i (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico 1-3.5. Fa eccezione, nel I volume, il bel saggio di G ö r i c h, Fragen, il quale, rigettando una
III. Menzinger, Diritto pubblico cittadino CXXVII
È importante chiarire che, se nella storiografia passata e presente la cit-tà comunale, per le sue ridotte dimensioni territoriali, non si configura come un’entità statale, coloro che pensavano e scrivevano in quel mondo ebbero invece fin dall’inizio la convinzione di appartenere a un esperimento politi-co che si ispirava proprio a quel modello. Le testimonianze in questo senso oggi non mancano, grazie al lavoro di alcuni studiosi che hanno ricostruito un panorama ormai abbastanza nutrito di opere giuridiche di provenienza co-munale incentrate sul diritto pubblico e il potere: ciò che la storiografia an-glofona chiama senza reticenze “the State”, intendendo il funzionamento, la concreta amministrazione, ma anche la teorizzazione politica dello Stato.6 E proprio quest’ultima costituisce una novità rilevante, la presenza cioè di un interesse tutto politico per la materia pubblicistica da parte degli intellettuali laici dell’Italia centro-settentrionale, animato non solo dalla curiosità antiqua-ria per il passato romano, ma dal gran desiderio di attualizzare quella tradi-zione. Si tratta di un punto sul quale ha ritenuto opportuno intervenire pochi anni or sono André Gouron, nell’ambito di un convegno franco-tedesco ap-parso sotto il titolo Science politique et droit public dans le facultés de droit européennes:7 contestando, ancora una volta, l’inconsistente leggenda di un supporto teorico alla sovranità sveva da parte dei giuristi comunali del XII secolo, lo storico francese ha messo in guardia dal rischio di non confondere l’assenza di un pensiero politico dedicato alla sovranità, con l’assenza di un pensiero politico tout court.8
Nel panorama culturale italiano del 1100, l’opera di Rolando da Lucca costituisce una delle testimonianze più significative di questo rinato deside-rio di accostamento alle fonti romane per motivazioni tutte politiche: giudi-ce e non professore, Rolando concentra la sua attività nelle aule giudiziarie,
prospettiva evoluzionistica che veda in Federico I e in Roncaglia l’avvio del moderno statali-smo, si concentra sul contesto della Dieta come prodotto dello scontro/incontro tra ammini-strazioni imperiale e cittadine, e come frutto dell’interazione culturale tra doctores bolognesi e corte imperiale (pp. 305-306); qualche spunto sull’apporto delle città alle decisioni imperiali in materia amministrativa si trova anche nel saggio di D a r t m a n n, Die Legitimation; una valo-rizzazione, se non dell’esperienza politica cittadina italiana, del contributo politico-ideologico apportato da singoli esponenti della dottrina comunale, è presente nel saggio di D o l e z a -l e k, Der Friede, e in quello di R y a n, Zur Tradition. Nel III volume, l’importanza del con-tributo urbano emerge bene invece dal saggio della S t o r t i (Progetti di riforma) su Milano nella primissima Età Moderna, all’interno del quale sono peraltro valorizzati interessanti spunti dottrinari retrospettivi.
6. Il riferimento è principalmente ai lavori di Ennio C o r t e s e, André G o u r o n, Ma-rio S b r i c c o l i, Emanuele C o n t e, Diego Q u a g l i o n i, Mario A s c h e r i e Victor C r e s c e n z i .
7. K r y n e n /S t o l l e i s (a cura di), Science politique.8. G o u r o n, Glossateurs
CXXVIII Diritto pubblico tra Impero e città
anziché universitarie, del suo tempo, e nella consulenza agli organi politici della sua città. È dunque un giurista cittadino nel senso più pieno della de-finizione, esponente di quella classe di iudices che arricchiscono la propria conoscenza pratica con elementi di diritto giustinianeo e che, nella Lucca di fine XII secolo, giungono ad esibire una formazione romanistica ormai completa.
Nato probabilmente intorno al 1150, egli si forma nella stagione cosid-detta ‘consolare’ dei governi comunali, in quei fondamentali decenni in cui molte città compiono lo sforzo di dotarsi di strumenti amministrativi volti a consolidare la legittimità del proprio potere dentro e fuori le mura, e allo stesso tempo a regolamentare le innovative forme che va assumendo il go-verno cittadino. Fedele sostenitore degli Hohenstaufen, Rolando, da giudice comunale e filoimperiale, inizia dunque a scrivere il suo commento agli ul-timi tre libri del Codice giustinianeo, intorno al 1195, per una duplice aspi-razione politica: da un lato l’interesse, approfondito da Emanuele Conte,9 per la teorizzazione dell’Impero come istituzione non più travalicante ma garante delle autonomie cittadine, in assonanza al nuovo contesto politico italiano all’epoca di Enrico VI; dall’altro, quello per il fenomenale modello amministrativo costituito dall’antico Impero romano, come archetipo su cui esemplare l’esperimento statale di cui Rolando si sente protagonista, il Co-mune di Lucca.
1. Trasformazione del quadro fiscale cittadino: alla ricerca di legittimità
1.1. Fiscalità e militia: compiti e privilegi dell’aristocrazia cittadina
La materia fiscale ricopre un’importanza tale nel pensiero di Rolando da Lucca, da potersi identificare come uno dei principali stimoli a muovere in lui il desiderio di confrontarsi con il diritto pubblico romano. Come ha ampia-mente illustrato Conte,10 la fede politica filo-imperiale sia personale che, più in generale, lucchese, ben giustificano un’inclinazione particolare del giudice verso il tema della fiscalità, considerato che il contenuto della politica degli Hohenstaufen in Italia, nella seconda metà del XII secolo, trova la sua prin-cipale espressione nella rivendicazione delle imposte. Commentare critica-mente le scelte dell’amministrazione sveva, inserendole nel contesto giuridico dotto della fiscalità tardo-imperiale romana, scaturisce dunque dall’esigenza
9. Cfr. supra, cap. II.10. Supra, C o n t e, II.2., I giuristi e l’Impero, e II.3., Autorità imperiale.
III.1.1. Menzinger, Trasformazione del quadro fiscale cittadino CXXIX
politica di legittimarle, condannarne gli eccessi, analizzare il concetto di so-vranità che sottendono. Ma l’etichetta di ghibellino ante litteram non esauri-sce l’identità politica e intellettuale di Rolando. La professione di iudex e lo status di miles determinano infatti in lui – come in molti altri giudici urbani attivi nella stessa epoca – una vera e propria vocazione di governo. Stando a quanto emerge dagli studi prosopografici di numerose città, l’assimilazione ai milites è largamente applicabile alla maggioranza dei giudici cittadini dell’Ita-lia centro-settentrionale, generalmente provenienti dallo strato della militia prima del Duecento.11 Né rappresenta un’eccezione Rolando, la cui residenza nella curtis regia lucchese, le proprietà fondiarie, i legami con potenti isti-tuzioni ecclesiastiche locali e lo svolgimento di cariche pubbliche per il go-verno consolare sembrano fuor d’ogni dubbio collocare nello strato elevato della Lucca di fine XII-inizio XIII secolo.12 L’impegno civico, tanto quanto l’adesione allo schieramento sovraregionale di matrice sveva, deve essere per-ciò tenuto in grande considerazione al fine di comprendere l’orientamento dei suoi interessi e la marcata predilezione che mostra per la materia delle imposte e il loro inquadramento teorico.
Non si tratta, d’altronde, di sfere di interessi disgiunte, se consideriamo l’influenza che la politica fiscale sveva esercitò sui sistemi tributari comunali della seconda metà del XII secolo.13 La definizione delle imposte cui erano te-nute le città nei confronti dell’Impero contribuì a stimolare lo sviluppo di un autonomo sistema fiscale cittadino, in cui si andarono gradualmente affinando modalità di prelievo dei tributi e tecniche di gestione delle finanze comunali.14 Non stupisce dunque la contiguità esistente, nel pensiero di Rolando, tra fisca-
11. Uso la parola militia nell’accezione tecnica di aristocrazia militare, nei termini definiti da M a i r e V i g u e u r, Cavalieri, passim.
12. Cfr. supra, B a g n a i L o s a c c o / T h e i s e n, I.2., Profilo biografico. Non con-cordo con W i c k h a m (Legge, pp. 98-99) secondo il quale il possesso da parte di Rolando di terre in foro pisano attesterebbe un inserimento della famiglia Guarmignani nel ramo mercanti-le: essendo tale espressione tratta dalla Summa di Rolando (infra, Summa in tit. C. 11.58, § 19), credo che il termine forum debba essere tradotto con “giurisdizione”, piuttosto che con “merca-to”, coerentemente con altre ricorrenze del termine, tra le quali cfr., per esempio, infra, Summa in titt. C. 10.39, § 44, C. 10.40, § 39. Per un uso del termine nel senso stretto di tribunale, infra, Summa in titt. C. 10.16, § 10, C. 10.19, § 18, C. 11.17, §§ 2 e 7, C. 12.1, § 59; nel senso invece di mercato, infra, Summa in titt. C. 11.30, § 44, C. 11.48 § 209, C. 11.50, § 61.
13. Cfr. J o n e s, The Italian, pp. 394-395. Sulla fiscalità sveva in Italia, cfr. i classici studi di B r ü h l, Fodrum, pp. 645-661; H a v e r k a m p, Die Regalien-, ricco di riferimenti alla realtà lucchese, e I d., Herrschaftsformen, pp. 559-728. Sull’idea di un’influenza mutua, cfr., oltre ai già citati lavori di H a v e r k a m p, la discussione in M a i n o n i, La “révolution fiscale”, pp. 220-224.
14. Cfr. B a r b a d o r o, Le finanze, pp. 3-29, e le importanti considerazioni in proposito di C a m m a r o s a n o, L’esercizio, pp. 104-111, I d., Le origini della fiscalità, e di B o c -c h i, Le imposte, 276-280.
CXXX Diritto pubblico tra Impero e città
lità imperiale e cittadina,15 né il diretto coinvolgimento in incarichi legati alla riscossione delle imposte.
Diversi passi della Summa attestano quanto il coinvolgimento attivo nel sistema fiscale urbano sia da Rolando avvertito come un imperativo profes-sionale e sociale. Ciò è visibile in primo luogo dal commento al titolo sui decurioni,16 gli amministratori degli antichi municipia romani che, agli oc-chi di un giurista del XII secolo, condividevano con i magistrati comunali il ruolo collettivo di guida amministrativa e politica delle città. Il valore para-digmatico che assumono le strutture amministrative romane del tardo Impe-ro è evidente nell’opera dei glossatori dei Tres Libri, che non esitano ad ap-plicare le norme giustinianee in materia ai componenti dei consigli cittadini medievali. Nella seconda versione della sua opera Rolando cita un pezzo di Pillio da Medicina († post 1213?) nel quale il giurista modenese sostiene esplicitamente l’equazione tra i decuriones e i sapientes del mondo comuna-le, coloro, afferma, deputati ai consigli.17 Si tratti quindi degli stessi consoli o dei membri dei ristretti consigli che originariamente dovevano affiancarli, Rolando sembra fondare l’identità della classe di governo cittadina, antica quanto contemporanea, sui compiti fiscali. Concludendo il titolo de decurio-nibus con l’evocativa immagine delle due spade – i duo gladii che, a secon-da delle epoche e dei contesti, erano stati assunti per esemplificare tante for-me diverse di rapporto tra il potere ecclesiastico e secolare nel Medioevo18 –, le paragona a due militiae che, dice, sembrano incedere di pari passo: da un lato un esercito spirituale, formato da canonici regolari, che deve servire la Chiesa con lodi divine; dall’altro una militia secolare delle città, le quali an-che possono contare su propri conversi, i curiales (o decuriones), deputati a incrementare gli obsequia urbani.19 E in cosa consistano concretamente tali ‘ossequi’ è spiegato a chiare lettere in un titolo di poco successivo: il decu-rione, afferma infatti, non ha motivo di esistere fuori dalla città, in cui deve sottostare agli incarichi, prestare il proprio servizio per la riscossione delle imposte, riporre le imposte prelevate e custodire ciò che ha raccolto. Fuori da tale contesto e funzione, diviene come un pesce senz’acqua, un monaco senza chiostro, un colono senza terra.20
Il ricorso a un linguaggio militante non rappresenta un mero artificio retorico: a questa suggestiva immagine della militia Rolando pare infatti
15. Aspetto su cui cfr. infra, III.1.3, Fiscalità imperiale/fiscalità comunale.16. Infra, Summa in tit. C. 10.32.17. Infra, Summa in tit. C. 10.47, § 25.18. Cfr. C o r t e s e, Il diritto, II, pp. 232-233.19. Infra, Summa in tit. C. 10.32, § 133.20. Infra, Summa in tit. C. 10.38, § 1.
III.1.1. Menzinger, Trasformazione del quadro fiscale cittadino CXXXI
affidare un programma politico, la vocazione dell’aristocratico miles cit-tadino con una nuova fede pubblica nella sua missione, l’amministrazione della città. Termini questi (milites, militia) cui nella Summa gira attorno un altro grosso nucleo di interessi, considerati l’ammirazione che il giudice nutre per l’autore tardo-antico Vegezio e per la sua opera di strategia milita-re, e lo spazio che in generale dedica alla tecnica della guerra e all’arte del combattimento.21 Il diritto romano non rappresenta più ai suoi occhi solo un monumento giuridico, ma diviene un vero e proprio modello di Stato in armi. Dalla sovrapposizione di queste immagini emerge un accostamen-to tutto speciale di arma e leges, che rispecchia bene quello che in uno dei suoi lavori più preziosi e dimenticati Hermann Fitting individuò, alla fine dell’Ottocento, come un topos tra i primi glossatori, vale a dire l’identifica-zione di militia e scientia iuris.22 Pur se scientificamente isolato e distante dalle sedi scolastiche e universitarie dove tali discorsi stavano comincian-do a circolare negli ultimi decenni del XII secolo, Rolando sembra subire il fascino delle particolari implicazioni sociali derivanti da tale accostamento che, come lo stesso Fitting metteva in evidenza, non erano romane ma tutte medievali;23 furono infatti i primi giuristi dotti comunali a valorizzare quei passi del Corpus iuris civilis in cui le leggi venivano avvicinate alle armi e gli avvocati ai soldati,24 per fondare ideologicamente l’equazione tra pro-fessionisti del diritto e militia urbana.25 Un’equazione che il nostro giudice rende operativa fin dal proemio della sua opera dove, chiedendo all’impe-ratore Enrico VI una ricompensa economica per la devozione espressa alla causa imperiale, che gli consenta di essere sollevato dalle incombenze della propria professione, si paragona esplicitamente a un miles veteranus, acco-stando l’ambita quiete del giudice a riposo al congedo (e forse anche alla buonuscita!) del veterano.26
21. Cfr., in particolare, infra, Summa in titt. C. 12.33-39. Per le citazioni dell’Epitoma rei militaris di Vegezio, supra, C o n t e, I.3.5., La letteratura classica.
22. F i t t i n g, Das castrense, pp. 538-547. F i t t i n g, Das castrense, pp. 538-547.23. Ibid., p. 566. Ibid., p. 566.24. Per Rolando, cfr. per esempio infra, Summa in titt. C. 10.55, §§ 37-40, C. 12.33, § 1,
C. 12.36, § 38, 25. Cfr. in particolare il bel proemio di Azzone alla Summa Institutionum citato da F i t -
t i n g (Das castrense, p. 539): Imperator … assignat duo tempora, unum bellorum et alterum pacis. In tempore bellorum necessaria sunt ad summam reipublicae tuitionem ista quatuor: arma, usus armorum, victoria, triumphus. In tempore vero pacis necessaria sunt quatuor simi-lia: leges scilicet, usus legum, calumniae pulsio, iuris religio … Ista ergo duo, arma et leges, pariter debent esse in principe … et tanta gaudent similitudine … ut nomen armorum et nomina eorum, qui exercentur in armis, accomodentur legibus et legistis. Leges ergo dicuntur arma … et milites dicuntur advocati.
26. Infra, Summa, Prooemium, §§ 36-39.
CXXXII Diritto pubblico tra Impero e città
Diversamente dall’uso linguistico tardo-antico, il termine militia si riferi-sce, nel mondo comunale, esclusivamente all’esercito a cavallo, ed è proprio l’identificazione con la cavalleria che consente agli aristocratici milites di oc-cupare una posizione preminente nella società urbana. Non sembra un caso che, in un breve passo dell’opera di Piacentino che Rolando cita nella sua, il primo, parlando dei tributi dovuti per i milites, introduca l’interessante speci-ficazione “e per i cavalli”,27 mostrandoci come i milites a cui pensano questi giuristi medievali non siano solo gli antichi componenti degli eserciti romani, ma anche gli esponenti della contemporanea cavalleria cittadina. Un punto questo sul quale Rolando sente peraltro il bisogno di soffermarsi, avvertendo il lettore contemporaneo che milites, sia nelle fonti giustinianee, sia, in parti-colare, in Vegezio, non significava (diversamente dal suo tempo) solo equites, ma includeva anche i pedites, coloro cioè che occupavano una posizione più umile o inferiore.28 Specificazione importante nel contesto sociale urbano di fine XII secolo, dove pedites, per contrapposizione alle implicazioni sociali del termine milites, inizia ad essere usato per designare non solo un ruolo mili-tare, quello dei soldati a piedi, ma l’appartenenza a una classe sociale inferiore alla militia, che comincerà presto a riconoscersi, da un punto di vista politico, nel movimento popolare.29
Questi slittamenti di significato che i termini antichi subiscono nel conte-sto comunale sono fondamentali per comprendere per esempio le ragioni per cui Rolando valorizzi, proprio in campo fiscale, tutti quei passi del diritto ro-mano che identificavano nelle esigenze militari un’importante causa imposi-tionis, per fini molto diversi, però, da quelli con cui tali norme erano state un tempo concepite. La legittimità del prelievo a fini militari gli sta a tal punto a cuore, da spingerlo a citare – o meglio a distorcere! – per ben quattro volte un passo di Cicerone tratto dal De officiis, il cui significato, nel contesto della Summa, risulta letteralmente capovolto: mentre Cicerone aveva infatti con-dannato il ricorso al tributum, pur riconoscendo l’utilizzo che Roma in passato ne aveva fatto per fronteggiare la scarsità di fondi pubblici e le spese militari,30
27. Infra, Summa in tit. C. 10.16, § 2.28. Infra, Summa in tit. C. 12.36, §§ 30 e 26, e cfr., ibid., §§ 27-29. La definizione dei
pedites è ricalcata sui caligati romani, in merito ai quali nelle Novellae giustinianee si dice: milites armatos, quos lex caligatos appellat, hoc est viliores et obscuriores, non perscrutamur etc. (Nov. 74.4.3).
29. Per le trasformazioni che subiscono i termini milites e pedites nei secoli X-XII, cfr. B o r d o n e, Uno stato, pp. 89-132.
30. Cicero, De officiis, 2.21.74: Danda etiam opera est, ne, quod apud maiores nostros saepe fiebat propter aerarii tenuitatem assiduitatemque bellorum, tributum sit conferendum, idque ne eveniat multo ante erit providendum. Sin quae necessitas huius muneris alicui rei publicae obvenerit (malo enim quam nostrae ominari neque tamen de nostra, sed de omni re
III.1.1. Menzinger, Trasformazione del quadro fiscale cittadino CXXXIII
nella citazione di Rolando la frequenza delle guerre e gli esili introiti dell’era-rio divengono la ragione per cui i contribuenti devono pagare le tasse.31
Nel commento al titolo del Codice De annona et tributis (C. 10.16), tra le cause per cui si versano tributi al fisco, il giudice identifica come principale e degnissima, per la salute dell’Impero, proprio la causa militare, dal momento che, afferma, sono i milites a sopportare per la società le maggiori avversità e che ne traggono dunque i benefici (… milites qui pro nobis dura sustinent inde merita capiunt).32 Siamo così introdotti a un argomento classico della propa-ganda aristocratica di inizio Duecento quando, facendo leva proprio sull’idea di un oneroso servizio prestato per la collettività, i milites cercarono da una parte di rivendicare il costante diritto a una serie di risarcimenti per le spese militari, dall’altra di ottenere cospicui privilegi fiscali.33 Se questo fu un feno-meno diffuso in molte città, l’adesione al partito svevo di Rolando e di Lucca potrebbe aver favorito in lui l’idea di una posizione privilegiata dei milites di fronte alle imposte, considerato per esempio che, tra il 1186 e il 1187, nelle non troppo distanti Firenze e Siena, Federico Barbarossa aveva concesso ai cavalieri cittadini l’esenzione dalla fiscalità urbana e persino imperiale.34
Stando all’approfondita analisi della militia comunale compiuta recen-temente da Jean-Claude Maire Vigueur, i vantaggi economici di cui godeva-no i milites cittadini, tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII, erano so-stanzialmente di tre tipi: il diritto a incamerare parte dell’entrate collettive, come contropartita del servizio reso, o a riscuotere doni in natura dalla città; il diritto a sottrarsi ad alcuni tipi di imposte cui doveva normalmente essere sottoposta tutta la cittadinanza;; infine il diritto a un risarcimento per le spe-se di mantenimento del cavallo e dell’equipaggiamento militare, oltre che per i danni subiti.35 In conseguenza dei sistemi di esazione sempre più sofi-sticati che si andarono affermando proprio a cavallo dei due secoli – come
publica disputo), danda erit opera, ut omnes intellegant, si salvi esse velint, necessitati esse parendum.
31. Cfr. infra, Summa in titt. C. 10.16, § 23, C. 10.25, § 3, C. 11.58, § 3, C. 11.75, § 6, dove Rolando riporta come segue il passo citato per esteso nella nota precedente, stravolgendone di fatto il significato: Propter erarii tenuitatem et assiduitatem bellorum tributum est conferen-dum, … ut omnes intelligant, si salvi esse volunt, necessitati parendum. Sul testo di Cicerone, cfr. C o r t e s e, Intorno alla causa, p. 355, S c o r d i a, “Le Roi doit vivre du sein”, p. 68; per altre citazioni del De officiis nella Summa, supra, C o n t e, I.3., La biblioteca di Rolando.
32. Infra, Summa in tit. C. 10.16, § 1. L’idea ritorna anche in Summa in tit. C. 12.40 § 7.33. Cfr. C a m m a r o s a n o, Le origini, pp. 39-42; M a i r e V i g u e u r, Cavalieri,
p. 207 e sgg.34. Per questi ed altri privilegi fiscali concessi ai milites, cfr. B a r b a d o r o, Le finanze,
pp. 28-29, e G a s p a r r i, I milites, pp. 98-99. Secondo G a s p a r r i, tali esenzioni furono concesse dall’Imperatore per stabilire legami privilegiati con alcuni gruppi di milites urbani ed esercitarono una certa influenza sulla coscienza aristocratica cittadina.
35. M a i r e V i g u e u r, Cavalieri, pp. 175-267.
CXXXIV Diritto pubblico tra Impero e città
riflesso del nuovo peso istituzionale che cominciò ad esercitare la popola-zione urbana non aristocratica –, tali privilegi divennero oggetto di violenti attacchi che, nel corso della prima metà del Duecento, determinarono, al-meno in materia fiscale, la riduzione, se non la scomparsa, del trattamento privilegiato di cui avevano goduto finora i milites. Se la loro esenzione dal pagamento di imposte minori, quali il focatico e la boateria, è testimoniato a lungo dagli statuti duecenteschi, la possibilità di sottrarsi alla nuova tassa diretta e proporzionale della ‘colletta’, introdotta, nei casi più precoci, a par-tire dagli ultimi decenni del XII secolo, fu aspramente combattuta dal resto della cittadinanza e, salvo eccezioni, resa nulla a partire dal terzo decennio del XIII secolo.36 Le ragioni sono evidenti: mentre tassazioni di carattere personale, come il focatico, non subivano grandi variazioni in conseguenza della ricchezza dei singoli e non costituivano né un’entrata fondamentale per il Comune né una grande uscita per i cittadini più abbienti, la nuova im-posta proporzionale ai beni mobili e immobili dei contribuenti diveniva un efficace strumento per aumentare il gettito fiscale, ottenendo dai più ricchi il contributo maggiormente significativo.37 Proprio per la sua natura onero-sa, la ‘colletta’ non fu un’imposta stabile ma mantenne a lungo un carattere straordinario e, diversamente dal fodro imperiale e dal focatico, fu concepi-ta, almeno inizialmente, per i residenti in città prima ancora che per gli abi-tanti del contado, ai quali comunque venne presto estesa.38 Secondo Maire Vigueur, occorre dunque prestare un’attenzione del tutto particolare a questo genere di contribuzione per comprendere le tensioni sociali che nelle città si verificarono in conseguenza delle novità fiscali.
Ai fini dei nostri interessi, l’importanza di tale questione è data soprat-tutto dalla coincidenza cronologica tra questi fenomeni storici e la redazione dell’opera da parte di Rolando il quale, dopo avere completato una prima versione della Summa antecedente al 1197, ne stilò una seconda nel corso dei primi tre decenni del Duecento.39 Dal paragone tra i manoscritti conte-nenti il testo più antico e più corto e quelli invece recanti la trattazione suc-
36. A Genova venne posto in essere, intorno al 1163, uno degli esperimenti più precoci: C a m m a r o s a n o, Le origini, pp. 49-50, M a i n o n i, Sperimentazioni, pp. 719-720, e cfr. p. 726 in nota per altre testimonianze risalenti; per un inquadramento di queste iniziative nel più vasto discorso delle finanze urbane, cfr. la sintesi di M e n a n t, L’Italia, pp. 29-38. Per le varianti linguistiche di collecta e la loro diffusione geografica, F i u m i, L’imposta, pp. 329-334.
37. Cfr. in proposito V i o l a n t e, Imposte, p. 8, F i u m i, L’imposta, pp. 332-334, e, più recentemente, M a i n o n i, La “révolution fiscale”, p. 240.
38. M a i r e V i g u e u r, Cavalieri, p. 262 e sgg., B o c c h i, Le imposte, pp. 281-283.
39. Cfr. supra, C o n t e, I.1.1., Rolando da Lucca.
III.1.1. Menzinger, Trasformazione del quadro fiscale cittadino CXXXV
cessiva e più estesa siamo in grado di datare in modo piuttosto preciso i pez-zi aggiunti da Rolando che, in sostanza, devono necessariamente risalire agli anni che corsero tra il 1197 e il 1234. Ed è proprio in una di tali aggiunte che troviamo un’eco interessante dei problemi che agitano in questo momento le città italiane sul piano fiscale, quando il giudice, descrivendo tutti i tipi di imposte che gravano sui patrimoni, e non sulle persone, comincia dall’im-posizione della collecta – termine non utilizzato in questo senso all’interno del Corpus iuris e che, come abbiamo accennato, rimanda invece a una tassa ben nota nel contesto fiscale del mondo comunale. La prima ragione che giu-stifica il ricorso a questo tipo di prelievo è, secondo Rolando, il reperimento di fondi per inviare i milites cittadini all’esercito; seguono, tra le motivazio-ni, il finanziamento di opere pubbliche, vale a dire costruzione e manuten-zione di ponti, strade, porti, acquedotti e mura della città.40 Soffermandoci per ora sulla prima motivazione, vediamo ancora una volta lo stretto nesso che nella sua mente lega la finanza pubblica all’apparato militare cittadino, un nesso che, come si è accennato, possiede implicazioni politiche forti al momento in cui scrive.
Detto questo, sarebbe tuttavia errato ridurre Rolando a un semplice ideo-logo della militia urbana e la sua articolata riflessione giuridico-fiscale a mera propaganda. Ciò che più lo distanzia da una prospettiva del genere è la posi-zione che assume in merito ai privilegi fiscali, dei quali il giudice si rivela es-sere, nella sua opera, un accanitissimo avversario. Se è vero che la sua avver-sione si esercita soprattutto nei confronti delle esenzioni di cui godono le per-sone e gli enti ecclesiastici,41 mostra però una coscienza civica che trascende la rivendicazione di privilegi di status, affermando che i milites non possono sottrarsi al pagamento dei tributi patrimoniali. L’unico vantaggio che ricono-sce apertamente alla militia, in materia fiscale, è l’esenzione dall’imposta per-sonale del testatico (o capitatio):42 tuttavia, a parte che, come si è detto, una tassa del genere non rappresentava un’uscita onerosa per persone abbienti, si tratta, come afferma lo stesso Rolando, di un prelievo generalmente riserva-to al contado, dal quale era esente tutta la popolazione urbana.43 Per quanto riguarda invece le imposte patrimoniali, si rifiuta categoricamente di ricono-scere esenzioni significative: ad esse, dice, sono tenuti tutti, si tratti di persone
40. Infra, Summa in tit. C. 10.42, §§ 48-49.41. Cfr. infra, III.2.3, La tassazione.42. Infra, Summa in titt. C. 10.41, § 47, C. 10.42, § 52.43. La questione è analizzata a fondo in Summa in tit. C. 11.49, dove Rolando da una parte
spiega come questo privilegio, riservato nel Codice ai cives romani, doveva essere esteso alla popolazione di tutte le città;; dall’altra illustra la diversa posizione fiscale di cives e forenses. Altri riferimenti infra, Summa in titt. C. 10.24, § 4, C. 10.42, § 52, C. 10.49, § 28, C. 11.1, § 2, C. 11.31B, § 7, C. 11.44, § 11, C. 11.70, § 6.
CXXXVI Diritto pubblico tra Impero e città
nate o semplicemente residenti in città, di individui qualsivoglia privilegiati, di adulti, fanciulli, donne, bambini o milites.44 Le devono pagare i senatores come i veterani, il miles come l’episcopus.45
È vero che, nel commento al titolo De muneribus patrimoniorum (C. 10.42), il luogo della Summa in cui Rolando affronta principalmente tale tema, il discorso, dopo queste enunciazioni nette, si va un po’ stemperando pro-prio in relazione ai milites. Elencando infatti le (poche) eccezioni al divieto di esenzione dai munera patrimoniorum, menziona il privilegio dei milites di sottrarsi ai tributi straordinari, quelli cioè che non sono indetti regolarmente.46 Considerato che la maggior parte delle imposte patrimoniali, almeno fino al 1250, mantenne un carattere straordinario, l’eccezione sembrerebbe vastis-sima e in contraddizione con quanto detto in precedenza. Va però ricordata l’abitudine comune ai glossatori di quest’epoca di ragionare in termini aperti, adducendo contemporaneamente leggi e tesi favorevoli e contrarie alla solu-zione di un certo problema, al fine di restituire un dibattito, più che una tesi univoca.47 Nell’opera di Rolando, inoltre, l’idea di una deroga indefinita al pagamento dei tributi patrimoniali risulta assai ridimensionata sia dalla speci-ficazione secondo cui il privilegio, per i milites, non viene considerato valido quando i tributi straordinari siano richiesti ad pietatem oppure ad publicam utilitatem48 – due categorie in cui, come vedremo, il giudice tende in realtà a far rientrare la motivazione di moltissime imposte –, sia dal drastico restringi-mento dei casi in cui un’imposta può essere definita straordinaria.49 Nel com-plesso, l’impressione è che Rolando riconosca ai milites privilegi piuttosto circoscritti, inferiori, ad esempio, a quelli che attribuisce ai doctores legum.50 Resta però interessante il fatto che, nella prima versione della sua opera (ante 1197), non si soffermi affatto su questi problemi, e sia invece spinto nei decen-ni a seguire a rimaneggiare massicciamente il suo commento relativo ai tributi
44. Infra, Summa in tit. C. 10.42, §§ 48-50.45. Ibid., § 45, e cfr. § 56, Ibid., § 45, e cfr. § 56, nec veteranus, nec miles, nec pontifex, nec minor etc.46. Ibid., §§ 64-65. Ibid., §§ 64-65.47. Torno più approfonditamente su tale questione infra, III.2.3., La tassazione.48. Infra, Summa in tit. C. 10.42, § 78.49. Cfr. infra, III.1.2., Imposte e bene pubblico, e III.2.3., La tassazione. Anche l’idea per
cui i veterani non sono esenti dai tributi patrimoniali spinge nella stessa direzione: cfr. infra, Summa in tit. C. 12.46, §§ 17-21.
50. Cfr. infra, Summa in tit. C. 10.53, § 33, dove sottolinea l’immunità dei professori di legge da tutti i munera publica, un’immunità in questo caso davvero significativa, considerato che con questa definizione intende: Omnia ergo predicta munera … una significatione compre-henduntur, nam ordinaria et extraordinaria, sordida et honesta, personalia, realia et mixta, ci-vilia seu publica appellantur (Summa in tit. C. 10.42, § 87). Non sembra estendere, invece, gli stessi privilegi ai professori d’arti e ai medici, cui il giudice riconosce esclusivamente l’esenzio-ne dai doveri di ospitalità, non dagli altri munera patrimoniali (ibid., §§ 68-70).
III.1.1. Menzinger, Trasformazione del quadro fiscale cittadino CXXXVII
patrimoniali e alle esenzioni da essi. Ed è difficile resistere alla tentazione di vedere in queste integrazioni l’influenza di problemi che vede insorgere nella amministrazione comunale del suo tempo.
Più che fonte di privilegi, l’identità aristocratica sembra invece in Ro-lando essere ispirazione di un alto compito politico. All’aristocrazia egli as-segna infatti il ruolo di guida della civitas, valorizzando nella sua opera quei passi del Corpus iuris che invitavano i nobili a vivere nell’ambiente urbano e a svolgere incarichi pubblici nelle città. In particolare, la frase tratta dalle No-vellae secondo cui convenit enim unumquemque nobilium semper functionem agere civitatum quas inhabitant, è citata spesso e per esteso da Rolando a que-sto scopo.51 Un invito che sembra rivolgere in modo particolare ai giudici – sfruttando l’accostamento suggerito dalla stessa Novella tra giudici e universi nobiliores civitatum habitatores52 e sottolineando il coinvolgimento dei giudi-ci in incarichi amministrativi, e segnatamente fiscali, nel mondo romano53 – e che accoglie senz’altro in prima persona se, stando alle sue parole, fu attivo in veste di consigliere dei consoli di Lucca.
Sicuramente ricoprì almeno due uffici pubblici di rilievo, la carica, nel 1179, di communis debiti Lucani iustitiator, con cui gli venne affidata, in-sieme ad altri due ufficiali, la gestione del debito del comune,54 e quella, nel 1182, di consul foretanorum, che lo vide protagonista nel rilevante settore del-la giurisdizione cittadina sul contado. La funzione di advocatus per l’impor-tante ente ospedaliero di Altopascio, che ricoprì ripetutamente nel 1184 e nel 1187, e incarichi episodici che lo videro arbiter in controversie in cui furono coinvolti altri enti ecclesiastici locali, completano il quadro delle vastissime competenze fiscali che egli dovette acquisire in questi anni, anche in materia
51. Nov. 15.6, citata in Summa in titt. C. 10.39, § 57, C. 10.71, § 42, C. 11.15, § 1, C. 11.37, § 2.
52. Nov. 15 praef. – 1: Fit enim sic congruentia utilis, si iudicum sumant officium civi-tatum defensores, et provinciae praeses videbitur quidam iudex esse potius iudicum et ex hoc honestior praecedentium apparere … Interim illud prius sanciendum est, ut nulli omnium sit li-centia defensoris ordinationem declinare, sed invicem universi nobiliores civitatum habitatores hoc ministerium eis adimpleant etc.
53. Infra, Summa in titt. C. 10.1, §§ 16 e 321, C. 10.16 § 41, C. 10.17, § 15, C. 10.41, § 11; cfr. anche Summa in titt. C. 10.19, §§ 26-31, C. 10.48, §§ 7-10. Pure il ruolo dei notai, in campo fiscale, viene spesso ricordato: Summa in titt. C. 10.19, § 31, C. 10.25, § 2, C. 10.42, § 26, C. 10.71, § 41.
54. S a v i g n i, Episcopato, p. 92 in nota; per il contemporaneo processo di formazio-ne del debito pubblico a Pisa, con riferimenti a molte altre città, cfr. V i o l a n t e, Le origi-ni;; per una riflessone sul concetto di debito pubblico nel mondo comunale e la politica fiscale adottata dalle città toscane nel Due e Trecento: G i n a t e m p o, Prima del debito, e E a d., Il finanziamento.
CXXXVIII Diritto pubblico tra Impero e città
di decime e sistemi di tassazione delle terre ecclesiastiche.55 È certo, comunque, che tutte queste esperienze stimolarono in lui una riflessione profonda sulla clas-sificazione delle imposte, sui motivi per i quali potevano essere richieste e sulle persone e le terre cui dovevano venire applicate. Tanto più se, abbandonando il discorso degli incarichi personali e uscendo dalle mura lucchesi, prendiamo in considerazione il contesto storico in cui si situa la vita di Rolando. Se, come ipotizziamo, egli nacque attorno al 1150 e morì all’incirca nel 1234, fu proprio nell’arco della sua lunga esistenza che gran parte del mondo comunale si con-frontò per la prima volta con problemi fondamentali in campo fiscale, quali il parziale abbandono dell’esazione su base personale in favore di un sistema di prelievo su base reale, la conseguente redazione dei primi elenchi catastali per stabilire le imposte su beni mobili e immobili, l’introduzione del criterio pro-porzionale, il passaggio dall’eccezionalità alla stabilità delle imposte, le nuove pretese di riscossione di tributi da terre del contado e beni ecclesiastici.56
È dunque sulla scia dei numerosi problemi con cui direttamente o indi-rettamente entrò in contatto nella sua città che Rolando si apprestò a delineare un quadro completo del sistema fiscale comunale, partendo dal ragionamento sulle fonti giustinianee e sull’amministrazione tardo-antica.
1.2. Imposte e bene pubblico: giustificazione teorica del prelievo
Prima di addentrarci in un’analisi dettagliata del pensiero di Rolando in campo tributario, è importante mettere a fuoco le alte motivazioni ideologiche dalle quali il giudice fa discendere i doveri fiscali dei cittadini. Tali motiva-zioni possono essere sintetizzate in un messaggio semplice e incisivo: il bene pubblico viene prima di quello privato e, dal momento che le città incarna-no l’amministrazione pubblica, hanno il diritto di imporre obblighi ai singo-li nell’interesse della collettività. Per comprendere la portata profondamente innovativa di queste idee occorre tenere ben presente il contesto politico e geografico nel quale si formano, quello cioè dei governi consolari di fine XII secolo, in cui si profila tutt’altro che conclusa l’aspra battaglia che da alcuni decenni stanno conducendo le città per affermarsi come soggetti giurisdizio-nali, alle spese di infiniti particolarismi laici ed ecclesiastici.57 Ed è in queste
55. Per tutti i dati biografici, supra, B a g n a i L o s a c c o / T h e i s e n, I.2., Profilo biografico;; sul contenuto delle controversie di norma sottoposte ai consules foretanorum, T i -r e l l i, Lucca, pp. 193-194, W i c k h a m, Legge, p. 85. Sull’elaborata organizzazione del patrimonio fondiario del capitolo di Lucca alla fine del XII secolo, J o n e s, Economia, pp. 275-294.
56. Cfr. infra, III.2.1.-3.57. Cfr., tra gli altri, M i l a n i, Lo sviluppo, V a l l e r a n i, Tra astrazione, M e n -
z i n g e r, Forme di organizzazione giudiziaria.
III.1.2. Menzinger, Trasformazione del quadro fiscale cittadino CXXXIX
tensioni che il diritto pubblico romano conosce una funzione straordinaria-mente attuale non solo per legittimare le nuove pretese politiche, ma per co-struire concretamente l’impalcatura istituzionale che di quelle pretese renda possibile l’attuazione.
Il ragionamento sviluppato a più riprese da Rolando nella Summa mostra in realtà la complessità di quel messaggio ideologico, che nella sua opera ap-pare spezzettato in tre grandi segmenti problematici: motivare la superiorità del bene collettivo su quello individuale; dimostrare che le città incarnano il bene comune e godono quindi a pieno diritto di uno status pubblico; sancire la natura pubblica di bisogni collettivi che coinvolgano l’intera cittadinanza in nuove forme di contributo fiscale. L’importanza che tali argomenti rivesto-no nella Summa è deducibile non solo dagli estesi passi che espressamente vi sono dedicati, ma da continui richiami disseminati lungo tutta l’opera, quasi a voler mantenere vigile l’attenzione del lettore su alcuni temi di fondo. Frasi significative del Corpus iuris vengono così estrapolate dal loro contesto origi-nale e trattate alla stregua di massime generali: “ciò che giova alla collettività vogliamo che preceda il nostro privato interesse”;58 “l’utilità pubblica va ante-posta a qualsiasi vantaggio privato” o “l’interesse pubblico è superiore a quel-lo privato”;59 “per nessuna ragione è lecito astenersi da ciò che giova a tutti”.60 La frequenza con cui ricorrono queste enunciazioni e, allo stesso tempo, la quantità di citazioni dotte da cui sono talvolta sorrette,61 attestano però da un lato la convinzione di Rolando che esse vadano in qualche modo ‘dimostrate’, dall’altro forse il desiderio di fornire al lettore una sorta di antologia di riferi-mento, dalla quale potere attingere argomenti per sostenere rivendicazioni in realtà molto concrete.
La coscienza della distanza che corre tra l’interesse per la cosa pubblica e gli affari privati è d’altronde ben visibile già nel proemio della Summa, dove il giudice, nella menzionata invocazione che rivolge a Enrico VI, sfrutta reto-ricamente il termine regius per definire la propria identità intellettuale: regio è detto il quartiere di Lucca nel quale abita e regale è la materia cui intende dedicare la sua opera;; con ciò si augura di prendere le definitive distanze dal chiassoso mondo delle controversie private, per concentrarsi esclusivamente
58. Quod communiter omnibus prodest, hoc rei private nostre utilitati volumus preferri (C. 6.51.1.14a), citata alla lettera da Rolando in Summa in tit. C.10.7, § 8, C. 11.62, § 10.
59. Omni privato commodo utilitas publica preferatur e publica utilitas preferenda est pri-vate, libere trasposizioni di Rolando (rispettivamente: Summa in titt. C. 12.4, § 10 e C. 11.65, § 7) della frase Utilitas publica praeferenda est privatorum contractibus, tratta da C. 12.62.3.
60. Nulla enim debent ratione ab hoc, quod in commune omnibus profuturum est, seiungi (C. 11.65.1), citata alla lettera da Rolando in Summa in tit. C. 11.65, § 6.
61. Cfr., per esempio, infra, Summa in tit. C. 11.65, § 7, dove la frase publica utilitas pre-ferenda est private è sorretta da ben venti allegazioni.
CXL Diritto pubblico tra Impero e città
sulle cose regali, inferiori, nella sua mente, solo a quelle divine.62 Che l’inte-resse per la materia regale non sia determinato tanto dal desiderio di esalta-zione della concreta figura dell’Imperatore, quanto piuttosto dal fascino che su Rolando esercita l’idea di un’astratta sovranità pubblica legalizzata,63 si evince bene dalla contrapposizione di questa ai conflitti privati e, allo stesso tempo, dall’accostamento alla sfera divina. Un accostamento qui tutt’altro che retorico, perché proprio il modello di ecclesia, come istituzione che massima-mente tende al bene collettivo, riveste una funzione fondamentale nella Sum-ma per giungere a cogliere il significato del concetto di pubblico.
È importante sottolineare l’assoluta originalità di tale operazione: com-ponendo la prima versione della sua Summa alla fine del 1100, Rolando ap-partiene a una generazione degli studi giuridici in cui il diritto civile e quello canonico costituiscono due branche scientifiche ben distinte, in scarsa comu-nicazione tra loro. A una sessantina d’anni dalla morte di Irnerio, i seguaci civilisti del grande maestro bolognese concentrano ancora i propri interessi quasi esclusivamente sul Corpus iuris civilis di Giustiniano, mentre il mondo canonistico ha appena cominciato ad aprirsi al diritto romano, avviando un cambiamento che si consumerà del tutto solo nella prima metà del Duecen-to. Senza voler radicalizzare troppo questa separazione, è tuttavia vero che la naturalezza con cui Rolando accosta citazioni e argomenti tratti dalle Sacre Scritture, dal Decretum di Graziano o dalle Decretali pontificie successive,64 a passi del diritto romano e della letteratura classica, fa di lui un civilista piut-tosto atipico, e colloca anzi la sua scrittura, per fantasia di riferimenti, più vicino alla creatività canonistica che alle rigide esposizioni romanistiche co-eve.65 Un’apertura che Rolando mostra fin dal proemio dell’opera, dove cita quei versetti di Matteo (“rendete a Cesare quel che è di Cesare …”) che nelle dispute teologiche costituivano spesso il punto d’avvio delle discussioni sulla fiscalità e sull’imposte.66 La ratio fiscalium, afferma il giudice, è utile e neces-saria a tutti, tanto ai milites quanto ai privati, ai templi e alla res publica.67 Una
62. Infra, Summa, Prooemium, §§ 36-39.63. Su cui cfr. supra, C o n t e, II.2.5., Ego quidem, e I d., II.3.2., Prerogative del principe.64. Per un bilancio delle citazioni del Decretum e delle Decretali da parte di Rolando, cfr.
supra, C o n t e, I.3.3., Il Decretum.65. Su alcuni elementi caratterizzanti la scrittura canonica nel XII secolo: P a d o a
S c h i o p p a, Il modello. 66. Cfr. S c o r d i a, “Le Roi doit vivre du sein”, pp. 58-60. Secondo Giovanni Tabacco, Cfr. S c o r d i a, “Le Roi doit vivre du sein”, pp. 58-60. Secondo Giovanni Tabacco, Secondo Giovanni Tabacco,
questo passo di Matteo rappresenta l’unico riferimento neotestamentario a una “dualità di poteri preposti alla vita degli uomini”: T a b a c c o, La relazione, a cura di G a f f u r i, pp. 5, 8.
67. Cfr. infra, Summa, Prooemium, §§ 17-19: … precipiente nobis Domino ut Cesari sua reddamus (Mt, 22.21) cum fiscalium ratio cunctis sit utilis et necessaria tam militibus quam privatis atque templis et cuncte rei publice.
III.1.2. Menzinger, Trasformazione del quadro fiscale cittadino CXLI
delle tante manifestazioni di quella condivisione di autorità ed argomenti che, fin dall’inizio del XII secolo, caratterizza, secondo Alain Boureau, la nuova scienza teologica e giuridica.68
Come l’Impero, anche la Chiesa di Rolando è distante dall’espressione concreta del potere spirituale nel suo tempo, configurandosi più come astrat-ta fonte di valori e modello di organizzazione amministrativa, che come soggetto ricoprente un preciso ruolo storico sulla scena politica del 1100. Conclusasi da tempo la Lotta delle Investiture, e lungi ancora dal clima di rinata conflittualità che segnerà i rapporti tra Chiesa e Impero nel Duecen-to, il giudice non sembra avvertire alcuna contraddizione nell’accomunare idealmente questi due grandi poteri, la cui interazione appare a tratti quasi anacronistica nella sua opera. Nonostante infatti l’uso di espressioni quali duo magna luminaria attesti – nella seconda versione della Summa – la co-noscenza dell’innovativa definizione di Innocenzo III dell’autorità pontifi-cia e secolare,69 e dunque della nuova disposizione gerarchica, anziché pa-ritetica, del potere spirituale e terreno, il quadro di riferimento ideologico di Rolando appare ancora dominato dal cosiddetto ‘dualismo gelasiano’ e dall’idea tardo-antica di separate sfere giurisdizionali aventi ciascuna a capo il proprio amministratore.70 Se la citata immagine delle due spade, spirituale e terrena, che incedono di pari passo alla fine del commento sui decurioni,71 esemplifica bene queste convinzioni, la metafora usata da Rolando in un al-tro punto della sua opera è assai più incisiva e allo stesso tempo evocatrice
68. B o u r e a u, Droit et théologie. B o u r e a u, Droit et théologie.69. Cfr. infra, Summa in tit. C. 10.64, § 23. L’espressione venne usata dal Papa nella de- Cfr. infra, Summa in tit. C. 10.64, § 23. L’espressione venne usata dal Papa nella de-C. 10.64, § 23. L’espressione venne usata dal Papa nella de-
cretale Solitae destinata all’imperatore di Costantinopoli, che entrò a far parte della Compila-tio III (1210) e successivamente del Liber Extra (1234): Q u a g l i o n i, Luminaria; secondo H a g e n e d e r (Das Sonne-Mond-Gleichnis), il paragone è però tracciato per la prima vol-ta dal pontefice nel 1198, in una lettera indirizzata a un console fiorentino (priore della Lega toscana); la trascrizione di tale documento nel registro innocenziano ebbe una storia piuttosto travagliata (H a g e n e d e r, ibid.).
70. Cfr. C o r t e s e, Il diritto, I, pp. 32-47. Sulla genealogia del principio dualistico, cfr. T a b a c c o, La relazione, a cura di G a f f u r i, pp. 5-56, il quale riassume così (p. 51) l’in-certa interazione tra sfera spirituale e terrena in epoca tardo-antica: “la distinzione fra temporale e spirituale possiede nel mondo romano-cristiano … un significato tutt’altro che preciso. Essa implica un duplice diritto, umano e divino, l’uno subordinato all’altro; una duplice giurisdizio-ne, materiale e spirituale, l’una parallela all’altra; un duplice ordinamento esterno, pubblico ed ecclesiastico, l’uno giustapposto all’altro. Queste varie distinzioni non sono precise e, quel che è più grave, non coincidono fra loro, ma si sovrappongono e formano un’idea composita, che appare ora sotto un aspetto, ora sotto un altro”. A dissipare parzialmente tali incertezze inter-venne la formula gelasiana, alla quale, secondo T a b a c c o (p. 56), “tornerà in ogni secolo chiunque, memor fragilitatis humanae, vorrà opporsi alla preponderanza dell’uno o dell’altro potere”.
71. Infra, Summa in tit. C. 10.32, § 133, su cui cfr. supra, III.1.1., Fiscalità e militia.
CXLII Diritto pubblico tra Impero e città
di un rapporto meno irenico tra i due poteri: il riferimento in questo caso è tratto dall’Antico Testamento dove, nel secondo libro di Samuele, si narra la storia della repentina morte di Uzzà, fulminato da Dio per aver indebita-mente allungato una mano al fine di sorreggere l’Arca mentre questa veniva trasportata su un carro e sembrava vacillare a causa dell’andatura dei buoi.72 La vicenda, nella Summa, diviene esemplificativa dell’idea per cui nessuno ha il diritto di intromettersi in affari che non gli competono, in uffici che non gli spettano, proprio come sacerdozio e Impero non devono ostacolarsi a vi-cenda: il primo amministra la sfera divina, il secondo presiede quella uma-na.73 Una spartizione di competenze chiaramente trasmessa al giudice dai te-sti che commenta, e soprattutto dalla Novella Quomodo oporteat episcopos che evocava le idee gelasiane74 e il cui significato si tentò di ribaltare, nei primi decenni del 1200, proprio accostandola alla nuova teoria innocenziana dei “due grandi astri”.75
Ma anche il Decretum di Graziano, di cui Rolando si rivela essere un intenso frequentatore, deve avere contribuito al suo inquadramento dei rap-porti tra Chiesa e Impero: come sappiamo, le nuove tesi ierocratiche, ampia-mente circolanti nel pensiero ecclesiastico post-gregoriano, non penetrarono nell’opera grazianea che, nel XII secolo, si configura più come un monumento al passato che come un avamposto delle innovative teorie canonistiche.76 Data la vicinanza geografica, è legittimo chiedersi se il nostro giudice non subisca l’influenza anche del grande canonista coevo Uguccione da Pisa († 1210), il quale, facendo leva proprio sul Decretum, fu un convinto sostenitore della vi-sione gelasiana – visione che, come ha rilevato Walter Ullmann, “did not ma-terially differ from the civilian standpoint.”77 La citazione della rivoluzionaria
72. 2 Sam, 6, 4-8, riassunto da Rolando in Summa in tit. C. 12.58, § 5.73. Ibid., §§ 4-6.74. Nov. 6 praef. le cui parole Maxima quidem in hominibus sunt dona dei a superna col-
lata clementia sacerdotium et imperium, illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens sono chiaramente evocate da Rolando nel passo Sacerdotium quoque et Imperium non sese impediant quia unum divinis ministrans, aliud humanis presidens (Summa in tit. C. 12.58, § 6).
75. Cfr. quanto afferma Q u a g l i o n i (Luminaria) in merito alla glossa apposta al passo del Decretum di Graziano nel quale è riportato il canone gelasiano, redatta da Giovanni Teutonico intorno al 1216.
76. Cfr. C o r t e s e, Il diritto, II, pp. 197-245.77. U l l m a n n, Medieval Papalism, p. 142. Le tesi di Uguccione dominarono la cano-
nistica fino all’affermazione del pensiero di Alano, il quale, nelle parole di Ullman, “marked a turning point in the development of canonistic political thought” (ibid., e pp. 138-198 per un inquadramento più generale). Rolando sembra evocare le idee di Uguccione anche nel paragone che compie tra gerarchie ecclesiastiche e secolari (cfr. infra, Summa in tit. C. 12.1, § 60, dove afferma: Sed et miro modo possumus spiritualibus civilia comparare et assimulare ut, sicut episcopus sub metropolitano et metropolitanus sub patriarcha et iste sub domino Papa, sic ma-
III.1.2. Menzinger, Trasformazione del quadro fiscale cittadino CXLIII
metafora di Innocenzo III, come anche l’aggiornamento in materia canonica di cui Rolando dà prova nella trattazione di materie specifiche,78 suggeriscono comunque che l’antiquata visione dei rapporti tra Chiesa e Impero non sia in lui tanto conseguenza dell’isolamento scientifico, né riflesso di una diffiden-za del pensiero civilistico nei confronti di quello canonico, quanto piuttosto espressione di una precisa visione politica, in linea certo con l’adesione al partito imperiale, ma che principalmente punta ad esaltare astratti modelli isti-tuzionali da far convergere sulle finalità pubbliche della loro esistenza. Una convergenza che ha un intento specifico: quello di dimostrare la natura asso-lutamente pubblica delle città, antiche quanto comunali, e della sovranità che ambiscono ad esercitare.
Tale scopo è reso esplicito da Rolando nel commento al titolo De iure rei publicae (C. 11.30), dove il paragone dell’ecclesia con la civitas è mirato in-nanzitutto a sanare quel dubbio insinuato da un passo del Digesto secondo il quale le città diverse da Roma, o municipia, dovevano essere considerate come soggetti privati.79 Proprio queste parole del Digesto indussero a lungo i giuristi contemporanei e successivi a Rolando ad applicare con riserva lo status di res publica alle città, riserve che furono sciolte del tutto solo negli ultimi decenni del Duecento, quando i comuni cominciarono diffusamente ad essere qualificati come poteri pubblici.80 Una cautela nient’affatto condivisa dal nostro giudice, che non indugia a qualificare res publicae le città in generale, rafforzando anzi la natura pubblicistica del loro potere attraverso il ricorso all’argomento secondo cui Giustiniano aveva un tempo accorpato la disciplina della chiesa e degli enti sacri con quella della città e connotato questo insieme come pubblico nella sua compilazione, tenendolo ben separato dal diritto privato.81 Da questo si evince, dice Rolando in conclusione, che le cose sacre non divergono molto da quelle pubbliche (sacre res a publicis non multum differunt),82 affermazione che, ispi-rata da un passo delle Novellae giustinianee,83 non si limita in realtà a confortare
gistratus civitatis sub preside provincie et preses sub prefecto pretorio et iste sub Imperatore), come pure, in tutt’altro contesto, nel sostenere la legittimità, in casi eccezionali, di poteri giuri-sdizionali femminili (cfr. infra, III.3.3., La donna medievale).
78. Visibile sia in materia di poteri giurisdizionali femminili (cfr. nota precedente), sia in materia di rappresentanza politica, (infra, III.3.1., Dalla fiscalità).
79. Infra, Summa in tit. C. 11.30, § 1, C. 11.31b, §§ 1-2. Per un punto su tale questione nel diritto romano, T h o m a s, L’institution.
80. Cfr. C r e s c e n z i, Il sindacato, pp. 457-463, e supra, C o n t e, II.3.5., Il ricono-scimento.
81. Infra, Summa in tit. C. 11.30, § 52.82. Ibid., § 54. 83. Cfr. Nov. 7.2.1: … utique cum nec multo differant ab alterutro sacerdotium et impe-
rium, et sacrae res a communibus et publicis, quando omnis sanctissimis ecclesiis abundantia et status ex imperialibus munificentiis perpetuo praebetur.
CXLIV Diritto pubblico tra Impero e città
quanto ha detto in precedenza, ma tradisce l’influenza che su di lui esercitano alcune importanti acquisizioni del pensiero giuridico romano risalenti a un’epo-ca ben anteriore a Giustiniano. Mi riferisco in particolare a quell’avvicinamento tutto speciale tra sfera sacra e pubblica che operarono già i giuristi di epoca re-pubblicana, che fu accolto e rielaborato da quelli di epoca imperiale, per giun-gere a lasciare evidenti tracce nel Corpus iuris giustinianeo.84 Dobbiamo a Yan Thomas la ricostruzione di questo processo e l’insuperabile analisi delle sue molteplici implicazioni.85 La sovrapposizione sacro/pubblico nel diritto romano si coglie specificamente in materia di beni, ed in particolare di quei beni cosid-detti extra-patrimoniali o indisponibili, sottratti cioè al commercio, alla vendi-ta, più in generale all’alienazione. Proprio l’indisponibilità è ciò che accomuna beni sacri e beni, specifica Thomas, non collettivi, ma cittadini, nel senso che è all’interno della realtà urbana – prima esclusivamente di Roma, poi delle altre civitates –, e non di altra generica comunità, che si verifica quell’accostamento particolarmente intenso tra pubblico e sacro.86
Benché molte delle fonti romane in cui compare il termine ‘sacro’ si rife-riscano a una sacertà pagana, esse tendono a mescolarsi, nella compilazione di Giustiniano, a tutte le costituzioni successive regolanti la Chiesa cristiana, dove i termini sacer o sanctus continuano ovviamente ad essere utilizzati, ma con un’accezione diversa. Se a ciò si aggiunge l’uso indiscriminato che, a partire almeno dall’epoca Flavia – e in misura proporzionalmente crescente all’influenza esercitata dall’idea di maiestas orientale –, gli imperatori fece-ro degli aggettivi sacrali per trasmettere l’idea di una loro natura sovruma-na, ci si avvicina all’ibrido e confuso strumentario linguistico che, in materia di sacertà, il Corpus iuris civilis mise a disposizione del giurista medievale. Uno strumentario eterogeneo, all’interno del quale si verificarono veri e pro-pri cortocircuiti attorno ad espressioni il cui significato, a distanza di secoli, non poteva che risultare ambiguo. È il caso ad esempio dell’aggettivo divinus e dell’espressione divina domus che daranno filo da torcere alle prime gene-razioni di glossatori.87
Rolando subisce il fascino di tutti i campi semantici della sacralità del pubblico, sia, abbiamo visto, come fonte di legittimazione del potere cittadino attraverso l’assimilazione della civitas alla Chiesa cristiana; sia come territo-rio interdetto all’appropriazione privata, sottratto ai singoli e riservato al bene
84. Basti pensare alle partizioni del diritto tracciate da Ulpiano, le cui incisive parole – publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit – sono apposte in apertura del Digesto (D. 1.1.1.2) dagli interpreti giustinianei.
85. T h o m a s, La valeur. T h o m a s, La valeur.86. Ibid., pp. 1434-1438, e cfr. T h o m a s, La construction, p. 24. Ibid., pp. 1434-1438, e cfr. T h o m a s, La construction, p. 24.87. Cfr., in proposito, F i s h w i c k, The Imperial Cult, II, pp. 423-435, e infra, III.2.3.,
La tassazione.
III.1.2. Menzinger, Trasformazione del quadro fiscale cittadino CXLV
comune dei cittadini e, un tempo, agli dei;; sia, infine, come espressione della sovranità imperiale, incarnata ora dalla città e dal ruolo sovrano che ambisce a esercitare. Una sommaria analisi dei contesti in cui nella Summa egli fa ricor-so agli aggettivi sacer o sanctus aiuta a comprendere meglio questo discorso: fin dall’inizio dell’opera, dove spiega la materia che si accinge a trattare, dice che, oltre alle cose fiscali intese come private e proprie del princeps, verran-no da lui approfondite alia fiscalia che non sunt privata sed publica et sancta, tra le quali rientra l’esazione dei tributi, certamente reputata propria della res publica.88 Riprende l’argomento qualche riga più avanti, per ribadire che pu-blica fiscalia – contrapposte alle cose de fiscalibus privatis, cioè spettanti al princeps –, come ad esempio pagamenti delle imposte o tributi pubblici, non possono cadere in prescrizione essendo res sanctae.89 All’esistenza di due sfe-re fiscali fa riferimento spesso, due erari, che definisce uno privato, relativo al princeps, l’altro “pubblico e santissimo”.90 Il discorso viene ripreso ancora una volta nel commento al titolo De annona et tributis (C. 10.16), dove af-ferma che le imposte versate all’erario dai provinciali erroneamente vengono dette “straordinarie”, trattandosi piuttosto di res sanctae91 – idea che, oltre a possedere un’importanza in sé, gli torna utile per il ridimensionamento della varietà di imposte che possono essere definite straordinarie, nella sua battaglia contro i privilegi fiscali.92 Sulla prossimità tra pecunia sacra e publica Rolan-do subisce l’influenza della Novella De mandatis principum (Nov. 17), in cui l’Imperatore aveva dato mandato a Triboniano di predisporre l’esazione delle pubbliche imposte anche nei templi, dato che – come ripete alla lettera il giu-dice nel proemio della Summa –, la ratio fiscalium è utile e necessaria ai sol-dati, ai privati, agli stessi templi e alla res publica.93
88. Infra, Summa in tit. C. 10.1, §§ 11-13. Per la scarsa percezione della distinzione tra patrimonio del sovrano e fisco pubblico nell’Alto Medioevo, cfr. C o r t e s e, Intorno alla cau-sa, p. 364 e sgg. Si vedano anche le recenti riflessioni di Giorgio A g a m b e n (Opus Dei, pp. 80-82) sul precoce ingresso del termine munus nel vocabolario ecclesiastico tardoantico.
89. Infra, Summa in tit. C. 10.1, § 330.90. Per esempio, infra, Summa in tit. C. 11.62, § 8.91. Infra, Summa in tit. C. 10.16, § 24.92. Cfr. infra, III.2.3., La tassazione.93. Nov. 17.7.1: Publicorum vero tributorum exactiones et intra templa decenter fieri
praeparabis, quoniam fiscalium ratio et militibus, et privatis ipsisque templis et cunctae rei-publicae utilis et necessaria est (citato per esteso da Rolando, infra, Summa, Prooemium, § 18). Nel proseguimento del passo della Novella, la sovrapposizione delle sfere sacro/pubbli-co risulta persino rafforzata: Auxiliabuntur autem tibi ad hoc etiam deo amabiles ecclesiarum defensores et oeconomi, nullum horum qui fiscalia tributa exiguntur abripientes exactioni, sed neque permittentes violentum aut seditiosum aliquid pati executionem inferentes, scientes quia, si quid tale gesserint, de suo satisfacere fisco cogentur. Cfr. quanto afferma T h o m a s, La va-leur, pp. 1431-1437, sulla prossimità di pecunia sacra e pecunia publica nel pensiero romano di epoca repubblicana, e, in tutt’altro contesto, quanto prescrive Giustiniano in C. 11.48.20.1
CXLVI Diritto pubblico tra Impero e città
Questa santificazione che Rolando opera del prelievo pubblico è prin-cipalmente ispirata da un editto che Giustiniano aveva un tempo indirizzato agli arcivescovi e ai patriarchi per spronarli a denunciare eventuali soprusi dei giudici in campo fiscale, “affinché”, affermava l’Imperatore, “non sia di-sprezzata alcuna delle cose sante e giuste che da noi sono state sancite”.94 Il riferimento, nella frase successiva, all’esazione fiscale,95 è quello che deve aver spinto Rolando a restringere alle imposte la definizione più vasta del-la formulazione giustinianea, trasponendo in qualche modo la santità che le decisioni imperiali traevano dal solo fatto di essere state sancite, alla mate-ria che andavano a regolamentare.96 L’idea era supportata da un passo a lui senz’altro noto del Digesto, nel quale Ulpiano aveva esplicitamente definito ‘santo’ ciò che era stato confermato da una sanctio (come ad esempio le leg-gi), anche se non consacrato a Dio.97 Nelle fonti romane, questo senso pret-tamente di inviolabilità delle res sanctae da un lato le distingueva da quelle sacre, dall’altro le manteneva però ad esse strettamente legate, accomunan-do entrambe, per il carattere di indisponibilità messo in luce da Thomas,98 alle res publicae in primo luogo cittadine. È per tale via che l’accostamento sanctus/publicus/civitas viene dunque trasmesso alla Summa di Rolando, una via parallela e genealogicamente diversa da quella che lo spinge ad assi-milare la città all’ecclesia, ma che ad essa si ricongiunge attraverso una con-
riguardo al luogo (metropolitana ecclesia) in cui devono essere conservati i soldi provenienti da terre di proprietà controversa, ripreso da Rolando in Summa in tit. C. 11.48, §§ 217-223. Cfr. anche, in materia di beni sacri/pubblici, l’esemplare caso della donazione del Pantheon citato da Rolando in Summa in tit. C. 10.1, § 181 e ricostruito da C o n t e, supra, I.3.6., La lettera-tura medievale.
94. Nov. 8 Edictum: Edictum scriptum in omni terra deo amabilibus archiepiscopis et sanctissimis patriarchis: Traditae nobis a deo reipublicae curam habentes et in omni iustitia vivere nostros subiectos studentes subiectam legem conscripsimus, quam etiam tuae sanctitati, et per eam omnibus qui tuae provinciae sunt, facere manifestam bene habere putavimus. Tuae igitur sit reverentiae et ceterorum haec custodire et, si quid transcendatur a iudicibus, ad nos referre, ut nihil contemnatur horum q u a e s a n c t e i u s t e q u e a n o b i s s a n -c i t a s u n t . Si enim nos quidem nostrorum subiectorum miserati, quoniam supra fiscalium functionum exactionem etiam maximas sustinent ex furto iudicum violentias propter factas pro-vinciarum venditiones, haec auferre per subiectam studuimus legem, vos autem neglegentes non referatis etc.
95. Cfr. nota precedente, la frase: Si enim nos.96. Per un esame semantico dei termini sancio, sanctio, sanctus, cfr. T h o m a s, De la
“sanction”, e B l o c h, Res sanctae.97. Ulpianus, lib. 68 ad edictum (D. 1.8.9.3): Proprie dicimus sancta, quae neque sacra
neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata: ut leges sanctae sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae. Quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit consecratum: et interdum in sanctionibus adicitur, ut qui ibi aliquid commisit, capite puniatur.
98. Oltre al citato articolo La valeur, pp. 1431-1437, cfr. T h o m a s, La construction.
III.1.2. Menzinger, Trasformazione del quadro fiscale cittadino CXLVII
divisione linguistica e semantica del santo/sacro applicato al mondo urbano. Questa interferenza di piani è ben visibile ad esempio nell’uso indistinto dei due aggettivi sanctus e sacer da parte di Rolando, il quale non sembra co-gliere fino in fondo le raffinate distinzioni operate nel III secolo da giuristi quali Ulpiano o Marciano, che avevano caratterizzato le res sanctae il primo come “cose né sacre né profane ma convalidate da una sanzione”;99 il secon-do come “ciò che viene protetto e difeso dalle offese degli uomini”.100 Tale fu il senso da entrambi affidato al termine ‘santo’ in relazione per esempio alle mura della città, per esaltarne il carattere di inviolabilità, tutelato da una sanctio che minacciava di pena capitale chi vi avesse attentato.101
La definizione non poteva non suscitare l’entusiasmo del giudice lucche-se, che non manca di narrare la leggenda di Remo, ucciso per aver tentato di scavalcare le mura di Roma, anziché accedere alla città attraverso le porte.102 Tuttavia, il fatto che traduca in ‘sacre mura’ l’originario ‘sante’,103 attesta più il desiderio di proiettare in una sfera sovrumana la rappresentazione per eccel-lenza dello spazio cittadino, che quello di richiamare l’originario significato trasmesso dai giuristi romani. Era peraltro pacifico, in questo caso, il trasferi-mento della santità delle mura di Roma a quelle di tutte le altre città operato da Rolando (dicuntur sacri muri c i v i t a t i s), grazie alle limpide parole di Marciano nel Digesto (in municipiis quoque muros esse sanctos Sabinum rec-te respondisse Cassius refert).104 Un’operazione che in Rolando risponde non solo all’intento ideologico di sacralizzare l’espressione materiale del potere
99. Vedi note precedenti.100. Marcianus, libro quarto regularum (D. 1.8.8 in princ.): Sanctum est, quod ab iniuria
hominum defensum atque munitum est.101. Secondo Marciano (D. 1.8.8.2): In municipiis quoque muros esse sanctos Sabinum
recte respondisse Cassius refert, prohiberique oportere ne quid in his immitteretur; per Ulpia-no, cfr. il riferimento alle mura in D. 1.8.9.4. Cfr. anche Inst. 2.1.10: Sanctae quoque res, veluti muri et portae, quodammodo divini iuris sunt et ideo nullius in bonis sunt. ideo autem muros sanctos dicimus, quia poena capitis constituta sit in eos qui aliquid in muros deliquerint. ideo et legum eas partes quibus poenas constituimus adversus eos qui contra leges fecerint sanctiones vocamus. Per una contestualizzazione nella storia e nel pensiero romano di questi ed altri passi del Digesto sul tema, cfr. B l o c h, Res sanctae, pp. 55-64.
102. Infra, Summa in tit. C. 10.49, § 23, la cui fonte è Pomponio (D. 1.8.11): … Si quis violaverit muros, capite punitur, sicuti si quis transcendet scalis admotis vel alia qualibet ratio-ne. Nam cives Romanos alia quam per portas egredi non licet, cum illud hostile et abominan-dum sit: nam et Romuli frater Remus occisus traditur ob id, quod murum transcendere voluerit; per i rapporti tra Pomponio e le fonti classiche sulla fondazione di Roma, cfr. B l o c h, Res sanctae, pp. 55-62.
103. Tutti e quattro i manoscritti contenenti questo passo della Summa concordano sul termine sacri, per il quale non compaiono varianti: cfr. infra, apparato critico relativo a Summa in tit. C. 10.49, § 20.
104. D. 1.8.8.2.
CXLVIII Diritto pubblico tra Impero e città
comunale, ma, ancora una volta, a concrete esigenze di carattere fiscale, con-siderato che i lavori sulle cinte murarie rappresentarono una delle principali causae di imposizione di tributi nelle realtà cittadine di fine XII secolo.105 Non è un caso che, tanto il discorso sulle ‘sacre mura’ quanto la leggenda di Remo vengano inseriti da lui non nel più ideologico commento al titolo del Codice De iure rei publicae (C. 11.30), ma in quello relativo agli “Oneri o pagamenti ai quali non è lecito sottrarsi” (C. 10.49).
La stessa idea di intangibilità associata alle mura accompagna, nel pen-siero giuridico romano, la figura dell’ambasciatore, definito ‘santo’ non in conseguenza di una metaforica assimilazione all’immagine venerata del santo, ma per la sua capacità di incarnare interessi collettivi.106 Non stupisce il successo che tale formulazione trovò tra i giuristi comunali: Rolando af-ferma che il legatus, ossia colui che rappresenta gli interessi urbani all’ester-no, deve essere considerato santo nel corso della sua missione. In patria, durante la sua assenza, gode di una serie di privilegi che gli garantiscono un certo grado di immunità, mentre all’esterno nessuno può maltrattarlo; anzi, se qualcuno offende un ambasciatore nemico, sia consegnato agli avversari per riparare all’ingiuria, perché ha commesso un reato contro lo ius gentium e perché i legati devono essere considerati santi.107 E qui il giudice coglie bene il significato originario espresso dai giuristi romani, supportato anche dall’erudizione di Pillio secondo il quale – parafrasando la fantasiosa etimo-logia formulata anticamente da Marciano – gli ambasciatori erano detti santi dal termine sagminae, le sacre piante che contraddistinguevano i legati ro-mani.108 Ancora una volta, il punto che sta a cuore a Rolando è però rendere partecipi tutte le città delle condizioni speciali un tempo riservate a Roma e ai suoi rappresentanti, intento che rende esplicito, in materia di ambascia-tori, attraverso un breve riferimento autobiografico: il legato, afferma, deve reputarsi tale a partire da quando è nominato, e da quel momento inizia a godere dei privilegi di colui che si sposta nell’interesse della res publica; sin da allora deve infatti porre mano ai preparativi per la missione, come sa bene egli stesso, per le fatiche che, come ambasciatore di Lucca, si è frequente-mente sobbarcato.109 L’accostamento della sua personale esperienza di lega-to lucchese a coloro che si spostavano nell’interesse della res publica ed ai loro speciali benefici, suggerisce che egli reputi questi ultimi operativi per i
105. Cfr. infra, III.2.1., “Cessante causa”.106. Cfr., in particolare, Marciano, D. 1.8.8.1, Pomponio, D. 50.7.18, e l’interpretazione
che ne fornisce B l o c h, Res sanctae, pp. 54-55. Per l’esame di alcune riflessioni dottrinarie Quattrocentesche sulla figura dell’ambasciatore, cfr. G i l l i, La fonction.
107. Infra, Summa in tit. C. 10.65, §§ 53-56.108. Ibid., § 28.109. Ibid., § 57.
III.1.3. Menzinger, Trasformazione del quadro fiscale cittadino CXLIX
rappresentanti di tutte le città, idea che viene invece rigettata nettamente da Pillio, in un brano citato da Rolando.110
1.3. Fiscalità imperiale/fiscalità comunale: osmosi e separazione
Insistere su elementi pubblicistici del potere cittadino risponde in Ro-lando non solo all’esigenza ideologica di rivendicare ai Comuni uno spazio politico autonomo dalle grandi potenze sovraregionali, ma anche a necessità dell’amministrazione urbana. Prima fra tutte quella di riscuotere pagamenti dagli abitanti della città e del contado per motivazioni nuove e in forme con-tributive diverse rispetto al passato.
Seppure vi siano, nella sua opera, riferimenti espliciti al diritto delle cit-tà di riscuotere tributi, il prelievo fiscale imperiale e quello urbano appaiono in essa indissolubilmente legati. Alla luce dei rapporti intercorrenti tra città e Impero in Toscana a cavallo dei secoli XII e XIII, il dato non sorprende. Basti ricordare il contenuto della nota concordia con i lucchesi siglata, nel 1162, dal rappresentante imperiale Rinaldo, arcivescovo di Colonia, nella quale veniva tra l’altro sancito che, fissato in 400 lire il tributo annuale dovuto da Lucca a Federico, la città si impegnava, se richiesta, a raccogliere il fodro in vece dei rappresentanti imperiali nel territorio della diocesi e del comitatus.111 Testimo-nianze di poco successive, provenienti da altre realtà toscane, mostrano come di fatto ciò in breve si tradusse prima in una sovrapposizione, poi in una vera e propria fusione dei sistemi di esazione imperiale e cittadino: tra il 1196 e il 1198, gli ufficiali del Comune di Arezzo non solo erano contemporaneamente responsabili della riscossione del fodro imperiale e del dazio comunale, ma potevano riscuotere e incassare il primo se l’Imperatore o i suoi rappresentanti non lo avessero richiesto; negli stessi anni, grazie anche alla vacanza dell’Im-pero, Firenze era riuscita di fatto ad usurpare il fodro imperiale, inglobandolo nei suoi tributi cittadini.112 Nella Lucca di Rolando le cose non dovettero an-dare molto diversamente, ed è assai probabile che a un inquadramento teorico unitario dei tributi imperiali e cittadini il giudice fosse spinto in primis dalla concreta esperienza svolta nell’amministrazione comunale lucchese.
La percezione unitaria di prelievo fiscale imperiale e urbano si coglie bene, nella Summa, analizzando le causae impositionis per le quali è reputata legit-tima la riscossione di tributi. Conformemente alla convinzione dominante nel pensiero giuridico della sua epoca, la causa è per Rolando elemento determi-
110. Ibid., §§ 34-35, e cfr. supra, C o n t e, II.3.5., Il riconoscimento. 111. MGH DD F I 2, p. 302, n. 214: … Et fodrum ei per episcopatum et comitatum Luca-
num bona fide recolligi iuvabo, cum ab eius certo misso ad hoc destinato requisitus fuero; sul punto, cfr. S a n t i n i, Studi, pp. 11-13.
112. B a r b a d o r o, Le finanze, pp. 9-12.
CL Diritto pubblico tra Impero e città
nante per la creazione e sussistenza di un’imposta; siamo di fronte alla peculia-re declinazione che in campo tributario subisce, secondo Ennio Cortese, la più vasta categoria della causa legis, perché la causa impositionis rappresenta “una semplice e naturale applicazione al processo creativo dell’imposta di risultati ot-tenuti … nei riguardi del processo creativo della legge”.113 Delle quattro causae su cui si concentrò la dottrina medievale in merito alla legge, fu soprattutto la ‘causa finale’ ad imporsi in campo tributario, come attesta fin dall’inizio del XII secolo l’idea di Pasquale II, per il quale condizione necessaria di una tassa era sapere ‘per cosa’ doveva essere pagata.114 È così che, “proprio esaltando l’ele-mento finale dell’imposta, l’uomo del Medioevo intendeva si attuasse la lega-lità nel campo tributario”.115 Un’interpretazione che si applica bene al pensiero di Rolando il quale, commentando una legge di Costantino in cui l’Imperatore aveva specificato l’importanza del pagamento dei tributi richiesti per l’esercito pro communi salute, ne apprezza proprio la motivazione: è degno di nota, af-ferma infatti, che “per sollevarci dal dubbio della nostra preoccupazione, venga aggiunta la causa per la quale i tributi sono richiesti (adicit causam quare tributa exigantur), ossia le spese per i milites dell’esercito imperiale. Non senza causa, infatti, si dice che si può ricorrere ai tributi pubblici (non enim sine causa pu-blice functiones dicuntur respicere)”.116 In queste formulazioni la causa assume chiaramente il ruolo di “strumento d’una valutazione di natura etica”, risolven-dosi nel concetto di necessitas da cui anche terminologicamente viene sostitu-ita, e divenendo il metro per definire giuste o ingiuste delle imposte:117 “tutti”, afferma Rolando, “sono obbligati dalla necessitas del prelievo pubblico”;118 “è dunque la necessitas che costringe i sudditi a pagare i tributi”,119 tributi che non devono eccedere quanto richiesto dalla necessitas stessa,120 certificata dai com-missari addetti alla ripartizione delle imposte;121 i tributi possono essere infatti
113. C o r t e s e, Intorno alla causa, p. 335.114. Sulle posizioni di Pasquale II, cfr. supra, C o n t e, II.3.3., L’esenzione.115. C o r t e s e, Intorno alla causa, p. 341, e cfr. S c o r d i a, “Le Roi doit vivre du
sein”, pp. 89-121, per il peso che il ragionamento causale riveste ancora nelle dispute sulla fi-scalità dei teologi francesi di fine Duecento.
116. Infra, Summa in tit. C. 10.19, §§ 14-16.117. C o r t e s e, Intorno alla causa, pp. 319 e 320 in nota; supra, C o n t e, II.3.3.,
L’esenzione; per alcune declinazioni della necessitas nella letteratura teologica tardo-duecente-sca e trecentesca, S c o r d i a, “Le Roi doit vivre du sein”, pp. 146-153.
118. Infra, Summa in titt. C. 11.65, § 6 (unumquemque privatorum necessitas publice pen-sitationis astringit) e C. 10.25, § 2 (necessitas tributarie functionis omnes omnino costringit).
119. Ibid., § 3 (necessitas ergo cogit subiectos ad tributum).120. Infra, Summa in tit. C. 10.49, § 16 (ut tamen non plus poscatur quam necessitas im-
petraverit).121. Infra, Summa in tit. C. 10.25, § 3 (necessitas inquam que sit firmata perequatione
censitorum perequatorum provincialium iudicum).
III.1.3. Menzinger, Trasformazione del quadro fiscale cittadino CLI
richiesti esclusivamente per necessità incombenti, tant’è che, decadendo la ne-cessitas, dovrà venire a cessare anche ciò che in virtù di essa è stato imposto (quia propter solas imminentes neccessitates honera debeant iniungi … et ces-sante neccessitate, cessabit quod pro ea erat iniunctum).122
Ma quali voci di spesa motiva concretamente la necessitas? Di una si è già parlato, vale a dire le inesauribili spese militari dell’esercito imperiale, una causa impositionis che, a dire la verità, si situa anch’essa a cavallo tra Impero e città, considerato che, tra i contributi richiesti dall’Imperatore per le sue mis-sioni, rientra quello dei milites cittadini che ciascun Comune deve mettergli a disposizione. Per rimanere a Lucca, nella citata concordia tra l’arcivescovo imperiale e la città del 1162, parallelamente al tributo di 400 lire annue, sono menzionati venti milites che il Comune si impegna a fornire al Barbarossa per la spedizione in Italia meridionale.123 L’amministrazione lucchese riscuo-te dunque imposte da destinare sia all’Imperatore, per il tributo dovuto dalla città (fodro), sia ai milites cittadini, per il servizio che prestano nell’esercito. Un punto sul quale Rolando è piuttosto chiaro, affiancando al generico usus imperialis exercitus,124 come motivazione di imposta, le più concrete spese ne-cessarie pro mittendis militibus ad exercitum e quelle direttamente sostenute dai milites nell’esercito imperiale.125 Del significato politico di queste dichia-razioni si è già detto;126 qui interessa piuttosto evidenziare la promiscuità dei tributi militari che, se sono indetti e riscossi indirettamente dall’Impero, pos-sono però giungere ad essere destinati a scopi francamente distanti dagli inte-ressi imperiali. Rolando giunge a teorizzarlo proprio sfruttando l’elasticità del concetto di causa/necessitas, che può pacificamente trasformarsi in pia cau-sa/communis salus/publica utilitas e divenire così la motivazione di una tassa imposta ai cittadini nel bene della collettività.127 E qui l’Impero è sfruttato re-toricamente per adempiere a una funzione legittimante di un’iniziativa fiscale
122. Infra, Summa in tit. C. 10.16, §§ 37-38.123. MGH DD F I 2, nr. 214, p. 303: Et dabo domino imperatori Frederico in expeditione
versus Romam et Apuliam et Calabriam milites viginti, et ad illos terminos, quos dominus im-perator per se vel per certum suum missum ad hoc nobis destinatum imposuerit michi.
124. Menzionato per esempio infra, Summa in tit. C. 10.19, § 14.125. Rispettivamente, infra, Summa in titt. C. 10.42, § 48 e C. 10.19, § 15.126. Cfr., supra, III.1.1., Fiscalità e militia.127. Cfr. per esempio infra, Summa in tit. C. 10.25, § 4. Per i legami intercorrenti tra cau-
sa, utilitas publica e necessitas, cfr. C o r t e s e, La norma, I, pp. 126-128, 257, 262-268. Sul potere coercitivo implicante l’utilitas e su alcune considerazioni di Baldo degli Ubaldi relative alla preminenza del potere pubblico perché preposto alla publica utilitas e al bonum publicum, cfr. C r e s c e n z i, Il problema, 225-228, 250-251. Per una riflessione sul ricorso alla publica utilitas in Bartolo da Sassoferrato e nella dottrina giuridica trecentesca, cfr. S b r i c c o l i, Legislation, pp. 44-46, secondo il quale (p. 45) “… the notion of public usefulness asserted it-self as one of the juridical instruments which performed a by no means secondary role in the process of transformation, towards the state, of the political institutions of the commune”.
CLII Diritto pubblico tra Impero e città
che, nei fatti, si emancipa da esso, essendo integralmente direzionata alla città: come l’Imperatore, dice Rolando, deve provvedere alla res publica in caso di necessità, così i suoi sudditi devono provvedere a sé stessi, ai propri ‹concit-tadini› e alla propria città.128 Il risultato è quello di uno spazio fiscale nuovo, per imposte destinate alla costruzione e manutenzione di mura, fortificazioni, strade, ponti e argini di fiumi;;129 alla creazione di magazzini, dove stipare beni di prima necessità per la cittadinanza in caso di emergenze; in poche parole, a una finanza cittadina, la cui natura pubblica è in un certo senso garantita pro-prio dal nesso permanente con la finanza imperiale.
2. Questioni di diritto fiscale
2.1. “Cessante causa cessat et effectus”: vantaggi e limiti della caducità del prelievo
È noto che il Medioevo conobbe scarsissime esperienze di sistemi di tas-sazione ordinaria. Tra i principali motivi, vi è quello che Cortese ha definito il carattere ‘sinallagmatico’ del prelievo medievale, in conseguenza del quale ciascuna imposta doveva essere collegata a un preciso servizio da parte del potere statuale, come contropartita dell’obbligo individuale.130 L’idea di Ro-lando secondo cui le autorità devono esplicitare la causa delle imposte e non chiedere di più di quanto la necessitas impone, esprime bene quel legame strettissimo che anche nel mondo comunale vi fu tra spesa e riscossione. La soluzione ricorrente si trovò, com’è noto, in forme di prelievo straordinario, che da una parte mantenevano saldo il nesso con la ragione per cui le imposte venivano richieste, dall’altra aggiravano l’idea di soggezione implicita a una tassa ordinaria, benché questo punto rimanesse problematico. La massima cir-colante tra i canonisti post-gregoriani, secondo cui praestatio tributi probat subiectionem,131 esemplifica con chiarezza i rischi che categorie di privilegiati vedevano insiti nel pagamento di una qualsiasi forma di tributo, fosse anche straordinario, soprattutto se assumeva le sembianze di un’imposta diretta.132 Basti pensare, ancora nella prima metà del Duecento, alle menzionate resi-
128. Infra, Summa in tit. C. 10.27, § 6.129. La nozione di beni di pubblica utilità sembra diffusa nella Lucca della seconda metà
del XII secolo, a giudicare dalle due interessanti cause relative alle strade lucchesi ricostruite da S a v i g n i, Episcopato, pp. 88-90.
130. C o r t e s e, Intorno alla causa, p. 345.131. Ibid., p. 375.132. Per un inquadramento teorico della questione dell’imposta come simbolo di sotto-
missione al potere, cfr. Scordia, “Le Roi doit vivre du sein”, pp. 56-60, 65.
III.2.1. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLIII
stenze dei milites cittadini, i quali cercarono costantemente di sottrarsi a tut-te le forme di tassazione urbana, o alla vera e propria battaglia che la Chiesa portò avanti per secoli al fine di non sottostare alle pretese fiscali comunali. Per queste ragioni la causa assunse un’importanza speciale, nel senso che le città cominciarono a mettere a fuoco alcune motivazioni di imposte ineludi-bili, cui neppure le persone privilegiate, che godevano di norma di una serie di esenzioni fiscali, potevano sottrarsi. Tali sono per Rolando tutti quei tributi richiesti per il bene della collettività (letteralmente definiti: ad pietatem, ad publicam utilitatem e pro communi salute), che nella sua opera possono essere ricondotti principalmente a cinque motivazioni:
- il transito dell’Imperatore- il trasporto di viveri destinati al suo esercito- la fornitura di milites all’esercito imperiale- l’acquisto, il trasporto e la custodia di derrate pubbliche- la costruzione e riparazione di mura, ponti, strade, argini etc.
Benché, come abbiamo detto, queste motivazioni vengano percepite in senso unitario e poste strumentalmente tutte sullo stesso piano, delle differen-ze naturalmente esistono: se infatti le accomuna l’elemento della straordina-rietà, l’idea per cui dei tributi possano essere indetti solo per una necessitas imminente e cessare una volta che questa sia esaurita rappresenta, agli occhi di un amministratore comunale, una garanzia per prelievi riconducibili alle prime tre ragioni, ma un grande ostacolo per quelli facenti capo alle ultime due. Sembra significativo che Rolando ricorra al principio cessante causa133 in un contesto molto delicato, quando cioè dialoga virtualmente con Enrico VI in merito all’auspicata esenzione dei fondi italici dai tributi imperiali, ri-cordando all’Imperatore, e a suo padre Federico, le eccessive richieste da loro avanzate ai comuni a fini militari (propter nimias expensas et honera impe-rialis exercitus).134 È ovvio che richiamare il principio per cui, col venir meno dell’emergenza militare, deve esaurirsi anche la richiesta fiscale, risponde in questo caso ad esigenze di tutela delle città. Si rivela viceversa un’idea scomo-
133. Sulla cui storia e significato cfr. B r o w n, Cessante causa, G o u r o n, Cessante causa; sull’origine della massima cessante necessitate debet utique cessare pariter quod urge-bat, circolante già dal V secolo in campo ecclesiastico, cfr. K u t t n e r, Urban II, pp. 61-63, 67, 78-81.
134. Infra, Summa in tit. C. 10.16, § 36. Il dovere del sovrano di abolire un’imposta una volta che si sia esaurita l’esigenza che l’ha generata è al centro di una disputa ‘quodlibetale’ discussa dal filosofo domenicano Pierre d’Auvergne alla fine del Duecento, il quale giunge ad affermare che, se la sospensione non è prescritta iure scripto, tamen est prohibitum iure natura-li: cfr. B r o w n, Cessante causa, p. 587.
CLIV Diritto pubblico tra Impero e città
da nel caso di spese ricorrenti, come la manutenzione di granai cittadini, o la realizzazione di opere pubbliche il cui finanziamento non può in nessun modo esaurirsi in imposizioni episodiche. È in quest’ultimo contesto che Rolando propone, per inciso, un ribaltamento del principio cessante causa, applican-done gli effetti al contribuente piuttosto che all’autorità che impone il tributo: analizzando la posizione di colui che non disponga di risorse sufficienti per alcuni munera, definisce l’esenzione una soluzione ad tempus perché, spiega, dura soltanto fintanto che la persona resti indigente;; qualora successivamente si arricchisca, deve pagare, infatti se viene meno la causa dell’esenzione, deve esaurirsi anche l’effetto (cessante causa excusationis cessat effectus).135
Al volgere del 1100, siamo ancora distanti dalle teorie di perpetua ne-cessitas cui la dottrina giuridica perviene agli inizi del XIV secolo, quando comincia ad affacciarsi l’idea – valorizzata da Ernst Kantorowicz in relazione al pensiero di Oldrado da Ponte († 1335) – di una necessitas in actu (urgenza effettiva) distinta dalla necessitas in habitu (perpetua), per giungere a legit-timare forme di tassazione permanenti e ordinarie, legate ormai ad esigenze amministrative routinarie più che emergenziali.136 Nei due secoli antecedenti, però, le città giunsero ad aggirare i limiti dettati da un sistema di tassazione straordinario escogitando delle causae di lunghissimo periodo che, pur gene-rando tributi strettamente collegati a una necessitas, assunsero frequentemen-te l’aspetto, in concreto, di un prelievo ordinario. Un’importanza del tutto par-ticolare rivestirono in questo contesto i lavori di costruzione e restauro delle cinte murarie: rappresentando infatti le mura un’impresa interminabile e allo stesso tempo costosissima da realizzare, misero in evidenza per la prima vol-ta, in molte realtà comunali del XII secolo, i problemi derivanti dall’assenza di costanti entrate fiscali.137
Non sembra casuale che alcuni dei conflitti più risalenti tra città e chie-se locali in materia di imposte abbiano avuto ad oggetto proprio il tentativo delle autorità comunali di estendere ai beni ecclesiastici tasse per le mura: è ciò che per esempio denuncia il noto canonista e autore della I Compilatio
135. Infra, Summa in tit. C. 10.32, § 86; il concetto è trattato più approfonditamente in Summa in tit. C. 10.52, §§ 53-57, dove la povertà, come condizione transeunte in cui può ver-sare un individuo, è fatta oggetto di una vera e propria quaestio, finalizzata a stabilire se deb-ba essere sottoposto ai munera anche colui che, inizialmente povero, si arricchisca in seguito illecitamente.
136. K a n t o r o w i c z, The King’s Two Bodies, pp. 208-213.The King’s Two Bodies, pp. 208-213., pp. 208-213.137. Cfr. quanto afferma V i o l a n t e (Le origini, p. 68, e I d., Imposte, pp. 104-105) in
relazione all’estimo di Pisa, alla costruzione delle mura di Ripafratta nel 1162 e alle prestanze forzate imposte agli abitanti di Cinzica per la fortificazione del loro stesso borgo nel 1164. Il ricorso all’imposizione di tributi straordinari, generati dalla necessità di costruire le mura, sono testimoniati almeno una volta anche nell’Alto Medioevo, se Lotario vi ricorse nell’846 per co-struire le mura della città leonina: C o r t e s e, Intorno alla causa, p. 367.
III.2.1. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLV
Bernardo Balbi nella biografia del vescovo pavese Lanfranco, il quale – rac-conta Bernardo – nel corso degli anni Novanta del 1100 si era scontrato con il comune di Pavia in conseguenza delle pressanti richieste subite dalla sua chiesa per il finanziamento delle fortificazioni cittadine.138 Lo stesso Concilio Lateranense III, pochi anni prima (1179), aveva esplicitamente menzionato i fossata come una delle motivazioni più frequentemente addotte dalle città al fine di imporre (indebite) tasse alla propriètà ecclesiastica.139 Che la questione sia stata dibattuta anche nelle scuole giuridiche sembra suggerirlo l’apparato della Glossa accursiana a un passo del Codex sui doveri fiscali della Chiesa (C. 1.2.7): spiegando infatti che, in base all’antica legge, la Chiesa era tenuta a versare imposte per la costruzione e manutenzione di strade e ponti, compare nella Glossa la significativa domanda se tra le motivazioni legittime potevano essere inclusi anche i lavori sulle mura (an ad muros civitatis?). E la risposta è senz’altro affermativa.140
Anche nella Lucca di Rolando le richieste di contributi per le mura agli enti ecclesiastici furono diffuse e misero talvolta persino in difficoltà le finan-ze di qualche monastero: nel 1208, per esempio, la badessa di S. Quirico di Casale fu apparentemente costretta a vendere proprietà del monastero al fine di pagare il datum murorum.141 Un documento degli stessi anni testimonia però che le tensioni fiscali non furono confinate, a Lucca, ai rapporti tra go-verno urbano ed enti ecclesiastici: nel 1206, infatti, i rappresentanti della al-lora neonata società popolare, dettando le nuove clausole da inserire nell’atto costitutivo della loro associazione (concordia), esortarono tutti i loro affiliati a non sottostare a prelievi straordinari o a prestanze richiesti dal podestà o dai consoli lucchesi, a meno che tali ufficiali non avessero prima reso esplicito,
138. La vicenda è ricostruita da A l b e r z o n i, Innocenzo III, pp. 837-845. 139. Si tratta del famoso canone 19 (citato ibid., p. 838 in nota): Sive quidem fossata sive
expeditiones sive quaelibet alia sibi arbitrentur agenda, de bonis ecclesiarum, clericorum et pauperum Christi usibus deputatis cuncta volunt fere compilari. Vedi infra, III.2.3., La tassazio-ne, per il ruolo dei fossata nelle liti tra il Papato e Modena (1204) e Lodi (1207). Per una disa-mina delle novità introdotte dal canone 19, F o r e v i l l e, Représentation, pp. 16-22.
140. Dopo avere chiarito che la Chiesa è tenuta a contribuire solo per le strade pubbliche e, in merito ai ponti, a lavori sia di costruzione che di manutenzione (ad C. 1.2.7: Ad instruc-tiones itinerum: an pro quolibet itinere faciendo? Responsum: non, sed pro illo scilicet publico per quod publice transitur. Pontium: de novo faciendorum vel etiam reficiendorum), la Glossa, per rispondere alla domanda sulle mura, rimanda infatti alla legge C. 10.49.3, secondo la quale: statuimus … omni excusatione cessante nullaque persona vel dignitate penitus excepta … mu-rorum constructionem … prout commodum atque necessarium magnitudo tua perspexerit, fieri. Cfr.: Corpus iuris civilis cum Commentariis Accursii, t. IV, col. 35.
141. S a v i g n i, Episcopato, p. 91; una questione analoga aveva coinvolto già, nel 1151, i monaci di S. Martino. Altri monasteri godettero di privilegi di esenzione concessi dal Papa o dalle stesse autorità lucchesi, come attesta, nel 1189, quello di S. Bartolomeo (ibid.).
CLVI Diritto pubblico tra Impero e città
nel proprio giuramento sui Vangeli all’inizio dell’incarico, l’impegno a spen-dere per le mura (in muris et pro muris lucane civitatis faciendo) le entrate cit-tadine. In altre parole, i rappresentanti popolari chiesero di ricorrere a prelievi straordinari per le mura solo qualora non fossero stati sufficienti, a coprire le spese, le entrate provenienti dai tribunali cittadini e da imposte indirette, quali quelle riscosse dalla dogana del sale e dagli approdi alle rive dei fiumi.142
Le testimonianze del nesso esistente tra lavori sulle mura e nuovi espe-rimenti fiscali non sono peraltro confinate all’Italia: il testo più antico in cui, a quanto ci risulta, si faccia riferimento a imposte patrimoniali proporzio-nali, vale a dire il documento del 1158 segnalato da Gouron per il castrum di Cailar, nei pressi di Arles, nella Francia meridionale, identifica proprio nelle mura la causa della nuova forma di prelievo;; sempre la stessa finalità (ad constructionem murorum) è quella che determina, nel 1204, la precoce introduzione dell’allibramento a Montpellier, e che verrà significativamen-te sostituita, nelle consuetudini di Carcassonne, da prelievi ad necessitates communes.143
Tutto ciò aiuta a comprendere la ragione per cui le mura occupino uno spazio così esteso nella Summa di Rolando:144 non può costituire una mera coincidenza cronologica l’imposizione a Lucca di una tassa per la costruzione di una nuova cerchia muraria che, come altrove, rappresentò la spinta verso una razionalizzazione del prelievo fiscale, con cui le autorità lucchesi si con-frontarono intensamente nei decenni a cavallo tra i secoli XII e XIII.145 Lo at-testa innanzitutto il primo censimento di beni che, sotto l’influenza dell’esti-mo realizzato a Pisa nel 1162, Lucca promosse intorno al 1182.146 La copertura
142. Il documento, analizzato già dal D e V e r g o t t i n i, Arti e “popolo”, è stato re-centemente valorizzato da S a v i g n i, Episcopato, p. 91 in nota, e da P o l o n i, Potere al popolo, pp. 127-135.
143. G o u r o n, L’“invention”, pp. 247, 257-258. 144. Cfr., per esempio, infra, Summa in titt. C. 10.24, § 8 (licet collatores ad operas
non cogantur, fallit in refectione viarum … item in Cesaris occursum et publicarum specie-rum transvectionem et murorum constructionem vel reparationem), C. 10.42, § 48, C. 10.49, §§ 13-24, 34, C. 10.32, §§ 67-68, C. 11.32, §§ 4, 12 (Vendit inquam civitas pro renovandis vel restaurandis publicis meniis, eo quod maxima est eius utilitas et ad tantam utilitatem et ipse Imperator confert terciam redditus qui ex fundis locisve illius civitatis fisco solet inferri). Per un riferimento tangenziale da parte di Piacentino, citato da Rolando, vedi anche Summa in tit. C. 10.25, § 5.
145. S a v i g n i, Episcopato, p. 91: la seconda cerchia muraria fu completata nel primo quarto del 1200.
146. Ibid., pp. 91-92. Benché Rolando non faccia riferimento nella Summa a tale impre-sa, sembra nobilitare indirettamente l’estimo attraverso un richiamo scritturale, ricordando per ben tre volte, nella sua opera, il censimento voluto da Augusto e narrato nel Vangelo di Luca, in conseguenza del quale Giuseppe si recò a Betlemme per farsi registrare. Cfr. infra, Summa in titt. C. 10.16, § 49, C. 10.22, § 2, C. 11.22, § 5.
III.2.1. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLVII
di diversi incarichi amministrativi (tra cui quello di responsabile del debito cittadino nel 1179), la profonda cultura romanistica e la conoscenza del siste-ma tributario di Pisa spingono anzi a chiedersi se non vi sia proprio Rolando tra le menti pensanti delle riforme attuate da Lucca in questi decenni. È certo comunque che, dato il ruolo svolto dalle mura nello sviluppo del sistema fi-scale cittadino, le argomentazioni teoriche avanzate dal giudice nella Summa siano tese a rafforzare la legittimità di tributi finalizzati a questo scopo. Il nes-so si coglie bene nel commento al titolo sui decurioni, il cui principale com-pito, ricorda Rolando, è quello di provvedere al buono stato della città e alla costruzione di una nuova cinta muraria (o restauro dell’antica), parallelamente all’impegno per la riscossione delle pubbliche imposte (providere statui civi-tatis/novos muros facere/publicas exactiones operam dare).147 Il discorso si approfondisce nel commento al titolo del Codice relativo agli “Oneri o paga-menti ai quali non è lecito sottrarsi” (C. 10.49), dove il giudice ricorda come i provvedimenti imperiali prescrivessero un tempo a chi amministrava le città o le province di prendersi cura delle strade, dei porti e delle mura, e infatti la terza parte dei proventi della res publica era stata devoluta, dagli imperatori Arcadio e Onorio, al restauro delle mura pubbliche (e dell’impianto di riscal-damento delle terme, opera che tuttavia a Rolando non interessa e per questo non menziona).148 Siamo nel medesimo brano della Summa in cui le mura vengono strategicamente definite sacre, evocando la già menzionata leggen-da della morte di Remo in conseguenza della violazione della cinta muraria di Roma.149
A guardar bene la struttura del commento di Rolando a questo titolo, la sacralizzazione che opera delle mura rientra in un progetto più vasto di le-gittimazione delle causae di tributi ai quali in nessun modo è lecito sottrarsi: il commento si apre infatti con il monito a tutti di non eludere il pagamento di qualsiasi imposta destinata all’Imperatore in occasione della sua venuta; dopo aver definito quest’ultimo dominus mundi, post Deum pater communis e vicarius Dei, sulla base da una parte del solito Vegezio, dall’altra del Nuo-vo Testamento e del Decretum di Graziano, il giudice ricorda al lettore che chi osasse sottrarsi al rispetto della maiestas imperiale, non conseguirà mai ricompense presso Dio.150 Il discorso si sposta poi sulle mura, per giungere in conclusione a concentrarsi su quella che è per Rolando l’altra fondamen-tale causa di tributi, vale a dire l’acquisto, il trasporto e la conservazione di frumento o altri beni di prima necessità per la cittadinanza. Anche in questo
147. Infra, Summa in tit. C. 10.32, §§ 67-68.148. Infra, Summa in tit. C. 10.49, §§ 18-19.149. Cfr. supra, III.1.2., Imposte e bene pubblico.150. Infra, Summa in tit. C. 10.49, §§ 7-12.
CLVIII Diritto pubblico tra Impero e città
caso è riscontrabile un ricorso intenso a fonti di legittimazione profane e sacre: Cicerone, spiega infatti il giudice, aveva ricordato nel De officiis che coloro che governano la res publica devono provvedere a che ci sia abbon-danza dei generi necessari per il sostentamento; allo stesso modo l’Impera-tore aveva un tempo ordinato al pretore della Pisidia di sincerarsi che le città d’Oriente versassero in una condizione di opulenza e che nulla mancasse ai loro abitanti; e se la città si fosse trovata in condizione di indigenza, l’Im-peratore avrebbe potuto introdurre una nuova imposta. Per far fronte al ri-schio della fame, conclude Rolando, è necessario quindi acquistare beni di sostentamento da mettere a disposizione della cittadinanza in caso di emer-genza, così come – ci racconta la Genesi – fece Giuseppe, riempiendo i de-positi del Faraone di beni che, successivamente, salvarono molti in tempo di carestia.151
La concentrazione di citazioni tratte da testi classici (Vegezio e Cice-rone), canonici (Decretum) e biblici, parallelamente agli usuali richiami del Corpus iuris, è straordinariamente elevata in questo brano della Summa, che sembra assolvere a una duplice funzione: definire un nucleo di tributi che si applicano universalmente a prescindere da privilegi di status, e stabilire che in tale categoria rientrano i prelievi finalizzati al bene della città. Un’operazio-ne, la seconda, che ben emerge dal raffronto tra il commento di Rolando e la fonte giustinianea dove, seppure vengano tangenzialmente menzionati i lavori sulle mura come causa d’imposta alla quale non è lecito sottrarsi, le città non risultano essere prese in considerazione affatto dalla legislazione imperiale, come prova anche l’assenza del termine civitas o res publica. Nel medesimo titolo del Codice (10.49) vi è però un terzo elemento che su Rolando esercita un’influenza del tutto speciale, l’idea che i suddetti tributi vadano da un lato riscossi su base patrimoniale, dall’altro calcolati proporzionalmente alle ric-chezze. Trattandosi di due fondamentali novità che compaiono nella fiscalità cittadina proprio nell’arco della sua vita, meritano entrambe di essere affron-tate in modo approfondito.
2.2. Prelievi sulle cose e non sulle persone
Per comprendere a fondo l’articolazione del panorama fiscale che pro-pone Rolando, occorre soffermarsi un momento sulle teorie circolanti nella seconda metà del XII secolo, cercando di capire qual sia, in materia di prelie-vo, lo status quaestionis al momento in cui scrive. È noto che, in occasione
151. Ibid., §§ 13-33. Questo passo della Genesi rappresenta uno dei principali riferimenti scritturali alle imposte e riveste importanza nelle teorie di sovranità medievale: S c o r d i a, “Le Roi doit vivre du sein”, pp. 55-56.
III.2.2. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLIX
della seconda Dieta di Roncaglia (1158), la fiscalità fu oggetto di confronto tra l’Imperatore e i rappresentanti della scienza e della prassi giuridica co-munale.152 Delle tre leggi che vennero formulate in quell’occasione, la lex Tributum rappresenta per noi una tappa fondamentale perché, nello sforzo di fornire all’Imperatore svevo un quadro delle imposte tardo-antiche, i giuristi bolognesi fecero probabilmente ricorso agli ultimi tre libri del Codice di Giu-stiniano che a quest’epoca – e forse proprio in tale occasione – cominciarono di nuovo a circolare dopo secoli di oblio.153 Come è ormai ampiamente dimo-strato, l’importanza di queste leggi, da un punto di vista politico, fu molto re-lativa, nel senso che non introdussero novità significative nei rapporti tra Fe-derico e le città, né segnarono di fatto l’applicazione, da parte imperiale, di un nuovo programma fiscale.154
Roncaglia rivestì invece un peso rilevante nello sviluppo degli appara-ti fiscali comunali, nel senso che il confronto dei rappresentanti cittadini da un lato con le pretese imperiali, dall’altro con le fonti romanistiche, contri-buì non solo, come abbiamo detto, alla costruzione di autonomi sistemi di prelievo urbani, ma all’introduzione di sostanziali novità.155 Basti ricordare che, a soli quattro anni di distanza (1162), Pisa cominciò a realizzare il più antico estimo di cui ci sia giunta notizia per l’Italia medievale, presto se-guito da una serie di analoghi esperimenti in molte altre città, toscane e non solo.156 E risulta difficile non mettere in relazione quel poco che sappiamo delle leggi di Roncaglia con questi cambiamenti, considerato che la legge Tributum si apriva con la distinzione tra prelievo su base personale e reale (tributum dabatur pro capite, tributum dabatur pro agro), una distinzione che sapientes bolognesi e di altre realtà urbane erano andati desumendo dal diritto pubblico giustinianeo, e che sicuramente contribuirono a mettere a frutto nelle rispettive città.
152. Si tratta però, come dimostrato da P o s t (Studies, pp. 80-86), più di un informale circolo di esperti che di veri e propri rappresentanti; per il loro ruolo nei lavori di Roncaglia, cfr. anche C o l o r n i, Le tre leggi, e, più recentemente, Q u a g l i o n i, Il diritto, G ö r i c h, Fragen, pp. 312-314.
153. C o n t e, Tres Libri, pp. 107-109, e I d., supra, II.2.1., Il rapporto.154. B o c c h i, Le imposte, pp. 274-277.155. Sul tentativo di Federico I di mettere a punto una sorta di “grossolano catasto” a Mi-
lano tra il 1162 e il 1166, dando vita a quello che nella cronachistica milanese venne definito come Liber tristium sive doloris, cfr. C a m m a r o s a n o, Le origini, p. 45.
156. Per Pisa, cfr. B a n t i, I brevi, pp. 49-51, V i o l a n t e, Imposte, pp. 107-110; per Firenze, F i u m i, L’imposta, pp. 334-337; per Siena, oltre allo stesso contributo di F i u m i, B i z z a r r i, Sull’epoca; per Lucca, S a v i g n i, Episcopato, pp. 91-92; per Faenza, V i o -l a n t e, Imposte, p. 108; per Volterra, F i u m i, L’imposta, p. 332; per Milano, B i s c a -r o, Gli estimi, e G r i l l o, L’introduzione; per Bergamo, N o b i l i, Alle origini; per Perugia, G r o h m a n n, L’imposizione;; per riflessioni generali sul tema, M a i n o n i, Finanza, 452-457.
CLX Diritto pubblico tra Impero e città
Tanto più che l’idea per cui le spese collettive andassero ripartite in pro-porzione ai beni circolava da tempo in campo ecclesiastico, dove i vescovi avevano messo a punto sistemi d’indagine di vario genere per stabilire i pro-venti delle chiese.157 Fin dall’Alto Medioevo, peraltro, la decima aveva costi-tuito un modello di regolarità e proporzionalità del prelievo.158 L’impossibilità di tassare la proprietà ecclesiastica per fuochi (che di fatto esprimevano unità familiari) fu anzi la causa per cui, secondo Bernardino Barbadoro, forme di imposizione su base reale, nella realtà fiorentina, fecero la loro prima compar-sa in ambito ecclesiastico, per poi essere adottate dall’amministrazione comu-nale al fine di tassare beni prima cittadini e poi del contado (senza tuttavia sop-piantare mai, in questi ultimi ambiti, sistemi di esazione su base personale).159 Testimonianze in questo senso provengono anche dalla Lucca di Rolando, dove, agli inizi del Duecento, il vescovo riscuoteva un’imposta simile (datum) dalle chiese della sua diocesi.160
Non sorprende dunque rinvenire, in opere dottrinarie degli stessi de-cenni, un’attenzione marcata verso la materia fiscale nel suo complesso e un interesse nuovo nei confronti dei cosiddetti munera patrimoniali. Nel se-gnalare l’importanza del menzionato documento di Cailar, che nel 1158 fece riferimento per la prima volta a un’applicazione proporzionale dell’imposta patrimoniale in Francia meridionale, Gouron ha richiamato l’attenzione su-gli autori più antichi che cominciarono a dedicare un certo spazio al discorso delle imposte, per i quali ha supposto una conoscenza di qualche genere del diritto pubblico romano, e dunque materialmente dei libri X-XII del Codi-ce.161 È importante tuttavia ricordare che il ragionamento in materia fiscale di tali autori, e segnatamente di Rogerio nella Summa Codicis e di Gugliel-mo da Cabriano nei Casus Codicis – ai quali si può accostare anche l’ano-nimo autore della Summa Berolinensis, di cui un frammento è stato edito da
157. B i s c a r o, Gli estimi, pp. 345-346, e F o r z a t t i G o l i a, Estimi; sulle prero-gative fiscali dei vescovi di Piacenza e Milano al confronto con ufficiali imperiali, cfr. M a i -n o n i, La “révolution fiscale”, pp. 229-230. Sui contatti tra forme di prelievo ecclesiastiche e secolari a cavallo dei secoli XII e XIII, cfr. le notizie fornite da C o n g a r (Quod omnes, pp. 217-218) in merito al progetto di Enrico VI di provvedere ai bisogni della Chiesa di Roma attraverso regolari imposte sulle chiese, ipotesi adombrata anche nello Speculum ecclesiae di Gerald of Wales, il quale, alla vigilia del IV Concilio Lateranense, progettò una serie di riforme di carattere anche fiscale: P o w i c k e, Stephen Langton, p. 83;; K a y, Gerald of Wales.
158. Per i riferimenti alla decima nelle Sacre Scritture e il loro significato: S c o r d i a, “Le Roi doit vivre du sein”, 63-66; per l’inquadramento della decima nel pensiero teologico della seconda metà del XIII secolo, M a r m u r s z t e j n, L’autorité des maîtres, pp. 155-165.
159. B a r b a d o r o, Le finanze, p. 51.160. S a v i g n i, Episcopato, p. 285, e cfr. pp. 296-299 per informazioni sulla ripartizio-
ne della decima nell’ambito della proprietà ecclesiastica lucchese. 161. G o u r o n, L’“invention”, pp. 250-255.
III.2.2. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXI
Luca Loschiavo162 – prese originariamente avvio non dai Tres Libri, ma dal titolo del Codice giustinianeo relativo ai privilegi della Chiesa e alle imposte dalle quali le terre ecclesiastiche andavano ritenute esenti o cui, viceversa, dovevano essere sottoposte (C. 1.2). Come a dire che, anche in campo dot-trinario, fu la questione della tassazione dei beni ecclesiastici da parte dei poteri laici a sollecitare, tra gli anni Cinquanta e Sessanta del XII secolo, le prime riflessioni dei glossatori in materia di imposte.163
Per quanto ne sappiamo, il più antico sforzo di sistematizzare in qual-che modo la materia fiscale è riconducibile a Rogerio, il quale presenta una doppia classificazione dei munera, qualificati da un lato in base al tipo di prestazione che implicano, dall’altro alla cadenza.164 Soffermiamoci per ora sulla prima definizione (cfr. infra, Tab. 1), il cui aspetto innovativo, come già sottolineato da Gouron, è il recupero della tripartizione del Digesto nella quale Arcadio Carisio (IV sec.) aveva un tempo distinto i munera in perso-nali, consistenti cioè in un’applicazione della mente e del corpo, senza per-dite materiali per chi li svolgeva; patrimoniali, che constavano di una spesa del patrimonio e comportavano quindi un detrimento economico per chi li subiva; misti, implicanti prestazioni sia del primo genere che del secondo.165 Rogerio coglie l’essenza di queste definizioni, che tuttavia riformula in ter-mini piuttosto semplici, equiparando i munera personali a prestazioni d’ope-ra manuali, quelli patrimoniali a pagamenti in moneta, i misti a prestazioni d’opera e pagamenti in denaro.166 La sua distinctio può essere resa schema-ticamente come segue:
162. L o s c h i a v o, Summa Codicis, pp. 157-192.163. Per l’influenza delle teorie di questi autori sul pensiero di Innocenzo IV, cfr. S c o r -
d i a, “Le Roi doit vivre du sein”, pp. 78-79, che ha valorizzato le idee espresse dal pontefice nella sua Lectura super quinque libros decretalium al titolo De immunitate ecclesiarum, senza tuttavia metterle in relazione al precedente dibattito civilistico.
164. Su Rogerio, G o u r o n, Sur les traces, I d., L’“invention”, C o r t e s e, Il diritto, II, pp. 105-111, 136-138; L a n g e, Römisches Recht, I, pp. 192-200.
165. D. 50.4.18.166. R o g e r i u s, R o g e r i u s, Summa Codicis, I.2, p. 51: Titulus: De sacrosanctis ecclesiis et rebus
et privilegiis earum: … In retinendo res proprias habet etiam ecclesia privilegium. Retinet enim res immunes ab extraordinariis et sordidis muneribus unde facienda est talis divisio munerum quod munus aliud dicitur personale, aliud patrimoniale, aliud mixtum. Personale, ut angaria, que in operiis manuum tantum constant. Patrimoniale, ut quod consistit in prestatione pecunie, ut sunt vectigalia tributa, ut cum negotiatores vocantur ad aliquam competentem prestationem et extraordinariam. Mixtum, ut sunt parangaria, que in opere prestatione et pecunie consistunt.
CLXII Diritto pubblico tra Impero e città
Tabella 1Rogerio, Summa Codicis in tit. 1.2 (metà del XII sec. ca.)
MUNERA
PERSONALI
(ut angaria, que in operiis manuum tantum constant)
PATRIMONIALI
(quod consistit in prestatione pecunie, ut sunt vectigalia
tributa)
MISTI
(ut sunt parangaria, que in opere prestatione et pecunie
consistunt)
possono inoltre essere divisi in:
MUNERA
ORDINARI
(ut sunt canonice illationes, ut tributa et vectigalia)
STRAORDINARI
(ut sunt collationes que fiunt ad instructionem viarum seu pontium)
Dignitosi (honesta) Svilenti (sordida)
ad pieta-tem, come la riscossione di imposte per strade e
ponti
ad publicam utilitatem,
come il tra-sporto di
derrate pub-bliche
MUNERA CUI È TENUTA LA CHIESA
ORDINARI STRAORDINARI
SIperché sia il privato sia l’ec-clesia sono tenuti a prestare
servizi come angaria, peran-garia et plaustra, dunque la Chiesa è tenuta a corrispon-dere tutti i munera ordinari
SVILENTI DIGNITOSI
NO ad pietatem ad publicam utilitatem
SI Solo in due casi: trasporto di derrate pubbliche e necessità
improvvisa
Se la sintesi rogeriana ha il pregio della chiarezza espositiva, non restituisce tuttavia la complessità della definizione del Digesto, soprattutto in materia di mu-nera personali, in nessun modo riducibili a mere prestazioni d’opera: come spie-gheranno a fondo, pochi decenni dopo, Pillio da Medicina e Rolando da Lucca, nei munera personali rientravano anche – e forse in primo luogo – tutte quelle cariche onorifiche e non che venivano svolte al servizio della collettività (amba-sciatore, giudice, esattore fiscale, etc.) o di privati (tutela e cura di inabili, etc.).
III.2.2. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXIII
Seppure l’interesse per la materia fiscale di cui dà prova Rogerio possa dunque costituire un indizio, come sostenuto da Gouron, della sua conoscenza del diritto pubblico romano – cosa che spingerebbe ad identificarlo con l’enig-matico R. autore delle glosse ai Tres Libri segnalate da Emanuele Conte in un manoscritto viennese (Wien Nat. Bibl. 2130)167 – la distanza che separa questo brano della sua Summa dalle opere successive dei grandi conoscitori dei Tres Libri è, a mio avviso, notevole. Il paragone con quest’ultime spinge persino a chiedersi se la fonte di Rogerio sia proprio l’originale passo del Digesto – dove l’elenco di cariche che dovevano esemplificare i munera personali non sembra affatto sintetizzabile nell’idea di prestazione d’opera manuale – e se, dunque, sia davvero identificabile con lui il misterioso R. autore di glosse ai Tres Libri, considerata la maggiore precisione terminologica e concettuale di cui tale giurista dà prova, quantomeno in materia di munera.168
È fuor di dubbio, invece, che il brano della Summa Codicis di Rogerio abbia ad oggetto privilegi e obblighi della proprietà ecclesiastica, e che dal relativo titolo del Codice giustinianeo (C. 1.2), più che dai Tres Libri, sembri profondamente ispirato sia nei contenuti che nella classificazione dei munera: è da qui che Rogerio trae materia per l’importante distinzione tra munera ordi-nari e straordinari, ed è in questo titulus che compare almeno una delle origi-nalissime causae impositionis messe in luce da Gouron, vale a dire la publica utilitas.169 Un’acquisizione importante, perché è proprio facendo leva sull’uti-lità pubblica che i giuristi comunali del XII secolo riescono ad inquadrare il pagamento dei tributi non più come mero segno di soggezione a un’autorità, ma come simbolo di appartenenza a una comunità. Mettere in dubbio la cono-scenza dei Tres Libri da parte di Rogerio non significa dunque sminuire l’im-portanza delle sue idee in materia fiscale, e in particolare del riferimento, nella classificazione tripartita, ai munera patrimonialia.170
Benché non sembrino in diretta comunicazione con il testo rogeriano, col-piscono le parole di un paio di autori a lui contemporanei (metà XII sec. ca.) i quali, pur non usando l’espressione munera patrimonialia, fanno riferimento ad imposte sulle terre proprio in relazione allo stesso brano del Codice commen-tato da Rogerio inerente alla proprietà ecclesiastica (C. 1.2.5): Guglielmo da Cabriano171 spiega infatti che, dalle prestazioni cosiddette svilenti (sordida mu-
167. G o u r o n, L’“invention”, p. 253; C o n t e, Tres Libri, pp. 100-101. G o u r o n, L’“invention”, p. 253; C o n t e, Tres Libri, pp. 100-101.168. Ibid., p. 101.169. Cfr. C. 1.2.10. Per una recente valorizzazione del pensiero pubblicistico di Rogerio
in materia di iurisidictio, cfr. C r e s c e n z i, Il problema, 225-227.170. Anche se, come rileva giustamente G o u r o n (L’“invention”, p. 253), l’aggettivo
patrimonialis non viene usato in D. 50.4.18, vi compare tuttavia il sostantitvo patrimonium e l’aggettivo ricorre in diverse occasioni nei primi nove libri del Codice: non rappresenta, in altre parole, un termine dal quale si può desumere la conoscenza da parte di Rogerio dei Tres Libri.
171. Sul quale, W a l l i n g a, The Casus.
CLXIV Diritto pubblico tra Impero e città
nera), sono esenti i fondi (predia) ecclesiastici, il che significa, afferma, che co-loro i quali servono Dio in quei fondi non devono essere sottoposti, per essi (pro hiis prediis), a tali prestazioni, né sottostare a richieste straordinarie in ragione di quei fondi (ratione prediorum).172 In termini non troppo diversi si esprime anche l’autore della Summa Berolinensis.173
Sebbene questi tre autori già parlino a metà del 1100 di imposte gravanti sulla terra, è davvero consistente la distanza che li separa da coloro che com-mentano i Tres Libri circa tre decenni dopo. Se le premesse di una nuova si-stemazione della materia sono gettate in parte già dal Piacentino († 1183?), è con l’opera di Pillio da Medicina († post 1213?) e Rolando che si realizza un vero e proprio scatto in avanti sia nella conoscenza delle fonti romanistiche di materia fiscale,174 sia, a ben vedere, nell’uso e contestualizzazione di queste nell’universo comunale. E ciò che consente tale avanzamento non è solo la ri-scoperta del diritto pubblico romano, ma la diretta conoscenza che entrambi questi giuristi devono avere acquisito dei nuovi sistemi di tassazione cittadini posti in essere a partire almeno dagli anni Sessanta del XII secolo.
Piacentino fornisce brevi e precise indicazioni sulla tipologia dei tributi nel mondo romano, ripartendo sostanzialmente dalla distinzione presentata dai bolognesi a Roncaglia: tributum … quandoque datur nomine capitis … quandoque nomine agri etc.175. Il suo principale interesse è tuttavia quello di denunciare i giuristi bolognesi per avere avallato le ingiuste pretese fiscali im-periali, nell’invettiva che molteplici studi hanno reso ormai celebre.176 Benché la generale questione dei doveri fiscali delle città o della Chiesa nei confronti dell’Imperatore resti viva nella Summa sia di Pillio che di Rolando, il massic-cio inserimento della materia tributaria in una prospettiva urbana determina, nelle opere di entrambi, l’apertura di un nuovo e fertilissimo fronte di rifles-sione. È in quest’ambito che la loro attenzione si focalizza su tre fondamen-tali questioni: la netta distinzione che separa i munera cosiddetti personali da quelli patrimoniali; la ripartizione di questi ultimi su base reale, e non perso-
172. Ibid., pp. 2-3, Ibid., pp. 2-3, ad C. 1.2.5, Placet rationabilis: … Predia ergo ecclesiastica sordido-rum munerum fece non vexantur, id est: persone Deo ibidem servientes pro hiis prediis predictis muneribus non subiuciuntur, vel etiam in hiis prediis nil tale presumitur. Set nec extraordina-Set nec extraordina-rium seu superindictum deinceps a predictis personis prediorum ratione exigitur.
173. L o s c h i a v o, Summa Codicis, p. 164, e cfr. p. 19 per la datazione dell’opera alla metà del XII secolo.
174. Vedi in proposito C o r t e s e, Il diritto, II, pp. 145-148.175. Per questo brano, citato integralmente da Rolando, cfr. infra, Summa in tit. C.10.16,
§§ 12-22; vedi anche Summa in tit. C. 10.17, §§ 4-8.176. C o n t e, Federico I, P e n n i n g t o n, The Prince, pp. 8-37, e L o s c h i a v o,
Summa Codicis, pp. 126-131, con ampia bibliografia di riferimento. Sul significato dell’invet-tiva di Piacentino, cfr. anche G ö r i c h, Fragen, pp. 314-317, il quale invita a distinguere ciò che effettivamente fecero i giuristi bolognesi nel 1158, dal significato che al loro operato venne retrospettivamente assegnato nei decenni successivi.
III.2.2. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXV
nale; l’adozione del criterio proporzionale nella tassazione dei beni. Ciò deri-va in primo luogo dal recupero, in tutta la sua complessità, della menzionata tripartizione offerta dal Digesto (D. 50.4.18) che classificava i munera in base alla prestazione che implicavano. La suddivisione tra imposizioni ordinarie e straordinarie non scompare, ma perde quella centralità che riveste nel pensie-ro degli autori di metà XII secolo e che, come vedremo, era molto legata alla tassazione delle terre ecclesiastiche.
Per Pillio, anche qualora una persona abbia un possesso in città, non è tenuta di norma a sottostare in essa ai munera se non possiede la qualifica di cittadino originario o residente; tuttavia, qualora si dia il caso di un munus im-ponibile solo a un possesso, tutti i possessori sono tenuti a sottostarvi, a pre-scindere dallo status di cives o residenti (cfr. infra, Tab. 2).177 Infatti, mentre molti possono sottrarsi ai munera personali, tutti devono sottostare a quelli patrimoniali, senza distinzioni relative all’età, al numero dei figli, alla digni-tà o al genere. Poco dopo questo passo, il giurista modenese riprende l’antica suddivisione tra imposte ordinarie e straordinarie,178 che non vengono più, tut-tavia, qualificate tali in conseguenza della causa che le genera – come in Ro-gerio (cfr. supra, Tab. 1) –, ma dell’autorità e del modo in cui sono indette (cfr. infra, Tab. 2): straordinarie devono essere infatti considerate, per Pillio, quelle imposte richieste senza preavviso dai magistrati, e ordinarie quelle prescritte invece da leggi o costituzioni imperiali, come le imposte patrimoniali e simili. Così si potrebbe rendere la classificazione di Pillio in forma schematica: 179
177. Infra, Summa in tit. C. 10.41, §§ 34-46, 50-51.178. Infra, Summa in tit. C. 10.46, §§ 6-8,179. La descrizione dei munera si trova in realtà, nell’edizione di Pillio a stampa, nella Sum-
ma al tit. C. 10.42. Rolando la cita integralmente inserendola tuttavia all’interno della sua Sum-ma al tit. C. 10.41, §§ 34-46, 50-51, di cui riporto qui di seguito i passi essenziali: De muneribus personarum: Munerum distinctio sive divisio multiplex est, quia munerum alia sunt personalia, alia patrimonialia, alia mixta. ‹35.› Item personalium alia sunt per que rei publice principaliter prospicitur, ut defensio civitatis, legatio ad census accipiendos et similia, alia non, ut tutela vel cura. ‹36.› Item patrimonialium, alia sunt patrimonialia et corporalia, alia non. ‹37.› Item alia possessionibus, alia personis imponuntur. ‹38.› Omnia tamen hec munera sic divisa sub uno no-mine continentur: universa enim civilia sive publica appellantur … ‹39.› Personalia munera illa dicuntur que animi provisione et corporalis laboris intentione sine aliquo gravati detrimento per-petrantur, ut tutela et cura … ‹40.› Patrimonialia vero munera sunt que maxime sumptibus patri-monii et dampnis administrantis expediuntur … ‹41.› Mixta vero munera illa dicuntur que partim corporali ministerio partim sumptu pecunie subeuntur, quapropter omnia personalia mixta fieri possunt; sed hii qui ea sustinent ex lege civitatis sue vel more de propriis facultatibus impensas fa-ciunt … ‹42.› Munera subire coguntur dumtaxat cives dumtaxat et incole; qui enim neque origina-lis neque incola est, licet domum vel possessionem in civitate habeat, munera tamen citra speciale privilegium civitatis sustinere non cogitur … ‹43.› Excipitur nisi sit tale munus quod possessioni tantum imponatur, quod omnes possessores subire oportet etsi neque cives neque incole fuerint … ‹44.› A muneribus personalibus multi excusantur et variis de causis ut dicetur inferius. ‹45.› Munera vero patrimoniorum omnes substinere sine delectu etatis, liberorum, dignitatis et sexus compelluntur. Per il testo integrale, cfr. infra, Summa in tit. C. 10.41, §§ 34-46, 50-51.
CLXVI Diritto pubblico tra Impero e città
Tabella 2Pillio da Medicina, Summa in tit. C. 10.41 (XII ex.)
MUNERA CIVILIA SIVE PUBLICA
PERSONALI
(que animi provisione et cor-poralis laboris intentione sine aliquo gravati detrimento per-
petrantur)
PATRIMONIALI
(que maxime sumptibus patri-monii et dampnis administrantis
expediuntur)
MISTI
(que partim corpo-rali ministerio par-tim sumptu pecunie subeuntur, quaprop-ter omnia personalia mixta fieri possunt)
Finalizzati alla res publica, come per es. la defensio civitatis o
missione volta alla raccolta
dei tributi e in-carichi simili
Non finaliz-zati alla res
publica, come tutela e cura
Alcuni sono indetti sulle
persone
Altri sono indetti sui possessi
Molte persone possono esserne esentate, e per varie cause
Fatta eccezione per i doveri di hospitalitas, da cui sono esentati
maestri d’arti liberali, dottori in legge, grammatici, oratores, medici e philosophi, tutti de-
vono sottostarvi, a prescindere dall’età, dai figli, dallo status e
dal genere
Ne sono esenti don-ne e minori, anche
se si tratta di munera ‹in parte› patrimo-
niali
Pillio da Medicina, Summa in tit. C. 10.46180 (XII ex.)
MUNERA PUBLICA
EXTRAORDINARIE COLLATIONES ORDINARIE COLLATIONES
Contributi imposti inaspettatamente dai magistrati, ai quali non sono tenuti colo-ro che godono di un’esenzione dai munera
publica
Contributi imposti per legge o per co-stituzione imperiale, quali le imposte patri-
moniali, da cui nessuno è esente
180. Passo citato da Rolando nella sua Summa al tit. C. 10.46, §§ 6-8: C. 10.46, §§ 6-8: ‹6.› Qui ergo pu-blici muneris vacationem habent, extraordinarias dumtaxat evitant collationes, idest ex im-
III.2.2. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXVII
Rolando condivide in pieno la prima parte del ragionamento di Pillio, che anzi espone in modo assai più approfondito, consentendoci di mettere a fuoco alcuni aspetti controversi. Ciò che lo interessa è stabilire che il criterio orga-nizzante del prelievo siano le terre e non le persone che le detengono: in una società che conosce un uso intensivo di concessioni fondiarie, dove una terra può essere assegnata e subassegnata ripetutamente nel giro di pochi decenni, è importante mettere al riparo le città dal rischio che concessioni progressive si trasformino di fatto in una diminuzione del gettito fiscale. Non a caso il giu-dice si appella a un principio tratto dal Decretum di Graziano, cosa che nella sua opera sembra avvenire spesso in sostegno di argometazioni nevralgiche:181 secondo quanto stabilito dall’antico Concilio di Coblenza nel X secolo, se un laico, un chierico, oppure qualsiasi altro uomo o donna, assegnava beni propri ad altri, non aveva alcuna facoltà di sottrarre la riscossione della decima alla chiesa cui era stata in origine assegnata.182 A tale regola affianca un’antica co-stituzione degli imperatori Antonino e Vero, tramandata dal Digesto, in base alla quale l’obbligo di pagare i tributi derivava dai fondi e non dalle persone, e i possessori erano pertanto responsabili anche delle insolvenze passate.183 Ciò si accorda bene, ai suoi occhi, a quanto sostenuto nel Codice giustinianeo in uno dei primi titoli dei Tres Libri, dove si affermava che, se la divina domus – cioè la domus imperiale accomunata, secondo le interpretazioni di alcuni, agli enti ecclesiastici184 – oppure chiunque altro si fosse rifiutato di pagare le
proviso a magistratibus indictas. ‹7.› Ordinarias vero, idest que a legibus vel constitutionibus Principum imponuntur, recusare non possunt, ut C. e. t. (C. 10.46.1), et ff. de mu. In honoribus § Qui publici (D. 50.5.8.3); ‹8.› et talia sunt omnia patrimoniorum munera et similia de quibus nemini licitum est se excusare, ut s. de mu. pri. (C. 10.42) diximus, et i. t. iii. dicemus inferius (C. 10.49) py.
181. Infra, Summa in tit. C. 10.19, § 37.182. Decr. Grat. C.16 q.1 cc.41-42: § 1. Decr. Grat. C.16 q.1 cc.41-42: § 1. Sed dicitur, predia monachorum, siue precio sint
empta siue pro salute animarum oblata, antequam in ius eorum uenirent, baptismalibus ec-clesiis siue quibuslibet aliis primicias et decimas persoluebant, illae autem ecclesiae suo iure priuari non possunt. Unde in Maguntiensi Concilio statutum inuenitur: Qui res suas alicui delegauerit, decimationum prouentum priori ecclesiae auferre non poterit: Si quis laicus, uel clericus, seu utriusque sexus persona, proprietatis suae loca uel res alicubi dare delegauerit, decimationum prouentum priori ecclesiae legitime assignatum inde abstrahere nullam habeat potestatem. Quod si facere temptauerit, talis traditio irrita prorsus ducatur, et ipse ad emenda-Quod si facere temptauerit, talis traditio irrita prorsus ducatur, et ipse ad emenda-tionem ecclesiastica coherceatur censura. Il riferimento a Magonza, nell’attuale edizione del Decretum, è frutto di confusione, trattandosi invece del c.8 del Concilio svoltosi a Coblenza nel 922: cfr. MGH Conc. 6.1, p. 70, e V i e j o - X i m é n e z, La Composición, p. 464 in nota.
183. D. 39.4.7: Papirius libro secundo de constitutionis: Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt in vectigalibus ipsa praedia, non personas conveniri et ideo possessores etiam praeteriti temporis vectigal solvere debere eoque exemplo actionem, si ignoraverint, habituros. L’idea in Rolando è supportata anche dalla legge C. 10.16.4 (Indictiones non personis, sed re-bus indici solent etc.) da lui valorizzata in Summa in tit. C. 10.16, § 6.
184. L’aggiunta della Chiesa, operata da Rolando, non è pacifica, perché dipendente dalla
CLXVIII Diritto pubblico tra Impero e città
imposte pubbliche per fondi acquisiti all’esterno di un’area urbana, tali pos-sessi avrebbero dovuto essere confiscati e assegnati alla curia della città sotto la quale si trovavano.185
Ed è così introdotto un secondo argomento di interesse vitale per Rolan-do, l’idea cioè che le terre situate nell’area di influenza urbana, a prescindere da chi le detiene, versano i tributi alla città che domina il territorio nel quale sono ubicate (cfr. infra, Tab. 3b). Si tratta di una rivendicazione importante, se consideriamo le difficoltà con cui a lungo si confrontarono le autorità co-munali per giungere a un’estensione sistematica delle imposte al contado.186 Un riferimento autobiografico rende cristallino il suo pensiero e svela allo stesso tempo le preoccupazioni da cui è animato: benché, afferma il giudice, egli sia lucchese e possieda terre nella giurisdizione pisana, non a Lucca, che è la sua patria, ma a Pisa, dove possiede il fondo, deve registrare fiscalmente le sue proprietà.187 Di conseguenza, come enunciato dal menzionato passo del Codice (C. 10.19.8), il fondo per il quale non vengono pagate le imposte va alla città che ha subito la perdita di questa entrata fiscale.188 La svalutazione dell’elemento personale è qui integralmente funzionale al rafforzamento di un’idea di territorialità del potere urbano, per aggirare il rischio che un certo status o la condizione di straniero del possessore possano tradursi in esenzioni dalle imposte cittadine sul contado.
E affrontando il nodo dei tributi dovuti dal territorio alla città Rolando fa appello, ancora una volta, a un fondamentale principio canonico, quello per cui le sedi provinciali devono prestare rispetto alla sede metropolitana cui
traduzione dell’espressione divina domus usata originariamente in C. 10.19.8: cfr. infra, III.2.3., La tassazione.
185. Infra, Summa in tit. C. 10.19, § 35, che parafrasa C. 10.19.8.186. Per il caso di Pisa, cfr. le considerazioni di V i o l a n t e, Imposte, pp. 110-111; per
i diversi tipi di prelievo fiscale nel contado senese all’inizio del XIII secolo: R e d o n, L’espa-ce, pp. 111-114;; per la svolta fiscale che, sotto la spinta razionalizzante del movimento politico “popolare”, si realizzò in molti comuni italiani intorno alla metà del XIII secolo, cfr. V a l l e -r a n i, L’affermazione, pp. 419-426.
187. Infra, Summa in tit. C. 11.58, § 19, passo già conosciuto dal N e u m e y e r, Die gemeinrechtliche Entwickelung, p. 93 in nota. La rilevanza della questione è ben visibile dalla frequenza con cui ricorre ancora nelle quaestiones disputate dai giuristi di fine Duecento, do-cumentate da B e l l o m o, Quaestiones in iure, tra le quali cfr., per esempio, l’incipit di due quaestiones di Francesco d’Accursio: Quidam de Aretio habebat quasdam possessiones in co-mitatu florentino. Modo florentini volunt eum extimare pro illis possessionibus quas habet Flo-rentie. Iste aretinus dicit quod non debet Florentie extimari quia pro omnibus suis bonis que habet solvit Aretio. Queritur quid iuris etc. (ibid., pp. 635-636); Quidam florentinus habet pos-sessiones in comitatu pisano. Commune pisanum vult quod ille florentinus solvat Pisis datium et factiones pro possessionibus illis. Florentinus dicit quod solvere non tenetur quia solvit Flo-rentie. Queritur quid iuris sit etc. (ibid., p. 298).
188. Infra, Summa in tit. C. 11.58, § 21.
III.2.2. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXIX
sono sottoposte.189 Ciò che lo attrae, in questo caso, è l’assetto gerarchico del-le istituzioni ecclesiastiche, ed in particolare il diritto di una sede superiore di ottenere la sottomissione di quella inferiore. Il giudice dà prova qui di un certo pragmatismo, caratteristico, in qualche misura, del suo modo di ragionare: la prospettiva statale del Corpus iuris civilis offre un sostegno teorico modesto alle pretese fiscali urbane sul contado, fatta eccezione per un paio di passi del Digesto, da lui sfruttatissimi, in cui viene menzionata la prerogativa di cui an-ticamente godevano alcune città di ricevere ogni anno un certo quantitativo di frumento da chi possedeva terre nel loro territorio.190 Ecco quindi che, per consolidare la legittimità di questa vitale pretesa urbana nel XII secolo, Rolan-do ricorre liberamente a una fonte canonica, poco importa se riferita, nel con-testo specifico del Decretum, all’obbligo di tutti i soggetti provinciali, sancito un tempo dal Concilio di Toledo, di osservare nel canto dei salmi il canone sta-bilito dalla sede metropolitana.191 Per inciso, Rolando definisce in questi passi la città, in rapporto al contado, come patria, termine che, dopo essere caduto in desuetudine per alcuni secoli, ricompare proprio nel linguaggio giuridico del 1100 nel campo delle rivendicazioni fiscali urbane, concordemente a quan-to osservava Ernst Kantorowicz nel famoso articolo Pro patria mori.192
Più complesso risulta invece stabilire qual tipo di imposta vada applicata al contado per Rolando. Non v’è dubbio che, tanto lui quanto Pillio, siano so-stenitori in generale delle imposte proporzionali, valutate cioè in base alle ric-chezze detenute dai contribuenti, come attesta l’uso, da parte di entrambi, di espressioni inequivocabili – quali: pro modo fortunarum idest possessionum
189. Infra, Summa in tit. C. 11.48, §§ 230-233.190. D. 50.4.18.25: Praeterea habent quaedam civitates praerogativam, ut hi, qui in ter-
ritorio earum possident, certum quid frumenti pro mensura agri per singulos annos praebeant: quod genus collationis munus possessionis est, citato per esteso da Rolando almeno tre volte: cfr. infra, Summa in titt. C. 10.42, § 47, C. 11.30, § 30, C. 11.49, § 14; cfr. anche Summa in titt. C. 10.39, § 58, C. 11.48, §§ 230-231, in cui è valorizzato il principio enunciato da Ulpiano (D. 50.15.4.2) secondo cui: Is vero, qui agrum in alia civitate habet, in ea civitate profiteri debet, in qua ager est: agri enim tributum in eam civitatem debet levare, in cuius territorio possidetur.
191. Decr. Grat. D.12 c.13 : Omnes prouinciales eundem in psallendo modum teneant, quem metropolitanam sedem habere cognouerint.: Item ex Concilio Tolletano. [XI. c. 3.] III. Pars. De his, qui contra Apostoli uoluntatem circumferuntur omni uento doctrinae, placuit san-cto concilio, ut metropolitanae sedis auctoritate coacti uniuscuiusque prouinciae ciues, recto-resque ecclesiarum unum eundemque in psallendo teneant modum, quem metropolitana in sede cognouerint institutum, nec aliqua diuersitate cuiusque ordinis uel offitii a metropolitana se pa-tiantur sede disiungi. Sic enim iustum est, ut inde unusquisque sumat regulas magisterii, unde honoris consecrationem accipit, ut iuxta maiorum decreta sedes, que uniuscuiusque sacerdota-lis dignitatis est mater, sit ecclesiasticae magistra rationis. Abbatibus sane indultis offitiis, que iuxta uoluntatem sui episcopi regulariter illis implenda sunt, cetera offitia publica, id est uespe-ram, matutinum, siue missam, aliter quam in principali ecclesia celebrare non liceat.
192. K a n t o r o w i c z, Pro patria mori, pp. 472-492.
CLXX Diritto pubblico tra Impero e città
… imponunt munera patrimonalia, o predicta onera … sunt patrimonialia, eo quod pro portione possessionis inducuntur, oppure civilia munera per ordi-nem, idest ordinate pro modo substantie, possessoribus indicenda sunt etc. – e la valorizzazione dei riferimenti normativi romani pertinenti.193 Non è chiaro tuttavia se il criterio territoriale, che secondo Rolando deve ispirare il prelievo urbano, rimandi nel suo pensiero a un uso diffuso di imposte su base reale e proporzionale nel contado, oppure ancora a una ripartizione pro capite. L’im-pressione è che pensi a un sistema combinato, che di fatto è quello testimo-niato da tutte le realtà comunali che siano state analizzate da un punto di vista fiscale nei decenni a cavallo dei secoli XII e XIII.194 L’intento di “tenere mano leggera sulla città e riversare sulla popolazione del territorio i maggiori one-ri”, caratterizzante fin dalle origini la politica fiscale urbana, rientra, secondo Gerolamo Biscaro, in quell’atteggiamento feudale che assume il Comune nei confronti del contado, che lo porta a riscuotere contributi richiesti a vario ti-tolo, in modo del tutto analogo a un signore con i propri sottoposti.195 Siamo nell’ambito di quella che Paolo Cammarosano ha descritto come “differenzia-zione dello status di cittadino da quello dei residenti del territorio rurale” che “… sul terreno delle imposte dirette, si manifestò ‹attraverso› la differenza sostanziale tra tributi annuali, dunque ordinari, che venivano imposti alle co-munità del territorio soggetto, e il prelievo dei cittadini, che mantenne sempre … un carattere di straordinarietà”.196
La questione degli obblighi contributivi del contado è affrontata in termi-ni piuttosto ambigui da Rolando, il quale, se da una parte afferma che la per-sona originaria della campagna, pur dovendo reputare sua patria la res publica nella cui amministrazione si trova il podere o borgo in cui vive, non è tenuta ad oneri e onori della città,197 dall’altra non sembra includere negli oneri le im-poste sulla terra: chiedendosi infatti più esplicitamente in che posizione si tro-
193. In particolare della legge C. 10.42.1, citata e commentata da Pillio in un passo della sua Summa inglobato da Rolando (infra, Summa in tit. C. 10.43, §§ 61-63), e da Rolando stesso (ibid., §§ 64-66); per le espressioni citate nel testo, cfr. inoltre Summa in titt. C. 10.42, § 50, C. 10.49, § 36. Sui riferimenti normativi, vedi anche G o u r o n, L’“invention”, pp. 248-249.
194. Per la varietà di forme contribuitive che potevano essere messe in atto contempora-neamente e sullo stesso territorio da alcuni comuni, cfr. le testimonianze relative a Piacenza e a tante altre città dell’Italia settentrionale analizzate da M a i n o n i, Sperimentazioni, passim, e a Bergamo, approfondite da N o b i l i, Alle origini, pp. 4-12.
195. B i s c a r o, Gli estimi, p. 344. Per le forme di prelievo nei patrimoni fondiari si-gnorili e le novità amministrative che vi compaiono già a partire dall’inizio del XII secolo, cfr. C a r o c c i, Signoria rurale, I d., Le lexique.
196. C a m m a r o s a n o, Le origini, pp. 43-44, e cfr. pp. 47-48.197. Alla stessa idea fa riferimento anche Pillio da Medicina (infra, Summa in tit. C.
10.39, § 17), ma per dimostrare che, essendo egli nato a Medicina, sottoposta a Bologna, poteva lecitamente definirsi (iure meritoque!) bolognese.
III.2.3. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXXI
vino gli abitanti del contado rispetto ai doveri fiscali, afferma che, benché essi non siano sottoposti agli stessi obblighi dei residenti in città, devono pagare a quest’ultima i tributi per le loro terre.198 La stessa ambiguità compare in un altro passo della sua opera, in cui sfrutta apparentemente la contrapposizione esistente nelle fonti romane tra cives e provinciales per inquadrare fiscalmente la popolazione rurale. Se in teoria si allinea infatti alla prescrizione del Codice che vietava la richiesta di prestazioni d’opera agli abitanti delle province,199 asserendo che anche i rustici erano tenuti solo alla corresponsione del testati-co e dell’annona,200 svuota di fatto il senso di questo comando stabilendo una serie di eccezioni in cui tale regola viene meno; e si tratta di eccezioni relative a richieste dettate da quel nucleo di causae che ormai abbiamo messo bene a fuoco, svolgenti in Rolando la funzione di rendere universale l’applicazione delle imposte, per aggirare fasce di esenzione o privilegio: la manutenzione delle strade, il transito dell’Imperatore, il trasferimento di merci pubbliche, la costruzione e manutenzione delle mura, il trasporto di viveri all’esercito, l’edificazione di fortificazioni necessarie.201
2.3. La tassazione dei beni ecclesiastici: fonti antiche, interpretazioni nuove
Il clima politico a cavallo dei secoli XII e XIIILa questione della tassazione dei beni ecclesiastici da parte dei poteri
laici, ricorrente nel corso del Medioevo, assume un profilo completamente nuovo durante il XII secolo sia nell’ambito dei nascenti regni nazionali,202 sia nell’esperienza cittadina. In Italia centro-settentrionale, le principali novità si verificano sul fronte laico, dato che le aspirazioni pubblicistiche dei comuni passano in primo luogo per lo sforzo di dare vita a forme di prelievo costan-
198. Infra, Summa in tit. C. 10.39, § 58: Quid autem de hiis qui in territorio civitatis mo-rantur? Certe non sicut civitatis illius incole ad eius munera astringentur, … licet in territorio eius nati illam civitatem debeant suam patriam reputare … et eorum predia in illam civitatem relevent tributa in cuius territorio possidentur … ; cfr. anche ibid., § 22.
199. C. 10.24.1.200. Cfr. infra, Summa in tit. C. 10.24, §§ 3-4: Quicquid enim provinciales debeant con-
ferre, non tamen operas cogantur prestare, et hoc ad prefecti qui ibi preest pertinet officium … Nam et rusticana plebs extra civitates posita, que suam capitationem intulit et annonam con-gruam dedit, ad nullum aliud obsequium est vocanda, … quia preter publicum censum iustum et legitimum ad alia non sunt cogendi; l’accostamento ai provinciales è rafforzato dal contenuto della legge che Rolando cita in sostegno dei diritti della rusticana plebs extra civitates posita, in cui si fa riferimento agli abusi fiscali subiti dai provinciali (C. 10.61.2).
201. Infra, Summa in tit. C. 10.24, §§ 8-9.202. Per la realtà francese e le discussioni teologiche tardo-duecentesche in proposito, cfr.
S c o r d i a, “Le Roi doit vivre du sein”, pp. 103-121.
CLXXII Diritto pubblico tra Impero e città
ti che consentano di finanziare la politica cittadina. A tal fine, come abbiamo visto, le città cominciano ad affinare gli strumenti esattivi ed in particolare a valorizzare le imposte patrimoniali da applicare al territorio più o meno vasto sul quale hanno stabilito il proprio dominio. Considerato però che una parte molto consistente del patrimonio fondiario del contado appartiene ancora, nel 1100, alla Chiesa, si delinea da subito il problema di come tassare beni che in nessun modo le città intendono vedere sottratti al proprio gettito fiscale.203
Le decisioni assunte dal Concilio Lateranense III nel 1179 testimoniano bene la fase matura cui sono giunte ormai tali tensioni, destinate tuttavia ad aumentare ancora nei decenni a venire. Gli studi dedicati ai rapporti tra Papa-to e città dell’Italia settentrionale in questa epoca204 aiutano a mettere a fuoco i veri obiettivi polemici che si trovano dietro le minacce dei canoni espressi dal Concilio voluto da Alessandro III (1159-1181), ed in particolare del noto canone 19: in esso, condannando l’operato di rettori e consoli delle città, col-pevoli di vessare i beni ecclesiastici ricorrendo ai più svariati pretesti, si mi-nacciava di anatema chi avesse continuato a ricorrere a tale pratica, salvo il caso in cui il vescovo e il clero non si fossero trovati di fronte a bisogni così grandi da stimare necessari contributi da parte delle chiese – da riscuotere senza costrizione e solo qualora fossero state insufficienti le risorse dei laici – per venire incontro ad esigenze collettive.205 Nei fatti, però, già il pontificato di Lucio III (1181-1185) dimostra che tale canone non rappresentò altro che il tentativo di tappare con un dito la falla che si era ormai aperta nella diga.206 Anzi, benché il canone 19 mirasse a contrastare un’estensione indiscrimina-ta degli oneri fiscali alle chiese, ottenne in parte il risultato opposto perché, avendo stabilito delle circostanze eccezionali in cui tali oneri potevano essere leciti, ne legittimò di fatto l’imposizione.207
203.Sul problema è tornata di recente B a i e t t o, Il Papa, pp. 10-15. I rapporti delle sin-gole città con la proprietà ecclesiastica del contado sono in realtà molto complessi, se pensiamo per esempio all’uso estensivo che Pisa fece di terre ecclesiastiche come pegni per i propri cre-ditori nella seconda metà del XII secolo: V i o l a n t e, Le origini, pp. 77-80.
204. M a c c a r r o n e, “Cura”; A l b e r z o n i, Innocenzo III; A m b r o s i o n i, Le città; B a i e t t o, Il Papa.
205. Quocirca sub anathematis districtione severius prohibemus ne de cetero talia prae-sumant attentare nisi episcopus et clerus tantam necessitatem vel utilitatem aspexerint ut ab-sque coactione ad relevandas communes necessitates ubi laicorum non suppetunt facultates subsidia per ecclesias existiment conferenda: Conciliorum oecumenicorum decreta, p. 197. Il canone prendeva essenzialmente in considerazione l’Italia comunale: M a c c a r r o n e, “Cura”, pp. 172-173. Dello stesso tenore sono gli altri canoni segnalati da A m b r o s i o n i, Le città, p. 380 in nota.
206. Cfr. gli scontri del Papa con Modena e Lodi negli anni 1182/1183, e i tanti altri con-flitti menzionati da A m b r o s i o n i, ibid.
207. F o r e v i l l e, Représentation, pp. 17-18; a un’impressione analoga giunge anche M a c c a r r o n e, “Cura ”, pp. 175-176.
III.2.3. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXXIII
I toni del conflitto si alzarono decisamente durante il Papato di Innocen-zo III (1198-1216), il quale da un lato accentuò il valore eversivo dei tentativi messi in atto dai comuni di imporre tributi alle chiese e al clero locali, confi-gurandoli sempre più come attacchi alla libertas ecclesiastica;208 dall’altro ac-centrò su sé stesso il ruolo quasi di “controparte dei regimi comunali in merito alla politica di tassazione imposta agli ecclesiastici”.209 Ciò avvenne in conse-guenza anche della fine della sintonia tra episcopato e potere imperiale che, da un punto di vista strettamente fiscale, lasciava le chiese più esposte alle nuove pretese cittadine. Basti ricordare il monito lanciato a città e castelli da Federi-co Barbarossa a Roncaglia, di non riscuotere dalle chiese illicitae exactiones, pena il pagamento del doppio di quanto fosse stato ingiustamente riscosso.210 Nei fatti, però, la politica imperiale non fu molto diversa, se nel 1186 Urbano III (1185-1187) accusava tanto Federico quanto Enrico di vessare alcune chie-se della Lombardia, della Tuscia e del Ducato di Spoleto.211
Gli esempi concreti del nuovo clima che comunque si respirò a partire già dai primissimi anni del XIII secolo sono molteplici: tra il 1200 e il 1201 Innocenzo III si scontrò con Novara, Verona e Cremona per i tributi che avevano imposto alle chiese cittadine;212 nel 1203 la questione aveva assun-to proporzioni tali in Lombardia da indurlo ad inviare un precetto a tutte le autorità comunali della regione in cui, ordinando ancora una volta la cessa-zione delle imposizioni fiscali urbane ai danni del clero, ribadiva i principi stabiliti nel III Concilio Lateranense, vale a dire: legittimità di un contributo ecclesiastico solo se volontario e se richiesto in situazioni di eccezionale ne-cessità in cui le risorse dei laici non fossero state sufficienti.213 A distanza di neppure sei mesi il problema tuttavia riemerse a Bergamo, accusata dal Papa di non saper distinguere tra sacro e profano per aver previsto la tassazione dei beni non solo di tutte le chiese, ma anche dei loca religiosa situati in città e nella diocesi, cui erano stati applicati criteri di stima proporzionali alle fa-coltà dei contribuenti, tra i quali venivano espressamente inclusi i chierici.214
208. Per l’accezione specifica che assume tale espressione nel suo pontificato, ibid., p. 173; A l b e r z o n i, Innocenzo III, pp. 847-848; B a i e t t o, Il Papa, pp. 12-15.
209. A l b e r z o n i, Città, Introduzione.210. Illicitas etiam exactiones maxime ab aecclesiis, quarum abusio iam per longa tem-
pora inolevit, per civitates et castella omnimodis condempnamus et prohibemus; et si facte fuerint, in duplum reddantur (Constitutio pacis, 1158): MGH DD F I 1, p. 246, § 9, su cui vedi anche B a r b a d o r o, Le finanze, pp. 6-7.
211. A l b e r z o n i, Innocenzo III, pp. 848-849.212. Ibid., pp. 860-865; B a i e t t o, Il Papa, pp. 15-23.213. M a c c a r r o n e, “Cura”, pp. 175-176; B a i e t t o, Il Papa, pp. 23-24.214. Innocentii III Romani Pontificis Regestorum sive Epistolarum Liber Sextus, n. 184
= P.L. vol. 215, coll. 201-202: … sane, sicut ex litteris multorum accepimus, Pergamenses in-ter sanctum et profanum nullatenus distinguentes, ut Pergamensem ecclesiam ancillarent et
CLXXIV Diritto pubblico tra Impero e città
Come per Novara, anche in questo caso Innocenzo era particolarmente pre-occupato dalla condizione di servitù in cui ai suoi occhi si veniva a trovare la chiesa bergamasca (letteralmente: Pergamenses … ecclesiam ancillarent et subiacerent liberam servituti) in conseguenza dell’imposizione di tributi che da un punto di vista giuridico simboleggiavano soggezione.215 L’anno successivo (1204) fu la volta di Modena, condannata per aver sottoposto a tributi pubblici la chiesa cittadina, sottomettendo i chierici a esazioni e a prestazioni d’opera per lo scavo di fossati.216 A partire dallo stesso anno, il Papa aprì un lungo scontro con Piacenza (1204-1207), volto ad ottenere la fine delle imposizioni fiscali ai danni di clero e vescovo.217 Il Concilio La-teranense IV (1215) formalizzò le istanze portate avanti da Innocenzo III, senza tuttavia introdurre sostanziali novità rispetto al 1179: nuovo apparve solo il rafforzato ruolo del pontefice, il quale doveva essere d’ora in avanti consultato per imposizioni fiscali sul clero da parte dei poteri laici, motivate da ragioni di pubblica utilità e necessità.218
Gli esempi si potrebbero moltiplicare ma sono in realtà sufficienti a de-lineare lo sfondo politico-ideologico su cui si muove Rolando da Lucca, per il quale l’imposizione di tasse patrimoniali ai beni ecclesiastici rappresenta uno dei grandi nodi problematici affrontati nella sua opera. Accingendoci ad esaminare il pensiero di un giudice filo-imperiale, attivo in una delle città che mantenne legami più saldi con gli Svevi, potremmo essere erroneamente spinti a considerare la sua avversione ai privilegi ecclesiastici come il portato di tali fattori. I casi addotti, invece, tratti spesso da comuni che intrattennero
subiacerent liberam servituti, receptis et perlectis litteris nostris, quas super ecclesiarum im-munitate, tam eis quam Lombardis aliis nos meminimus destinasse, possessiones non solum ec-clesiarum omnium, sed universorum religiosorum locorum quae sita sunt in civitate vel diocesi Pergamensi, pro suae voluntate arbitrio aestimantes, ab eis duodecim denarios, et a clericis quindecim pro libra qualibet exegerunt. Per la ricostruzione della vicenda, cfr. A l b e r z o n i, Innocenzo III, pp. 872-880 e, recentemente, N o b i l i, Alle origini, pp. 8-9.
215. Cfr. quanto affermo supra, III.2.1., “Cessante causa”, in merito alla massima canoni-sta secondo cui praestatio tributi probat subiectionem; per il dibattito dottrinario in proposito, cfr. C o n t e, Servi, pp. 124-127.
216. Innocentii III Romani Pontificis Regestorum sive Epistolarum Liber Sextus, n. 184 = P.L. vol. 215, col. 323, n. 41: … se dolet ecclesia Mutinensis, dum eius filii, subacti iugo pessi-mae servitutis, publicis functionibus fatigantur, patent violentiae laicorum, gravantur exactio-nibus, et angariis et perangariis opprimuntur. … Mutinensis potestas … oneribus … superaddit onera graviora. Nam non solum clericis exactionibus subiacere, ac effodiendis fossatis servire compellit, sed etc.: sulla vicenda, A l b e r z o n i, Innocenzo III, pp. 880-882, e cfr. ibid., p. 906, per un altro caso (Lodi, 1207) di imposizione fiscale a un monastero per costruire fossata.
217. M a c c a r r o n e, “Cura”, p. 176.218. Così secondo la cost. 46 del IV Concilio Lateranense, la cui introduzione in Francia,
un’ottantina d’anni dopo, da parte di Bonifacio VIII, fu alla base dgli scontri con Filippo il Bel-lo: F o r e v i l l e, Représentation, pp. 21 e sgg., M a c c a r r o n e, “Cura”, p. 179.
III.2.3. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXXV
buoni rapporti con il Papato, testimoniano che l’imposizione di tasse al clero e alle chiese fu una questione urgente per il mondo comunale nel suo comples-so, e che l’esigenza di affrontarla, da un punto di vista teorico, scaturì da una coscienza civica assai più che dall’adesione a una parte.
Come abbiamo visto in relazione al tema dei tributi dovuti dai milites,219 anche la questione della tassazione dei beni ecclesiastici viene trattata da Ro-lando a varie riprese, giacché, a un nucleo originario e piuttosto coerente di idee sui doveri fiscali della Chiesa, databile alla metà degli anni Novanta del XII secolo, si giustappone una cospicua serie di aggiunte composte nei decen-ni successivi. In assonanza alle abitudini dell’epoca, il nuovo materiale non sostituisce il precedente, ma lo integra innovandolo profondamente. L’impres-sione generale è che la nuova sistematicità con cui le città comunali tentano di imporre tributi alle chiese e, allo stesso tempo, le grandi battaglie intraprese da Innocenzo III nei primi anni del 1200 per opporvisi, spingano Rolando se non a un ripensamento delle tesi sostenute in un primo momento, quantomeno a una serrata argomentazione dei loro contenuti.
È certo comunque che l’attualità della questione imponga al giudice un gran rigore interpretativo, sollecitato anche da importanti dibattiti dottrinari coevi aventi ad oggetto il significato da attribuirsi ad alcune antiche parole o espressioni del testo giustinianeo. Ed in questa riflessione linguistica dà sfog-gio di possedere una certa familiarità con la dialettica, strumento argomenta-tivo fondamentale del pensiero scolastico in campo sia filosofico-teologico, che giuridico. Tiene fede così a quel principio che gli sta a tal punto a cuore da menzionarlo nelle prime righe del proemio alla Summa dove, giustificandosi retoricamente con i suoi lettori per l’alta impresa che si accinge a compiere (il commento ai Tres Libri), si dichiara cosciente del rischio, nel quale un auto-re potrebbe incorrere, di allontanarsi dalla verità non mettendo a confronto i contrari, come invece è doveroso fare (ne quivis compositor … sic a veritate deviet non allegando ut decet contraria).220 Ed è proprio questa ispirazione dialettica a conferire particolare interesse ad alcuni passi dell’opera nei quali Rolando non si limita all’esposizione di quella che egli reputa essere la cor-retta interpretazione delle fonti antiche, ma si impegna a restituire nella sua interezza l’oppositio di contrari da cui si sviluppa la scientia.221 Ciò non av-viene, nella Summa, solo in tema di tassazione dei beni ecclesiastici – sebbene il confronto tra posizioni contrapposte sia particolarmente vivace in proposi-
219. Supra, III.1.1., Fiscalità e militia.220. Infra, Summa, Prooemium, § 7.221. Cfr. quanto afferma supra, C o n t e, I.1.3., La circolazione professionale, per lo
stretto legame esistente, nell’esposizione di Rolando, tra astratta ispirazione dialettica e concre-ta argomentazione processuale.
CLXXVI Diritto pubblico tra Impero e città
to – , ma nella trattazione di molte altre materie, quali ad esempio i doveri fi-scali dei milites, la liceità dell’esercizio di poteri giurisdizionali da parte delle donne, le regole del consenso.222 L’impressione è anzi che, nonostante l’im-postazione ‘aperta’ caratterizzi in buona misura tutta la Summa, il ricorso ad esposizione dei contrari si faccia più intenso quando si affrontano le questioni maggiormente spinose e attuali. L’esenzione dalle imposte patrimoniali è una di queste, e per contrastarla Rolando costruisce una sorta di virtuale dibattito volto a vanificare gli argomenti di coloro che tentano di legittimarla. Il com-mento al titolo dedicato ai munera patrimoniorum (C. 10.42) è così scandi-to dalle espressioni secundum quosdam/dicunt quidem/dicunt etiam etc., cui puntualmente si contrappongono i suoi sed hoc non placet/sed contra puto/sed hodie puto etc.
La difficile interpretazione della costituzione Placet rationabilis (C. 1.2.5)Nella discussione sugli oneri fiscali spettanti alle chiese, il punto di par-
tenza non poteva essere che quella stessa costituzione Placet rationabilis for-mulata agli inizi del V secolo dagli imperatori Teodosio e Onorio (C. 1.2.5), che nella riflessione dottrinaria medievale precedente a Rolando abbiamo vi-sto sollecitare le prime e timide riflessioni sulla fiscalità.223 L’antica norma si prefiggeva di definire da quali necessitates le chiese cittadine dovevano con-siderarsi immuni, stabilendo che:
“non possono essere imposti oneri svilenti ai fondi dedicati al culto, né essere ri-chiesto alle chiese alcun contributo straordinario e aggiuntivo …;; non deve esse-re insomma aggiunto, ai doveri fiscali delle chiese, alcun pagamento che esorbiti dalla regolare tassa che impone un improvviso gravame, dettato da un’esigenza imprevista”.224
222. Cfr., rispettivamente, supra, III.1.1., Fiscalità e militia, e infra, III.3.1, Dalla fiscalità, III, 3.3., La donna medievale.
223. Supra, III.2.2., Prelievi sulle cose.224. Traduzione libera della legge che qui di seguito riporto per intero: C. 1.2.5: Impe-
ratores Honorius, Theodosius: Placet rationabilis consilii tenore perpenso destricta modera-tione praescribere, a quibus specialiter necessitatibus ecclesiae urbium singularum habeantur immunes. Prima quippe illius usurpationis contumelia depellenda est, ne praedia usibus cae-lestium secretorum dedicata sordidorum munerum faece vexentur. Nihil extraordinarium ab hac superindicticiumve flagitetur, nulla translationum sollicitudo gignatur, postremo n i h i l p r a e t e r c a n o n i c a m i l l a t i o n e m, q u a m a d v e n t i c i a e n e c e s -s i t a t i s s a r c i n a r e p e n t i n a d e p o p o s c e r i t, eius functionibus adscri-batur. Si quis contra venerit, post debitae ultionis acrimoniam, quae erga sacrilegos iure pro-menda est, exilio perpetuae deportationis uratur. L’espressione nulla translationum sollicitudo gignatur, che potrebbe sembrare a prima vista riferirsi all’esenzione della Chiesa dai servizi di trasporto, allude, secondo la Glossa accursiana, al fatto che le terre ecclesiastiche non dovevano temere la confisca da parte del fisco in caso di mancato pagamento dei tributi (ad C. 1.2.5: …
III.2.3. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXXVII
Da questa sommaria traduzione già emerge la complessità di un provve-dimento che poteva dare – e diede in effetti – adito a molteplici dubbi, come attestano quantomeno tre grandi discussioni dottrinarie che, direttamente o in-direttamente, presero avvio, nel XII secolo, dal suo dettato:
I) cosa doveva intendersi strettamente per proprietà ecclesiastica; II) la distinzione tra tributi ordinari e straordinari; III) l’assimilazione dei beni ecclesiastici al regime fiscale un tempo vigente
per quelli imperiali.
I) Il primo dubbio che lasciava aperto la legge era cosa dovesse intendersi per ‘fondi consacrati al culto’ (usibus caelestium secretorum dedicata), se cioè l’esenzione da prestazioni di vario genere fosse confinata ai beni della chiesa destinati alla celebrazione della messa, o si estendesse alla proprietà ecclesia-stica in generale, e se spettasse anche a persone e beni del clero. Nella breve disamina sopra presentata di alcuni conflitti con i comuni verificatisi nel corso del pontificato di Innocenzo III, abbiamo avuto modo di vedere la rilevanza di questa distinzione: le citate lettere a Bergamo e a Modena attestano infatti che, se le città ricorsero usualmente alla tassazione dei chierici e, in taluni casi, alla richiesta persino di prestazioni d’opera, il pontefice reputò tali pratiche alta-mente illegittime.225
Intorno alla metà del XII secolo, Guglielmo da Cabriano aveva dedicato poche ma importanti parole a tale questione, sostenendo, in forza di una più antica legge di Costantino – secondo la quale in nessun caso i beni del clero erano da considerarsi esenti dai doveri fiscali –, che potevano essere confiscati i fondi privati dei chierici per i quali non fossero stati pagati tributi.226 L’idea, condivisa dal Piacentino,227 se era parsa forse pacifica a Rolando in un primo
id est non timeat ecclesia, nec sit sollicita, quod transferatur in fiscum praedium ob cessatio-nem tributorum etiam debitorum, nedum indebitorum: Corpus iuris civilis cum Commentariis Accursii, t. IV, col. 34).
225. Cfr. supra, pp. CLXXIII-CLXXIV, in nota. La richiesta di prestazione d’opera ai chierici non era un’esclusiva dei comuni italiani, se intorno alla metà del XII secolo veniva espressamente proibita nell’opera di origine provenzale Lo Codi: Et talem libertatem habet Ec-clesia et res ecclesie quod non cogitur facere multas res preter usaticum de quibus esset coacta alia persona, sicut sunt officia extraordinaria, sicut esset facere fossam in villa vel in castro vel in nocte custodire civitatem vel facere alia similia istis: Lo Codi, p. 2.
226. W a l l i n g a, The Casus, pp. 2-3, ad C. 1.2.5, Placet rationabilis: … predia, que sunt clericorum propria, transferuntur si tributa non persolvantur, ut infra de epis. et cler. l. iii.
227. P l a c e n t i n u s, Summa Codicis, II, De sacrosanctis ecclesiis, p. 4: Item, licet praedia clericorum propter cessationem tributorum infiscentur, non tamen praedia ecclesiarum transferuntur, ut C. de epis. l. De his et C. eo. l. Placet.
CLXXVIII Diritto pubblico tra Impero e città
momento,228 richiese invece un suo ulteriore e più approfondito intervento nel-la seconda versione della Summa (post 1197-1234), quando egli doveva per forza essere giunto a conoscenza quantomeno di alcuni degli scontri portati avanti da Innocenzo III. Nella seconda redazione dell’opera afferma a chia-re lettere che, gli unici fondi per i quali la Chiesa non deve sottostare ai tributi sono quelli destinati all’eucaristia: tutti gli altri fondi, sia dei chierici, sia delle persone ecclesiastiche, sia delle chiese, sono invece tenuti a versare imposte pa-trimoniali e pertanto passibili di confisca.229 Il significato che Rolando attribui-sce alla vaga definizione di predia ad heucaristie confectionem dedicata – con cui traduce l’antica e ancor più indefinita espressione del Corpus iuris “fondi consacrati alle esigenze dei misteri celesti” – non è chiarissimo: è possibile che, con tali parole, non intenda riferirsi ai luoghi della celebrazione del culto, quan-to piuttosto a quelle terre dedicate alla coltivazione del frumento e della vite, dalle quali cioè materialmente derivavano pane e vino per l’eucaristia. In que-sto senso spingerebbe l’interpretazione che, pochi decenni prima, aveva fornito dell’espressione il Piacentino,230 il quale, accingendosi a descrivere nella sua Summa Codicis i privilegi della Chiesa, aveva peraltro enumerato i significati di ecclesia, chiarendo che il termine poteva riferirsi a un luogo fisico eventual-mente delimitato da pareti, non a uno spazio libero all’aria aperta.231
È certo comunque che, anche assumendo l’accezione più vasta fornita dal Piacentino di fondi per l’eucaristia (terreni cioè coltivati a frumento o a vite), la distinzione che Rolando opera tra questi e il resto della proprietà ecclesiastica, e la convinzione secondo cui l’esenzione da tributi e confisca debba essere cir-coscritta ai primi, rappresenta una radicalizzazione dell’idea originaria di Gu-glielmo da Cabriano, secondo il quale i beni della Chiesa, a differenza di quelli dei chierici, non potevano essere confiscati se cessavano di corrispondere i tri-buti.232 Il Piacentino, pur condividendo in buona parte la posizione di Rolando
228. Cfr. infra, Summa in tit. C. 10.16, l’inciso al § 24, che è presente nei manoscritti con-tenenti la versione più antica della Summa (ante 1197).
229. Infra, Summa in tit. C. 10.42, §§ 57-59, paragrafi assenti dai manoscritti contenenti la versione più antica della Summa.
230. Item retinendo haec privilegia habet ecclesia. Praedia ecclesiarum muneribus sor-didis, ut calcis coquendae, vexari non debent: et praesertim si fuerint dedicata ut ex frumento vinoque in his nato eucharistia conficiatur: P l a c e n t i n u s, Summa Codicis, p. 4.
231. Ibid.: Et quidem ecclesia dicitur locus venerabilis in quo divinum ministerium cele-bratur, eucharistia consecratur. Ita tamen intelligo si locus sit vel parietibus circumdatus. Nec enim si sub libero aere, id est sub dio, in aliquo loco missa canitur. Locus ille vacuus ecclesie recte vocabitur. Secundum hanc acceptationem ecclesia talia sortitur privilegia etc. La defini-zione sarà ripresa da Azzone e parzialmente dalla Glossa accursiana: cfr. A i m o n e - B r a i -d a, Principio, pp. 218-219, in nota.
232. W a l l i n g a, The Casus, pp. 2-3, ad C. 1.2.5, Placet rationabilis: … Sed nec tran-sferuntur predia ecclesiarum venditone aliove modo ea ratione quia cessent in tributo.
III.2.3. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXXIX
– ricordando che, oltre ai servizi dovuti in caso di transito della corte imperiale, le chiese erano tenute a contribuire alla manutenzione di strade e ponti nonché, come i chierici, a versare tributi per le loro proprietà –, prende le distanze da un problema che, ai suoi occhi, sembra apparentemente secondario rispetto alla rivendicazione che davvero lo interessa, l’esenzione cioè dei fondi italici (com-presi quelli ecclesiastici) da tributi nei confronti dell’Imperatore.233
II) Il secondo e più controverso punto nell’interpretazione della costituzione Placet rationabilis era però la distinzione tra onere ordinario e straordinario: l’impressione è che, presentandosi anticamente la legge come un intervento a protezione delle chiese, da un lato sancisse il fondamentale principio per cui le chiese erano tenute al pagamento di imposte ordinarie nei confronti delle città; dall’altro, pur vietando le imposte straordinarie, lasciasse in realtà spalancata al fisco secolare la porta per imporle, considerata l’oscurissima definizione di quella che veniva chiamata canonica illatio. Il dettato cristallino dell’esordio, secondo cui le chiese erano immuni da imposte straordinarie, veniva infatti compromesso in toto dalla descrizione che, nell’inciso della legge, si dava di questa ‘imposta regolare’ (“che impone un improvviso gravame, dettato da un’esigenza imprevista”): rappresenta naturalmente una contraddizione in termini qualificare come regolare un’imposta generata da una necessità ina-spettata.234 Il paragone però con la versione originaria e più estesa della stes-sa norma, tramandata dal Codex Theodosianus,235 rende palese l’errore che si consolidò nella vulgata del Codex Iustiniani dove, tagliando una frase e tra-smutando in quam un quod,236 si stravolse il significato affidato da Teodosio e Onorio alla legge.237 Questi tagli con ogni probabilità avvennero, all’epoca
233. A questa nota posizione politica del Piacentino faccio riferimento anche supra, III.2.2., Prelievi sulle cose.
234. Per la necessitas come “criterio di deroga alle norme” o concetto che viene “affinandosi sul piano della liceità morale dell’atto contra legem” cfr. C o r t e s e, La norma, I, pp. 263-265.
235. C. Th: 16.2.40: C. Th: 16.2.40: Imperatores Honorius et Theodosius aa. Melitio praefecto praeto-rio: Placet rationabilis consilii tenore perpenso destricta moderatione praescribere, a quibus specialiter necessitatibus ecclesiae urbium singularum habeantur inmunes. Prima quippe illius usurpationis contumelia depellenda est, ne praedia usibus caelestium secretorum dicata sor-didorum munerum fasce vexentur. Nullam iugationem, quae talium privilegiorum sorte gratu-latur, muniendi itineris constringat iniuria; nihil extraordinarium ab hac superindicticiumve flagitetur;; nulla pontium instauratio, nulla translationum sollicitudo gignatur;; non aurum ce-teraque talia poscantur. Postremo nihil, praeter canonicam illationem, q u o d adventiciae necessitatis sarcina repentina depoposcerit, eius functionibus adscribatur. Per la forma in cui circolò nel Codice giustinianeo, cfr. supra, nota 224.
236. Già segnalato da Paul Krüger nell’editio maior del Codex (Berlin 1877, ad 1.2.5), che riconduce anche la trasformazione del quod in quam ai compilatori giustinianei.
237. Come si evince dal confronto tra le due differenti versioni che ho riportato nelle note precedenti.
CLXXX Diritto pubblico tra Impero e città
di Giustiniano, per non esentare le chiese dal pagamento delle imposte fina-lizzate alla costruzione di strade e ponti, come attesta l’inclusione, nel Codex Iustiniani, di un’altra legge di Teodosio, di poco successiva alla Placet ratio-nabilis e destinata alla parte orientale dell’Impero, nella quale era stato sanci-to tale obbligo.238 Poiché invece la Placet rationabilis in origine lo negava, fu tagliata ad arte dalla commissione di giuristi giustinianei e resa meno chiara, favorendone probabilmente la corruzione nei secoli successivi.
È certo comunque che, per tutto il XII secolo e per buona parte del XIII, complice anche la citazione che della Placet rationabilis fece Graziano nel Decretum,239 l’errore non venne – quantomeno espressamente – rileva-to, ma spianò anzi la strada ad interpretazioni tendenziose da parte dei po-teri laici.240 Rolando non a caso cita la legge per ben 13 volte, 7 delle quali
238. C. 1.2.7: Imperatores Honorius, Theodosius: Ad instructiones itinerum pontiumque etiam divinas domos et venerabiles ecclesias tam laudabili titulo libenter adscribimus, quia non est inter sordida munera numeratum. Conferma questa interpretazione il diretto intervento di Giustiniano nella Nov. 131, dove si afferma: Ad haec sancimus omnium sanctarum ecclesiarum et omnium venerabilium domuum possessiones usque sordidas functiones neque extraordinarias descriptiones sustinere. Si tamen itineris sternendi aut pontium aedificii vel reparationis opus fuerit, ad instar aliorum possessorum huiusmodi opus et sanctas ecclesias et venerabiles domos complere, dum sub illa possident civitate sub qua tale fit opus … (Auth. coll. 9.6=Nov. 131.5).
239. Decr. Grat. C.16 q.1 c.40. A giudicare dalla citazione dell’opera di Enrico di Gand, riportata da S c o r d i a, “Le Roi doit vivre du sein”, p. 146 in nota, la legge circolava ancora corrotta nelle dispute teologiche di fine Duecento.
240. Senza pretesa di esaustività, riporto alcune delle posizioni più significative della dot-trina sul tema: per Lo Codi (ante 1149 o post 1158: cfr. C o r t e s e, Il diritto, II, pp. 135-136 in nota), nonostante la Chiesa goda di molti privilegi, essa non è tuttavia esente, per le sue pro-prietà, né dal tributo dovuto all’Imperatore, né da quello richiesto da una città per la costruzione di strade o ponti (Set quamvis ecclesia habeat multa privilegia, non tamen potest se excusare vel res suas quod non reddat tributum imperatori. Similiter si comune civitatis faceret viam ali-quam vel pontem, ecclesia non poterit se excusare plus quam alia persona: F i t t i n g / S u -c h i e r (a cura di), Lo Codi in der lateinischen Übersetzung, p. 2). La Summa Trecensis (metà XII sec. ca.) si esprime in termini del tutto simili, aggiungendo però l’idea che la Chiesa è esen-te da imposte straordinarie richieste tanto su base reale per beni pertinenti ai venerabilia loca, quanto su base personale per chi vi lavori (Retinet quoque res proprias, quorumdam munerum, maxime extraordinariorum sive sordidorum, necessitate sive inmunitate eis indulta. Set ne ratio privilegiorum seu inmunitatum prosiliat, inserit ibidem ius commune, quod tam in rebus divi-nis quam etiam in humanis vertitur. Iure communi utuntur, ut in regulari canone fisco solvendo. Item conferre debent ad instructiones pontium seu viarum, si necessitas hoc suggerit. Ceterum ab extraordinariis seu sordidis muneribus tam nomine rerum ad venerabilia loca pertinentium, quam etiam nomine personarum ibidem servientium relaxantur: F i t t i n g (a cura di), Sum-ma Codicis des Irnerius mit einer Einleitung, pp. 6-7). Il panorama diviene più articolato nella Summa di Rogerio (le cui posizioni in proposito ho già parzialmente analizzato supra, III.2.2., Prelievi sulle cose, e cfr. Tab. 1), per il quale la Chiesa è tenuta a munera straordinari se richie-sti ad pietatem (ed espressamente per costruzione di strade e ponti); qualora si tratti invece di munera motivati da publica utilitas, deve sottostarvi solo in due casi: per il trasporto di derrate
III.2.3. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXXXI
concentrate nel commento al titolo sui munera patrimoniorum:241 essendo essenzialmente straordinario il carattere delle imposte della sua epoca, era
pubbliche e per un gravame improvviso (Munus in genere acceptum aliud ordinarium, ut sunt canonice illationes, ut tributa et vectigalia;; aliud extraordinarium, ut sunt collationes que fiunt ad instructionem viarum seu pontium. Extraordinarium aliud honestum, aliud sordidum. Hone-stum aliud respicit ad pietatem, ut collatio viarum seu pontium, aliud ad publicam utilitatem, ut si felix embola poposcerit navigium ecclesie, vel cuiuslibet privati … quia sive privatus sive ecclesia sit, cogitur nobis prestare angaria, perangaria et plaustra, unde colligitur quod eccle-sia omnia ordinaria cogitur subire. Ab extraordinariis vero et sordidis muneribus omnimodo est immunis. Extraordinaria vero et honesta, si ad pietatem respiciant, omnimodo cogitur subire. Sin autem ad publicam utilitatem, duo solummodo cogitur subire, scilicet felicem embolam et repentinam sarcinam. Iure communi utitur, ut in regulari canone fisco solvendo …: R o g e r i -u s, Summa Codicis, a cura di P a l m i e r i, I.2, p. 51). Anche la Summa Berolinensis riporta la legge Placet rationabilis della quale, benché cambi lievemente il dettato, mantiene ferma l’idea per cui i fondi ecclesiastici sono tenuti solo all’imposta regolare, mentre devono conside-rarsi immuni da munera straordinari, eccetto se richiesti da un improvviso gravame, dettato da un’esigenza imprevista (Predia muneribus funguntur. Que tamen ecclesie sunt, sordidorum mu-nerum fece nequaquam vexantur. Set nec extraordinarium superindictumve aliquid flagitatur. Nichil preter canonicam illationem temporis functionibus ascribitur preter si adventicie neces-sitatis sarcina repentina poposcerit: L o s c h i a v o, Summa Codicis, p. 164); similmente, per Guglielmo da Cabriano, ai fondi ecclesiastici non deve essere ascritto alcun obbligo oltre alla regolare tassa che impone un improvviso gravame, dettato da un’esigenza imprevista (Prediis ergo earum nihil adscribitur preter canonicam illationem quam repentina adventicie necessi-tatis sarcina poposcitur: W a l l i n g a, The Casus, pp. 2-3). Piacentino riassume in modo dif-ferente quelli che a suo avviso sono i doveri fiscali delle chiese, senza addentrarsi troppo nella distinzione tra ordinario e straordinario: le chiese, afferma infatti, nulla devono all’Imperato-re, eccetto il caso in cui ciò non venga loro ordinato, come avviene per la tributaria collatio; sono tenute a un solo contributo straordinario, quello che si versa per il transito imperiale (Item nihil praestabunt principi ecclesiae, nisi ordinatum, id est tributariam collationem et unam extraordinariam, ut si contigerit Imperatorem inde proficisci ut C. eo. l. Placet et l. Neminem: P l a c e n t i n u s, Summa Codicis, p. 4). Un certo distacco dalle contraddizioni della Placet rationabilis comincia ad essere visibile con Azzone († 1220 o intorno al 1230: cfr. C o r t e s e, Il diritto, II, pp. 177-178 in nota), il quale, pur accogliendo la posizione di Rogerio secondo cui la Chiesa era tenuta al pagamento di munera extraordinaria se richiesti ad pietatem e, in casi eccezionali, se motivati da publica utilitas, omette significativamente l’idea per cui la publica utilitas possa essere dettata da ‘gravame improvviso’, limitando i doveri fiscali ecclesiastici, per il bene comune, al transito dell’Imperatore e al trasporto di derrate pubbliche (A z o, Summa Codicis, ad tit. C. 1.2, 3v): Extraordinaria: si quidem ad pietatem respiciant, subit ecclesia ut infra e. Ad instructionem (C. 1.2.7), et, si ad publicam utilitatem, non subit, nisi in adventum principis et felicis embole, et hec cum superioribus probantur i. e. l. Placet § (!) Rationabilis et l. Iubemus nullam et l. Neminem (C. 1.2.5, 10 et 11). La Glossa accursiana dichiara apertamente che la Placet rationabilis non funziona: chiariti infatti i termini canonicam, (canon, id est, re-gula, inde canonica, idest regularis) e illationem (id est, ordinarium tributum), in relazione alle parole quam adventitia afferma che: si autem illud “quam” refertur ad canonicam illationem, falsum esset, quia quod haec sarcina poscit, non est canonicum sed extraordinarium (Corpus iuris civilis cum Commentariis Accursii, t. IV, col. 34).
241. Cfr. infra, Summa in tit. C. 10.42, e l’Indice delle citazioni per le altre ricorrenze.
CLXXXII Diritto pubblico tra Impero e città
vantaggioso disporre di una antica legge romana che, a patto di una generi-ca necessità imprevista, ne sancisse la legittima applicazione alla proprietà ecclesiastica.
Tanto più che nella stessa direzione spingevano ulteriori ambiguità pre-senti nel patrimonio normativo giustinianeo: così per esempio il significato da attribuire all’espressione ‘contributo straordinario o aggiuntivo’ presente nella Placet rationabilis, considerato che, benché la legge usasse i due aggettivi alla stregua di sinonimi, tra extraordinarius e superindicticius era stata operata in realtà una distinzione importante in altro punto del Codice. Nel 416, infatti, Onorio e Teodosio avevano sancito che l’imposta sui possessori fondiari che fino a quel momento era andata sotto il nome di ‘aggiuntiva’ (superindictum), doveva invece essere considerata regolare (canon); non andava quindi in al-cun modo catalogata come straordinaria (con conseguenti fasce di esenzione), ma doveva piuttosto assumere il nome di contributo ‘canonico’ cui tutti i pos-sessori, senza esclusione alcuna (omnes omnino quocumque titulo possiden-tes), erano tenuti. Nessuna domus, dunque, inclusa quella imperiale, poteva esserne considerata esente.242
Se da una parte, quindi, la Placet rationabilis (C. 1.2.5) complicava la de-finizione di imposta ordinaria, quest’altra costituzione (C. 10.17.1), facendo passare sotto il nome di ordinario un prelievo anticamente straordinario, non rappresentava di certo un aiuto, per la dottrina medievale, al fine di giungere a una sistematizzazione della materia. Significative appaiono di nuovo le pa-role di Guglielmo da Cabriano, il quale, ricordando che la Chiesa non è tenuta a tasse patrimoniali straordinarie o aggiuntive, si sofferma sul significato del termine ‘aggiuntivo’ (superindictum): quello, afferma cioè, che viene indetto sopra al tributo (sic dictum quia superindicitur et supradditur tributo); ma, ag-giunge, facendo quasi un gioco di parole, non va detto straordinario il prelievo che viene aggiunto, che deve invece essere definito ‘canonico’ (nec extraordi-narium dicitur quod superindicitur, set canonicum potius appellatur).243 Che Rolando conosca o meno i Casus di Guglielmo, giunge a conclusioni simili ed anzi assai più esplicite, motivandole attraverso l’idea per cui un provvedi-mento più tardo – quello cioè di Onorio e Teodosio – prevale sui precedenti (lex sit potior quia posterior). Ciò che richiede il Princeps, afferma il giudi-ce, non deve essere chiamato mai straordinario, essendo stato definito dai due
242. C. 10.17.1: Imperatores Honorius, Theodosius: Omnes omnino quocumque titulo possidentes, quod delegatio superindicti nomine videtur amplexa, velut canonem cogantur in-ferre: et ne qua sit dubietas, hac aperta definitione decernimus, ut id potius canonis vocabulo postuletur. 1. Nulla igitur domus vel sacri patrimonii vel emphyteutici iuris vel hominum priva-torum, etiamsi privilegium aliquod habere doceantur, ab hac necessitate seiuncta sit, quae iam non extraordinarium, ut hactenus, sed ipsis facientibus canonicum nomen accepit.
243. W a l l i n g a, The Casus, pp. 2-3.
III.2.3. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXXXIII
antichi imperatori contributo ‘canonico’. L’immunità dunque della Chiesa o di altro soggetto privilegiato dalle imposte aggiuntive va circoscritta solo a quelle straordinarie, e non vale invece in caso di prelievi aggiuntivi ordinari cui le autorità ricorrano per necessità (habent immunitatem a superindicto ex-traordinario, sed ab ordinario, quod nomen canonicum habet et quod causa necessitatis indicitur, nequaquam).244
III) Che l’inclusione della Chiesa tra i contribuenti sia però tutt’altro che pa-cifica alla fine del 1100, lo attesta bene il vivace dibattito che Rolando stesso restituisce in uno dei brani di maggiore interesse della sua opera (Summa in tit. C. 10.42), dove discute l’assimilazione della proprietà ecclesiastica al regime fiscale un tempo vigente per i beni imperiali. Il primo nodo da scio-gliere per il giudice è di ordine teorico, perché consiste nella errata estensio-ne a tutte le chiese cittadine di un privilegio un tempo concesso a una spe-cifica realtà ecclesiastica, quella della Chiesa di Tessalonica. È un principio generale, ricorda infatti Rolando, che un provvedimento speciale, formulato per un caso specifico, non opera negli altri (si quid speciale in uno casu sta-tuitur, in aliis casibus ius commune optinet in contrarium), e dunque non è corretto estendere alla proprietà ecclesiastica in generale l’immunità dai mu-nera patrimonalia.245 Neppure è corretto affermare – e siamo qui introdotti al vero e più spinoso problema – che le parole divina domus si riferiscano solo all’Imperatore e alle pertinenze imperiali, perché, sostiene Rolando, si applicano invece in modo altrettanto rispondente alla Chiesa e alla sua proprietà.246 Siamo di fronte a un altro di quei rompicapi linguistici e con-cettuali che la tradizione giuridica tardo-antica aveva lasciato in eredità ai glossatori medievali, cui l’espressione divina domus – in origine riferita alle corti imperiali, ma che per assimilazione giunse ad includere la Chiesa247– risultò davvero complessa da decifrare. La rilevanza della questione è ben riassunta dall’antica e già citata legge del Codice, secondo la quale le città potevano confiscare i fondi ubicati nella propria area di influenza territoriale
244. Cfr. infra, Summa in titt. C. 10.17, §§ 9-12, C. 11.75, §§ 1-4. 245. Cfr. infra, Summa in tit. C. 10.42, §§ 53-55: Immo, quod plus est, nulla patrimonalia
munera prestat Thessalon‹icensis› ecclesia, … Item ecclesia, secundum quosdam, nulla prestat patrimonalia munera, ut s. de sacro. s. ecc. l. Placet (C. 1.2.5): nam ibi dicitur ad munera ec-clesia non teneri; sed hoc non placet quia, preterquam in Thessalonicensi ecclesia, ut dictum est, cetere ecclesie patrimonialia prestant munera.
246. Ibid., § 56 e Summa in tit. C. 11.75, §§ 1-4.247. Sull’uso originario di tale espressione, indicante “the house of the divus, later the
house of the divi”, e le connotazioni invece sovrannaturali con cui comincia ad essere utilizzata in epoca Flavia (I sec.) e poi nei secoli a venire, cfr. F i s h w i c k, The Imperial Cult, II, pp. 426-435 e bibliografia ivi citata. Per il confuso panorama linguistico offerto dal Corpus iuris in materia di sacro/santo/divino etc., cfr. supra, III.1.2., Imposte e bene pubblico.
CLXXXIV Diritto pubblico tra Impero e città
per i quali non fossero state corrisposte le pubbliche imposte, anche qualora si fosse trattato di fondi appartenenti alla divina domus.248 Attualizzandone il dettato, si poteva in altre parole arrivare, attraverso questa legge, ad au-torizzare la confisca da parte dei comuni di terre ecclesiastiche del contado per le quali non fossero state versate le imposte richieste dai governi urbani. Per evitare tale rischio (o cogliere questa opportunità) divenne urgente chia-rire il significato dell’aggettivo divinus, che fu tradotto restrittivamente con ‘imperiale’, o, viceversa, estensivamente, con ‘ecclesiastico ed imperiale’, a seconda degli interessi che si vollero tutelare.
Il problema è nettamente compreso in opere giuridiche risalenti già alla metà del XII secolo, come attesta l’anonima Summa Codicis Berolinensis nel-la quale si afferma che:
“qualora la Chiesa cessi di corrispondere i tributi consueti, le sue terre non vanno trasferite a nessuno. I fondi appartenenti invece alla domus divina – ossia la domus regia –, acquistati dall’Imperatore o giunti nelle sue mani in modo simile, e sotto-posti in precedenza al pagamento di imposte, devono essere confiscati ed assegnati alla curia della città nel cui territorio si trovano ‹se smettono di pagare›”.249
Ma questa posizione nettamente contraria a un’interpretazione estensiva della divina domus appare già più sfumata nelle coeve riflessioni di Guglielmo da Cabriano, il cui pensiero, in materia di obblighi e privilegi della proprietà ecclesiastica, sembra l’anello di congiunzione tra Rolando e la dottrina che lo precede. Asserendo infatti che i fondi della Chiesa non sono passibili di confi-sca a causa di inadempienze fiscali, Guglielmo, pur assumendo una posizione in apparenza simile all’anonimo autore della Summa Berolinensis, ne mitiga in realtà gli effetti sia ricordando, come abbiamo visto,250 che ciò poteva in-vece avvenire ai beni dei chierici; sia parafrasando un antico provvedimento – in cui le domus imperiali ed ecclesiastica erano accostate in forma davvero
248. C. 10.19.8: Imperatores Leo, Anthemius: Si divina domus aut quilibet cuiuscumque dignitatis atque fortunae re vera fundos extra metrocomias non patrocinii gratia, sed emptionis iure vel quolibet alio titulo legitimo possederit et non impositas rei publicae functiones agno-verit, quemadmodum prior dominus dependebat, omnibus modis possessiones eorum publico vindicentur et curiae eiusdem civitatis sub qua vici siti sunt adsignentur, ut publicis commodita-tibus circa tributarias functiones undique nostra provisione videatur esse consultum. Parte dei contenuti di questa legge è stata da me già discussa supra, III.2.2., Prelievi sulle cose.
249. Si in prestatione sollenpnium tributorum cesset ecclesia, sua predia non sunt ad ali-quem transferenda. Predia tamen divine – idest regie – domus, que enptione vel alio simili titulo ad Cesarem perveniant, quibus ante fuerant obnoxia solenpnibus pensionibus, publicantur et curie civitatis in cuius territorio sunt assignantur, ut in x libro C. De exactionibus tributorum l. ultima. Sicut autem non sunt sua ecclesie predia transferenda, etc: L o s c h i a v o, Summa Codicis, p. 164. La traduzione è mia.
250. Supra, in questo stesso paragrafo, al punto I).
III.2.3. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXXXV
ambigua251 – che sanciva l’obbligo da parte anche delle chiese di produrre i consueti servizi in caso di transito dell’Imperatore.252
Che siano o meno questi gli autori cui polemicamente si rivolge Rolando nella seconda versione della sua Summa (licet quidam dicant legem illam loqui in divina domo idest imperiali), la conclusione cui egli giunge è netta: l’espressione divina domus si riferisce anche alla Chiesa, le cui terre possono venire confiscate per inadempienze di fronte al fisco, cosa che indirettamente significa che i fondi ecclesiastici devono essere sottoposti al prelievo da parte delle autorità temporali (sed in divina domo idest ecclesia potest loqui per iura predicta. Tamen quia nul-la persona ab huiusmodi munere patrimoniali debet excusari … patitur ecclesia venditionem et translationem in fiscum).253 E a prelievi non solo ordinari bensì anche straordinari, a patto che siano richiesti ad pietatem, finalizzati cioè alla manutenzione di ponti e strade, e ad publicam utilitatem, indetti per esempio per il transito dell’imperatore o il trasporto di pubbliche derrate (cfr. infra, Tabb. 3 e 3b). A tributi motivati da queste causae, ricorda Rolando, nessuno può sottrarsi, non la Chiesa né – associazione significativa – tantomeno i milites.254
Dopo questa lunga tirata, il giudice sembra improvvisamente capitolare ed ammettere che tali radicali convinzioni, basate sul Codice e il Digesto, sono sta-te ormai superate dal ‘nuovo diritto’, vale a dire le Novelle giustinianee da una parte e le leggi degli imperatori svevi dall’altra, che unanimemente condannano i prelievi straordinari, nonostante l’uso radicato di ricorrervi: tutti possono per-tanto considerarsi immuni da tali richieste, anche se definite ad pietatem e ad publicam utilitatem, e soprattutto le chiese nei confronti dei laici.255 Guardando le parole che seguono, ci accorgiamo però, ancora una volta, di trovarci all’in-
251. C. 10.49.2: Imperatores Theodosius, Valentinianus: Cum ad felicissimam expeditio-nem numinis nostri omnium provincialium per loca, qua iter adripimus, debeant nobis mini-steria exhiberi, neminem ab angariis vel parangariis vel plaustris vel quolibet munere penitus excusari praecipimus, sed omnes, sive ad divinam nostram domum sive ad venerabilis Augu-stae vel ad sacrosanctas ecclesias vel quaslibet illustres domos pertinent, nec lege pragmatica nec divina adnotatione sacrove oraculo excusatos indictionibus magnificae tuae sedis tempore nostrae expeditionis oboedire decernimus.
252. W a l l i n g a, The Casus, pp. 2-3: Quod autem ibi accipiatur divine domus, idest regie, infra libro x. t. de quibus muneribus l. i. reperitur aperte, cum dicit predia pertinentia ad divinam domum, idest principis seu Auguste, vel ad sacrosanctas ecclesias, ab angariis, paran-gariis se etiam plaustris non esse excusanda, cum ad felicissimam expeditionem predicta fue-rint necessaria. Prediis ergo earum nihil adscribitur preter canonicam illationem quam repen-tina adventicie necessitatis sarcina poposcitur. Cum enim per loca iter arripimus, ministeria ad felicem expeditionem necessaria etiam ab ecclesiis nobis exhibentur.
253. Cfr. infra, Summa in titt. C. 10.42, §§ 56-57, C. 11.75, §§ 1-4.254. Cfr. infra, Summa in titt. C. 10.49, §§ 5-6, C. 10.42, §§ 76-78.255. Ibid., §§ 79-81.
CLXXXVI Diritto pubblico tra Impero e città
terno non di una univoca e coerente esposizione, ma di un animato dibattito. E l’arma usata da Rolando è sempre la stessa, appellarsi cioè all’esistenza di un nucleo di causae che generano prelievi cui nessuno può sottrarsi: se, conclude enfaticamente il giudice, la legge espressamente dice che da tali obblighi “nes-suno può essere scusato”, e se non è prevista la possibilità che tali prescrizioni “cambino”, non si può correggerne il dettato, perché resta un dovere del giurista quello di concordare le norme tra loro traendone una disciplina organica e coe-rente, rifuggendo dalla tentazione di correggere il dettato delle leggi che si fatica ad inserire nel ‘sistema’ (non debemus esse prompti ad legum correctionem, sed iura debemus iuribus concordare).256
Tabella 3Rolando da Lucca, Summa in tit. C. 10.42 (XII ex.-XIII in.)257
MUNERA CIVILIA SEU PUBLICA
(Est ergo munus non, sicut alias dicitur, donum, sed proprie dicitur munus, idest honus, ut hic accipitur, quod necessario subimus lege, more, imperiove eius qui iubendi habet potestatem)
ORDINARI STRAORDINARI
(quando non indicitur regulariter omnibus de pro-
vincia, sed certe civitate vel vico)
Svilenti (sordida) Dignitosi (honesta)
Cuocere la calce,fare il pane, portare la legna, servizi di trasporto per la do-
mus imperiale, etc.
Angaria (o perso-
nalia)
Rerum (o rea-
lia)
Mixta
Ne è esente la Chiesa, gli ec-clesiastici e, più in generale, coloro che sono esenti dai
munera honesta
Sono esentate le categorie elencate infra, Tabb. 3a e 3b
Ne sono esenti ecclesia-stici e milites, a meno che
non si tratti di munera extraordinaria richiesti ad
pietatem o ad publicam utilitatem, nel qual caso
tutti, inclusi milites e chie-rici, devono sottostarvi
256. Ibid., §§ 82-83. 257. Il valore di queste tabelle riferite a Rolando (ancor più delle altre) è meramente esem-
plificativo: il brano da cui traggo i dati che le compongono è infatti assai più ricco e articolato.
III.2.3. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXXXVII
Tabella 3aRolando da Lucca, Summa in tit. C. 10.42 (XII ex.-XIII in.)258
258. Cfr. infra, Summa in tit. C. 10.64, e III.3.3., La donna medievale.
MUNERA PERSONALI (definiti, ricalcando D. 50.4.1.3, quod in corporis labore et sollicitudine animi ac vigilantia
principaliter existit, et sine aliquo gerentis detrimento in rebus perpetratur)
MUNERA
(elenco esemplato su D. 50.4.1 e 18)DESTINATARI ESENTI DAI MUNERA PERSONALI
Defensio civitatis: l’incarico cioè di rappresentante (syndicus) e di chi è stato eletto ad causam agendam vel
defendendam, o di chi fa parte di una legazione destinata al sacrarium
imperiale
Cariche di coloro addetti alla riscos-sione dei tributi o delle pubbliche entrate delle città, e alla loro regi-
strazione scritta
Cariche di chi deve provvedere a la-vori urbanistici quali pavimentazio-ne delle strade, acquedotto, restauro di palazzi pubblici, cantieri navali,
etc., o alla annona, ai fondi pubblici, all’acquisto di olio e frumento, agli spettacoli equestri e a tutto quello
che non implica un ricorso al proprio patrimonio
Incarichi di cura e tutela di persone reputate inabili a vario titolo
Calendarii curatio, questura, carica di irenarcha; episcopi (qui presunt
pani et … rebus que civitatum popu-lis sunt ad victum necessarie)
Fornitura di reclute e cavalli o di al-tri animali o servizi di trasporto
Compito di giudicare
Abitanti nativi delle città o ivi residenti
Chiesa ed ecclesiastici, esenti da tutti i munera sordida e da quelli persona-li, a meno che non ne accettino uno
volontariamente, per esempio in caso di cura o tutela di un parente
Donne, con qualche eccezione258
Servi
Chi è inabile perché infamis, indigen-te, anziano, malato o per il numero
di figli
Notai addetti alla registrazione delle entrate fiscali, che sono esenti dai
munera sordida e da altri tributi stra-ordinari
Senatori, persone definite illustres, op-pure chi, a vario livello, è al servizio dell’Imperatore, in particolare nella
sua cancelleria
Decurioni, in casi molto specifici
Colui che viene chiamato a ricoprire un incarico inferiore ad uno già ricoperto in precedenza, per esempio un maior iudex nominato a una sede inferiore
Padre che abbia trasferito al figlio le proprie sostanze perché inabile;; figlio
di padre abile all’incarico
Chi lavora per mare
CLXXXVIII Diritto pubblico tra Impero e città
Tabella 3bRolando da Lucca, Summa in tit. C. 10.42 (XII ex.-XIII in.) 259 260
259. Cfr. supra, III.2.3., La tassazione.260. Sui doveri fiscali degli abitanti del contado, Rolando è ambiguo: cfr. supra, III.2.2.,
Prelievi sulle cose, e infra, Summa in tit. C. 10.24.
Munera patrimoniali
(definiti, ricalcando D. 50.4.18.18, patrimoniale munus est in quo sumptus maxime consistit; nam sumptibus patrimonii et dampnis administrantis expeditur)
Munera Destinatari esenti Servizio di trasporto per terra
e per mare
Incarico di provvedere al l’acqui-sto e conservazione di beni ali-
mentari per la collettività
Pagamento dei tributiDoveri di albergaria nei con-
fronti dell’esercitoMaestri d’arti liberali, dot-tori in legge, grammatici,
oratores, medici, philosophi, servitori imperiali, iudices or-dinarii, possessores agrorum, consules ed altre persone che
ricoprono cariche illustriGravami imposti ai possessori
non cittadini, come fornire cavalli e muli per servizi mili-
tari e di trasporto
Tutti i possessori che non sia-no cittadini o residenti in città, inclusi senatori, veterani, mi-
lites e vescovo
Cittadini e residenti in città (municipes + incolae)
Costruzione delle strade e con-tributi versati dai fondi: alcune città godono infatti della pre-rogativa di ottenere annual-
mente, da coloro che possiedono terre nel loro territorio, una certa quantità di frumento calcolata in
base all’estensione della terra
Possessori non cittadini
Imposizione della collecta per fornire milites all’esercito im-periale, tributi per il transito dell’Imperatore e raccolta di
fondi (collatio) per la ricostru-zione e restauro di ponti, strade, porti, acquedotti e mura, con im-posta da calcolarsi proporzional-mente (pro modo fortunarumi) su ciò che i cittadini possiedono
Cittadini e residenti in cit-tà (cives + incolae), inclusi privilegiati, giovani, adulti,
donne, bambini, milites e, se-condo alcuni, Chiesa, sia sulle
proprietà ecclesiastiche che su quelle private dei chierici; abitanti del contado (rustici/
rusticana plebs) con modalità di prelievo non specificate260
Chiesa, secondo alcuni, solo per quei fondi dedicati
all’eucaristia (praedia ad con-fectionem heucaristie dicata);
Chiesa e chierici, secondo altri, sia sulle proprietà eccle-siastiche che su quelle private
dei chierici259
Capitatio Abitanti del contado (rustici/rusticana plebs)
Milites, veterani, cives ro-mani e di tutte le altre civi-
tates, coloni Tracenses
III.3.1. Menzinger, Questioni di diritto fiscale CLXXXIX
Tabella 4Azzone, Summa Codicis in tit. C. 1.2 (XIII in.)261
Munera SVILENTI (sordida)
DIGNITOSI (honesta)
ORDINARI STRAORDINARI
Da cui la Chiesa è esente
Angaria(que con-sistunt in
exhibitione opere)
Perangaria (que in exhi-bitione opere consistunt et
sumptu)
Rerum(ut tributa)
ad pietatem ad publicam uti-litatem
Da cui la Chiesa è esente Cui è tenuta anche
la Chiesa, oltre al
superindictum che è
un’imposta ordinaria261
Cui è tenuta an-che la Chiesa
Cui non è tenuta la Chiesa,
a meno che non siano
richiesti per il transito
dell’Imperatore o per il tra-
sporto di derrate pub-
bliche
3. Riflessi teorico-politici dei nuovi dibattiti sulla fiscalità
3.1. Dalla fiscalità alle teorie del consenso: il contributo dell’esperienza politica comunale
Numerosi studi hanno dimostrato il nesso intrinseco esistente tra i nuovi esperimenti fiscali del XII secolo e le prime riflessioni che contemporaneamen-te si svilupparono sulle regole del consenso.262 In particolare, alcune questioni inerenti alla tassazione dei beni ecclesiastici da parte sia dei governi urbani che delle stesse chiese contribuirono significativamente ad alimentare, negli ultimi decenni del 1100, il dibattito dottrinario su cosa fosse il consenso di una comu-nità e come si giungesse all’elaborazione di decisioni collettive. Il III Conci-lio Lateranense (1179) rappresentò notoriamente un’importante tappa di questo
261. Interpreto così la frase di Azzone: … Rerum vero subit, p r e t e r s u p e r i n -d i c t u m quod est ordinarium, ut ff. de mu. et ho. Munerum usque ad illum § Patrimoniorum (D. 50.4.18) et infra de indictionibus l. i. (C. 10.17.1) et de exactionibus tribu. l. Si divina (C. 10.19.8) etc., alla luce dei contenuti delle leggi che cita.
262. P o s t, Sudies, P o s t, Sudies, passim, C o n g a r, Quod omnes, F o r e v i l l e, Représentation.
CXC Diritto pubblico tra Impero e città
percorso, non solo perché in esso vennero definite le regole per l’elezione pon-tificia da parte del collegio cardinalizio, ma anche per la comparsa dell’idea, ribadita a varie riprese in seguito, secondo cui l’eventuale contributo fiscale da parte delle chiese al potere secolare avrebbe dovuto essere volontario (absque coactione) e concordemente stabilito da vescovo e clero. Ma come perveniva il capitolo a una decisione unitaria?263 La risposta a questa domanda era intima-mente legata ad altri interrogativi: la risoluzione cui fosse giunto un capitolo avrebbe dovuto essere rispettata da tutti, anche qualora alcuni non fossero stati presenti o d’accordo? E, se si fosse trattato di un’imposta, tutti erano obbligati a versarla in quanto aderenti a un organo collettivo? Anche se la volontà fosse stata espressa da un procuratore? È noto che furono proprio tali questioni – ge-nerate anche dalla distinzione sottile e nient’affatto pacifica che correva tra beni della chiesa e beni personali del clero264 – a suscitare, tra i canonisti, l’interesse per la rappresentanza intesa sia, in senso privatistico, come i poteri di un indivi-duo delegato da un altro soggetto a rappresentarlo;265 sia, in senso pubblicistico, come manifestazione del consenso da parte di un’assemblea.266
In entrambi i campi, il contributo del pensiero laico fu fin dalle origini no-tevole, anche perché le discussioni sulle diverse accezioni di rappresentanza si andarono presto svincolando dal campo fiscale, per giungere ad abbracciare orizzonti più vasti. Tanto la struttura collegiale che da subito scelsero i comu-ni per auto-amministrarsi, quanto l’associazionismo che caratterizzò a tanti li-velli la società urbana dell’Italia centro-settentrionale non potevano infatti che alimentare l’esigenza di mettere a punto delle regole da porre in essere negli organi istituzionali secolari. E queste istanze non pesarono solo sul pensiero civilista, ma influirono necessariamente anche su quello canonico, considerato che gli interpreti di entrambi le discipline si formarono nelle strutture di inse-gnamento dell’Italia comunale e furono in molti casi originari di città apparte-nenti a questo contesto politico e geografico. Per quanto banale possa apparire tale considerazione, a fronte di una storiografia che ha sostanzialmente iden-tificato nel Concilio la fonte di ispirazione per eccellenza delle regole assem-
263. Cfr., tra gli altri, P o s t, Studies, pp. 150-151; P e n n i n g t o n, Representation.264. Cfr. C o n g a r, Quod omnes, pp. 213-215, e la distinzione che successivamente
traccerà l’Ostiense tra quod omnes tangit ut singuli e quod omnes tangit ut collegiati, diretta-mente legata al problema delle imposte su fondi comuni o personali.
265. Su cui cfr., tra gli altri, P o s t, Studies, pp. 61-68, per le prime riflessioni sulla rap-presentanza di una comunità in sede giudiziaria, che fioriscono sul versante canonico;; P a d o a S c h i o p p a, Sul principio;; M a y a l i, Procureurs et représentation, con ampia bibliografia ivi citata, e, più in generale, il volume La représentation, all’interno del quale il saggio di Ma-yali è contenuto.
266. Il contributo del pensiero canonico e soprattutto delle decretales a questi temi è stato ricordato da P a d o a S c h i o p p a, Gerarchia e giurisdizione, pp. 118-119, e I d., Il mo-dello, p. 201.
III.3.1. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CXCI
bleari, sembra importante valorizzare ancora una volta l’esperienza politica cittadina, il cui nerbo consiliare deve avere parimenti stimolato una riflessione dotta su questi temi.267
Nel caso di Rolando, il marcato interesse per la fiscalità da un lato, e la familiarità sia con le istituzioni cittadine sia con soggetti ecclesiastici locali di entità variabile dall’altro, ben giustificano un interesse per le teorie circolanti in materia soprattutto di consenso e consultazione allargata. Insieme a Pillio da Medicina, è infatti uno tra i primi civilisti a citare la massima Quod om-nes tangit, che concordemente dalla storiografia giuridica è stata identificata come il punto d’avvio delle riflessioni sulla rappresentanza politica. Come è noto agli esperti, questa massima, secondo la quale quando si trattava di inte-ressi che toccavano tutti, diveniva necessario il consenso di tutti, compariva nel Codice giustinianeo per delineare una situazione di carattere non pubblici-stico ma privatistico, riferendosi al modo in cui doveva essere regolamentata l’autorità di più tutori su un minore.268 Non si è tuttavia insistito a sufficienza sull’idea che fu proprio il riferimento al minore la molla che fece scattare tanto nei canonisti quanto nei civilisti l’interesse per questo passo, trasformandolo in un principio di diritto pubblico.269 Infatti, l’assimilazione dei municipia da un lato a Roma, dall’altro all’ecclesia,270 aveva aperto la possibilità di rende-re operativo per i comuni il regime giuridico riservato alla res publica, che il diritto giustinianeo equiparava, attraverso un artificio giuridico, una fictio, al minore di età. Sfruttando questa finzione tecnica, alla civitas, come alla res publica, potevano allora essere attribuiti tutti quei diritti e quei vantaggi che nella legislazione romana spettavano a un soggetto minore (pupillus). Questo gioco di sovrapposizioni successive, ecclesia/civitas/res publica/pupillus, era stato peraltro favorito anche in campo ecclesiastico, dove pure si era giunti a sostenere l’equazione tra ecclesia e civitas e l’applicazione del favorevole re-
267. Il punto, messo a fuoco già da M o u l i n, Les origines religieuses, ed enfatizzato Il punto, messo a fuoco già da M o u l i n, Les origines religieuses, ed enfatizzato da P o s t, Studies, p. 80, è stato più recentemente ripreso da T h é r y, Moyen Âge, secondo il quale (p. 668): “si les influences ecclésiastiques sont indéniables, les pratiques séculières ont eu leur dynamique et leur chronologie propres”.
268. Cfr. C. 5.59.5.2, cui generalmente è associato un passo delle Istituzioni sullo stesso argomento (Inst. 1.24.1), citato per esempio da Rolando in Summa in tit. C. 10.32, § 77 e C. 12.4, § 13.
269. L’operazione è del tutto simile a quella assimilazione dei rappresentanti cittadini ai tutori in materia di sindacato, descritta da C r e s c e n z i (Il sindacato, p. 387) come segue: “… con la costruzione del rapporto tra ufficiale e comune quale rapporto di natura tutelare, si finisce per riconoscere automaticamente come organica a tale complesso di figure … l’esisten-za di un ufficio controllore, al quale il gestore dei negozi di un minore deve rendere conto della propria gestione”.
270. Su cui cfr. supra, III.1.2., Imposte e bene pubblico, e C o n t e, II.3.5., Il riconosci-mento.
CXCII Diritto pubblico tra Impero e città
gime giuridico vigente per il soggetto minore alle istituzioni ecclesiastiche.271 Dalla creazione di un territorio comune di condivisione giuridica (ecclesia/civitas/pupillus) discese la possibilità, per il giurista colto medievale, di poter accostare i tutori ai rappresentanti della città o della chiesa, per sostenere che, come fece per primo intorno al 1190 il canonista Bernardo da Pavia, quando ci si trovava di fronte a decisioni che toccavano un intero capitolo, era necessaria l’espressione di un consenso collegiale.272
Come Pillio da Medicina, Rolando si confronta intensamente con tali questioni quando nella Summa approfondisce le istituzioni proprie dei decu-rioni, antichi ufficiali che, come abbiamo più volte sottolineato, destano un interesse del tutto particolare in questi giuristi per le somiglianze che li legano ai rappresentanti della città medievale. Definire come convocare i decurioni di una certa curia cittadina, quanti di loro devono intervenire affinché le deci-sioni siano valide, o l’ammontare di voti necessari per raggiungere una mag-gioranza, significa inequivocabilmente riflettere, nel XII secolo, sulle regole da adottare nei collegi consolari o nei consigli sempre più numerosi che van-no ad affiancarli. Diversamente da Pillio, però, il nostro giudice non aderisce all’aprioristica convinzione – condivisa da tanti civilisti attivi, alla sua epoca, in ambiente universitario – secondo cui lo studio del diritto colto dovrebbe es-sere confinato ai testi romanistici, ma mette dialetticamente a confronto idee provenienti da ambiti diversi, mostrandosi piuttosto aggiornato in merito alle novità che, proprio negli anni in cui scrive, vanno delineandosi in campo ec-clesiastico. Se dunque nel commento al titolo De decurionibus accoglie ini-zialmente l’idea romana secondo cui, perché le decisioni della curia abbiano valore, devono essere convocati almeno i due terzi dei componenti,273 aggiun-ge però che sarebbe meglio convocare il numero più alto possibile di persone, come era stato deciso, in materia di elezioni ecclesiastiche, dal Concilio late-ranense IV (1215), in una costituzione confluita poi nel Liber Extra di Gre-gorio IX.274 La stessa oscillazione la mostra per identificare la maggioranza necessaria a rendere validi gli atti della curia: è sufficiente, si chiede Rolando,
271. Cfr. O r e s t a n o, L’assimilazione, pp. 1353-1357, e la discussione di questi temi in C r e s c e n z i, Il sindacato, pp. 451-463.
272. Sciendum est igitur quod in his quae a capitulo fieri vel ordinari debent omnium con-sensus est requirendus, ut quod omnes tangit ab omnibus comprobetur, su cui cfr. C o n g a r, Quod omnes, p. 213, che mette in luce il valore difensivo con cui questo principio è usato dal clero per limitare richieste fiscali secolari e papali (ibid., p. 215).
273. Infra, Summa in tit. C. 10.32, § 72, che dipende da C. 10.32.45; cfr. anche Summa in titt. C. 10.47, § 1, C. 10.48, § 24.
274. Cfr. X. 1.6.42, secondo cui: Quia propter diversas electionum formas, quas quidam invenire conantur … statuimus, ut, quum electio fuerit celebranda, praesentibus omnibus, qui debent, et volunt et possunt commode interesse, assumantur tres de collegio fide digni, qui se-crete et sigillatim vota cunctorum diligenter exquirant etc.
III.3.1. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CXCIII
che questi trovino concorde la maggior parte dei presenti o di tutti i membri del collegio (exigitur quod pars que eligit sit maior habito respectu ad totum ordinem, vel sufficit si sit maior quoad presentes)?275 Per spiegare meglio ciò che intende attinge alle proprie conoscenze giudiziali, contrapponendo una regola di maggioranza vigente per gli arbitrati – secondo cui, se erano stati nominati tre o più arbitri a pronunciarsi su una certa controversia, affinché la loro sentenza avesse valore dovevano intervenire tutti, ma se, una volta inter-venuti, due fossero stati d’accordo per una certa risoluzione e il terzo no, la sentenza doveva coincidere con la decisione della maggioranza276 – all’idea per cui la sentenza o veniva pronunciata da tutti gli arbitri, o da nessuno.277
Sarebbe sbagliato immaginare che queste discussioni – pur scandite dal ritmo della dialettica scolastica – fossero confinate in un’opera dottrinaria: Rolando stesso, in diversi frangenti, fa riferimento al suo ruolo di consulente dei consoli di Lucca.278 Sul suo pensiero influiscono modelli diversi: da un lato sembra infatti sposare il modello romano, che prediligeva la maggio-ranza numerica; dall’altro, accogliere – applicando all’assemblea le regole vigenti per gli arbitrati – l’idea di una maggioranza qualificata (i due terzi) che si era fatta strada nel mondo canonistico, al quale anche va ricondotta l’aspirazione al coinvolgimento di un numero di persone il più esteso possi-bile nelle decisioni.279
Secondo le fondamentali ricerche di Edoardo Ruffini,280 queste due posi-zioni, nel XII secolo, rispecchiano le diverse strade imboccate, in materia di rappresentanza, dalle istituzioni secolari e spirituali, le prime, quelle comuna-li, strettamente interessate a valorizzare una maggioranza di tipo numerico; le seconde, quelle ecclesiastiche, che andavano invece elaborando strategie più complesse per ovviare a due ostacoli: da un lato il fascino dell’unanimi-tà che, assai più che per il mondo laico, costituiva, in campo ecclesiastico, la forma decisionale più ambita, perché espressione collettiva di una volontà trascendente;281 ancora per Giovanni Teutonico († 1245-1246), canonista di poco successivo a Rolando, il dissenso rappresenta una manifestazione del
275. Infra, Summa in tit. C. 10.32, § 80.276. Ibid., §§ 73-76, che poggiano su D. 4.8.17.6-7; l’idea era condivisa in campo cano-
nistico: cfr. X. 1.43.1.277. Infra, Summa in tit. C. 10.32, § 79. 278. Cfr., per esempio, infra, Summa in tit. C. 10.39, § 70.279. Per un inquadramento di queste idee nel pensiero canonico e dei provvedimenti as-
sunti in proposito dai concili lateranensi III e IV, cfr. T h é r y, Moyen Âge, pp. 667-672.280. Raccolte in R u f f i n i, La ragione dei più, sulla cui contestualizzazione storica cfr.
G r o s s i, Omaggio, C a p r i o l i - R o s s i, Per Edoardo Ruffini, e, più recentemente, D e A n g e l i s, Profilo, I d., “Omnes simul”, pp. 1-6.
281. R u f f i n i, La ragione dei più, pp. 16-19, 255-256; G r o s s i, Unanimitas, pp. 276, 294-310; T h é r y, Moyen Âge, pp. 668-670.
CXCIV Diritto pubblico tra Impero e città
peccato originale.282 L’altro ostacolo da superare era costituito invece dalla ge-rarchia, dall’esigenza cioè di conciliare decisioni assunte da una maggioranza con un’istituzione, come la Chiesa, di carattere gerarchico. Benché lo stesso Ruffini evidenzi punti di contatto tra queste linee divergenti, quali ad esempio l’influenza che sui primi collegi consolari esercitò l’argomento dell’unanimità (non a caso in molti collegi figurava inizialmente un numero pari di consoli)283 vede tuttavia una frattura indelebile tra i due sistemi, soprattutto per l’introdu-zione nel pensiero canonico del notissimo principio in base al quale le volontà non dovevano essere soltanto sommate, ma anche pesate. Ciò concretamente venne realizzato, in campo ecclesiastico, introducendo il riferimento alla sa-nior pars, la parte più saggia, più meritevole, più autorevole dell’assemblea, le cui decisioni talvolta andavano rispettate anche se non coincidenti con quelle della maggioranza, appellandosi a un’autorità superiore.284
L’impatto di queste tesi sul pensiero di Rolando ci aiuta forse a compren-dere meglio alcuni aspetti caratteristici delle istituzioni assembleari consolari e successive nelle città: in primo luogo, il giudice non conferma l’idea di Ruf-fini secondo la quale in campo urbano laico ci si indirizzò da subito verso le regole di maggioranza numerica, a discapito di quei discorsi, fioriti soprattutto sul versante ecclesiastico, che tesero invece a valorizzare aspetti qualitativi. In un passo della Summa, si legge infatti che, in caso di nomine a cariche secolari ed ecclesiastiche da deliberare in seno ad organi collegiali, non si deve valuta-re l’identità, l’età o il decoro di una persona, ma piuttosto il parere (consilium) che avanza, affinché sempre si osservi l’opinione più meritevole e giusta per la repubblica (quod sanius et equius consilium pro re publica esse videbitur id servetur); talvolta infatti il parere di uno solo e forse inferiore, prosegue Rolando, può superare quello di molti e superiori: si tratti di un cardinale o di un canonico, gli affari della chiesa toccano entrambi, e deve pertanto essere ammesso il parere di tutti altrimenti la decisione non vale, a meno che non sia corroborata dal consiglio della parte maggiore e più meritevole.285
In primo luogo, è interessante notare che Rolando tenga qui fede a quell’esortazione da lui altrove avanzata secondo cui le leggi, o meglio i dirit-
282. T i e r n e y, Religion, pp. 22-23, G r o s s i, Unanimitas, pp. 304-306, e cfr. T i e r n e y, Religion, pp. 22-23, G r o s s i, Unanimitas, pp. 304-306, e cfr. A i m o n e - B r a i d a, Principio, pp. 209-212, C o n d o r e l l i, Principio, pp. 27-28.
283. R u f f i n i, La ragione dei più, pp. 243-246; altra eccezione che evidenzia è il pen-siero sia dell’Ostiense che di Innocenzo IV, sostenitori del principio maggioritario e non quali-tativo (ibid., pp. 79-81). Per un’analisi estensiva dei meccanismi di deliberazione consolare nel XII secolo, cfr. ora D e A n g e l i s, “Omnes simul”, con ampia bibliografia di riferimento. Interessante anche la notizia fornita da A s c h e r i, Istituzioni, p. 331, secondo cui le prime assemblee consolari si svolgevano in chiesa.
284. Ibid., pp. 56-79, e T i e r n e y, Religion, p. 23. Ibid., pp. 56-79, e T i e r n e y, Religion, p. 23.285. Infra, Summa in tit. C. 12.4, §§ 10-13.
III.3.1. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CXCV
ti, vanno ‘concordati’:286 per trovare infatti un punto di contatto tra divergenti correnti di pensiero, cita uno dei pochi passi romanistici in cui non viene esal-tata la superiorità numerica, la costituzione Deo auctore di Giustiniano, nella quale l’Imperatore, per la compilazione del Digesto, dichiarava che si poteva talvolta derogare al criterio aritmetico del numero di opinioni convergenti, e accettare il parere di uno, qui potest multos et maiores in parte aliqua supe-rare.287 È assai probabile che, dietro le convinzioni di Rolando, non vi siano affatto preoccupazioni di carattere sociale – come potrebbe indurre a pensare il riferimento al canonico e al cardinale, o il ricorso a termini come inferioris e maioris –, quanto piuttosto la valorizzazione di esperienze individuali. Da giudice dotto che ha già sperimentato il ruolo di consulente negli organi di go-verno della sua città, egli sembra qui ricorrere alle fonti ecclesiastiche per ga-rantire, anche in campo secolare, l’espressione del parere politico più compe-tente a prescindere dai meccanismi di maggioranza, meccanismi che, proprio negli ultimi decenni della sua vita (che coincidono con i primi del Duecento) stanno trasformandosi radicalmente. Rolando sembra cioè qui farci toccare con mano quello che resterà un nervo scoperto nelle regole di rappresentanza comunali di tutto il Duecento, il problema di come salvaguardare la possibili-tà di interventi individuali qualificati in governi in cui si andranno sempre più irrigidendo criteri di rappresentanza politica su base numerica. Il suo pensiero invita perciò a non assumere in senso semplificatorio una bipartizione che ten-da a confinare la qualitas alle regole di rappresentanza canonica, schiacciando l’esperienza secolare su criteri meramente quantitativi. I collegi di sapientes che affiancarono costantemente i veri e propri consigli deliberativi lungo tut-ta la storia comunale, si avvicinano molto a una traduzione istituzionale laica della sanioritas ecclesiastica, benché gli estesi poteri decisionali che concre-tamente esercitarono non furono mai espressamente teorizzati.288
Che non sia ad un’apertura sociale che puntano le parole di Rolando è reso comunque indiscutibile dal modello di maggioranza qualificata che anche in campo laico comincia ad essere adombrata da lui stesso e da altri civilisti, i quali giungeranno in breve a teorizzare la superiorità di una parte dell’assemblea non perché più meritevole e portatrice di un’opinione più giusta rispetto alla mag-
286. Cfr. supra, III.2.3., La tassazione;; sul significato profondo delle operazioni di ‘con-cordanza’, K u t t n e r, Harmony.
287. Cfr. C. 1.17.1.6288. Per il significato politico dei collegi di sapientes comunali, sia consentito rimandare
a M e n z i n g e r, Giuristi e politica, e E a d., Pareri eccezionali. Per una riflessione sul si-gnificato di maggioranza nel Basso Medioevo, cfr. quanto afferma Giacomo T o d e s c h i -n i (Visibilmente crudeli, p. 262), secondo il quale, tra XII e XIII secolo, si verificherebbe il passaggio dall’unanimità a “il diritto prevalente del sottogruppo più potente e più riconoscibile nell’ambito di un organismo decisionale ossia di un apparato per sua natura esclusivo …”.
CXCVI Diritto pubblico tra Impero e città
gioranza, come la sanior pars canonica, ma perché più rappresentativa degli interessi economici del collegio o del gruppo. Il punto è chiarito nella Summa quando viene spiegato il modo in cui la curia urbana deve scegliere gli affittuari dei beni comuni cittadini, per ricavare proventi da investire sulle cariche pubbli-che. Non si tratta di un tema neutro: sappiamo infatti che è proprio per decisio-ni riguardanti tali beni che i governi consolari del XII secolo sperimentarono le prime votazioni a maggioranza.289 Non sembra casuale quindi che interessanti riflessioni sul consenso vengano espresse da Rolando in materia di beni comuni, per decidere la destinazione dei quali, afferma, è necessario il consenso di tutti i curiales, ma soprattutto dei più ricchi tra loro:290 è infatti degno di nota che si presti credibilità ai più ricchi, quasi questi venissero a rappresentare la maggior parte, come accade, spiega il giudice, nel campo del credito, dove – stando al Digesto – all’interno di un gruppo di creditori, la maggior parte è intesa coinci-dere con quei creditori cui spetta la restituzione della somma maggiore (maio-rem esse partem pro modo debiti, non pro numero personarum placuit).291 Stes-so discorso in campo successorio, dove per erede maggiore si intende colui cui spetta l’eredità più cospicua, e in campo processuale, dove si presta maggiore fede ai testimoni più ricchi.292 Rolando giunge dunque all’enunciazione di un principio di diritto pubblico attraverso la valorizzazione di regole che nel Cor-pus iuris si riferiscono a situazioni di carattere privatistico (credito, eredità), in
289. Cfr. gli esempi addotti da D e A n g e l i s, “Omnes simul”, pp. 37-40.290. Infra, Summa in tit. C. 10.34, §§ 9-12 ( Infra, Summa in tit. C. 10.34, §§ 9-12 (Et erunt locanda talia predia illis conducto-
ribus in quibus consentiant omnes de curia, et maxime ditiores curiales vel illis qui dabunt ido-neam fideiussionem … et ditioribus quidem curialibus creditur, quod est nota dignum … quasi illi reputantur maior pars). Ad analoghe conclusioni giunge quando parla di vendita dei beni comuni: Summa in tit. C. 11.32, § 7: Debent autem interesse omnes curiales vel maior pars eo-rum item et honoratorum et possessorum civitatis, et propositis sacrosanctis scripturis singilla-tim unusquisque designet sententiam quam utilem sue patrie putaverit.
291. D. 2.14.8. Al successo di questo passo di Papiniano contribuisce peraltro l’idea in esso avanzata secondo cui, in caso di eguale ripartizione della somma da ottenere tra un numero pari di creditori, il pretore deve prediligere l’autorità di colui che si distingua per dignità (Quod si aequales sint in cumulo debiti, tunc plurium numerus creditorum praeferendus est. In nume-ro autem pari creditorum auctoritatem eius sequetur praetor, qui dignitate inter eos praecellit). Che Rolando tenga in alta considerazione tale principio è visibile anche dal fatto che aggiunge l’allegazione di questo passo alla citazione di un brano di Pillio da Medicina, riportato nella sua Summa in tit. C. 10.47, §§ 10-15. La valorizzazione, da parte di Rolando, di queste anti-che regole sul credito va in una direzione opposta a quella teorizzata per il pensiero filosofico-giuridico dell’Età Moderna da Francesco G a l g a n o (La forza, pp. 95-105) secondo il quale i meccanismi di voto delle più antiche società per azioni avrebbero esercitato un’influenza di-retta sulle teorie del consenso, anticipando forme di ‘democrazia economica’ rispetto a quella politica. Per una contestualizzazione storica delle idee di G a l g a n o nel Seicento inglese e un’interpretazione diversa della presunta ‘democraticità’ dell’East India Company, cfr. ora G i a l d r o n i, East India Company, pp. 247-274.
292. Infra, Summa in tit. C. 10.34, §§ 10-11.
III.3.1. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CXCVII
linea con ciò che Tierney rilevava in merito alla massima Quod omnes tangit e ad altri importanti acquisizioni del pensiero costituzionale: i giuristi medievali attingono cioè a principi di diritto privato romano, che vengono poi trasformati, in seno al diritto ecclesiastico, in principi costituzionali e riassorbiti, in questa nuova forma, nella sfera del governo secolare; un processo che non presuppone l’imitazione di un corpo separato da parte dell’altro, ma la condivisione del me-desimo patrimonio giuridico-culturale.293
L’idea che le capacità rappresentative di un ceto poggino comunque su presupposti di status torna spesso nella Summa: gli incarichi in favore della patria vanno assunti dai più degni per merito e per ricchezza; i munera perso-nali per la res publica devono essere preferibilmente ricoperti da coloro che la fortuna ha reso ricchi o degnissimi;; le cariche onorifiche che spettano ai de-curioni non possono essere ricoperte da plebei, ma da chi è reso degno e ricco dalla fortuna, etc.294 A conclusioni molto simili giunge Pillio da Medicina,295 il quale, in uno di quei passi della propria Summa fatti confluire da Rolando nella seconda versione della sua, afferma che: affinché le decisioni (decreta) dei decuriones abbiano valore, devono essere presenti tutti i componenti della curia cittadina o la maggior parte di loro, vale a dire i due terzi o più, e so-prattutto i più ricchi e nobili; altre volte, afferma ancor più esplicitamente, la maggior parte è invece da intendersi non in base al numero delle persone, ma alle ricchezze (alias autem non pro numero personarum, sed pro modo facul-tatum maior pars accipitur).296 Per inciso, Pillio esemplifica bene, a differenza
293. T i e r n e y, Religion, pp. 23-25; sull’importanza di questa intuizione è tornato re-centemente M a r t í n e z - T o r r ó n, Les influences canoniques, p. 16.
294. Rispettivamente, infra, Summa in titt. C. 10.32, §§ 84-96, C. 10.43, §§ 4-8, C. 10.52, §§ 41-57. Cfr. anche quanto affermo supra, III.1.1., Fiscalità e militia, in merito alla Nov. 15.6.
295. Confino la mia analisi a un intervento specifico di Pillio in materia di rappresentanza politica;; per altre fondamenatli idee dello stesso autore, già valorizzate dalla storiografia giu-ridica (per esempio P o s t, Studies, p. 64 e sgg.) e citate da Rolando nella Summa, cfr. infra, Summa in titt. C. 10.39, § 67, C. 10.47, §§ 10-11, in cui Pillio enuncia il principio per cui ciò che è deliberato dalla maggioranza, o ciò che è compiuto dai suoi rappresentanti, deve essere considerato come deliberato e compiuto da tutti (quod enim maior pars curie facit pro eo, est ac si omnes fecissent, et ad universos refertur quod publice fit per maiorem partem; oppure: municipes scire intelliguntur quod sciunt hii quibus cura municipii est commissa … nam et uni-versis redditur, quod pro voto omnium eorum primatibus indulgetur … municipes quoque iura-re intelliguntur iurantibus ipsorum administratoribus, etc., concetto che compare in modo più circostanziato anche in Rolando: Sicut autem tutores locum pupille, sic et cives ergo et civitatis primates optinent locum rei publice, et rite universis redditur quod pro voto omnium primati-bus indulgetur. Nam etsi omnes cives deberent iurare, si consules eorum iurant, omnes iurasse videntur: Summa in tit. C. 11.30, § 46).
296. Infra, Summa in tit. C. 10.47, §§ 10-15. La posizione è in linea con idee espresse altrove da Pillio e in generale dai civilisti seguenti: A i m o n e - B r a i d a, Principio, pp. 222-227.
CXCVIII Diritto pubblico tra Impero e città
di Rolando, ciò che Ruffini sosteneva per il mondo comunale laico, la predi-lezione cioè per una maggioranza numerica (benché condizionata da questa variante sociale), accompagnata dal netto rifiuto che il giurista modenese op-pone a prendere in considerazione e dare validità a decisioni decretate da una minoranza (quid autem a pauciori numero factum fuerit non valebit).297
Non sembra un caso che questi autori giungano a teorizzare una prevalen-za di status proprio commentando i passi del Corpus iuris relativi ai decurioni: sollecitava infatti tali riflessioni in entrambi l’immagine tardo-antica che di tali ufficiali restituiva il Codice, il cui compito primario era quello di riscuo-tere le imposte e versarle all’erario, con il rischio però di vedere intaccate le loro stesse sostanze se il governo centrale avesse riscontrato delle omissioni. Ecco il motivo per cui le fonti romane insistevano in alcuni passi sull’impor-tanza delle fortune individuali del curialis (o decurione), perché, per dirla con Rolando, si male agat, sit unde solvat.298 Nell’equazione adesso stabilita tra magistrati comunali e curiales, potevano pertanto essere valorizzati quei passi romanistici sulla ricchezza, in un contesto e per fini diversi.
Queste riflessioni di Pillio e Rolando documentano una fase precoce dell’evoluzione che in campo laico subisce l’idea di sanior pars, formula spes-so valorizzata nel suo esito finale trecentesco, e in particolare con Marsilio da Padova e la teorizzazione della sua valentior pars, ma che sembra importante contestualizzare propriamente nello scenario storico di fine XII-inizio XIII se-colo. È a questa altezza che si verifica una delle prime metamorfosi del pote-re comunale, non più identificabile con ristretti collegi aristocratici, sostituiti sempre più frequentemente da consigli di crescenti proporzioni e composti da un’umanità assai più variegata.
3.2. Cittadinanza, fiscalità, giurisdizione: tre sfere interconnesse
Nell’ambito dei trattati dedicati al diritto pubblico giustinianeo, alcuni giuristi italiani avanzarono originali riflessioni politiche che ebbero ad ogget-to, tra gli altri temi, la questione della cittadinanza. Le ricerche che si sono occupate di questo tema nel mondo comunale hanno più volte sottolineato la difficoltà di definire un concetto univoco di cittadinanza, per le grandi diffe-renze con cui la materia venne regolamentata dagli statuti dei singoli comuni e per le diverse forme di cittadinanza coesistenti nell’ambito delle medesime realtà.299 Questa varietà di ordinamenti va ricondotta alla situazione politica
297. Infra, Summa in tit. C. 10.47, § 14.298. Infra, Summa in tit. C. 10.43, § 6: Et ideo dixi divitem preferendum, qui pro modo
fortunarum, idest divitiarum, debet eligi et vocari ut, si male agat, sit unde solvat, ut s. de decur. l. Ad subeunda (C. 10.32.46), C. e. t. l. ult. (C. 10.43.4)
299. Si vedano le considerazioni di C o s t a, Civitas, 1, pp. 13-18.
III.3.2. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CXCIX
delle città dell’Italia centro-settentrionale, centri di potere autonomi che, seb-bene ispirati a criteri istituzionali comuni, regolarono in modi molto diversi le questioni dell’appartenenza e dell’accesso alla civitas e gli effetti di questa condizione. A testimonianza della scarsa uniformità di orientamento sul tema è spesso addotta la corrispettiva fragilità del pensiero dei giuristi comunali sulla cittadinanza che, prima del XIV secolo, in altre parole prima di Cino da Pistoia († 1336/37), Bartolo da Sassoferrato († 1357) o Baldo degli Ubaldi († 1400), avrebbero espresso uno scarso interesse per l’argomento, senza giun-gere a una sistemazione coerente della materia.300 Credo che da una parte sia possibile una visione più ottimistica, perché un interesse per la cittadinanza compare già a partire dalla seconda metà del XII secolo;; dall’altra che le rifles-sioni dei giuristi trecenteschi non rappresentino semplicemente una evoluzio-ne o una fase matura del pensiero giuridico comunale, ma attestino piuttosto l’elaborazione di un concetto diverso di cittadinanza, i cui contenuti cambiano in circa due secoli di storia urbana. Tali convinzioni si basano principalmente sull’esame delle riflessioni che, a cavallo dei secoli XII e XIII, Pillio da Medi-cina e Rolando da Lucca formularono nelle loro Summae ai Tres Libri.
L’esame del pensiero sulla cittadinanza nel secolo XII riveste una rile-vanza notevole se consideriamo che, a quest’altezza, il fenomeno delle auto-nomie cittadine è relativamente nuovo. La cittadinanza costituisce un terreno di confronto fondamentale per qualsiasi potere pubblico che rivendichi un’au-torità su una determinata area geografica e sulle persone che la popolano. In base a quali criteri si poteva essere definiti cives? Cosa comportava questo status? Sono domande tutt’altro che secondarie per un’epoca in cui esiste un massiccio fenomeno di migrazione dalle campagne verso le città, nonché una discreta mobilità fisica in conseguenza della rinascita economica e dei com-merci. Attraverso il confronto con quei passi della compilazione giustinianea all’interno dei quali i giuristi romani avevano spiegato i criteri di appartenenza all’Impero e gli effetti della cittadinanza romana, gli esperti di diritto medie-vali cercano dunque di definire le regole da applicare nelle loro città. I luoghi principali in cui i compilatori giustinianei sistemarono la materia della citta-dinanza sono due: i titoli De municipibus et originariis e De incolis contenuti nel decimo libro del Codice, e il titolo Ad municipalem, con cui si apre l’ulti-mo libro del Digesto.301 Come molte altre sezioni del diritto pubblico romano, costituiscono tre punti poco frequentati dalla scienza giuridica medievale, il
300. Benché ricche di riferimenti a testi dottrinari e statutari precedenti, le ricerche sul-la cittadinanza hanno valorizzato soprattutto le considerazioni di questi autori. Cfr. in parti-Cfr. in parti-colare B o w s k y, Medieval citizenship, K i r s h n e r, “Civitas”, I d., “Ars”, I d., Mulier, R i e s e n b e r g, Citizenship, C a n n i n g, The political thought, pp. 159-184.
301. Rispettivamente: C. 10.39, C. 10.40 e D. 50.1.
CC Diritto pubblico tra Impero e città
che fa maggiormente risaltare le brevi ma importanti riflessioni di Pillio, e la vasta e articolata trattazione di Rolando, il cui interesse per il tema è testimo-niato in primo luogo dall’estensione del commento.302
In materia di cittadinanza, i problemi che la costruzione giustinianea po-neva al giurista comunale erano di due ordini diversi: il primo consisteva nel conciliare l’appartenenza a una cittadinanza universale romana,303 quella cioè che consentiva di sentirsi destinatari di tutti i diritti civili originariamente spet-tanti al cittadino romano, con la realtà particolare nella quale un intellettua-le del XII secolo era inserito. L’esigenza di classificare le proprie città come municipia, centri diversi da Roma, l’appartenenza ai quali consentiva l’ac-quisto della cittadinanza romana, sembra essere chiaramente avvertita da Pil-lio all’inizio del suo commento, nel quale egli provvede subito ad accostare agli esempi contenuti nel Codice di municipes, i cittadini a lui più familiari di Ferrara e Bologna.304 Stabilire che i comuni avevano il rango di municipia consentiva ai rispettivi cives di essere titolari dei diritti romani, perché l’ap-partenenza a città così classificate rappresentava il canale per accedere alla patria universale romana.305 Pillio, ma in misura persino maggiore Rolando, mostrano una perfetta coscienza di questo automatismo e dell’artificio giuridi-co attraverso il quale è reso possibile: sembra infatti significativo, nelle opere di entrambi, il richiamo a quei passi, in particolare del Digesto, in cui i giuristi romani avevano enunciato la forza del concetto di Roma communis patria.306
Rolando spiega chiaramente che, per mezzo di questo concetto, tutte le per-sone libere possono dirsi a pieno titolo cives Romani perché Roma, come fonte della legge, caput mundi e vertice del sommo pontificato è un riferimento astrat-to che trascende l’identificazione con un luogo materiale.307 Due punti di questa affermazione sembrano di estremo interesse: il primo è la coincidenza tra libertà e cittadinanza romana, ossia il principio per cui, per dirla con Rolando, voca-mur omnes qui sumus liberi cives Romani.308 Per quanto astratto possa sembrare questo ragionamento, si tratta di una idea tutt’altro che relegata ai testi di diritto
302. Cfr. infra, Summa in titt. C. 10.39 e C. 10.40.303. Le cui vaste implicazioni sociali e giuridiche nel mondo romano sono state oggetto
di un approfondito studio da parte di T h o m a s, “Origine”. Per alcune riflessioni sull’impatto di questa idea sulla canonistica del XIII secolo, cfr. C o p p e n s, Roma communis.
304. Infra, Summa in tit. C. 10.39, §§ 9-10. 305. Cfr. T h o m a s, “Origine”, pp. 1-9.306. Si tratta, in particolare, dei passi di Modestino (D. 50.1.33), in cui compare la formu-
la Roma nostra communis patria e di Paolo (D. 50.5.9), entrambi citati da Rolando in Summa in tit. C. 10.39, § 74; il passo di Modestino è richiamato anche da Pillio nel commento al titolo de incolis (infra, Summa in tit. C. 10.40). Per la rilevanza di questi passi nella costruzione del concetto di cittadinanza universale romana, cfr. T h o m a s, “Origine”, pp. 9-23.
307. Infra, Summa in tit. C. 10.39, § 74.308. Ibid.
III.3.2. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CCI
colto. Rolando stesso, in veste di giudice, applicava questo principio nei tribu-nali della sua città: ci è noto infatti che nel 1192, quando si trovò a definire una controversia tra il vescovo di Lucca e alcuni contadini, li dichiarò liberi homines et cives romani per indicare appunto la condizione di libertà.309
Nei Libri iurium di Genova, vale a dire quei libri in cui nel XII secolo venivano conservati gli atti rilevanti per il Comune e le decisioni dei consoli, vi sono almeno tre casi in cui questa idea è resa operativa: nel 1166, quan-do i consoli di Genova condannarono alcuni eminenti personaggi locali con l’accusa di avere consegnato un castello sottoposto alla città al marchese di Monferrato, emanciparono i loro servi affermando che, d’ora in avanti, i servi fossero sciolti da qualsiasi vincolo di servitù e godessero di tutti quei vantaggi connessi alla cittadinanza romana.310 Che con l’espressione beneficio floride civitatis Romane perfruantur si intendessero quelle prerogative che si desi-gnano oggi come diritti civili, è reso evidente da altri due documenti genovesi di poco successivi (1173) nei quali, per vendicarsi della ribellione da parte dei conti di Lavagna, i consoli di Genova emanciparono per rappresaglia i loro servi; questi sarebbero stati liberi, d’ora in poi, di godere di tutti i vantaggi connessi alla cittadinanza romana, ossia, specifica il testo, di acquistare, ven-dere, donare, permutare, obbligarsi, fare testamento e compiere tutti gli altri civilia negotia normalmente spettanti a un uomo libero.311
309. L’idea apparentemente circolava all’epoca a Lucca, considerato che con questa af-fermazione Rolando confermava la petizione dei contadini che chiedevano al vescovo di non fare eis litem vel molestiam pro aliqua manentia vel colonaria sive inquilinaria condictione sed permittat eos et eorum posteros stare et habitare ubicumque voluerint sicut liberi homines et cives Romani …: S a v i g n i, Episcopato, pp. 200-201;; il documento testimonierebbe, se-condo l’Autore, l’opposizione dei tenitores di terre ecclesiastiche ad essere omologati alla con-dizione semiservile dei manentes (ibid., p. 78). Sullo stesso caso, cfr. supra, C o n t e, II.1.7., Il modello imperiale; sulla questione dei manentes nel pensiero di Rolando da Lucca, cfr. I d., Servi, pp. 104-116.
310. I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/1, doc. 199, pp. 291-292: In ecclesia Sancti Laurentii, in publico parlamento, consules comunis … laudaverunt quod universi servi et ancille Guilielmi Gimbi de Carmandino, Boterici vicecomitis et Guilielmi Monticelli, cuiu-scumque sexus vel etatis, sint liberi et ab omni servituitis vinculo absoluti ac de cetero honore, comodo et beneficio floride civitatis Romane omnifariam perfruantur …
311. Ibid., doc. 240, pp. 341-342: Ianue, in publico parlamento, consules de comuni … laudaverunt quod Bertolotus filius quondam Guinengisi de Cademarçano, Nobilinus de Lava-nia …, sint liberi et et ab omni servitutis vinculo absoluti et mera puraque libertate, honore, commodo ac beneficio floride civitatis Romane perfruantur, emendo scilicet, vendendo, donan-do, permutando, in solutum dando et ab aliis stipulando seseque aliis obligando, testamentum quoque ac cetera civilia negotia faciendo … La medesima formula è utilizzata in un altro do-cumento che porta la stessa data (ibid., doc. 242, pp. 349-350), dove è registrata l’emancipazio-ne di un certo Albertino di Gandolfo, effettuata, anche in questo caso, dai consoli genovesi per punire la ribellione dei conti di Lavagna.
CCII Diritto pubblico tra Impero e città
Non stupisce che considerazioni di questo genere siano rintracciabili per un’epoca così risalente proprio nella documentazione genovese, essendo Ge-nova una delle città che, insieme a Pisa, mostra maggiore familiarità con il diritto romano. Per inciso, Lucca e Genova sono a quest’epoca legate da patti commerciali e, in base ai dati biografici di cui disponiamo, il giudice Rolando potrebbe essere entrato in contatto diretto con alcuni colleghi genovesi: non solo infatti egli è ricordato nel 1181 e nel 1188 come testimone di trattati di pace tra Pisa e Genova ratificati a Lucca,312 ma in un passo della sua Summa descrive anche la posizione del faro del porto di Genova, ricordo forse di un viaggio svolto personalmente nel capoluogo ligure.313
Il secondo aspetto rilevante che emerge dalle riflessioni di Rolando sul concetto di patria comune è l’aggiunta della residenza del pontefice come mo-tivo dell’universalità di Roma.314 Per la grande popolarità di cui godrà que-sta idea nei secoli XIII e XIV, è bene procedere a un esame puntuale del suo pensiero. L’originalità, in questo caso, non è data tanto dalle frasi con cui si esprime il giudice, tratte quasi integralmente dalla compilazione giustinianea, quanto piuttosto dall’accostamento che egli propone dei passi del Corpus iu-ris. In particolare, la triplice identificazione di Roma con l’astratta commu-nis patria del Digesto, con la sede concreta del pontefice, menzionata dalle Novelle,315 e con il luogo in cui risiedeva l’Imperatore, da equipararsi a Roma, secondo il Codice,316 sortiva l’effetto di trasferire i temi dell’universalità alle residenze papali. Si andavano così definendo gli importanti presupposti che, alla metà del 1200, consentirono a papa Innocenzo IV di dichiarare “dove si trova il Papa, lì è Roma” (ubi papa, ibi Roma), formula gravida di conseguen-ze nel Trecento, quando avverrà il trasferimento della Curia ad Avignone. Sarà allora che Alberico da Rosate († 1360), commentando il passo citato di Mo-destino (D. 50.1.33), giungerà alla formulazione ancor più esplicita: Roma est ubicumque sedet dominus Papa cum curia sua.317
312. Per il 1181, cfr. W i c k h a m, Legge, p. 98; per il 1188, I Libri iurium della Repub-blica di Genova, I/4, doc. 673, pp. 43-48, e supra, B a g n a i L o s a c c o / T h e i s e n, I.2., Profilo biografico.
313. Infra, Summa in tit. C. 11.6, § 58.314. Infra, Summa in tit. C. 10.39, § 74.315. Cfr. la Novella Ut ecclesia romana centum annorum habeat prescriptionem (Auth.
coll. 2.4=Nov. 9 praef.), che inizia con la frase Et legum originem anterior Roma sortita est, et summi pontificatus apicem apud eam esse nemo est qui dubitet, citata quasi alla lettera da Ro-lando (infra, Summa in tit. C. 10.39, § 74).
316. Così in base alla costituzione di Giustiniano (C. 1.17.1.10) che equiparava Costanti-nopoli a Roma: … Romam autem intellegendum est non solum veterem, sed etiam regiam no-stram, quae Deo propitio cum melioribus condita est auguriis, citata da Rolando nel medesimo passo.
317. P r o s d o c i m i, “Roma”, p. 47 in nota.
III.3.2. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CCIII
Se questo esempio testimonia la complessità di un’operazione che, su un piano astratto, mirava all’applicazione del concetto di communis patria alle città del 1100, difficoltà assai maggiori poneva la distinzione romanistica tra origo e domicilium, vale a dire tra cittadinanza originaria, acquisita per di-scendenza, e invece la semplice residenza in un luogo, non comportante, di per sé, l’acquisto della cittadinanza. Si discute anzi se la differenza tra civis e habitator venisse ancora percepita e comportasse delle differenze significative di diritti, o viceversa fosse del tutto scomparsa nel XII secolo, come sembra-no provare molti documenti che usano i termini in modo intercambiabile.318 È quanto possiamo constatare per esempio a Lucca durante i primi decenni del 1100, quando il marchese Corrado, confermando i privilegi concessi da Enri-co IV alla città, tradusse il termine cives, che figurava originariamente nel di-ploma imperiale, con l’espressione habitatores Lucane civitatis.319
La preoccupazione che la costruzione romana destava nel giurista comu-nale era il ruolo prevalente da assegnare alla cittadinanza originaria, quella cioè acquistata iure sanguinis (per discendenza da un padre cittadino) o iure loci (per nascita nel territorio cittadino), perché poteva costituire un limite per le competenze delle autorità comunali. L’idea romanistica secondo cui un in-dividuo era legato al luogo nel quale era nato o da cui discendevano i propri antenati, costituiva un presupposto scomodo e che alterava la naturale aspet-tativa della città di esercitare la propria autorità su tutti i soggetti e le cose che di fatto rientravano nel proprio territorio. Le ragioni sono evidenti: non siamo più in un ‘sistema’ organizzato su vasta scala, con un coordinamento e una gerarchia degli organi amministrativi e giurisdizionali, ma in entità politiche autonome, le cui prerogative statali si arrestano davanti ai confini della sfera di influenza politica.
La forza legittimante riconosciuta a quest’epoca al diritto romano non consente però di sbarazzarsi facilmente delle parti poco attuabili di quel dirit-to, tanto più se consideriamo, nel caso di Rolando, la marginalità professio-nale e geografica rispetto alle sedi culturali del suo tempo e la fede politica filoimperiale che lo portava ad attribuire un particolare valore ideologico alle fonti del Corpus iuris. Come si coordinano allora le esigenze di un contesto politico fortemente ancorato a una cittadinanza di fatto e una costruzione che fondava la cittadinanza su criteri originari di discendenza? Nonostante qual-che incertezza terminologica, il problema è chiaramente avvertito dal giudice lucchese, che nella sua opera fornisce soluzioni originali e rivelatrici in certa misura del pensiero di un’epoca.
Nel suo lungo ed articolato ragionamento giuridico egli sembra comples-sivamente orientato a convalidare due fondamentali rivendicazioni dei gover-
318. Cfr. B i z z a r r i, Ricerche; C o r t e s e, Cittadinanza.319. S a v i g n i, Episcopato, p. 49.
CCIV Diritto pubblico tra Impero e città
ni urbani: della prima abbiamo già parlato, vale a dire il diritto della città a riscuotere imposte dalle terre situate nella propria area di influenza politica. Collegata a questa istanza ve n’è però un’altra, stabilire cioè l’autorità dei con-soli su chiunque risieda all’interno delle mura urbane o nel territorio dominato dal Comune. Per entrambi questi argomenti la cittadinanza riveste grande im-portanza, e non sembra essere un caso il fatto che riflessioni giuridiche in pro-posito comincino a svilupparsi, nei comuni italiani, proprio in coincidenza dei primi estimi. Ciò che concretamente interessa al giudice è impedire che uno straniero residente nella città possa avvalersi del pretesto di essere originario di un altro posto per sottrarsi ai doveri del luogo di residenza. Egli si chiede infatti: come devono comportarsi i consoli lucchesi qualora una persona che abiti a Lucca si rifiuti di sottostare agli obblighi che gli vengono qui imposti, rivendicando di essere originario di Bologna? Persino nel caso in cui proven-ga da Bologna, fonte di giustizia per eccellenza, la questione, secondo Rolan-do, non compete all’autorità preposta alla Romagna.320 Questa affermazione si spiega alla luce di una convinzione espressa altrove dal giudice, secondo cui chiunque intenda sottrarsi a un dovere impostogli dalle autorità comunali deve provare le sue ragioni davanti a un tribunale, e non può considerarsi libe-ro dall’impegno fin tanto che non lo dichiari tale la sentenza di un giudice.321 Per Rolando, dunque, non vi sono dubbi: chi abita a Lucca deve sottostare agli obblighi impostigli dai consoli cittadini, e per qualsiasi contestazione sono competenti i tribunali lucchesi.
La soluzione, tuttavia, non è così semplice. Al principio romano secondo cui il legame con la città di origine non si spezza semplicemente spostando il domicilio, si aggiunge infatti il fascino intrinseco che possiede l’origo agli occhi tanto di Pillio quanto di Rolando, perché essa è determinata dalla natu-ra che, nel pensiero medievale, è fonte di veritas.322 La cittadinanza derivan-te dal domicilio, invece, può ben apparire come un’appartenenza fittizia, una finzione che si sovrappone alla naturalità dell’origo. La preferenza assoluta da accordare alla veritas è chiaramente enunciata da entrambi nei rispettivi commenti, dove vengono allegati numerosi esempi in cui questo criterio deve essere rispettato.323
320. Infra, Summa in tit. C. 10.39, § 70.321. Infra, Summa in tit. C. 10.48, §§ 7-10.322. Cfr. le importanti considerazioni sull’uso estensivo della fictio nel diritto romano e il
suo impatto sul pensiero giuridico medievale, formulate da T h o m a s, Fictio;; per le riflessioni sul binomio fictio-veritas nella dottrina trecentesca, cfr. K i r s h n e r, “Ars”, e C a n n i n g, The political thought, pp. 170-177.
323. Infra, Summa in titt. C. 10.39, §§ 3-8 (Origo, inquam, vera; nec enim assumptio originis, que non est, veritatem nature perimit: errore enim veritas originis non amittitur, nec mendacio dicentis se esse unde non sit deponitur; nec recusando quis patriam, de qua oriundus
III.3.2. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CCV
Sorgevano inoltre una serie di quesiti pratici tutt’altro che secondari. Cosa sarebbe accaduto, per restare nell’esempio di Rolando, se Bologna aves-se imposto degli obblighi al bolognese per nascita trasferitosi a Lucca? Costui doveva considerarsi ora civis Lucanus? E se Bologna e Lucca lo avessero con-temporaneamente chiamato ad assolvere dei doveri, a quale autorità avrebbe dovuto obbedire?
Per superare questi ostacoli, Rolando cerca di valorizzare tutti gli esempi di cittadinanza artificiale menzionati dal Corpus iuris in cui si poteva derogare al criterio dell’origine. Ciò si verificava, per il diritto romano, principalmen-te in tre casi: l’adozione, l’affrancamento e la adlectio (cittadinanza acquisita per privilegio concesso da una città). Benché Rolando descriva succintamen-te quest’ultima e menzioni la regola romana secondo cui l’adottato assume-va l’origine dell’adottante,324 sembra complessivamente essere molto più at-tratto dal tema dell’affrancamento, cui dedica uno spazio piuttosto vasto nel suo commento.325 Questo perché il liberto non solo era tenuto, analogamente all’adottato, ad assumere un’origine diversa dalla propria, divenendo cittadi-no del luogo di cui era originario il padrone che lo liberava; ma – e questo è il punto che davvero interessa il giudice – poteva trovarsi a godere di una citta-dinanza multipla. Rolando spiega infatti che, se lo schiavo fosse stato eman-cipato da più padroni aventi origini diverse, avrebbe dovuto seguire la patria di tutti;326 lo stesso si verificava, a suo avviso, quando lo schiavo veniva libe-rato da un padrone con una doppia cittadinanza: secondo un famoso privilegio menzionato dal Digesto, i figli di matrimoni misti tra le donne di Ilio, di Delfi e del Ponto, e uomini stranieri potevano eccezionalmente assumere la cittadi-nanza della madre,327 e dunque, secondo Rolando, essere municipes di due città, trasmettendo così una duplice cittadinanza agli schiavi che avessero emancipa-to.328 Il punto riveste una importanza notevole nel pensiero del giudice perché
est, neque mentiendo ‹de ea› quam non habet, veritatem mutare potest … In iure nulla maligna-tione vel ymaginatione nature veritas debet obumbrari. … Veritas enim rerum gestorum erro-ribus non vitiatur … et opinioni veritas prefertur … nec confessio contra naturam et veritatem facta preiudicat … Falsa enim demonstratio veritatem non perimit …; quod enim naturale est, simulatione aliqua tolli non potest, quia iura naturalia et sanguinis tolli non possunt), C. 10.11, §§ 22-23 (testantis error non tollit veritatem … Veritas enim opinioni – licet contra dicatur – prefertur), C. 10.33, § 10, C. 11.06, § 52 (‹testibus› supradictis deficientibus, ab aliis veritas inquiratur; … quod est nota dignum, ne veritas lateat, est inquirendum), C. 12.36, §§ 18-19. Per il significato originario dei riferimenti alla natura nel Corpus iuris e il processo attraverso il quale vengono cristianizzati nel diritto medievale, cfr. T h o m a s, Fictio, pp. 37-38.
324. Infra, Summa in tit. C. 10.39, §§ 42, 47.325. Ibid., §§ 23-34. 326. Ibid., §§ 26 e 30.327. D. 50.1.1. 328. Infra, Summa in tit. C. 10.39, §§ 28-29, e l’argomento viene successivamente ripreso
ai §§ 56, 63 e 73.
CCVI Diritto pubblico tra Impero e città
rafforza l’idea secondo cui una persona può trovarsi ad essere contemporanea-mente sottoposta alle autorità comunali di posti diversi. E ciò non solo nei casi eccezionali di cittadinanza multipla, ma anche quando qualcuno semplicemente trasferiva il proprio domicilio in un luogo diverso da quello di origine. Anche in questa evenienza, sottolinea infatti Rolando, un individuo deve sottoporsi alla giurisdizione sia del luogo di residenza che di origine, con l’obbligo di compari-re di fronte ai funzionari pubblici (magistrati) di entrambe le città.329
La vasta trattazione della cittadinanza del liberto è poi arricchita, nel suo commento, da un lungo elenco di altri casi in cui, secondo il diritto romano, una persona poteva mutare in forma più o meno stabile il luogo di residenza. Questo avveniva in prima istanza quando una donna sposava uno straniero e si trasferiva nella sua città: trattandosi di un aspetto inerente a un discorso più vasto sulla cittadinanza femminile, ne parlerò nel prossimo paragrafo.330 La casistica di Rolando include ancora i relegati, che assumevano il domicilio del posto che veniva loro assegnato senza tuttavia perdere quello del luogo da cui erano stati allontanati; gli studenti, che acquistavano il domicilio nella città universitaria soltanto dopo dieci anni; e i senatori che, una volta nominati tali, potevano assumere il domicilio a Roma ed essere esentati dagli obblighi della città di origine.331
Come è noto, sarà solo con il pensiero politico-giuridico del Trecento che i giuristi medievali si emanciperanno dall’idea classica di una cittadinanza di sangue che, secondo il diritto romano, si ereditava dal padre ed era per sua na-tura irreversibile e incancellabile.332 Bartolo da Sassoferrato parlerà tra i primi di cittadinanza come artificio giuridico, non più derivante né dal sangue né dalla nascita in un certo luogo, ma da un patto stretto tra l’individuo e l’autorità cit-tadina.333 Un’idea a ragione molto valorizzata per la sua modernità. Rolando da Lucca però non scrive nel Trecento ma alla fine del 1100;; non ha accesso agli strumenti concettuali di Bartolo, di cui la dottrina giuridica si è munita soprat-tutto in Francia nel secolo e mezzo che li separa;; non sperimenta il flagello dei bandi di massa che colpiranno molte città italiane nella seconda metà del Due-cento e che, nella quotidiana contrattazione processuale di cittadinanze negate e recuperate, spingeranno i giuristi coevi e successivi a Bartolo a distanziarsi dalla componente ‘naturale’ della cittadinanza, esaltandone invece aspetti artificiali e contrattualistici. Rolando ha ben chiaro però un problema che si pone eviden-
329. Infra, Summa in tit. C. 10.40, § 5.330. Infra, III.3.3., La donna medievale.331. Infra, Summa in tit. C. 10.39, §§ 43, 53 e 75-76. 332. Cfr. K i r s h n e r, Civitas; I d., “Ars”; I d., Between nature, pp. 196-203; C a n - Cfr. K i r s h n e r, Civitas; I d., “Ars”; I d., Between nature, pp. 196-203; C a n -
n i n g, The political thought, pp. 170-184.333. Oltre ai lavori di K i r s h n e r citati nella precedente nota, cfr. Q u a g l i o n i,
“Civilis sapientia”.
III.3.2. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CCVII
temente da subito nella riflessione giuridica e politica del Comune, la distan-za che separa la frammentaria esperienza urbana da quella unitaria statale, uno Stato che si delinea sotto ai suoi occhi studiando l’amministrazione pubblica dell’antico Impero romano. Sa bene che, a differenza di questo, la città possiede scarsissimi strumenti per far valere le proprie ragioni oltre il raggio di territorio che è in grado di dominare, un problema consistente in un’epoca caratterizzata da una profonda mobilità fisica di donne e di uomini. Superare l’ostacolo della cittadinanza di sangue romana diviene perciò un imperativo urgente al fine di salvaguardare il principio per cui, dovunque un individuo si trasferisca, continua ad essere sottoposto alle autorità della città di origine come a quelle del luogo di residenza, salva la regola in base alla quale le imposte patrimoniali si pagano là dove il patrimonio è ubicato. È così che Rolando giunge precocemente a un’em-brionale idea di cittadinanza multipla, valorizzando quei luoghi del Corpus iuris che in qualche modo derogavano allo ius sanguinis ed avvicinandosi a un prin-cipio di territorialità del diritto cittadino.334
Le sue considerazioni in materia paiono peraltro gettare una luce diversa sulle teorie di cittadinanza medievali nel loro complesso, modificandone in qualche misura il significato. Se infatti il superamento della cittadinanza ro-mana è stato sempre e giustamente letto in termini molto ideali, come proces-so di emancipazione dal sangue, in queste manifestazioni più risalenti mostra di essere in origine il frutto di esigenze assai concrete, fiscali in primis, aspetto che aveva colto Dina Bizzarri in un articolo cui forse non è stato ancora attri-buito tutto il peso che merita.335 Le politiche di cittadinanza estensive messe in atto dal primo Comune, illustrate dalla Bizzarri, ben si riflettono nel pensiero politico-giuridico della stessa fase, che vede la cittadinanza come un insieme di doveri prima che di diritti, inclusiva più che esclusiva, perché dà accesso ad obblighi assai più che a privilegi.
Il commento di Rolando sulla cittadinanza si conclude con un elenco dei molti casi in cui, in base al diritto romano e non solo, una persona deve sot-tostare a un’altra giurisdizione oltre alla propria (et in non suo foro respon-dere teneatur).336 In questo campo, egli è interessato esclusivamente all’indi-viduazione del foro competente nelle cause in cui fossero coinvolti stranieri, e appare invece del tutto estraneo al dibattito dottrinario relativo al diritto da applicare.337
334. Le convinzioni di Rolando non sembrano confermare, per il XII secolo italiano, l’idea di un’appartenenza basata su criteri di stirpe e di natali, valorizzata da R o s s e t t i nell’Introduzione a: Dentro la città, p. xvi.
335. B i z z a r r i, Ricerche.336. Cfr. infra, Summa in tit. C. 10.39, § 77, in cui il giudice si allinea all’idea romanistica
secondo cui, nel penale, era competente il foro nel quale era stato commesso il delitto.337. Sul quale cfr. S t o r t i S t o r c h i, Aspetti, pp. 13-20.
CCVIII Diritto pubblico tra Impero e città
Ma la complessiva indifferenza nei confronti del diritto statutario è un tratto caratterizzante della sua opera. L’assenza di interesse per il potere nor-mativo comunale risulta particolarmente evidente in un discorso sulla citta-dinanza e si riflette nello scarso rilievo che il giudice accorda alla questione della cittadinanza acquisita per privilegio concesso dalla città. Se Pillio da Medicina non menziona affatto la adlectio come quarta strada per divenire ci-vis, limitandosi alla discussione delle altre tre vie previste dal Codice (nascita, affrancamento e adozione), Rolando dedica all’argomento poche e confuse ri-ghe: il termine adlectio è da lui tradotto con le espressioni expressa voluntas e consensus, che tende però a riferire all’individuo, anziché alla civitas.338 Si tratta di una incomprensione interessante, se si considera il ruolo fondamen-tale che, per superare l’idea di una cittadinanza originaria unica, i giuristi tar-do-duecenteschi e trecenteschi attribuirono alla adlectio come strumento per ottenere una seconda cittadinanza (artificiale) risultante da una disposizione legislativa del Comune.339
Come abbiamo visto, però, il lungo ragionamento su tutte le categorie di persone che nel diritto romano si trovavano a vivere in un posto diverso da quello in cui erano nate o da cui discendevano i propri antenati, consente a Rolando di giungere per altre vie a risultati simili (cittadinanza multipla), ag-girando abilmente il problema. Il disinteresse quasi completo che sia lui che Pillio nutrono nei confronti della adlectio non è dunque motivato dalla man-cata esigenza di superare l’origo, ma sembra piuttosto essere un indicatore del fatto che, per loro, la città non si identifica con la potestas statuendi. Ciò non implica un’indifferenza nei confronti della cittadinanza, quanto piuttosto una visione profondamente diversa dei suoi contenuti. In questa fase della storia comunale, l’espressione del potere della civitas consiste nella rivendicazione di un’autorità esclusiva in campo giurisdizionale e fiscale, che non si presen-tano tanto quali “settori” del potere politico comunale, ma come la vera essen-za di esso. È sul diritto di riscuotere le imposte e sull’esercizio della giustizia che, alla fine del XII secolo, la città fonda la propria identità sia verso l’ester-no, nei confronti del potere imperiale, sia verso l’interno, per ottenere il ri-spetto dei soggetti che la compongono. Per un giudice di quest’epoca, parlare di cittadinanza significa perciò parlare dei diritti fiscali e giurisdizionali della città, fondandone la legittimità su presupposti teorici romanistici.
338. Infra, Summa in tit. C. 10.39, § 48.339. Cfr. K i r s h n e r, Mulier, p. 151. Secondo lo studioso (I d., Civitas, p. 697), prima
di Bartolo il principio di adlectio inter cives fu comunque “rarely developed and related to con-temporary institutions”.
III.3.3. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CCIX
3.3. La donna medievale nella sfera pubblica: alcune riflessioni in tema di cittadinanza
Un esame del pensiero di Rolando in tema di cittadinanza rivela un ina-spettato interesse per alcuni aspetti pubblicistici della condizione femminile. Ciò che lascerebbe erroneamente supporre la lontananza della Summa da ri-flessioni sui diritti/doveri delle donne cittadine sono soprattutto tre elementi: in primo luogo la materia trattata (il diritto pubblico) considerato che, fino alla conclusione del Duecento, pesarono come un macigno sul pensiero giuridico medievale le parole del Digesto che precludevano alle donne qualsiasi via di accesso a incarichi di rilevanza anche solo latamente pubblica.340 L’ambiente scientifico civilista, al quale Rolando fa riferimento per formazione e meto-do, è il secondo aspetto che dovrebbe motivare un certo scetticismo nei suoi confronti da parte di chi si interessi oggi di questioni di ‘genere’: se infatti un’apertura vi fu, nelle riflessioni giuridiche di questa epoca, a una valuta-zione meno pessimista della posizione sociale della donna, non è in campo civilistico ma in quello canonico che dobbiamo cercare, dove a partire dalla seconda metà del XII secolo trovarono qualche spazio considerazioni meno mortificanti dei diritti femminili, in particolare in ambito processuale. È in questa produzione che sarà per esempio valorizzata per la prima volta l’espe-rienza di Matilde di Canossa, che contribuirà a motivare lo schieramento di parte della canonistica (e non solo) a favore del riconoscimento, in casi cer-to eccezionali, di poteri amministrativi e giurisdizionali alle donne.341 Infine, l’epoca in cui Rolando compose la sua opera, i decenni a cavallo dei secoli XII e XIII, che furono quelli di più stretta osservanza dei dettami romanistici da parte dei glossatori e nei quali dunque non ci aspetteremmo deroghe con-sistenti a posizioni nette quali quella del Digesto sulle donne. Non a caso gli studi di Julius Kirshner ed altri sulla cittadinanza femminile prendono avvio dal Trecento, quando la corrente cosiddetta dei ‘Commentatori’ si emancipò dalla sudditanza delle precedenti generazioni nei confronti del diritto roma-no, grazie ai contatti più stretti col diritto canonico e alla valorizzazione delle esperienze statutarie.
Viene fatto di chiedersi, allora, perché un esperto di diritto formatosi nel-la fase consolare della storia comunale includa alcune riflessioni sulla donna in un’opera di marcato carattere romanistico e pubblicistico. Intanto è interes-sante notare che, tra le attestazioni biografiche che documentano la vasta atti-vità di Rolando in qualità di giudice a Lucca, una serie di documenti lo ritrag-
340. D. 50.17.2 pr., Ulpianus: Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio inter-venire nec procuratores existere.
341. M i n n u c c i, La capacità, I, p. 114 e sgg., e cfr. infra.
CCX Diritto pubblico tra Impero e città
gano presente, in veste di iudex, a negozi voluti da donne che, conformemente ad una norma di Liutprando del 721 confluita negli editti longobardi vigenti in Toscana, dovevano dichiarare al giudice, una volta avuto il consenso del pro-prio ‘mundoaldo’, di agire liberamente e senza nessuna costrizione.342 Questi contatti con l’antico diritto longobardo, di cui sono note applicazioni a Lucca e altrove sia per il XII che per il XIII secolo, potrebbero avere suscitato in lui un interesse più vasto per la condizione giuridica femminile e per diritti e ob-blighi della donna del suo tempo.343 La vasta conoscenza che nella sua opera mostra di avere del diritto canonico potrebbe essere un’altra delle ragioni che lo spinge ad assumere una posizione più aperta. Sono però soprattutto le strin-genti esigenze di ordine fiscale ad indurlo a confrontarsi in generale con la materia della cittadinanza, cui, come abbiamo visto, dedica uno spazio vasto nella sua Summa, e ad includere la donna nella trattazione.344
Il ragionamento sui doveri della donna prende avvio in Rolando da una delle principali sedes materiae per le teorie sulla cittadinanza femminile, il titolo del Codice giustinianeo relativo al “luogo in cui debbano essere ricono-sciuti alle donne obblighi e onori compatibili con il loro sesso”.345 In base ad esso, le donne che sposavano uomini di un luogo diverso dal proprio non era-no più tenute a sottostare a munera cosiddetti personali nel paese di origine, bensì presso la residenza del marito, dove si trasferivano in conseguenza del matrimonio. Rimanevano tuttavia responsabili per gli obblighi patrimoniali là dove erano ubicati i loro beni. Come gli studi di Kirshner hanno ampiamen-te dimostrato, la trasposizione di questo principio nell’universo comunale fu fonte di notevoli problemi pratici e interpretativi.346 Le ragioni sono evidenti: tale norma era stata concepita nel III secolo d.C. per i sudditi di un Impero, e si tentava ora, a partire dalla seconda metà del 1100, di applicarla agli abitanti di
342. Cfr. supra, B a g n a i L o s a c c o / T h e i s e n, I.2., Profilo biografico, e un esempio concreto nella trascrizione del documento del 23 febbraio 1184, ibid., Appendice do-cumentaria.
343. Per l’influenza del diritto longobardo sull’inquadramento della donna negli statuti comunali, cfr. S t o r t i S t o r c h i, La tradizione.
344. Lo studio dei doveri, oltre che dei diritti, di cittadinanza è stato posto al centro di al-cune ricerche americane che sono così riuscite a cogliere aspetti profondi della posizione socia-le, politica e giuridica della donna in contesti moderni: cfr. in particolare K e r b e r, No Con-stitutional Right, e quanto afferma in proposito K i r s h n e r, Genere, p. 23.
345. C. 10.64: De mulieribus in quo loco munera sexui congruentia et honores agnoscant: 1. Imperator Philippus A. Claudio: Malchaeam, quae aliunde oriunda alibi nupta est, si non in urbe Roma maritus eius consistat, non apud originem suam, sed apud incolatum mariti ad honores seu munera, quae personis cohaerent quorumque is sexus capax esse potest, compelli posse saepe rescriptum est. Patrimonii vero munera necesse est mulieres in his locis in quibus possident sustinere.
346. K i r s h n e r, Donne; I d., Mulier.
III.3.3. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CCXI
città autonome e non coordinate tra loro da un’unica autorità. Ciò nonostante, questa costituzione si trasformò nel principio regolatore dei doveri femminili in caso di matrimoni intercittadini che, come è noto, furono molto frequenti nel mondo comunale per ragioni sociali, economiche e politiche.
Per chi, come Rolando, fosse coinvolto nel discorso della fiscalità urba-na, i motivi di interesse di questo titolo erano principalmente due:347 in primo luogo il fatto che in esso prevalesse un principio di carattere territoriale, sta-bilendo che le imposte dovevano essere pagate dalla donna al Comune nella giurisdizione del quale possedeva i suoi beni, e non a quello in cui si trasfe-riva. In seconda istanza per il riferimento alle imposte patrimoniali, di cui il giudice sappiamo essere uno strenuo sostenitore. In altro luogo della sua ope-ra dirà chiaramente che le imposte patrimoniali vanno pagate da tutti, si tratti di qualsivoglia privilegiato, di una donna, un miles, un clericus.348 Come ab-biamo visto, siamo di fronte tutt’altro che a riferimenti casuali, nel senso che ognuna di queste categorie rimanda a una fascia di contribuenti fondamentale ma anche problematica per il Comune, come si evince dall’eloquente inclu-sione di milites e clerici tra coloro che devono pagare.349 Nel caso della donna, il problema che essa poteva sollevare al fisco era duplice: da un lato sfruttare in qualche modo l’immunità dagli obblighi cosiddetti personali, quali appunto le cariche e gli oneri pubblici, per non pagare le imposte; dall’altro sottrarre al gettito fiscale del Comune di origine beni immobili che fossero andati a costi-tuire la sua dote congiungendosi in nozze a un uomo di un’altra città. Da qui i divieti, studiati tra i primi da Claudia Storti Storchi negli statuti lombardi, che a partire dalla seconda metà del Duecento, e per i due secoli successivi, si in-contrano frequentemente nelle compilazioni statutarie per impedire che donne abbienti sposassero stranieri, con conseguente impoverimento del patrimonio urbano oggetto di imposizione fiscale.350
Come si è detto, la figura romanistica della cosiddetta mulier alibi nupta (o donna maritata altrove) contribuisce, nel pensiero di Rolando, a giungere a una nuova teoria destinata ad avere molto successo: l’idea che un individuo possa godere di una cittadinanza multipla. Il caso della donna gli torna a tal fine particolarmente utile, sia perché la sposa che si trasferiva nella città del marito vedeva in qualche modo scissa, o meglio moltiplicata, la sua cittadi-nanza; sia perché un esempio eccezionale di cittadinanza multipla riportato dal Digesto traeva spunto proprio dalle donne: e Rolando non manca di valo-rizzarlo, raccontando ai suoi lettori come, per un antico privilegio documenta-
347. Infra, Summa in tit. C. 10.64, §§ 3-4.348. Infra, Summa in tit. C. 10.42, §§ 50 e 59.349. Cfr. supra, III.1.1., Fiscalità e militia, e III.2.3., La tassazione. 350. S t o r t i S t o r c h i, Aspetti, pp. 24-25.
CCXII Diritto pubblico tra Impero e città
to da Ulpiano, i figli di donne di Ilo, di Delfi e del Ponto potevano anticamente ereditare dalla madre, oltre che dal padre, la propria cittadinanza, divenendo dunque municipes di due città.351 Rarissimo caso, nelle fonti romane, di tra-smissione della cittadinanza per via femminile.
L’importanza di queste tesi ben si comprende se paragoniamo il pensiero di Rolando a quello dei suoi contemporanei: è proprio negli stessi anni, infat-ti, che la dottrina giuridica civilistica sta cominciando a sostenere il principio per cui la donna che in seguito al matrimonio si trasferisce, smette di essere cittadina della città di provenienza. L’idea romana secondo la quale essa non era più tenuta ad obblighi personali nel luogo d’origine tende cioè ad essere tradotta, nel corso del Duecento, in una rischiosissima cancellazione della cit-tadinanza originaria, implicante l’impossibilità di concludere contratti, la per-dita di diritti successori e di altra natura.352 Tale corrente di pensiero è assai probabile che prenda avvio da un passo di Pillio da Medicina, apparentemente ispiratore della posizione poi espressa dalla Glossa accursiana:353 l’idea di Pil-lio secondo cui, in caso di nozze con uno straniero, la donna “segue a tal punto il domicilio del marito, da allontanarsi dalla propria origine” (adeo uxor mari-ti domicilium sequitur quod propriam declinat originem … quod non contingit in aliis qui domicilium mutant )354 spiana evidentemente la strada a coloro che in seguito parleranno di perdita della cittadinanza originaria, in deroga al noto assioma romano secondo cui l’origine è immutabile.
Mentre quindi la dottrina sta indirizzandosi su una strada che sarà abbrac-ciata dalla maggior parte dei giuristi Duecenteschi – una strada penalizzante per la donna –, cui reagiranno in parte gli interpreti Trecenteschi, Rolando sembra introdurre possibilità diverse.355
351. Cfr. infra, Summa in tit. C. 10.39, § 29. La fonte del passo è sicuramente D. 50.1.1.2: Qui ex duobus igitur Campanis parentibus natus est, Campanus est. Sed si ex patre Campa-no, matre Puteolana, aeque municeps Campanus est, nisi forte privilegio aliquo materna ori-go censeatur: tunc enim maternae originis erit municeps. Ut puta Iliensibus concessum est, ut qui matre Iliensi est, sit eorum municeps. Etiam Delphis hoc idem tributum et conservatum est. Celsus etiam refert Ponticis ex beneficio Pompeii Magni competere, ut qui Pontica matre natus esset, Ponticus esset.
352. K i r s h n e r, Mulier, p. 160 e sgg., con particolare riferimento a quanto afferma sulla Glossa di Accursio; I d., Civitas, p. 700 e sgg.
353. Per la quale cfr. K i r s h n e r, Mulier, pp. 160-161.354. Citata da Rolando infra, Summa in tit. C. 10.40, §§ 25-28.355. Nel complesso, il debito del pensiero di Bartolo e di altri esponenti del Commento
nei confronti delle teorie pubblicistiche sviluppate dai primi giuristi che si confrontarono con i Tres Libri non è stato ancora oggetto di un’analisi approfondita. Per restare in tema di mulier alibi nupta, si segnala l’importanza sia del commento di Pillio al tit. C. 10.64, in cui compare il principio secondo cui la donna que desponsata est, ante contractas nuptias suum non mutat domicilium, sed ob id non apud sponsi incolatum, sed in sua patria munera sustinebit (infra, Summa in tit. C. 10.64, § 18), all’origine dell’idea espressa da Bartolo nel commentario a D.
III.3.3. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CCXIII
Ma la cittadinanza femminile non possiede un’importanza esclusivamen-te strumentale nel suo pensiero: rappresenta viceversa un argomento nei con-fronti del quale sembra nutrire un interesse genuino, che mostra ad esempio segnalando al lettore quella che reputa essere un’aporia interna al citato titolo del Codice sui munera femminili (C. 10.64). Afferma infatti di non compren-dere quali siano obblighi e incarichi compatibili con il sesso femminile, dal momento che, per il Digesto, le donne dovevano rimanere estranee a tutti i munera pubblici.356 Lo stesso dubbio aveva colto anche Pillio da Medicina, il quale però se l’era cavata sbrigativamente affermando che tutte le regole possono avere un’eccezione, così non sempre alle donne venivano preclusi incarichi ed obblighi di carattere personale.357 A Rolando questa risposta non basta, non solo perché, afferma, alle donne potevano essere assegnati incarichi personali, come ad esempio la tutela dei figli in caso di morte del marito se ne facevano domanda alle autorità; ma anche perché le fonti romane citavano una serie di munera personali e pubblici cui le donne dovevano essere sottoposte, per esempio se appartenevano a certe corporazioni di mestiere quale quella dei murileguli, i pescatori di molluschi, dalle cui conchiglie veniva un tempo estratto l’inchiostro rosso riservato ai vestiti imperiali.358 Ancora una volta, rileva come le donne tra costoro che avessero sposato un uomo estraneo alla corporazione, avrebbero trasmesso alla prole per via femminile la condizione svilente di pescatori di murici, in osservanza delle disposizioni tardo-antiche che miravano a perpetuare tale professione.359
Il richiamo a circostanze così specifiche e distanti dalla realtà in cui vive non è dettato solo da curiosità antiquarie: identificare i rari casi in cui, in de-roga al divieto del Digesto, le leggi romane contemplavano direttamente o ve-latamente la possibilità che le donne ricoprissero incarichi personali, sembra rispondere in Rolando all’esigenza di legittimare una qualche forma di attivi-
50.1.38.3: desponsata per verba de futuro, non mutat domicilium (cfr. K i r s h n e r, Mulier, p. 173); sia del riferimento di Rolando alla legge divina: in personalibus autem muneribus, si mulier sit nupta quia efficitur una caro cum viro, testante Domino, et “erunt duo in carne una … et vir caput mulieris sit” (Ef, 5.31 et 23), sequitur domicilium viri et relinquit originarium; mulieres enim honore maritorum erigimus et genere nobilitamus, et forum ex eorum persona statuimus (infra, Summa in tit. C. 10.64, § 5), confluito in Cino da Pistoia e poi in Bartolo (cfr. K i r s h n e r, Mulier, pp. 162 in nota e 173).
356. Infra, Summa in tit. C. 10.64, § 12.357. Ibid., §§ 19-20.358. Ibid., §§ 26-30.359. Cfr. C. 11.8.12: imperatores Theodosius, Valentinianus. Ii, qui ex filiabus murilegu-
lorum et alienae originis patribus sunt vel fuerint procreati, iura maternae condicionis agno-scant, richiamata da Rolando sia nel passo citato alla precedente nota, che in Summa in tit. C. 11.8, § 22: Si condicionem patris sequntur filii, et multo magis maternam condicionem sequun-tur, si nascantur ex filiabus murilegulorum, ut C. e. l. Hii qui (C. 11.8.12).
CCXIV Diritto pubblico tra Impero e città
tà giudicante femminile. E dietro tale esigenza non può esservi che l’ingom-brante figura di Matilde di Canossa, la cui vasta attività giurisdizionale, svolta tra gli altri luoghi proprio in Toscana, doveva essere notissima a un giudice lucchese nato poco più di una generazione dopo la sua morte.360 Ecco quindi che l’articolato discorso sull’esercizio di civilia munera da parte delle donne mira in realtà a giustificare la deviazione da quel principio del Digesto che, nel vietare cariche pubbliche al mondo femminile, faceva riferimento proprio e soprattutto all’attività giudicante (nec iudices esse possunt nec magistratum gerere etc.).
In sostegno di tale posizione giungeva inoltre la sorprendente decisione assunta da Innocenzo III nel 1203 di riconoscere validità al pronunciamento ar-bitrale di Eleonora d’Aquitania nella controversia che in Francia aveva opposto Ospedalieri e Cistercensi della diocesi di Sens. Con la decretale Dilecti filii, il Papa pose fine alle proteste degli Ospedalieri francesi, i quali si erano appella-ti proprio all’argomento di illegittimità di un pronunciamento femminile per sottrarsi alla sfavorevole decisione che Eleonora aveva assunto nei loro con-fronti.361 L’idea che le donne potessero in qualche modo essere titolari di poteri amministrativi si era però già fatta strada nel pensiero canonistico che, se nel complesso aveva assunto un orientamento nettamente contrario all’attribuzione di incarichi istituzionali ad elementi femminili, era stato tuttavia costretto a con-frontarsi non solo con i poteri di governo riconosciuti alle badesse sulle proprie sottoposte, ma con l’esercizio di veri e propri poteri giurisdizionali da parte di donne sia interne alla Chiesa, che attive nell’universo secolare.
Come documentano gli studi di Giovanni Minnucci, nell’ambito della ca-nonistica italiana, le riflessioni più interessanti in proposito furono espresse da Uguccione da Pisa, il quale intorno al 1188 invertì la tendenza inaugurata dal Decretum di Graziano di svilire gli esempi vetero-testamentari di donne giudi-canti a mere testimonianze storiche.362 Benché Graziano fosse stato tacciato di anteporre così la legge romana a quella sacra, nessuno prima di Uguccione si era avventurato a sostenere con tale convinzione la legittimità dell’esercizio di
360. Cfr. G o l i n e l l i, Matilde di Canossa, che ricostruisce nel dettaglio alcuni mo-menti dell’operato giurisdizionale di Matilde, inclusi interventi nella città di Lucca, come il placito che presiedette nel 1073 insieme al giudice Flaiperto di Lucca; altri interventi giurisdi-zionali di Matilde nella città, risalenti agli anni 1099 e successivi, sono descritti da S a v i g n i, Episcopato, pp. 43-45. Matilde muore nel 1115 e Rolando nasce intorno al 1150.
361. La decretale, che circolò inizialmente nella III Compilatio, entrò a far parte dopo del Liber Extra (3 Comp. 1.25.1=X. 1.43.4). Per la ricostruzione della vicenda storica, cfr. M e t z, Le statut, pp. 103-105, e M i n n u c c i, La capacità, II, pp. 100-101.
362. Per Graziano, I d., La capacità, I, pp. 8-10; per Uguccione da Pisa, ibid., pp. 114-116, e cfr. I d., La capacità, II, pp. 76-80, 193-195, 212, 264. Per un precoce riferimento alla questione da parte di Stefano di Tournai († 1203 ca.) nella sua Summa Decreti, cfr. F o w l e r, Forms, p. 133.
III.3.3. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CCXV
poteri giurisdizionali da parte di donne che ricoprissero posizioni di comando. Sino a quel momento, infatti, il dibattito era stato circoscritto a figure leggen-darie o di un trapassato remoto, come la profetessa Debora citata dai Libri dei Giudici, o le mitiche regine Constantia di Gallia e Brunechilde dei Franchi, esempi di ‘giudicesse’ che, nel migliore dei casi, risalivano a più di cinquecen-to anni prima per chi scriveva alla fine del XII secolo. Accostare a tali icone Matilde di Canossa, come fece appunto Uguccione, significò invece proiettare la questione in una dimensione storica e concreta, facendo riferimento a una donna che aveva rivestito funzioni giudicanti fino a pochi decenni prima.363 In tal modo, afferma Minnucci, “i divieti contenuti nel Digesto e nel Decreto”, per Uguccione, “non possono … trovare applicazione allorquando la donna ricopra cariche cui sia connesso un potere giurisdizionale, o quando l’autorità pontificia espressamente l’autorizzi all’esercizio di quel potere”.364
La decisione che Innocenzo III, per ragioni di calcolo politico, prese nel 1203, trovava dunque la strada già in parte spianata da alcune idee di avan-guardia della canonistica di fine XII secolo, che incontrarono qualche consen-so nei decenni successivi. Sorprende tuttavia vederle accogliere da Rolando, il quale seppure poteva contare su qualche riflessione in proposito maturata in ambiente civilistico,365 sembra in realtà spinto a confrontarsi con l’argomento in conseguenza della decretale di Innocenzo III e del coevo dibattito canonisti-co. A sostegno di tale ipotesi sta il fatto che le dichiarazioni sulla legittimità di un’attività giudicante femminile sono contenute esclusivamente nella seconda versione della sua opera, databile ai primi decenni del Duecento, e non nella prima, composta invece prima del 1197.366 Riprendendo la motivazione addotta
363. Cfr. quanto afferma Uguccione nel commento al dictum post del c.1 C.3 q.7 (edito da M i n n u c c i, La capacità, I, p. 114): Sed quid de commitissa Matilda que iudicavit et de multis aliis que cotidie iudicant, quid denique de Delbora qua legitur in Veteri Testamento iu-dicasse …, sed in Veteri Testamento ex eius fuit permissum ut femine iudicarent effeminatum populum non autem prohibentur iudicare et si alter fiat, non est de vir. Prohibentur tamen iudi-care pro se, sed non per alios si sint regine, vel ducisse, vel commitisse; Uguccione si esprime in modo analogo nel commento al principium della C.15 q.3, dove il Decretum riferiva della biblica profetessa Debora, la cui attività giudicante Graziano aveva tuttavia liquidato sulla base delle Epistole paoline (M i n n u c c i, La capacità, I, pp. 8-10, 115-116): … Idem fuit et in novo tempore commitissa Matilda et de Brunichelda regina cui scripsit Gregorius ut puniat malefi-cos … et quidem si tale officium virile et iure civili a feminis alienum ut iii. q. i. § Tria etc.
364. Ibid., p. 116.365. Il riferimento è a Rogerio, il quale nella sua Summa Codicis aveva affermato che le
donne non potevano rivestire la carica di giudice a meno che non fossero state delegate a tale compito da un’autorità superiore (ordinarii iudices esse non possunt, quamvis delegari inter-dum possint etc.: M i n n u c c i, Processo e condizione, pp. 654-655).
366. Cfr. infra, Summa in tit. C. 10.64, §§ 21-32, tutti assenti dai manoscritti contenenti la versione più antica. Per la datazione dell’opera di Rolando, cfr. supra, C o n t e, I.3., La bi-blioteca di Rolando.
CCXVI Diritto pubblico tra Impero e città
dallo stesso pontefice, secondo il quale, nonostante i divieti del Corpus iuris di Giustiniano, la donna poteva essere arbitro di una controversia in forza di una consuetudo regionis,367 Rolando afferma che, se una consuetudine locale preve-de che la donna possa essere chiamata a giudicare, ella deve, può ed è tenuta a giudicare. Ugualmente, se a tale compito è chiamata dal Papa o dall’Imperatore, in conseguenza della scarsa (o nulla) presenza di uomini in patria.368 Colpisco-no, tra gli altri, due punti di questo ragionamento: in primo luogo il fatto che con l’espressione consuetudo regionis egli faccia riferimento non a una remo-ta consuetudine vigente in partibus Gallicanis, quale quella che aveva seguito Eleonora d’Aquitania secondo Innocenzo III, ma alle leggi municipali nel loro complesso.369 Come sarà messo in evidenza anche da qualche insigne canonista, la decretale innocenziana implicava infatti un problema di gerarchia delle fonti del diritto, consentendo a una consuetudine vigente in un determinato territorio di derogare alla legge ordinaria.370 Secondariamente, l’uso sia del verbo iudico che del sostantivo arbitrium, che lascia intendere il riconoscimento alla donna, da parte di Rolando, non solo delle funzioni di arbiter, cui apparentemente si era limitata la decretale pontificia, ma anche di quelle di iudex.
Essendo il suo ragionamento partito dai diritti di cittadinanza femminili, può allora concludere che le donne sono in grado di ricoprire, nelle situazioni che ha delineato, civilia o publica munera, mostrando una chiara coscienza dell’originalità della sua posizione sia nella frase “non ostanti le leggi secondo le quali la donna non può essere chiamata a ricoprire i munera”, sia nella lista finale di tutti i loci di diritto civile e canonico contrari invece alla sua idea.371 Tale lista potrebbe sembrare in palese contraddizione con quanto da lui detto
367. Nella decretale Dilecti filii (3 Comp. 1.25.1=X. 1.43.4), il pontefice infatti aveva detto: Quamvis autem secundum regulam iuris civilis feminae a huiusmodi publicis officiis sint remotae …, quia tamen iuxta consuetudinem approbatam, quae pro lege servatur, in partibus Gallicanis huiusmodi feminae praecellentes in subditos suos ordinariam iurisdictionem habere noscuntur etc.
368. Cfr. infra, Summa in tit. C. 10.64, §§ 21 e sgg.369. Ciò risulta particolarmente chiaro dalle prime due allegazioni del Codex Iustiniani
(C. 8.48.1 e C. 11.30.4) che Rolando adduce in sostegno dell’idea secondo cui la donna può svolgere incarichi personali se ciò è autorizzato da una consuetudine regionale; entrambi le leggi, infatti, fanno riferimento a casi di vigenza del diritto municipale (C. 8.48.1: Imperatores Diocletianus, Maximianus: Si lex municipii, in quo te pater emancipavit, potestatem duumviris dedit … id quod a patre factum est suam obtinet firmitatem; C. 11.30.4: Imperatores Diocle-tianus, Maximianus. Si secundum legem civitatis res publica, cuius meministi, ruina collapsis aedificiis tuis distraxit aream, nihil contra huius legis tenorem rector provinciae fieri patietur). Per il contesto delle citazioni, cfr. infra, Summa in tit. C. 10.64, § 21.
370. Così per esempio Lorenzo Ispano, autore della Glossa Palatina, apparato al Decre-tum composto tra il 1210 e il 1214: M i n n u c c i, La capacità processuale, II, p. 134 e sgg.
371. Infra, Summa in tit. C. 10.64, §§ 25 e 32.
III.3.3. Menzinger, Riflessi teorico-politici dei dibattiti sulla fiscalità CCXVII
in precedenza, ma dobbiamo piuttosto considerarla espressione di quell’abitu-dine comune ai glossatori di quest’epoca di ragionare in termini dialettici.372
Risulta difficile accertare qual sia il peso che possano avere rivesti-to nell’esperienza storica tali avventurose posizioni dottrinali. A prima vista sembrerebbe di trovarci di fronte a un astratto ‘caso di scuola’, in cui l’auto-re si cimenta con argomentazioni dotte anche ardite al fine non di legittimare l’attribuzione di anacronistici diritti alle donne, ma di far quadrare suggestive tesi provenienti da diversi testi autoritativi: il diritto romano, il Decretum di Graziano, le Decretali pontificie, la prassi feudale. Un’impressione in certa misura corretta, perché in nessun modo Rolando intende sostenere che le don-ne godano di diritti di cittadinanza lontanamente paragonabili a quelli maschi-li, né tantomeno svolgano funzioni pubbliche, quali quelle di giudici, nella realtà comunali. Ciò detto, vanno rilevati due aspetti interessanti del suo pen-siero: il primo è che il dibattito sulla ‘donna-giudice’ possiede una rilevanza in sé, anche se per un numero molto circoscritto di donne, le praecellentes, come le chiameranno i canonisti, vale a dire regine, duchesse o contesse che, per ragioni essenzialmente successorie, si trovarono a rivestire eccezionali posi-zioni di comando; il discorso ebbe però indirettamente una portata assai mag-giore, in conseguenza dal fatto che, in campo dottrinario, si presentò sempre legato a una questione davvero urgente per l’universo femminile medievale nel suo complesso, vale a dire il diritto della donna a sporgere denuncia. Come si evince dagli studi di Minnucci, dimostrare la legittimità teorica dei poteri giurisdizionali della donna implicava, nel serrato ragionamento giuridico del canonista, riconoscerle diritti inferiori in campo processuale, quali appunto quello di poter sporgere denuncia.373 Il secondo aspetto importante riguarda invece più strettamente le teorie di cittadinanza, nell’ambito delle quali da un lato Rolando non sembra aderire all’idea, che comincia a circolare al suo tem-po, secondo cui la donna che sposava uno straniero seguiva a tal punto il do-micilio del marito da allontanarsi dalla sua propria origine; dall’altro ipotizza, seppure non teorizzandole ancora appieno, forme di cittadinanza multipla che, come dimostrerà Bartolo da Sassoferrato a metà del Trecento, costituiranno la base concettuale per lo sviluppo di argomentazioni in favore delle donne che sposavano uomini di altre città, consentendo loro di non perdere fondamentali diritti in patria, una volta che si trasferivano. Sembra dunque interessante evi-denziare come il problema della cittadinanza femminile, che si pose con forza nei casi di donne maritate altrove, non appartenga integralmente al patrimo-nio culturale Tre-Quattrocentesco, ma al pensiero giuridico se non proprio del primissimo Comune, comunque di una sua fase precoce.
372. Cfr. supra, III.2.3., La tassazione. 373. M i n n u c c i, La capacità, I, pp. 8 e sgg.; I d., La capacità, II, pp. 32-33.
Fonti inedite
Archivio Arcivescovile di Lucca (AAL) AAL, * C 42, 2 dicembre 1153AAL, AH 27, 10 settembre 1169AAL, + 95, 14 dicembre 1182AAL, + O 88, 10 febbraio 1184AAL, * D 20, 16 luglio 1192AAL, ++ S 65, 22 marzo 1193AAL, ++ F 89, 6 marzo 1195AAL, A 35, 9 aprile 1209
Archivio Capitolare di Lucca (ACL)ACL, R 200 (=RCL II n. 1232), 15 marzo 1165ACL, G 123 (=RCL II n. 1266), 20 luglio 1168ACL, O 61 (=RCL II 1292), 14 settembre 1171ACL, B 82 (=RCL II n. 1297), 18 marzo 1172ACL, O 152 (=RCL II n. 1399), 13 aprile 1179ACL, N 11 (=RCL II n. 1413), 27 marzo 1180ACL, E 25 (=RCL II n. 1423), 14 settembre 1180ACL, O 152 (=RCL II nn. 1480 e 1484), 28 settembre e 5 novembre 1182 ACL, D 174 (=RCL III n.1641), 16 agosto 1191ACL, I 120 (=RCL III n. 1669), 30 dicembre 1192ACL, G 1, 28 agosto 1201ACL, A 10, 1 dicembre 1204ACL, P 51, 18 marzo 1209ACL, G 104, 28 luglio 1218ACL, A†1 fol. 52v, 18 novembre 1220ACL, E 102, 4 dicembre 1220ACL, A†1 foll. 75v e 102r, 16 gennaio e 31 marzo 1221ACL, M 163, 4 novembre 1255ACL, G 98, 3 settembre 1260
Archivio di Stato di Lucca (ASL)ASL, Dipl., Fregionaia, 16 maggio 1170ASL, Dipl., S. Ponziano, 3 settembre 1175ASL, Dipl., S. Ponziano, 27 gennaio 1179
Fonti e bibliografia
CCXLIV Fonti e bibliografia
ASL, Dipl., S. Giovanni, 17 luglio 1179ASL, Dipl., S. Giovanni, 31 luglio 1179ASL, Dipl., Spedale di S. Luca, 31 luglio 1179ASL, Dipl., Fiorentini, 16 aprile 1181ASL, Dipl., Fiorentini, 13 maggio 1181ASL, Dipl., S. Giustina, 23 gennaio 1182ASL, Dipl., Altopascio, 22 febbraio 1183ASL, Dipl., S. Giustina, 24 dicembre 1183ASL, Dipl., S. Giustina, 23 febbraio 1184ASL, Dipl., Altopascio, 26 agosto 1184ASL, Dipl., S. Ponziano, 14 giugno 1185ASL, Dipl., S. Ponziano, 31 luglio 1185ASL, Dipl., S. Giovanni, 10 novembre 1186ASL, Dipl., Altopascio - Deposito Orsetti Cittadella, 3 febbraio 1187ASL, Dipl., S. Giovanni, 29 novembre 1187ASL, Dipl., S. Ponziano, 6 marzo 1188ASL, Dipl., S. Maria Forisportam, 27 agosto 1188ASL, Dipl., S. Giustina, 5 marzo 1190ASL, Dipl., Altopascio - Deposito Orsetti Cittadella, 15 febbraio 1191ASL, Dipl., S. Maria Forisportam, 27 novembre 1192ASL, Dipl., S. Ponziano, 8 marzo 1193ASL, Dipl., Spedale di S. Luca, 5 febbraio 1196ASL, Dipl., Altopascio, 12 marzo 1202ASL, Dipl., Spedale di S. Luca, 3 marzo 1204ASL, Dipl., S. Maria Corteorlandini, 28 agosto 1207ASL, Dipl., Altopascio - Deposito Orsetti-Cittadella, 10 aprile 1209ASL, Dipl. S. Giovanni, 6 giugno 1209ASL, Dipl., Serviti, 16 dicembre 1209ASL, Dipl. S. Ponziano, 14 settembre 1213ASL, Dipl., Serviti, 10 novembre 1217ASL, Dipl., Serviti, 4 gennaio 1218ASL, Dipl. S. Giovanni, 19 luglio 1221ASL, Dipl., S. Giovanni, 26 ottobre 1246ASL, Dipl., S. Agostino, 11 dicembre 1279
Archivio di Stato di Pisa (ASP)ASP, Dipl., Atti pubblici, 4 settembre 1181
Regesto del Capitolo di Lucca (RCL, 4 voll., G u i d i / P a r e n t i, Roma 1910-1939)RCL I n. 271, 3 novembre 1058RCL I n. 744, 2 marzo 1115RCL II n. 1046, 1148RCL II n. 1192, 5 dicembre 1160RCL II n. 1456, 29 gennaio 1182RCL III n. 1623, 1190
Fonti edite CCXLV
Fonti edite
A l c i m i Ecdicii Aviti Viennensis episcopi Opera quae supersunt, a cura di Rudolf P e i p e r, MGH Auct. ant. 6, 2, Berlin 1883.
A z o, Summa Codicis et Institutionum, Venetia 1499.
B a s s i a n u s, Summa Quicumque vult = Die Summa “Quicumque Vult” des Jo-hannes Bassianus, a cura di Friedrich Carl v o n S a v i g n y, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, IV, Heidelberg 1850 (rist. in: Quellen zur Ge-schichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter, IV.II, a cura di Lu-dwig W a h r m u n d, Aalen 1962).
Bibliotheca rerum Germanicarum, I, a cura di Philip J a f f é, Berlin 1864.
C i c e r o, De officiis = M. Tullii Ciceronis, De Officiis, a cura di Michael W i n -t e r b o t t o m, Oxford 1994.
Codex Iustinianus (Editio maior), a cura di Paul K r ü g e r, Berlin 1877.Codice diplomatico del Senato Romano dal MCXLIV al MCCCXLVII, I, Fonti per la
storia d’Italia 87, a cura di Franco B a r t o l o n i, Roma 1948.Conciliorum oecumenicorum decreta, a cura di Giuseppe A l b e r i g o/Giuseppe
D o s s e t t i/Pericle J o a n n o u/Claudio L e o n a r d i/Paolo P r o d i, Frei-burg i. Br. 1962.
Corpus glossatorum iuris civilis, II, Torino 1966.Corpus iuris civilis cum Commentariis Accursii, 6 voll., Lugduni 1627 (rist. anast.
Frankfurt a. M. 2006).I costituti della legge e dell’uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica integrale del testo
tradito dal “Codice Yale” (Ms. Beinecke Library 415), a cura di Paola V i g n o -l i, Roma 2003.
Cronica Pontificum et Imperatorum S. Bartholomaei in insula Romani, a cura di Oswald H o l d e r - E g g e r, MGH SS 31, Hannover 1903, pp. 189-225.
Decretum Magistri Gratiani, a cura di Emil F r i e d b e r g, Leipzig 1879.Digesta Iustiniani Augusti (Editio maior), a cura di Theodor M o m m s e n, I, Berlin
1870.Dissensiones dominorum sive controversiae veterum juris Romani interpretum qui
glossatores vocantur, a cura di Gustav Friedrich H ä n e l, (Leipzig 1834) Aalen 1964.
Distinctiones Glossatorum: Studien zur Distinktionen-Literatur der romanistischen Glossatorenschule: verbunden mit Mitteilungen unedierter Texte, a cura di Emil S e c k e l, Festschrift der Berliner juristischen Fakultät für Ferdinand von Mar-titz, Berlin 1911, pp. 275-436.
F i t t i n g, Hermann, Bernardus Cremonensis und die lateinische Übersetzung des Griechischen in den Digesten, in: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1894, pp. 813-820.
Glossa = Corpus iuris civilis cum Commentariis Accursii.
CCXLVI Fonti e bibliografia
G o t i f r e d u s V i t e r b i e n s i s, Pantheon, a cura di Georg W a i t z, MGH SS 22, Hannover 1872.
–, Speculum Regum, a cura di Georg W a i t z, MGH SS 22, Hannover 1872.G u n t h e r d e r D i c h t e r, Ligurinus, a cura di Erwin A s s m a n n, MGH SS
rer. Germ. 63, Hannover 1987.
H a y m o H a l b e r s t a t e n s i s Episcopus, Homiliarum Sive Concionum Ad Plebem In Evangelia De Tempore Et Sanctis, in: M i g n e, Jacques Paul (a cura di), Patrologia latina, vol. 118.
I n n o c e n t i i I I I Romani Pontificis Regestorum sive Epistolarum Liber Sex-tus, in: M i g n e, Jacques Paul (a cura di), Patrologia latina, vol. 215.
I s i d o r o d i S i v i g l i a, Cronica Maiora, a cura di Georg Heinrich P e r t z, MGH SS 5, Hannover 1844.
Lex Romana Visigothorum, a cura di Gustav Friedrich H ä n e l, (Leipzig 1849) Aa-len 1962.
Liber Extravagantium Decretalium, a cura di Emil F r i e d b e r g, Leipzig 1881.Le Liber pontificalis, I, a cura di Louis D u c h e s n e, Paris 1886.I Libri iurium della Repubblica di Genova I.4, a cura di Sabina D e l l a C a s a,
Fonti per la storia della Liguria, XI, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti XXVIII, Roma-Genova 1998.
I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I.1, a cura di Antonella R o v e r e, Fon-ti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti XIII, Roma-Genova 1992.
Lo Codi: eine Summa Codicis in provenzalischer Sprache aus der Mitte der XII. Jahr-hunderts, a cura di Hermann F i t t i n g/Hermann S u c h i e r, Erster Teil, Lo Codi in der lateinischen Übersetzung des Ricardus Pisanus, Halle 1906.
M a f f e i, Domenico, Un’epitome in volgare del ‘Liber Augustalis’, Centro Europeo di Studi Normanni. Fonti e Studi 2, Roma-Bari 1995.
O t t o n i s e t R a h e w i n i Gesta Friderici I. Imperatoris, a cura di Georg W a i t z/Bernhard Eduard v o n S i m s o n, MGH SS rer. Germ. 46, Hanno-ver 1912.
P a o l o D i a c o n o, Pauli Historia Langobardorum, a cura di Ludwig K. B e t h -m a n n/Georg W a i t z, MGH SS rer. Lang. 1, Hannover 1878, pp. 1-187.
P i e t r o d a E b o l i, Liber ad honorem Augusti, a cura di Giovanni Battista S i -r a g u s a, Fonti per la storia d’Italia 39, Roma 1906.
P i l l i u s d e M e d i c i n a, Libellus disputatorius = Libellus Pylei disputato-rius, liber primus, a cura di Jürgen M e y e r - N e l t h r o p p, Hamburg 1959.
P l a c e n t i n u s, Summa Codicis, Moguntiae 1536 (rist. anast. Torino 1962, con prefazione di Francesco C a l a s s o ).
P r u d e n t i u s, Contra Symmacum, a cura di Maurice P. C u n n i n g h a m, in: Corpus Christianorum 126, Turnholt 1966.
Fonti edite CCXLVII
Quaestiones de iuris subtilitatibus des Irnerius, a cura di Herman F i t t i n g, Berlin 1894.
Quaestiones de iuris subtilitatibus, a cura di Ginevra Z a n e t t i, Firenze 1958.Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter, vol. IV.2,
a cura di Ludwig W a h r m u n d, (Innsbruck 1905) Aalen 1962.Quinque Compilationes Antiquae, a cura di Emil F r i e d b e r g, Leipzig 1882.
Regesta Imperii IV: Ältere Staufer, 3. Abteilung: Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich VI. 1165 (1190)-1197, a cura di Johann Friedrich B ö h m e r/Gerhard B a a k e n, Köln-Wien 1972-1979.
R o g e r i u s, Summa Codicis, in: Scripta Anecdota Glossatorum, I.2, a cura di Gio-vanni Battista P a l m i e r i, Bologna 1913.
Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, a cura di Giovan Domenico M a n s i, XXII, Firenze 1767, coll. 476-478 = M i g n e, Jacques Paul (a cura di), Patrologia latina, vol. 201.
Statutum Lucani Communis an. MCCCVIII, presentazione di Vito T i r e l l i, Lucca 1991 (rist. anastatica dell’edizione Giusti del 1867).
Summa Codicis Berolinensis. Studio ed edizione di una composizione ‘a mosaico’, a cura di Luca L o s c h i a v o, Ius Commune Sonderhefte 89, Frankfurt a. M. 1996.
Summa Codicis des Irnerius mit einer Einleitung, a cura di Herman F i t t i n g, Ber-lin 1894.
Tractatus de violento possessore “Cum varie multiplicesque” a Pilio Medicinensi compositus, a cura di Peter W e i m a r, Goldbach 1997.
Die Urkunden Friedrichs I. 1158-1167, a cura di Heinrich A p p e l t, MGH DD F I 2, Hannover 1979.
Die Urkunden Heinrichs III., a cura di Harry B r e s s l a u/Paul K e h r, MGH DD H III, Berlin 1931, Nachdruck 1993.
V e g e t i u s, Epitoma rei militaris = F l a v i u s V e g e t i u s R e n a t u s, Epitoma rei militaris, a cura di Michael D. R e e v e, Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis, Oxford 2004.
CCXLVIII Fonti e bibliografia
Studi
A b l a i n g, Willem M. d’, La “Summa Rolandi de Luca”, in: Nouvelle revue histo-rique de droit français 12 (1888), p. 361.
A g a m b e n, Giorgio, Opus Dei. Archeologia dell’ufficio. Homo sacer II.5, Torino 2012.
A i m o n e - B r a i d a, Pier V., Il principio maggioritario nel pensiero di glossatori e decretisti, in: Apollinaris 58, 1-2 (1985), pp. 209-285.
A l b e r z o n i, Maria Pia, Città, vescovi e papato nella Lombardia dei comuni, No-vara 2001.
–, Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiastica nei comuni dell’Italia setten-trionale, in: S o m m e r l e c h n e r, Andrea (a cura di), Innocenzo III. Urbs et Orbis, Miscellanea della Società romana di storia patria 44 – Nuovi studi storici 55, Roma 2003, pp. 837-845.
A l l m a n d, Christopher Thomas, The Re militari of Vegetius in the Middle Ages and the Renaissance, in: S a u n d e r s, Corinne J./L e S a u x, Françoise Ha-zel Marie/T h o m a s, Neil (a cura di), Writing War. Medieval literary responses to warfare, Cambridge 2004, pp. 15-28.
Altopascio, un grande centro ospitaliero nell’Europa medievale (Altopascio 22 luglio 1990), Comune di Altopascio 1992.
A m b r o s i o n i, Annamaria, Le città italiane tra papato e impero dalla pace di Ve-nezia alla pace di Costanza, in: La Pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana e impero (Milano-Piacenza 27-30 aprile 1983), Stu-di e testi di storia medievale 8, Bologna 1984, pp. 35-57, ora in: E a d., Milano, papato e impero.
–, Milano, papato e impero in età medievale. Raccolta di studi, a cura di Maria Pia A l b e r z o n i/Alfredo L u c i o n i, Milano 2003.
A m e r i s e, Marilena, Il battesimo di Costantino il Grande. Storia di una scomoda realtà, Stuttgart 2005.
A n t o n o v i c s, Anthony, The Library of Cardinal Domenico Capranica, in: C l o u g h, Cecil H. (a cura di), Cultural Aspects of the Italian Renaissance, Manchester-New York 1976, pp. 141-159.
A p p e l t, Heinrich, Federico Barbarossa nella storiografia tedesca a partire dal XVIII secolo, in: M a n s e l l i, Raoul/R i e d m a n n, Josef (a cura di), Federi-co Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania, Annali dell’Isti-tuto Storico Italo-Germanico in Trento 10, Bologna 1982, pp. 17-43.
–, Friedrich Barbarossa und das Römische Recht, in: H a g e n e d e r, Othmar/W e i g l, Herwig (a cura di), Kaisertum, Königtum, Landesherrschaft. Gesam-melte Studien zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, Wien-Köln-Graz 1988, pp. 61-79.
–, Die Kaiseridee Friedrich Barbarossas, in: H a g e n e d e r, Othmar/W e i g l, Her-wig (a cura di), Kaisertum, Königtum, Landesherrschaft. Gesammelte Studien zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, Wien-Köln-Graz 1988, pp. 11-39.
–, Die Urkunden Friedrichs I., Einleitung, MGH DD F I 5, Hannover 1990, pp. 123-129.
Studi CCXLIX
A r n a l d i, Girolamo, Rinascita, fine, reincarnazione e successive metamorfosi del Senato romano (secoli V-XII), in: Archivio della Società Romana di Storia Patria 105 (1982), pp. 5-56.
A s c h e r i, Mario, Le città-Stato, Bologna 2006.–, Istituzioni medievali, Bologna2 1999.
B a a k e n, Gerhard, Das sizilische Königtum Kaiser Heinrichs VI., in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung 112 (1995), pp. 202-244.
B a i e t t o, Laura, Il Papa e le città. Papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII, Spoleto 2007.
B a n t i, Ottavio, I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164. Stu-dio introduttivo, testi e note con un’appendice di documenti, Roma 1997.
B a r b a d o r o, Bernardino, Le finanze della Repubblica fiorentina. Imposta diretta e debito pubblico fino all’istituzione del Monte, Firenze 1929.
B a r r é, Henry, Les Homéliaires carolingiens de l’École d’Auxerre, Città del Vati-cano 1962.
B a r r e t - K r i e g e l, Blandine, La défaite de l’érudition, Paris 1988.–, La politique de la raison, Paris 1994.B e l l i B a r s a l i, Isa, La topografia di Lucca nei secoli VIII-XI, Atti del 5° Con-
gresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (Lucca 3-7 ottobre 1971), Spoleto 1973, pp. 461-554.
B e l l o m o, Manlio, Personaggi e ambienti nella vicenda storica del diritto comune, in: S e g o l o n i, Danilo (a cura di), Il diritto comune e la tradizione giuridica europea, Atti del Convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini (Perugia 1976), Perugia 1980, pp. 35-50.
–, Quaestiones in iure civili disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento, Roma 2008.
B e l l o n i, Annalisa, Le questioni civilistiche del secolo XII. Da Bulgaro a Pillio da Medicina e Azzone (Ius Commune. Sonderhefte 43), Frankfurt a. M. 1989.
B e n s o n, Robert Louis, Political Renovatio: two Models from Roman Antiquity, in: B e n s o n, Robert Louis/C o n s t a b l e, Giles (a cura di), Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Oxford 1982, pp. 339-386.
B e r t o l i n i, Margherita Giuliana, Enrico IV e Matilde di Canossa di fronte alla città di Lucca, in: V i o l a n t e, Cinzio (a cura di), Sant’Anselmo vescovo di Lucca nel quadro delle trasformazioni sociali della riforma ecclesiastica. Atti del convegno internazionale di studio (Lucca 1986), Roma 1992, pp. 331-389.
B e r t r a m, Martin, Drei neuere Kataloge juristischer Handschriften, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 82 (1996), pp. 380-402.
– et al. (a cura di), Catálogo de los manuscritos jurídicos de la Biblioteca Capitular de la Seu de Urgell, La Seu d’Urgell 2009.
B e z e m e e r, Kees, Legal Remedies for non-Roman Law in Medieval Doctrine. The Condictio ex consuetudine and Similar Actions, in: Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 60 (1992), pp. 63-80.
CCL Fonti e bibliografia
Bibliotheca Casinensis seu codicum manuscriptorum qui in tabulario Casinensi asser-vantur series, II, Montis Casini 1880.
B i r o c c h i, Italo, Persona giuridica nel diritto medievale e moderno, in: Digesto, IV edizione, sezione civile, 13, Torino 1996, pp. 407–420.
B i s c a r o, Gerolamo, Gli estimi del Comune di Milano nel secolo XIII, in: Archi-vio storico lombardo VI, 55.II (1928), pp. 343-495.
B i z z a r r i, Dina, Sull’epoca dell’introduzione della “lira” e della magistratura po-destarile in Siena, in: Atti della Regia Accademia delle Scienze di Torino 50 (1915), pp. 571-586.
–, Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale, in: P a t e t t a, Federico/C h i a u d a n o, Mario (a cura di), Studi di Storia del Diritto Italiano, Torino 1937, pp. 61-158.
B l o c h, David J., Res Sanctae in Gaius and the Founding of the City, in: Roman Legal Tradition. A Journal of Ancient Medieval and Modern Civil Law 3 (2006), pp. 48-64.
B l o c h, Herbert, Der Autor der Graphia aureae urbis Romae, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 40 (1984), pp. 55–175.
B o c c h i, Francesca, Le imposte dirette a Bologna nei secoli XII e XIII, in: Nuova Rivista Storica 57 (1973), pp. 273-312.
B o n g i, Salvatore, Inventario del Reale Archivio di Stato in Lucca, voll. 1-2, Lucca 1872-1876.
B o r d o n e, Renato, L’influenza culturale e istituzionale nel regno d’Italia, in: H a -v e r k a m p, Alfred (a cura di), Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers, Sigmaringen 1992, pp. 147-168.
–, Uno stato d’animo: memoria del tempo e comportamenti urbani nel mondo comu-nale italiano, Reti Medievali. E-Book, Monografie, 1, Firenze University Press 2002 (URL : http://www.rm.unina.it/e-book/titoli/bordone.htm; 18-4-2012).
B o u r e a u, Alain, Droit et théologie au XIIIe siècle, in: Annales. Économies, So-Économies, So-ciétés, Civilisations 47.6 (1992), pp. 1113-1125.
B o w s k y, William B., Medieval citizenship: the individual and the State in the commune of Siena, 1287-1355, in: Studies in Medieval and Renaissance History IV (1967), pp. 193-243.
B r o w n, Elisabeth A. R. Cessante causa and the Taxes of the Last Capetians: the Political Applications of a Philosophical Maxim, in: S t r a y e r, Joseph R./Q u e l l e r, Donald E. (a cura di), Post Scripta. Essays on Medieval Law and the Emergence of the European State in Honor of Gaines Post, Studia Gratiana 15, Roma 1972, pp. 565-588.
B r ü h l, Carlrichard, Fodrum, Gistum, Servitium regis. Studien zu den wirtschaftli-chen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in fränkischen Nachfol-gestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahr-Jahr-hunderts, Köln-Graz 1968.
B u c k l a n d, William Warwick/K a n t o r o w i c z, Hermann Ulrich (a cura di), Studies in the Glossators of the Roman Law, Aalen 1969.
C a l a s s o, Francesco, I glossatori e la teoria della sovranità, Milano3 1957.
Studi CCLI
–, Medioevo del diritto, Milano 1954.–, Umanesimo giuridico (1949), ora in: I d., Introduzione al diritto comune, Milano
1951, pp. 181-205.C a m m a r o s a n o, Paolo, L’esercizio del potere: la fiscalità, in: P a r a v i c i n i
B a g l i a n i, Agostino/T o u b e r t, Pierre (a cura di), Federico II e le città ita-liane, Palermo 1994, pp. 104-111.
–, Le origini della fiscalità pubblica delle città italiane, in: F u r i ò, Antoni (a cura di), La gènesi de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV), Valencia 1996, pp. 39-52.
C a n n a t a, Carlo Augusto, ‘Possessio’, ‘possessor’, ‘possidere’ nelle fonti giuri-diche del basso Impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell’età postclassica, Milano 1962.
C a n n i n g, Joseph, The political thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge 1987.C a p r i o l i, Severino, Visite alla Pisana, in: Le Pandette di Giustiniano. Storia e for-
tuna di un codice illustre. Due giornate di studio, (Firenze, 23-24 giugno 1983) Firenze 1986, pp. 37-98.
– /R o s s i, Luciano (a cura di), Per Edoardo Ruffini, Perugia 1985.C a r a v i t a, Andrea, I codici e le arti a Monte Cassino, I-II, Monte Cassino 1869-70.C a r o c c i, Sandro, Le lexique du prélèvement seigneurial: note sur les sources ita-
liennes, in: Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campa-gnes médiévales, II, B o u r i n, Monique/M a r t i n e z S o p e n a, Pascual (a cura di), Paris 2007, pp. 137-157.
–, Signoria rurale, prelievo signorile e società contadina (sec. XI-XIII): la ricerca ita-XI-XIII): la ricerca ita-liana, in: Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales. Réalités et représentations paysannes, B o u r i n, Monique/M a r -t i n e z S o p e n a, Pascual (a cura di), Paris 2004, pp. 63-82.
C a r o n, Pier Giovanni, Patronato ecclesiastico, in: Novissimo Digesto Italiano XII, Torino 1965, pp. 698-706.
C a s t a l d o André, Pouvoir royal, droit savant et droit commun coutumier dans la France du Moyen Age. A propos de vues nouvelles. I. Le roi est-il le maitre du droit privé, via le droit romain?, in: Droits. Revue française de théorie juridique 46 (2007), pp. 117-158.
–, Pouvoir royal, droit savant et droit commun coutumier dans la France du Moyen Age. A propos de vues nouvelles. II. Le droit romain est-il le droit commun?, in: Droits. Revue française de théorie juridique 47 (2008), pp. 173-247.
C a v a n n a, Adriano, II ruolo del giurista nell’età del diritto comune (un’occasione di riflessione sull’identità del giurista di oggi), in: Studia et Documenta Historiae et Iuris 44 (1978), pp. 95-138.
C h a g n o l l a u d, Dominique (a cura di), Les origines canoniques du droit consti-tutionnel, (Paris, 25 gennaio 2008) Paris 2009.
C l a s s e n, Peter, Burgundio von Pisa. Richter, Gesandter, Übersetzer, Sitzungs-berichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-histori-sche Klasse 1974/4, Heidelberg 1974.
–, Causa imperii: Probleme Roms in Spätantike und Mittelalter, in: Das Hauptstadt-problem im Mittelalter. Festgabe zum 90. Geburtstag Friedrich Meineckes, Jahrbuch für Geschichte des deutschen Ostens 1, Tübingen 1952, pp. 225-248.
CCLII Fonti e bibliografia
–, Studium und Gesellschaft im Mittelalter, a cura di Johannes F r i e d, Stuttgart 1983.
I codici del Collegio di Spagna di Bologna, studiati e descritti da Domenico M a f -f e i/Ennio C o r t e s e/Antonio G a r c ì a y G a r c ì a/Celestino P i a n a/ Guido R o s s i, Orbis Academicus 5, Milano 1992.
C o i n g, Helmut, Römisches Recht in Deutschland. Ius Romanum Medii Aevi V, 6, Milano 1964.
– (a cura di), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privat-europäischen Privat- Privat-rechtsgeschichte I, Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten Rechte und die Ge-setzgebung, München 1973.
C o l o r n i, Vittore, Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un mano-scritto parigino (Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677), in: Scritti in memoria di Antonino Giuffrè, Milano 1967, I, pp. 111-170.
C o n d o r e l l i, Orazio, Principio elettivo, consenso, rappresentanza. Itinerari ca-nonistici su elezioni episcopali; provvisioni papali e dottrine sulla potestà sacra da Graziano al tempo della crisi concliare (secoli XII-XV), Roma 2003.
C o n g a r, Yves, Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet, in: Ré-vue historique de droit français et étranger 35 (1958), pp. 210-259, ora in: I d., Droit ancien et structures ecclesiales, London 1982, n. III.
C o n t e, Emanuele, Archeologia giuridica medievale. Spolia monumentali e reperti istituzionali nel XII secolo, in: Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Insti-tut für europäische Rechtsgeschichte 4 (2004), pp. 118-136.
–, La biblioteca di Rolando da Lucca (1195-1234), in: A n d e r s e n, Per/L e t t o -V a n a m o, Pia/M o d é e r, Kjell Ade/V o g t, Helle (a cura di), Liber amico-rum Ditlev Tamm. Law, History, Culture, Copenhagen 2011.
–, ‘De iure fisci’. Il modello statuale giustinianeo come programma dell’impero svevo nell’opera di Rolando da Lucca (1191-1217), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiede-nis 69 (2001), pp. 221-244.
–, Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico, Bologna 2009.–, Diritto romano e fiscalità imperiale nel XII secolo, in: Bullettino dell’Istituto Stori-
co per il Medio Evo 106/2 (2004), pp. 169-206.–, I diversi volti di un testo del XII secolo. La Summa di un giudice fra aule universitarie
e tribunali, in: C o l l i, Vincenzo (a cura di), Juristische Buchproduktion im Mitte-lalter, Frankfurt a. M. 2002, pp. 351-366.
–, Ego quidem mundi dominus. Ancora su Federico Barbarossa e il diritto giustinia-neo, in: G a t t o, Ludovico/S u p i n o M a r t i n i, Paola, Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi, Firenze 2002, pp. 135-148.
–, Federico I Barbarossa e il diritto pubblico giustinianeo, in: Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo 96 (1990), pp. 248-259.
–, Servi medievali. Dinamiche del diritto comune, Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall’Istituto di Storia del Diritto Italiano dell’Università di Roma 21, Roma 1996.
–, Tres Libri Codicis. La ricomparsa del testo e l’esegesi scolastica prima di Accursio, Ius Commune Sonderhefte 46, Frankfurt a. M. 1990.
Studi CCLIII
C o p p e n s, Chris, Roma communis nostra patria, in: C o l l i, Vincenzo/C o n t e, Emanuele (a cura di), Iuris historia. Liber amicorum Gero Dolezalek, Berkeley 2008, pp. 177-192.
C o r t e s e, Ennio, Agli albori del concetto di diritto comune in Italia (sec. XII-XIII), in: El dret comú i Catalunya, Actes del VIII Simposi internacional, Barcelona 1999, pp. 173-195.
–, Cittadinanza, in: Enciclopedia del Diritto VII, Milano 1960, pp. 132-139.–, Il diritto nella storia medievale, I: L’Alto Medioevo, Roma 1995.–, Il diritto nella storia medievale, II: Il Basso Medioevo, Roma 1995.–, Esperienza scientifica. Storia del diritto italiano, in: Cinquanta anni di esperienza
giuridica in Italia, (Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981) Milano 1982, pp. 785-858.
–, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma 2000.–, Intorno agli antichi iudices toscani e ai caratteri di un ceto medievale, in: Scritti in
memoria di Domenico Barillaro, Milano 1982, pp. 5-38, ora in: C o r t e s e, En-nio, Scritti, a cura di Italo B i r o c c h i/Ugo P e t r o n i o, Spoleto 1999, pp. 747-782.
–, Intorno alla “causa impositionis” e a taluni aspetti privatistici delle finanze medie-vali, in: Annali di storia del diritto 2 (1958), pp. 111-186, ora in: C o r t e s e, Ennio, Scritti, a cura di Italo B i r o c c h i/Ugo P e t r o n i o, Spoleto 1999, pp. 155-232.
–, Legisti, feudisti e canonisti. La formazione di un ceto medievale, in: Università e società nei secoli XII-XVI, Atti del IX Convegno Internazionale di Studi (Pistoia - Montecatini Terme, 20-25 settembre 1979), Pistoia, 1982, pp. 195-281.
–, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II voll., Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall’Istituto di Storia del Diritto Italiano dell’Università di Roma 6.1, Varese 1962-1964.
–, Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale, Roma 1966.–, Il Rinascimento giuridico medievale, Roma 1992.–, Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo, in: Legge, giudici,
giuristi (Cagliari, 18-21 maggio 1981), Milano 1982, pp. 93-148 (ora in: C o r -t e s e, Ennio, Scritti, a cura di Italo B i r o c c h i/Ugo P e t r o n i o, Spoleto 1999, pp. 691-746).
–, Tra glossa, commento e umanesimo, in: Studi senesi 104, III.41 (1992), pp. 458-503 (poi in: Miscellanea Domenico Maffei dicata: historia, ius, studium, a cura di Antonio G a r c i a y G a r c i a e Peter W e i m a r, III, Goldbach 1995, pp. 29-74; C o r t e s e, Ennio, Scritti, a cura di Italo B i r o c c h i/Ugo P e -t r o n i o, Spoleto 1999).
C o s t a, Pietro, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, I: Dalla civiltà comunale al Settecento, Roma-Bari 1999.
C r e s c e n z i, Victor, Il problema della forma del potere pubblico e dei suoi limi-ti nel diritto comune classico, in: D i u r n i, Giovanni/M a r i, Paolo/T r e g -g i a r i, Ferdinando (a cura di), Per saturam, Studi per Severino Caprioli, II voll., Spoleto 2008, I, pp. 214-252.
CCLIV Fonti e bibliografia
–, Il sindacato degli ufficiali nei comuni medievali italiani, in: L’educazione giuridi-ca, IV: Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi, I: Profili storici. La tradizione italiana, Perugia 1981, pp. 383-529.
C s e n d e s, Peter, Heinrich VI., Darmstadt 1997.–, Die Kanzlei Kaiser Heinrichs VI., Denkschriften der österreichische Akademie der
Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 151, Wien 1981.C u r t i u s, Ernst Robert, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern-
München 91978.C z e r n y, Albin, Die Handschriften der Stiftsbibliothek St. Florian, Linz 1871.
D a r t m a n n, Cristoph, Die Legitimation von Amtsgewalt in den oberitalienischen Städten des 12. Jahrhunderts zwischen kaiserlichen Ansprüchen und kommuna-ler Praxis, in: D i l c h e r, Gerhard/Q u a g l i o n i, Diego (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico. L’età di Federico Barbarossa, pp. 327-345.
D e A n g e l i s, Gianmarco, “Omnes simul aut quot plures habere potero”. Rap-presentazioni delle collettività e decisioni a maggioranza nei comuni italiani del XII secolo, in: Reti Medievali Rivista 12/2 (2011), pp. 1-44 (URL: http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/319; 19-4-2012).
–, Profilo di Edoardo Ruffini (Torino, 1901- Borgofranco d’Ivrea, 1983), in: Reti Me-dievali Rivista 11/1 (2010), pp. 1-10 (URL: http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/26; 19-4-2012).
D e B e n e d i c t i s, Angela (a cura di, con la collaborazione di Annamaria P i -s a p i a ), Specula principum, Ius Commune Sonderhefte 117, Frankfurt a. M. 1999.
D e l a c h e n a l, Roland, La bibliothèque d’un avocat du XIVe siècle. Inventaire es-timatif des livres de Robert Le Coq, in: Nouvelle revue historique de droit fran-çais 11 (1887), pp. 524-537.
D e M a r t i n o, Francesco, Storia della Costituzione romana V, Napoli 1967.D e V e r g o t t i n i, Giovanni, Arti e “popolo” nella prima metà del secolo XIII
(1943), ora in: I d., Scritti di storia del diritto italiano, a cura di Guido R o s s i, I, Milano 1977, pp. 387-467.
–, I giuristi bolognesi a Roncaglia (1955), ora in: I d., Scritti di storia del diritto italia-no, a cura di Guido R o s s i, II, Milano 1977, pp. 695-792.
–, Lo studio di Bologna, l’Impero, il papato, Spoleto 1996.D i l c h e r, Gerhard/Q u a g l i o n i, Diego (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico,
1: L’età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto / Die Anfänge des öffentlichen Rechts, 1: Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich Barbarossas und das Gelehrte Recht (Trento, giugno 2006), Annali dell’Istituto storico italo-ger-manico in Trento. Contributi 19, Bologna-Berlin 2007.
– (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, 2: Da Federico I a Federico II / Die Anfän-ge des öffentlichen Rechts, 2: Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II (Trento, settembre 2007), Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Contribu-ti 21, Bologna-Berlin 2008.
– (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, 3: Verso la costruzione del diritto pubbli-co tra medioevo e modernità / Die Anfänge des öffentlichen Rechts, 3: Auf dem
Studi CCLV
Weg zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne (Trento, settembre 2009), Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi 25, Bologna-Berlin 2011.
D i o n i s o t t i, Carlo, Chierici e laici, (1960), ora in: I d., Geografia e storia della letteratura italiana, Torino 1967, pp. 47-73.
–, Discorso sull’umanesimo italiano (1956), ora in: I d., Geografia e storia della lette-ratura italiana, Torino 1967, pp. 145-161.
D u f o u r, Jean/G i o r d a n e n g o, Gérard/G o u r o n, André, L’attrait des “le-ges”. Note sur la lettre d’un moine victorin (vers 1124/1127), in: Studia et docu-menta Historiae et Iuris 45 (1979), pp. 504-529.
D o l e z a l e k, Gero R., Der Friede von Konstanz 1183 in der Literatur des “Jus Commune”, in: D i l c h e r Gerhard/Q u a g l i o n i, Diego (a cura di), Gli ini-zi del diritto pubblico, 2, pp. 277-307.
–, Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani, Ius Commune Sonder-hefte 23, Frankfurt a. M. 1985.
–, Verzeichnis der Handschriften zum Römischen Recht bis 1600, VI, Maastricht-Münster 1972.
E n g e l s, Odilo, Federico Barbarossa nel giudizio dei suoi contemporanei, in: M a n s e l l i, Raoul/R i e d m a n n, Josef (a cura di), Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania, Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento 10, Bologna 1982, pp. 45-81.
E s p o s i t o, Anna, Le “Sapientie” romane: i collegi Capranica e Nardini e lo “Stu-dium Urbis”, in: Roma e lo Studium Urbis, Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento. Atti del Convegno Roma 7-10 giugno 1989, Pubblicazioni degli Ar-chivi di Stato. Saggi 22, Roma 1992, pp. 40-68.
F e e n s t r a, Robert, Les origines du dominium utile chez les glossateurs (avec une appendice concernant l’opinion des ultramontani (1971), ora in: I d., Fata iuris romani: études d’histoire du droit, Leyde 1974, pp. 215-259.
F i s h w i c k, Duncan, The Imperial Cult in the Latin West, II: Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire, Brill 1992, pp. 423-435.
F i t t i n g, Hermann, Das castrense peculium in seiner geschichtlichen Entwicklung und heutigen gemeinrechtlichen Geltung, (Halle 1871) Aalen 1969.
F i u m i, Enrico, L’imposta diretta nei comuni medioevali della Toscana, in: Studi in onore di Armando Sapori, I, Milano 1957, pp. 327-353.
F o r e v i l l e, Raymonde, Représentation et taxation du clergé au IVe Concile du Latran (1215), in: Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles lettres 110 (1966), pp. 16-28.
F o r z a t t i G o l i a, Giovanna, Estimi e tassazione del clero nel secolo XIII. Al-cune precisazioni su Milano e Pavia, in: A n d e n n a, Giancarlo/H o u b e n, Hubert/V e t e r e, Benedetto (a cura di), Tra Nord e Sud, Studi dedicati dagli allievi a Cosimo Damiano Fonseca nel sessantesimo genetliaco, Galatina 1993, pp. 157-170.
CCLVI Fonti e bibliografia
F o w l e r - M a g e r l, Linda, Forms of Arbitration, in: K u t t n e r, Stephan (a cu-ra di), Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law (Toronto 1972), Città del Vaticano 1976, pp. 133-147.
–, Ordines iudiciarii and libelli de ordine iudiciorum, Turnhout 1994.–, Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung, Frankfurt a. M.
1984.F r e n z, Barbara, Barbarossa und der Hoftag von Roncaglia (1158) in der Historio-
graphie des 12. und 13. Jahrunderts, in: D i l c h e r Gerhard/Q u a g l i o n i, Diego (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, 1, pp. 101-126.
F r i e d, Johannes, Die Bamberger Domschule und Rezeption von Frühscholastik und Rechtswissenschaft in ihrem Umkreis bis zur Ende der Stauferzeit, in: F r i e d, Johannes (a cura di), Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, Sigmaringen 1986, pp. 163-201.
–, “… auf Bitten der Gräfin Mathilde”. Werner von Bologna und Irnerius, in: H e r -b e r s, Klaus (a cura di), Europa an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert. Beiträge zu Ehren von Werner Goez, Stuttgart 2001, pp. 171-201.
–, Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen und politi-schen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena, Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte 21, Köln-Wien 1974.
F r u g o n i, Arsenio, Arnaldo da Brescia nelle fonti del secolo XII, Roma 1954.–, Sulla ‘renovatio Senatus’ del 1143 e l’‘ordo equestris’, in: Bollettino dell’Istituto
Storico Italiano per il Medioevo 62 (1950), pp. 159-174.
G a l g a n o, Francesco, La forza del numero e la legge della ragione. Storia del prin-cipio di maggioranza, Bologna 2007.
G a m b e r i n i, Andrea/L a z z a r i n i, Isabella (a cura di), The Italian Renaissan-ce State, Cambridge 2012.
G a s p a r r i, Stefano, I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia, Roma 1992.G e n e s t, Jean-François, Le fonds juridique d’un stationnaire italien a la fin du XIIIe
siècle: matériaux nouveaux pour servir à l’histoire de la pecia, in B a t a i l l o n, Louis-Jacques/G u y o t, Bertrand-Georges/R o u s e, Richard-Hunter (acura di): La production du livre universitaire au moyen âge. Exemplar et pecia. Actes du symposium tenu au Collegio S. Bonaventura de Grottaferrata en mai 1983, Paris 1988, pp. 133-154.
G i a l d r o n i, Stefania, East India Company. Una storia giuridica (1600-1708), Bo-logna 2011.
G i a r o, Tomasz, Aktualisierung Europas. Gespräche mit Paul Koschaker, Genova 2000.
G i b b o n, Edward, Decline and Fall of the Roman Empire, London-New York 1910 (rist. 1962).
G i e r k e, Otto Friedrich von, Das deutsche Genossenschaftsrecht, III, Berlin 1881 (rist. anast. Graz 1954).
G i l l i, Patrick, La fonction d’ambassadeurs dans les traités juridiques italiens du XVe siècle: l’impossible représentation, in: Mélanges de l’École française de Ro-me. Moyen Âge 121/1 (2009), pp. 173-187.
Studi CCLVII
–, Aux sources de l’espace politique: techniques électorales et pratiques délibératives dans les cités italiennes (XIIe-XIVe siècles), in: Rivista Internazionale di diritto comune 18 (2007), pp. 253-270.
G i n a t e m p o, Maria, Il finanziamento del deficit pubblico nelle città dell’Italia centro-settentrionale (XIII-XV secolo), in: Barcelona. Quaderns d’història 13 (2007), pp. 29-57.
–, Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.), Firenze 2000.
G i o r d a n e n g o, Gérard, Le droit romain aux temps de la Réforme: une étincel-le? (1050-1130), in: Mélanges de l’Ėcole Française. Moyen Age, 113/2 (2001), pp. 869-911.
–, Jus commune et “droit commun” en France du XIIIe au XVe siècle, in: Droit romain, jus civile et droit français, a cura di Jacques K r y n e n, n. spéc. des Études d’histoire du droit et des idées politiques 3, Toulouse 1999, pp. 219-247.
– /D u f o u r, Jean/G o u r o n, André, L’attrait des “leges”. Note sur la lettre d’un moine victorin (vers 1124/1127), in: Studia et documenta Historiae et Iuris 45 (1979), pp. 504-529.
G o l i n e l l i, Paolo, Matilde di Canossa, in: Dizionario Biografico degli Italiani LXXII (2009), pp. 114-126.
G ö r i c h, Knut, Fragen zum Kontext der roncalischen Gesetze Friedrich Barbaros-sas, in: D i l c h e r Gerhard/Q u a g l i o n i, Diego (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, 1, pp. 305-325.
G o u r o n, André, Bologne: un modèle inaccessible aux juristes européens du XIIe siècle?, in: Études d’histoire du droit et des idées politiques 3 (1999), Droit ro-main, ius civile et droit français, pp. 189-199.
–, Cessante causa cessat effectus: à la naissance de l’adage, in: Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 143/1 (1999), pp. 299-309.
–, De la “constitution” Habita aux Tres Libri, in: I d., Juristes et droits savants: Bolo-gne et la France médiévale, Variorum V, Adelshot 2000.
–, Glossateurs et théories politiques, in: K r y n e n, Jacques/S t o l l e i s, Michael (a cura di), Science politique et droit public dans les facultés européennes (XIIIe-XVIIIe siècle), pp. 7-22.
–, L’“invention” de l’impôt proportionnel au Moyen Âge, in: Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 138/1 (1994), pp. 245-260.
–, Les “Quaestiones de juris subtilitatibus”: une oeuvre du maître parisien Albéric, in: Revue historique 618 (2001/02), pp. 343-362.
–, Rogerius, Quaestiones de iuris subtilitatibus et pratique arlésienne: à propos d’une sentence archiépiscopale (1141, 5 novembre), in: I d., La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, London 1984, n. XIV.
–, Sur les traces de Rogerius en Provence, in: A u b i n, Gerard (a cura di), Liber ami-corum. Études offertes à Pierre Jaubert, Bordeaux 1992, pp. 313-326.
– /D u f o u r, Jean/G i o r d a n e n g o, Gérard, L’attrait des “leges”. Note sur la lettre d’un moine victorin (vers 1124/1127), in: Studia et documenta Historiae et Iuris 45 (1979), pp. 504-529.
CCLVIII Fonti e bibliografia
G r a f i n g e r, Christine M., Beiträge zur Geschichte der Biblioteca Vaticana, Studi e Testi 373 = Studi e documenti sulla formazione della Biblioteca Apostolica Va-ticana 3, Città del Vaticano 1997.
G r e l l e, Francesco, Stipendium vel tributum. L’imposizione fondiaria nelle dottri-ne giuridiche del II e III secolo, Napoli 1963.
G r i l l o, Paolo, L’introduzione dell’estimo e la politica fiscale del Comune di Mila-no alla metà del secolo XIII, in: M a i n o n i, Patrizia (a cura di), Politiche finan-ziarie e fiscali nell’Italia settentrionale (secoli XIII-XV), Milano 2001, pp. 11-37.
G r o h m a n n, Alberto, L’imposizione diretta nei comuni dell’Italia centrale nel XIII secolo. La libra di Perugia del 1285, Perugia 1986.
G r o s s i, Paolo, Omaggio a Edoardo Ruffini (Discorrendo di una singolare espe-rienza di studio e di due libri singolari), in: Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 7 (1978), pp. 575-582.
–, Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico, in: Annali di Storia del diritto 2 (1958), pp. 229-331.
G u a l a z z i n i, Ugo, Bernardo da Cremona, in: Dizionario Biografico degli Italia-ni IX (1967), p. 270.
G u i d i, Pietro/P a r e n t i, Oreste (a cura di), Regesto del Capitolo di Lucca, 4 voll., Regesta Chartarum Italiae, Roma 1910-1939.
H a e n e l, Gustav, Catalogi librorum manuscriptorum qui in bibliothecis Galliae, Hel-vetiae, Belgii, Britanniae M., Hipaniae, Lusitaniae asservantur, Lipsiae 1830.
H a g e n e d e r, Othmar, Das Sonne-Mond-Gleichnis bei Innocenz III. Versuch ei-ner teilweisen Neuinterpretation, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichi-sche Geschichtsforschung 65 (1957), pp. 340–368, ora in: I d., Il sole e la luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII, a cura di Maria Pia A l b e r z o n i, Milano 2000, pp. 33-68.
H a u s m a n n, Friedrich, Gottfried von Viterbo. Kapellan und Notar, Magister, Ge-schichtsschreiber und Dichter, in: H a v e r k a m p, Alfred (a cura di), Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers, Vorträge und Forschungen 40, Sigmaringen 1992, pp. 603-621.
H a v e r k a m p, Alfred, Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien, Teil I, Stuttgart 1970; Teil II, Stuttgart 1971.
–, Die Regalien-, Schutz- und Steuerpolitik in Italien unter Friedrich Barbarossa bis zur Entstehung des Lombardenbundes, München [1966]; anche in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 29 (1966), pp. 3-156.
H o l t e r, Kurt, Bibliothek und Archiv. Handschriften und Inkunabeln, in: B i r k e, Veronika et al. (a cura di), Die Kunstsammlungen des Augustiner-Chorherren-stiftes St. Florian, Österreichische Kunsttopographie 48, Wien 1988, pp. 29-92.
I n g u a n e z, Mauro, Codicum Casinensium Manoscriptorum Catalogus, I.I (Codd. 1-100), Montis Casini 1915.
Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional V (1599 a 2099), Madrid 1959.
J e m o l o, Viviana/ M o r e l l i, Mirella (a cura di), Guida a una descrizione unifor-
Studi CCLIX
me dei manoscritti e al loro censimento, con contributi di Bonifacio B a r o f -f i o/Massimo G e n t i l i T e d e s c h i/Valentino P a c e, Roma 1990.
J e r i c k e, Hartmut, Imperator Romanorum et Rex Siciliae. Kaiser Heinrich VI. und sein Ringen um das normannisch-sizilische Königreich, Frankfurt a. M. 1997.
J o n e s, Philip, Economia e società nell’Italia medievale, Torino 1980.–, The Italian City-State. From Commune to Signoria, Oxford 1997.
K a y, Richard, Gerald of Wales and the Fourth Lateran Council, in: Viator: Medieval and Renaissance Studies 29 (1998), pp. 79-93.
K a n n o w s k i, Bernd, Der roncalische Regalienbegriff und seine Vorgeschichte, in: D i l c h e r, Gerhard/Q u a g l i o n i, Diego (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, 1, pp. 157-177.
K a n t o r o w i c z, Ernst H., Inalienability. A Note on Canonical Practice and the English Coronation Oath in the Thirteenth Century, in: Speculum 29 (1954), pp. 488–502, ora in: K a n t o r o w i c z, Ernst, Selected Studies, Locust Valley 1965, pp. 138–150.
–, The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton 1957 (trad. it.: I due corpi del re: l’idea di regalità nella teologia politica medievale, Torino 1989).
–, Pro patria mori in Medieval Political Thought, in: The American Historical Review (1951), pp. 472-492.
K a n t o r o w i c z, Hermann Ulrich, Max Conrat (Cohn) und die Mediävistische Forschung, in: Zeitschrift der Savigny-Stifung für Rechtsgeschichte. Romanisti-sche Abteilung 33 (1912), pp. 417-473.
– /B u c k l a n d, William Warwick (a cura di), Studies in the Glossators of the Ro-man Law, Aalen 1969.
K e r b e r, Linda K., No Constitutional Right to Be Ladies: Women and the Obliga-tions of Citizenship, New York 1998.
K i r s h n e r, Julius, “Ars imitatur naturam”: a consilium of Baldus on naturalization in Florence, in: Viator: Medieval and Renaissance Studies 5 (1974), pp. 289-331.
–, Between nature and culture: an opinion of Baldus of Perugia on Venetian citizen-ship as second nature, in: The Journal of Medieval and Renaissance Studies 9/2 (1979), pp. 179-208.
–, “Civitas sibi faciat civem”: Bartolus of Saxoferrato’s doctrine on the making of a citizen, in: Speculum 48 (1973), pp. 694-713.
–, Donne maritate altrove. Genere e cittadinanza in Italia, in: S e i d e l M e n c h i, Silvana/J a c o b s o n S c h u t t e, Anne/K u e h n, Thomas, Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed Età Moderna, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni 51, Bologna 1999, pp. 377-429.
–, Genere e cittadinanza nelle città-stato del Medioevo e del Rinascimento, in: C a l -v i, Giulia (a cura di), Innesti. Donne e genere nella storia sociale, Roma 2004, pp. 21-38.
–, Mulier alibi nupta, in: B a u m g ä r t n e r, Ingrid (a cura di), Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung, Sigmaringen 1995, pp. 147-175.
CCLX Fonti e bibliografia
K o c h, Gottfried, Auf dem Wege zum Sacrum Imperium. Studien zu ideologischen Herrschaftsgründung der deutschen Zentralgewalt im 11. und 12. Jahrhundert, Berlin 1972.
K o c h, Walter, Die Reichskanzlei in den Jahren 1167 bis 1174: eine diplomatisch-paläographische Untersuchung, Österreichisce Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse 115, Wien 1973.
K o s c h a k e r, Paul, Europa und das römisches Recht, München-Berlin 1947.–, Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft, Schrif-
ten der Akademie für Deutsches Recht. Gruppe Römisches Recht und fremde Rechte 1, München-Berlin [1938].
K r i s t e l l e r, Paul Oskar, Humanism and scholasticism in the Italian Renaissance, in: Byzantion 17 (1944/1945), pp. 346-374, ora in: I d., Renaissance Thought and its Sources, a cura di Michael M o o n e y, New York 1979, pp. 85-105, e in: I d., Studies in Renaissance Thought and Letters, Roma 1956.
–, Umanesimo e scolastica a Padova fino al Petrarca (1985), ora in: I d., Studies in Re-naissance Thought and Letters IV, Storia e letteratura 193, Roma 1996.
K r y n e n, Jacques, Le droit romain “droit commun de la France”, in: Droits. Revue française de théorie juridique 38 (2003), pp. 21-35.
– /S t o l l e i s, Michael (a cura di), Science politique et droit public dans les facultés européennes (XIIIème-XVIIIème siècle), Frankfurt a. M. 2008.
K u t t n e r, Stephan, Harmony from Dissonance. An Interpretation of Medieval Canon Law, in: I d., The History of Ideas and Doctrines of Canon Law in the Middle Ages, I, London 1980.
–, On the Medieval Tradition of Justinian’s Novellae: an Index titulorum Authen-tici in novem Collationes Digesti, in: Revista española de derecho canónico 47 (1990), pp. 23-33; riapparso poi in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts-geschichte. Kanonistische Abteilung 80 (1994), pp. 88-98, e in: G a r c í a y G a r c í a, Antonio, Estudios jurídicos-canónicos. Commemorativos del Primer Cincuentenario de la Facultad de Derecho Canónico en Salamanca (1948-1989), Salamanca 1991, pp. 34-45.
–, Urban II and the Doctrine of Interpretation: a Turning Point?, in: Studia Gratiana 15 (1972), rist. ora in: I d., The History of Ideas and Doctrines of Canon Law in the Middle Ages, Variorum IV, London 1980.
L a n d a u, Peter, Jus Patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronats im Dekreta-lenrecht und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts, Köln-Wien 1975.
L a n g e, Hermann, Römisches Recht im Mittelalter, I: Die Glossatoren, München 1997.
L a z z a r i n i , Isabella (a cura di), The Italian Renaissance State, vedi G a m b e -r i n i, Andrea.
L o s c h i a v o, Luca, Il “codex graecus” e le origini del “Liber authenticorum”. Due contributi alla storia dell’Authenticum, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 127 (2010), pp. 115-171.
–, La riscoperta dell’Authenticum e la prima esegesi dei glossatori, in: L o s c h i a -v o, Luca/M a n c i n i, Giovanna/V a n o, Cristina (a cura di), Novellae consti-
Studi CCLXI
tutiones. L’ultima legislazione di Giustiniano tra Oriente e Occidente da Tribo-niano a Savigny, (Teramo 2009) Napoli 2011, pp. 111-139.
M a c c a r r o n e, Michele, “Cura animarum” e “parochialis sacerdos” nelle costi-tuzioni del IV Concilio Laterananse (1215). Applicazioni in Italia nel sec. XIII, in: Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (secoli XIII-XV). Atti del 6º Convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze 1981), Italia Sacra. Studi e do-cumenti di storia ecclesiastica 35, Roma 1984, pp. 81-195.
M a c e r a t i n i, Ruggero, Ricerche sullo status giuridico dell’eretico nel diritto ro-mano-cristiano e nel diritto canonico classico (da Graziano a Uguccione), Dipar-timento di scienze giuridiche Università di Trento 19, Padova 1994.
M a f f e i, Domenico, Fra Cremona, Montpellier e Palencia nel secolo XII: ricerche su Ugolino da Sesso, in: Rivista internazionale di Diritto Comune 1 (1990), pp. 9-30.
–, Un’epitome in volgare del ‘Liber Augustalis’, Centro Europeo di Studi Normanni. Fonti e Studi 2, Roma-Bari 1995.
M a i n o n i, Patrizia, Finanza pubblica e fiscalità nell’Italia centro-settentrionale tra XIII e XV secolo, in: Studi Storici 40/2 (1999), pp. 449-470.
–, La “révolution fiscale” dans l’Italie du Nord (XIIe-XIIIe siècle). Quelques considé-rations, in: L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen, XIIIe-XVe siècle (Bercy octobre 2001), Paris 2005, pp. 219-254.
–, Sperimentazioni fiscali e amministrative nell’Italia settentrionale. Per una rilettu-ra delle fonti del XII secolo, in: A n d e n n a, Giancarlo (a cura di), Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella ‘Societas Christiana’ (1046-1250), Milano 2007, pp. 705-760.
M a i r e V i g u e u r, Jean-Claude, L’autre Rome. Une histoire des Romains à l’époque communale (XIIe-XIVe siècle), Paris 2010.
–, Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell’Italia comunale, Bologna 2004.
–, Gli “iudices” nelle città comunali: identità culturale ed esperienze politiche, in: T o u b e r t, Pierre/P a r a v i c i n i B a g l i a n i, Agostino (a cura di), Fe-derico II e le città italiane, Palermo 1994, pp. 161-176.
M a l e c z e k, Werner, Das Kardinalskollegium unter Innocenz II. und Anaklet II, in: Archivum Historiae Pontificiae 19 (1981), pp. 27–78.
M a r m u r s z t e j n, Elsa, L’autorité des maîtres. Scolastique, normes et société au XIIIe siècle, Paris 2007.
M a r t í n e z - T o r r ó n, Javier, Les influences canoniques sur le droit constitu-tionnel: problematique, in: C h a g n o l l a u d (a cura di), Les origines canoni-ques du droit constitutionnel, pp. 11-24.
M a u s e n, Yves, A demonio merediano? Le droit savant au parlement de Paris, in: Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques 48 (2009), pp.159-177.
M a y a l i, L a u r e n t, Lex animata. Rationalisation du pouvoir politique et science juridique (XIIème-XIVème siècles), in: G o u r o n, André/R i g a u d i è r e, Al-bert (a cura di), Renaissance du pouvoir législatif et génèse de l’état, Montpellier 1988, pp. 155-164.
CCLXII Fonti e bibliografia
–, Procureurs et représentation en droit canonique médiéval, in: La représentation dans la tradition du jus civile en Occident, Mélanges de l’École française de Ro-me. Moyen Âge 114/1, Rome 2002, pp. 41-57.
M a y e r - M a l y, Theodor, Volusius 7, in: Paulys Real-Encyclopädie der clas-sischen Altertumswissenschaften 9 (1961), coll. 904-906.
M e i j e r s, Eduard Mauritius, Études d’histoire du droit, a cura di Robert F e e n s -t r a/David F i s c h e r, III, Leyde 1959.
M e n a n t, François, L’Italia dei Comuni (1100-1350), (Paris 2005) Roma 2011.M e n z i n g e r, Sara, Fisco, giurisdizione e cittadinanza nel pensiero dei giuristi co-
munali italiani tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, in: Quellen und For-schungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 85 (2005), pp. 36-73.
–, Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII: l’uso dell’arbitrato nei governi consolari e podestarili, in: A r l i n g h a u s, Franz-Josef/B a u m g ä r t n e r, Ingrid (a cura di), Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters (Frankfurt a. M. 2004), Frankfurt a. M. 2006, pp. 113-134.
–, Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto, Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall’Istituto di Storia del Diritto italiano, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 34, Roma 2006.
–, Pareri eccezionali: procedure decisionali ordinarie e straordinarie nella politica co-munale del XIII secolo, in: V a l l e r a n i, Massimo (a cura di), Sistemi di ecce-zione, Quaderni Storici n. s. 131/2 (2009), pp. 399-410.
M e t z, René, Le statut de la femme en droit canonique medieval, in: La Femme, Re-cueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire comparative des institutions XII.II, Bruxelles 1962, pp. 59-113.
M e y e r, Andreas, Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 92, Tübingen 2000.
M e y e r, Christoph H. F., Die Distinktionstechnik in der Kanonistik des 12. Jahrhun-derts. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des Hochmittelalters, Medievalia Lovaniensia, series 1.29, Leuven 2000.
M i g l i o, Massimo, Il senato in Roma medievale, in: A r n a l d i, Girolamo (a cura di), Il senato nella storia, II: Il senato nel Medioevo e nella prima età moderna, Roma 1997, pp. 117-172.
M i l a n i, Giuliano, Lo sviluppo della giurisdizione nei comuni italiani del secolo XII, in: A r l i n g h a u s, Franz-Josef/B a u m g ä r t n e r, Ingrid (a cura di), Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters (Frank-furt a. M. 2004), Frankfurt a. M. 2006, pp. 21-46.
M i n n u c c i, Giovanni, La capacità processuale della donna nel pensiero canoni-stico classico, I: Da Graziano a Uguccione da Pisa, Quaderni di “Studi senesi” 68, Milano 1989.
–, La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico, II: Dalle Scuole d’Oltralpe a S. Raimondo di Pennaforte, Quaderni di “Studi senesi” 79, Milano 1994.
–, Processo e condizione femminile nel pensiero dei primi glossatori civilisti, in: Stu-dia Gratiana 29 (1998), pp. 641-660.
Studi CCLXIII
M o n a h a n, Arthur P., Consent, Coercion and Limit: the Medieval Origins of Par-liamentary Democracy, Kingston and Montrèal 1987.
M o r p u r g o C a s t e l n u o v o, Maria, Il Cardinal Domenico Capranica, in: Archivio della Società Romana di Storia Patria 52 (1929), pp. 1-146.
M o u l i n, Léo, Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes (1953), ora in: Politix 11/43 (1998), pp. 117-162.
N e u m e y e r, Karl, Die gemeinrechtliche Entwickelung des internationalen Privat- und Strafrechts bis Bartolus, II, Berlin-Leipzig 1916.
N i c o l a j, Giovanna, Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinasci-Alle origini del rinasci-mento giuridico, Milano 1991.
N i c o l i n i, Ugo, Leggendo le Quaestiones de iuris subtilitatibus, in: Ius 28 (1981), pp. 27-119.
–, La proprietà, il principe e l’espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia, Milano 1952.
N o b i l i, Paolo Gabriele, Alle origini della fiscalità comunale. Fodro, estimo e pre-stiti a Bergamo tra fine XII e metà XIII secolo, in: Reti Medievali Rivista 2010/1 (URL: http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/6; 19-4-2012).
N ö r r, Knut Wolfang, Zur Stellung des Richters im gelehrten Prozeß der Frühzeit: Iudex secundum allegata non secundum conscientiam iudicat, München 1967.
O b e r h a m m e r, J., Inventarium manoscritto [Biblioteca Apostolica Vaticana, Sa-la Barberini, 390 (6)].
O r e s t a n o, Riccardo, L’assimilazione canonistica degli enti ecclesiastici ai pupilli e la sua derivazione romanistica, in: Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, II, Paris 1965, pp. 1353-1357.
P a d o a S c h i o p p a, Antonio, Gerarchia e giurisdizione: il modello canonistico medievale, in: A l z a t i, Cesare (a cura di), Cristianità ed Europa, Miscellanea di Studi in onore di Luigi Prosdocimi, II, Roma-Freiburg-Wien 2000, pp. 107-121.
–, Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna 2003.–, Il modello del diritto canonico, in: I d., Italia ed Europa nella storia del diritto, pp.
181-208.–, Sul principio della rappresentanza diretta nel diritto canonico classico, in: K u t t -
n e r, Stephan (a cura di), Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law (Toronto 1972), Città del Vaticano 1976, pp. 107-131.
–, Sul ruolo dei giuristi nell’età del diritto comune: un problema aperto, in: S e g o -l o n i, Danilo (a cura di), Il diritto comune e la tradizione giuridica europea, Atti del convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini (Perugia 1976), Perugia 1980.
–, Sur le rôle du droit savant dans quelques actes judiciaires italiens des XIe et XIIe siècles, in: Confluence des droits savants et des pratiques juridiques (Montpellier 1977), Milano 1979, pp. 341-371.
P a d r o s a G o r g o t, Inés, Biblioteca del Palau de Peralada, in: Annals de l’Insti-tut d’Estudis Empordanesos 21 (1988), pp. 297-306.
CCLXIV Fonti e bibliografia
P a n e r o, Francesco, Schiavi, servi e villani nell’Italia medievale, Torino 1999.P a n o f s k y, Erwin, Renaissance and Renascences in Western Art, Stockholm
1960.P a r a d i s i, Bruno, Appunti per un commento alle quaestiones de iuris subtilitati-
bus (“exordium”), in: Estudios en Homanaje a Don Claudio Sanchez Albornoz en sus 90 años, vol. III, Buenos Aires 1985, pp. 3-58.
–, Diritto canonico e tendenze di scuola nei glossatori da Irnerio ad Accursio, in: Studi medievali s. 3, 6.2 (1965), pp. 155-287, ora in: Id., Studi sul Medioevo giuridico, II, Roma 1987, pp. 525-656.
P a r e n t i, Oreste/G u i d i, Pietro (a cura di), Regesto del Capitolo di Lucca, 4 voll., Regesta Chartarum Italiae, Roma 1910-1939.
P e l l e g r i n, Élisabeth/F o h l e n, Jeannine/J e u d y, Colette/R i o u, Yves-François (a cura di, con la collaborazione di Adriana M a r u c c h i/Paola S c a r c i a P i a e n t i n i ), Les manuscrits classiques latins de la Biblio-thèque Vaticane, II, 2me partie, Paris 1982.
P e n n i n g t o n, Kenneth, The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, Berkeley 1993.
–, Representation in Medieval Canon Law, in: M e l l o n i, Alberto/F a g g i o l i, Massimo (a cura di), Repræsentatio: Mapping a Key Word for Churches and Governance, Proceedings of the San Miniato International Workshop (October 2004), Berlin 2006, pp. 21-40.
P e t e r s o h n, Jürgen, Friedrich Barbarossa und Rom, in: H a v e r k a m p, Al-fred (a cura di), Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungswei-sen des staufischen Kaisers, Vorträge und Forschungen 40, Sigmaringen 1992, pp. 129-146.
–, Kaisertum und Rom in spätsalischer und staufischer Zeit. Romidee und Rom politik von Heinrich V. bis Friedrich II., MGH Schriften 62, Hannover 2010.
P o l o n i, Alma, Lucca nel Duecento. Uno studio sul cambiamento sociale, Pisa 2009.
–, Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell’Italia comunale del Duecen-to, Milano-Torino 2010.
P o s t, Gaines, Studies in Medieval Legal Theory. Public Law and the State. 1100-1322, Princeton 1964.
P o w i c k e, Frederick M., Stephen Langton, Oxford 1928.P r o s d o c i m i, Luigi, “Roma comunis patria” nella tradizione giuridica della cri-
stianità medievale, in: La nozione di “romano” tra cittadinanza e universalità, Atti del II seminario internazionale di studi storici “Da Roma alla terza Roma”, (Roma 1982) Napoli 1984, pp. 43-48.
Q u a d r i o, Giuseppe, Il trattato “De assumptione Beatae Mariae Virginis” dello Pseudo-Agostino e il suo influsso nella Teologia Assunzionistica Latina, Analec-ta Gregoriana LII, Roma 1951.
Q u a g l i o n i, Diego, “Civilis sapientia”. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età Moderna, Rimini 1989.
Studi CCLXV
–, Il diritto comune pubblico e le leggi di Roncaglia. Nuove testimonianze sulla l. “Omnis iurisdictio”, in: D i l c h e r, Gerhard/Q u a g l i o n i, Diego (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, 1, pp. 47-65.
–, Luminaria, Duo, in: Enciclopedia Federiciana, Roma 2005, pp. 320-325.– (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, cfr. D i l c h e r, Gerhard.Q u i n e t, Edgar, Les Révolutions d’Italie, Paris 1848.
R e d o n, Odile, L’espace d’une cité. Sienne et le pays siennoise (XIIIe-XIVe siècles), Rome 1994.
R e e v e, Michael D., The Transmission of Vegetius’s Epitoma rei militaris, in: Ae-vum 74 (2000), pp. 243-354.
R e n a n, Ernest, Oeuvres complètes, VIII, Paris 1958.R i e d m a n n, Josef, Studien über die Reichskanzlei unter Friedrich Barbarossa
in den Jahren 1156-1166, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Ge-schichtsforschung 76 (1968), pp. 23-105.
R i e s e n b e r g, Peter, Citizenship at law in late medieval Italy, in: Viator: Medie-val and Renaissance Studies 5 (1974), pp. 333-346.
R o n z a n i, Mauro, La nuova Roma: Pisa, Papato e Impero al tempo di S. Bernardo, in: B a n t i Ottavio/V i o l a n t e, Cinzio (a cura di), Momenti di storia medie-vale pisana. Discorsi per il giorno di S. Sisto, Pisa 1991, pp. 61-77.
R o s s e t t i, Gabriella, Introduzione a: E a d. (a cura di), Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli XII-XVI, Napoli 1989, pp. xiii-xxxii.
R u f f i n i, Edoardo, La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggio-ritario, Bologna 1977.
R u g g i e r o, Antonio, L. Volusio Meciano tra giurisprudenza e burocrazia, Napoli 1983.
R y a n, Magnus, Zur Tradition des langobardischen Lehnrechts, in: D i l c h e r, Gerhard/Q u a g l i o n i, Diego (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, 2, pp. 225-245.
S a n t i n i, Pietro, Studi sull’antica costituzione del Comune di Firenze, in: Archivio Storico Italiano 26 (1900), pp. 3-80.
S a v i g n i, Raffaele, Episcopato e società cittadina a Lucca da Anselmo II († 1086) a Roberto († 1225), Accademia lucchese di scienze, lettere e arti. Studi e testi 43, Lucca 1996.
S a v i g n y, Friedrich Carl von, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, 3, Heidelberg 1834; 4, Heidelberg 1850; 5, Heidelberg 21850.
S b r i c c o l i, Mario, L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale, Milano 1969.
–, Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400, in: P a d o a S c h i o p p a, Antonio (a cura di), Legislation and Justice: The Origins of the Modern State, 13th-18th Centuries, Oxford 1997, pp. 37-55.
S c a l i a, Giuseppe, Romanitas pisana tra XI e XII secolo. Le iscrizioni romane del Duomo e la statua del console Rodolfo, in: Studi medievali s. 3, 13 (1972), pp. 791-843.
CCLXVI Fonti e bibliografia
S c h m a l e, Franz-Josef, Studien zum Schisma des Jahres 1130, Köln-Graz 1961.S c h n e i d e r, Fedor, L’ordinamento pubblico nella Toscana medievale. I fonda-
menti dell’amministrazione regia in Toscana dalla fondazione del regno longo-bardo alla estinzione degli Svevi (568-1268), Firenze 1975.
S c h r a m m, Percy Ernst, Kaiser, Könige und Päpste. Beiträge zur allgemeinen Ge-schichte, III, Stuttgart 1969.
–, Kaiser, Rom und Renovatio, I-II, Berlin 1929. S c h u l z, Fritz, Storia della giurisprudenza romana, Firenze 1968.S c o r d i a, Lydwine, “Le Roi doit vivre du sein”. La théorie de l’impôt en France
(XIIIe-XVe siècles), Paris 2005. S i n i, Aurelia, Giuspatronato, in: Enciclopedia del diritto XIX (1970), pp. 524-536.S o e t e r m e e r, Frank P. W., Zur Identität des Magister Rufinus Lumbardus,
Rechtslehrer in Angers (um 1275/80), in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 109 (1992), pp. 539-546.
–, Recherches sur Franciscus Accursii. Ses Casus Digesti Novi et sa répétition sur la loi Cum pro eo, in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 51 (1983), pp. 3-50.
–, La taxatio peciarum et quaternorum de l’Université de Bologne, in: S o b r e -q u é s, Jaume/P e l à e z, Manuel J. (a cura di), Estudis de Dret Romà i d’His-tòria del Dret Comparat en homenatge a Ramon d’Abadal i de Vinyals pel seu Centenari, Annals of the Archive of Ferran Valls Taberner’s Library 6, Barcelona 1989, pp. 175-192.
–, “Utrumque ius in peciis”. Aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Tre-cento, Orbis Academicus 7, Milano 1997.
S o m e r v i l l e, Robert, The Council of Pisa, 1135: a Re-examination of the Evi-dence for the Canons, in: Speculum 45 (1970), pp. 98–114.
–, Pope Innocent II and the Study of Roman Law, in: Révue des études islamiques 44 (1976), pp. 105-114, ora in: I d., Papacy, Councils and Canon Law in the 11th–12th Centuries, London 1990.
S t o l l e i s, Michael/K r y n e n, Jacques (a cura di), Science politique et droit public dans les facultés européennes (XIIIème-XVIIIème siècle), Frankfurt a. M. 2008.
S t o r t i S t o r c h i, Claudia, Aspetti della condizione giuridica dello straniero negli statuti lombardi dei secoli XIV e XV, in: Archivio storico lombardo 111 (1985), pp. 9-66.
–, Intorno ai Costituti pisani della legge e dell’uso (secolo XII), Quaderni GISEM 11, Napoli 1998.
–, Progetti di riforma istituzionale: Milano nell’età di Luigi XII, in: D i l c h e r, Ger-hard/Q u a g l i o n i, Diego (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, 3, pp. 171-195.
–, La tradizione longobarda nel diritto bergamasco: i rapporti patrimoniali tra coniugi, in: Diritto comune e diritti locali nella storia dell’Europa (Varenna 1979), Milano 1980, pp. 481-553.
S t r n a d, Alfred A., Capranica (Crapanica), Domenico, in: Dizionario biografico de-gli italiani XIX (1976), pp. 147-153.
Studi CCLXVII
T a b a c c o, Giovanni, L’allodialità del potere nel Medioevo, in: Studi medievali s. 3, 11/2 (1970), pp. 565-615.
–, Impero e Regno meridionale, in: Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210), Atti delle V giornate normanno-sveve (Bari-Conversano 1981), Bari 1983, pp. 13-48.
–, La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV (Torino 1950), n. e. a cura di Laura G a f f u r i, Fi-renze University Press 2010.
T e s k e, Gunnar, Ein neuer Text des Bulgarus-Briefes an den römischen Kanzler Haimerich. Zugleich ein Beitrag zum Verhältnis von Saint-Victor in Paris zur Kurie, in: N e i s k e, Franz/P o e c k, Dietrich V./S a n d m a n n, Mechthild (a cura di), Vinculum Societatis. Joachim Wollasch zum 60. Geburtstag, Sigmarin-gendorf 1991, pp. 302–313.
T h e i s e n, Frank, Rolandus von Lucca. Bemerkungen zu seiner Biographie, in: C o l l i, Vincenzo (a cura di), Juristische Buchproduktion im Mittelalter, Frankfurt a. M. 2002, pp. 385-394.
–, Studien zur Emphyteuse in ausgewählten italienischen Regionen des 12. Jahrhun-derts: Verrechtlichung des Alltags?, Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 162, Frankfurt a. M. 2003.
T h é r y, Julien, Moyen Âge, in: P e r r i n e a u, Pascal/R e y n i é, Dominique (a cura di), Dictionnaire du vote, Paris 2001, pp. 667-678.
T h i e r r y, Augustin, Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers État. Pre-mière série. Chartes, coutumes, actes municipaux, statuts des corporations d’arts et métiers des villes et communes de France, Région du Nord, I, Paris 1850.
T h o m a s, Yan, La construction de l’unité civique. Choses publiques, choses com-munes, choses n’appartenant à personne et représentation, in: Mélanges de l’Eco-le française de Rome. Moyen Âge 114/1 (2002), pp. 7-39.
–, Fictio legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales, in: Droits. Revue française de théorie juridique 22 (1995), pp. 17-63, ora in: I d., Les opéra-tions du droit, cap. 6, pp. 133-186.
–, L’institution civile de la cité, in: Le Débat 74 (1993), pp. 23-45, ora in: I d., Les opérations du droit, cap. 5, pp. 103-130.
–, Les opérations du droit, édition établie par Marie-Angèle H e r m i t t e/Paolo N a p o l i, Paris 2011.
–, “Origine” et “commune patrie”. Étude de droit public romain (89 av. J.-C.-212 ap. J.C.), Rome 1996.
–, Les ornements, la cité, le patrimoine, in: D u p o n t, Florencee/A u v r a y - A s -s a y a s, Clara, Images romaines, Actes de la table ronde organisée à l’École normale supérieure (Paris 1996), Paris 1998, pp. 263-283.
–, De la “sanction” et de la “sainteté” des lois à Rome. Remarques sur l’institution juridique de l’inviolabilité, in: Droits. Revue française de théorie juridique 18 (1993), pp. 135-151, ora in: I d., Les opérations du droit, cap. 4, pp. 85-102.
–, La valeur des choses. Le droit romain hors la religion, in: Annales, Histoire, Scien-ces sociales 57/6 (2002), pp. 1431-1462.
CCLXVIII Fonti e bibliografia
T i e r n e y, Brian, Religion, Law and the Growth of Constitutional Thought. 1150-1650, Cambridge 1982.
T i e t z e, Hans, Die illuminierten Handschriften der Rossiana in Wien-Lainz (Be-schreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich 5), Leip-zig 1911.
T i r e l l i, Vito, Lucca nella seconda metà del secolo XII. Società ed istituzioni, in: I ceti dirigenti dell’età comunale nei secoli XII e XIII (Atti del II Convegno, Fi-renze 1979), Pisa 1982, pp. 157-231.
T o d e s c h i n i, Giacomo, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età moderna, Bologna 2007.
T r o j e, Hans Erich, Graeca leguntur. Die Aneignung des byzantinischen Rechts und die Entstehung eines humanistischen Corpus iuris civilis in der Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts, Köln-Wien 1971.
–, Novelleneditionen der humanistischen Jurisprudenz, in: L o s c h i a v o, Luca/M a n c i n i, Giovanna/V a n o, Cristina (a cura di), Novellae constitutiones. L’ultima legislazione di Giustiniano tra Oriente e Occidente da Triboniano a Sa-vigny, (Teramo 2009) Napoli 2011, pp. 281-301.
U l l m a n n, Walter, Medieval Papalism. The Political Theories of the Medieval Ca-nonists, London 1949.
V a l l e r a n i, Massimo, L’affermazione del sistema podestarile e le trasformazio-ni degli assetti istituzionali, in: A n d e n n a, Giancarlo/B o r d o n e, Renato/S o m a i n i, Francesco/V a l l e r a n i, Massimo (a cura di), Comuni e Signo-rie nell’Italia settentrionale: la Lombardia, Torino 1998, pp. 385-482.
–, Tra astrazione e prassi. Le forme del processo nelle città dell’Italia settentrionale del secolo XII, in: Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spät-mittelalters (Frankfurt a. M. 2004), Frankfurt a. M. 2006, pp. 135-154.
V i e j o - X i m é n e z, José Miguel, La Composición del Decreto de Graciano, in: Ius Canonicum XLV, 90 (2005), pp. 431-485.
V i o l a n t e, Cinzio, Economia società istituzioni a Pisa nel Medioevo. Saggi e ri-cerche, Bari 1980.
–, Imposte dirette e debito pubblico, in: I d., Economia società istituzioni a Pisa, pp. 101-156.
–, Le origini del debito pubblico e lo sviluppo costituzionale del Comune, in: I d., Economia società istituzioni a Pisa, pp. 67-90.
V o l t e r r a, Edoardo, Intorno alla formazione del Codice Teodosiano (1980), ora in: I d., Scritti giuridici VI, Antiqua 66, Napoli 1994, pp. 281-317.
W a l l i n g a, Tammo, The Casus Codicis of Whilelmus de Cabriano, Frankfurt a. M. 2005.
W a l t h e r, Helmut G., Die Anfänge des Rechtsstudiums und die kommunale Welt Italiens im Hochmittelalter, in: F r i e d, Johannes (a cura di), Schulen und Stu-dium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, Vorträge und For-schungen 30, Sigmaringen 1986, pp. 121-162.
Studi CCLXIX
W e i m a r, Peter, Zur Entstehung der Azoschen Digestensumme, in: A n k u m, J. A./S p r u i t, J. E./W u b b e, F. B. J., (a cura di), Satura Roberto Feenstra se-xagesimum quintum annum aetatis compienti ab alumnis collegis amicis oblata, Fribourg Suisse 1985, pp. 371-392.
–, Die legistische Literatur der Glossatorenzeit, in: C o i n g, Helmut (a cura di), Handbuch der Quellen und Literatur, pp. 129-260.
W i c k h a m, Chris, Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo, Roma 2000.
W i e a c k e r, Franz, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Unter besonderer Berück-sichtigung der deutschen Entwicklung, 2. bearb. Auflage, Göttingen 1967 (trad. it.: Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania, Milano 1980, vol. II).
W i l k i n s o n, Bertie, Constitutional History of Medieval England, 1216–1399, III, London 1958.
Z e i l l i n g e r, Kurt, Kaiseridee, Rom und Rompolitik bei Friedrich I. Barbarossa, in: Bollettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo 96 (1990), pp. 367-419.