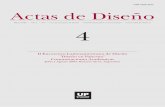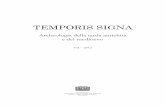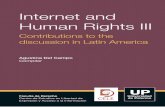Palazzo Belmonte a Palermo
Transcript of Palazzo Belmonte a Palermo
LEXICONStorie e architetturain Sicilia e nel Mediterraneo
n. 16 - 2013Edizioni Caracol€ 15,00ISSN: 1827-3416
ISBN: 978-88-98546-01-5
SOMMARIO
Marco Rosario NobileEditoriale
Ciro D’ArpaDue architetture effimere di Paolo Amato per la festa dell’Assunta a Palermo
Federica ScibiliaIl progetto di Giacomo Amato per il palazzo Statella dei marchesi di Spaccaforno a Palermo
Natale FinocchioNotizie sulla biblioteca di Agatino Daidone dal suo inventario testamentario (1724)
Antonio Belvedere, Sabina MontanaPalazzo Belmonte a Palermo
Conrad ThakeStefano Ittar. Architect of the Order of St John in Malta (1784-1790)
DOCUMENTI
Antonello CapodicasaLa costruzione della Domus Consilii a Noto Antica (1559-1604)
Paolo NifosìLa Torre Cabrera a Pozzallo: da palazzo a fortezza
Fulvia ScadutoIl seicentesco palazzo vescovile di Santa Lucia del Mela (Messina)
Abstracts
Edizioni CaracolLE
XICO
N n. 16 - 2013 Architettura civile in età moderna tra Sicilia e Malta
Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel MediterraneoRivista semestrale di Storia dell’ArchitetturaN. 16/2013
ISSN: 1827-3416ISBN: 978-88-98546-01-5
Tribunale di Palermo. Autorizzazione n. 21 del 20 luglio 2005
Edizioni Caracol - Palermo
Direttore responsabile:Marco Rosario Nobile
Comitato scientifico:Beatriz Blasco Esquivias (Universidad Complutense de Madrid)Richard Bösel (Istituto Storico Austriaco di Roma)Monique Chatenet (Centre André Chastel, Paris)Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid)Alina Payne (Harvard University, Cambridge - MA)
Comitato di review:Paola Barbera, Maria Sofia Di Fede, Erik H. Neil, Stefano Piazza, Fulvia Scaduto
Capo redattore:Emanuela Garofalo
Redazione:Giuseppe Antista, Antonella Armetta, Maria Mercedes Bares, Federica Scibilia, Domenica Sutera, Maurizio Vesco
Questo numero è stato curato da Federica ScibiliaI sommari dei numeri precedenti sono consultabili su http://www.edizionicaracol.it/lexicon.htm
Gli articoli devono essere inviati al direttore della rivista, presso il Dipartimento di Architettura, Viale delle ScienzeEdificio 8, 90128 Palermo o in alternativa all’indirizzo di posta elettronica della casa editrice [email protected] scritti pervenuti saranno valutati dal comitato scientifico e dal comitato di review che, di volta in volta, sottopor-ranno i testi ai referees, secondo il criterio del blind peer review.La rivista adotta un modello di condotta e un codice etico ispirati a obiettivi di correttezza e professionalità, che trovanoriferimento in quanto stabilito dal Committee on Publication Ethics (COPE). Il codice etico e di condotta della rivista èconsultabile su http://www.edizionicaracol.it/codice-etico.html.
Amministrazione:Caracol s.n.c. via Mariano Stabile, 110 Palermo
© 2013: by Edizioni CaracolStampa: Tipografia Priulla - PalermoPer abbonamenti rivolgersi alla casa editrice Caracol ai seguenti recapiti:e-mail: [email protected]. 091-340011
Questo numero è stato pubblicato con i contributi del fondo Progetto COSMED, Programma Ideas, AzioniAdvanced Investigator Grant 2011, European Research Council (ERC).
In copertina: Valletta. Biblioteca, volta sul vestibolo (fotografia di D. Cilia).
SOMMARIO
5 Marco Rosario NobileEditoriale
7 Ciro D’ArpaDue architetture effimere di Paolo Amato per la festa dell’Assunta a Palermo
15 Federica ScibiliaIl progetto di Giacomo Amato per il palazzo Statella dei marchesi di Spaccaforno a Palermo
29 Natale FinocchioNotizie sulla biblioteca di Agatino Daidone dal suo inventario testamentario (1724)
41 Antonio Belvedere, Sabina MontanaPalazzo Belmonte a Palermo
53 Conrad ThakeStefano Ittar. Architect of the Order of St John In Malta (1784-1790)
67 DOCUMENTI
68 Antonello CapodicasaLa costruzione della Domus Consilii a Noto Antica (1559-1604)
75 Paolo NifosìLa Torre Cabrera a Pozzallo: da palazzo a fortezza
79 Fulvia ScadutoIl seicentesco palazzo vescovile di Santa Lucia del Mela (Messina)
86 Abstracts
41
Lexicon - n. 16/2013
La storia, gli attori Le vicende di palazzo Afflitto, nucleo originario dipalazzo Belmonte, appaiono fin dagli esordi intima-mente connesse alla crescita e allo sviluppo dell’an-tico cuore della città, al Qasr, nel Quattrocentoappannaggio di alcune dinastie all’apice della nobil-tà degli uffici tra cui i Castrone, i Bologna, gliAfflitto1. L’intreccio delle vicende parentali ed eco-nomiche di queste famiglie rende conto delle relazio-ni e analogie tra le rispettive fabbriche, come quelle,già rilevate in sede storiografica, tra i palazziCastrone e Afflitto2. Labili tracce, pochi indizi docu-mentali e il gioco delle possibili comparazioni resti-tuiscono di palazzo Afflitto l’immagine di un quat-trocentesco edificio a corte con scalone in pietraall’aperto e innesto di elementi gotici o “alla moder-na”, tra cui una bifora centrale, che nel tempo lasciòposto, o forse fu solo affiancata, da nuovi inserti,come la loggia del piano nobile con colonne dimarmo bianco e le finestre d’intaglio squadrate econtornate da una cornice continua (chinta), questeultime realizzate nell’ultimo ventennio delQuattrocento su modello di quelle del vicino cantie-re Castrone3. A sottolineare il prestigio del casato,una torre, svettante dal prospetto orientale, tessutocon pietrame informe contrapponibile al gioco iso-domo del fronte su via Toledo.Probabilmente, fin dalla rinascita cinquecentesca delquartiere quest’ultima quinta presentava una parti-tura bugnata al primo livello e un’articolazione abotteghe sovrastate da mezzanini adibiti a uso abita-tivo, soluzione comune a molti palazzi cinquecente-schi prospicienti su via Toledo4. A partire da questa stagione la documentazione si fapiù copiosa e lascia intravedere una secolare vicendache può dipanarsi solo in relazione ai nuovi assettiproprietari che videro gli Afflitto e poi i Ventimigliadi Belmonte, il monastero del Cancelliere, quello diMontevergini, gli Aragona e Settimo di Giarratana epoi i Ventimiglia di Geraci impegnati nell’accaparra-
mento di case e viridaria da destinare all’ampliamen-to delle rispettive fabbriche5. Nel 1658 palazzo Afflitto passò per via dotale aiVentimiglia e Rossell; nel primo quarto delSettecento, alla vigilia dell’investitura a principe diGiuseppe Emanuele Ventimiglia e Statella, l’architet-to Carlo Infantolino fissò i termini della riforma delladimora, che il tecnico riteneva inderogabile, in osse-quio «al grado della sua qualità e nascita conditionedi tanto famiglia cospicua»6. Gli interventi portaronoad una progressiva estensione orizzontale e vertica-le delle ali perpendicolari al piano de’ Bologni. Nel1736 una immagine della fabbrica parata a festa fuinserita nel libro di La Placa dedicato all’acclamazio-ne di Carlo III7 [fig. 1]. L’incisione, eseguita su dise-gno di Nicolò Palma8, ritrae il fronte su via Toledo,ancora privo di accesso d’onore e marcato da undecorativismo di matrice locale frammisto a decorigeometrici che arricchivano le bugne lisce del pianosu strada: quadri, triangoli e losanghe che, con evi-denza, rimandano agli ornati di Vredeman de Vries
PALAZZO BELMONTE A PALERMO
Antonio Belvedere*, Sabina Montana**
Fig. 1. Nicolò Palma, Prospetto del Palazzo nel Cassaro, dirim-petto alla Statua di Carlo V... (da P. La Placa, La Reggia inTrionfo…, cit.).
42
(1577), diffusi nella Sicilia del Seicento nelle versionidi Rutger Kasemann e Gabriel Krammer9. A quelladata gli interventi alla fabbrica continuavano a sus-seguirsi ma solo nel 1776 Giuseppe EmanueleVentimiglia e Statella, con lascito testamentario,dispose la ricostruzione integrale del palazzo«secondo il disegno e modello formato colla direzio-ne del Signor Don Alessandro Vanni Principe di SanVincenzo»10. Vanni elesse coadiutore Giuseppe VenanzioMarvuglia11, che assunse la direzione del cantiere,stilò i capitoli delle opere murarie, di legno e dimarmo e fornì nuovi disegni, secondo autografadichiarazione, «uti architectus» della nuova fabbrica.Il suo contributo fu rilevante nel prospetto, comeconferma il confronto tra l’attuale fronte e un dise-gno ritrovato tra le sue carte e unanimemente attri-buito al Vanni12 [fig. 2]. Nell’assetto finale le mem-brature furono alleggerite, fu eliminato il fregio dori-co impostato sui capitelli ionici, risolto il mancatoraccordo tra le paraste giganti dei livelli superiori ela continua fascia bugnata del piano terra e furonomodificati gli elementi decorativi con l’introduzionedi “triglifi” laterali ai finestroni del piano nobile, sudisegno di quelli già proposti dal Marvuglia nellachiesa dell’Olivella. I capitelli di facciata proponeva-no alcune aggiunte “alla moderna”, come la varia-
zione calibrata della sezione delle volute, l’accentua-ta curvatura dell’echino e l’uso di festoni “alla roma-na”, secondo un disegno che mediava cultura di trat-tato e cultura antiquaria e che, a detta di AgostinoGallo, l’architetto elaborò per il palazzo prendendospunto da alcuni reperti della Solunto antica. Nelsuo trattato dedicato all’architettura civile13,Marvuglia chiarisce la preferenza per l’ordine ionico,che ben si accordava «all’onor della pace, e della giu-stizia»14, ai Tribunali di Giustizia e agli edifici dedi-cati al culto della pietà. In palazzo Belmonte è ipotizzabile che il ricorsoall’ordine ionico evocasse deliberatamente memoriae valore del principe. Negli anni in cui i precetti delMuratori raccomandavano agli uomini nobili d’ani-mo e di natali di «ridondare in Bene a vantaggio dellapovera gente»15, il principe di San Vincenzo propone-va infatti l’istituzione nell’isola di una Deputazionedei Proietti e nel 1751 il viceré chiamava il Belmontea farne parte, ponendo le basi per un sodalizio tra ilcommittente e l’architetto nobile esteso negli anniseguenti anche al Marvuglia16. In questo contesto ilcoinvolgimento nel cantiere di palazzo Belmonte delFuga, sostenuto da Dufourny e da Hittorff, appareeventuale e solo indiretto17. L’influenza dell’architet-to toscano nella cultura di progetto della città capita-le è di certo patente. A tal riguardo ricordiamo che laromana dimora Petroni è già stata segnalata comemodello dei prospetti di palazzo Ventimiglia e delcollegio di Maria a Monreale, recentemente attribuitoal Vanni e datato intorno al biennio 1762-6418. Secomunque evidenti appaiono alcune affinità lessicalitra la dimora dei Belmonte e le architetture del Fuga,la ricostruzione settecentesca del palazzo palermita-no testimonia una tensione emulativa che ampliava ilcampo del confronto e delle sperimentazioni benoltre il modello romano. A proposito, e quanto all’im-pianto generale, il ricorso alla sequenza atrio-cortili-scalone, filtrati da porticati, con relativa enfasi tribu-tata alla scenografia e alla funzionalità degli edifici,comprova un’adesione alla tradizione locale reinter-pretata in senso classicista e non aliena da influenzericonducibili alla tradizione genovese, ma anche,come suggerisce Hittorff, alla cultura piemontese19.Suggestivi, a riguardo, gli spunti di riflessione com-parativa elaborati dal viaggiatore francese e nonestranei alla coeva pubblicazione del testoArchitecture italienne, ou Palais, maisons et autres édificesde l’Italie moderne di Jean Baptiste Cicéron Lesueur e
Fig. 2. A. Vanni di San Vincenzo (attribuito), disegno del prospet-to principale di palazzo Belmonte a Palermo, anni Sessanta delXVIII secolo (Palermo, archivio privato Palazzotto).
43
Lexicon - n. 16/2013
Félix Callet, corredato da una silloge di rilievi di cor-tili e palazzi di Torino ed edito a Parigi nel 1827,all’indomani del viaggio siciliano di Hittorff20.
Il cantiere Le ultime volontà di Giuseppe Emanuele Ventimigliae Statella testimoniano il valore tributato alla nuovafabbrica dal testatore che, a sostegno della causa edi-ficatoria, dispose la devoluzione integrale dei cespitiannuali ereditari e dei proventi della vendita dei benisuntuari di famiglia21.Nel giugno del 1777, a tre mesi dall’apertura deltestamento, i “capitoli” delle opere murarie redattidal Marvuglia furono affissi all’incanto e i lavoriaggiudicati all’asta, con un ribasso del 17%, a unaimpresa rappresentata dallo “stagliante” FrancescoLa Bua22. Nel mese successivo furono eseguite ledemolizioni preliminari alla nuova edificazione23.Interamente rasa al suolo l’ala prospiciente viaToledo: le camere del terzo livello, del piano d’ono-re (comprendente due camere e un camerone) e lesei botteghe sottostanti, dotate di piani ammezzatiper uso abitativo. Eliminata la scala a tre tavolieri suvolta che dal baglio accedeva al piano nobile erisparmiate le parti d’intaglio in marmo bianco dellaloggia del palazzo, coperta con volte reali impostatesu tre colonne dotate di basi e capitelli, che furonosmontate per un futuro riutilizzo. Sul fronte orienta-le fu abbattuta l’antica torre che prospettava sulpiano del Cancelliere e l’ala di rappresentanza che sisnodava nell’ordine nobile, ovvero la sala e le dueanticamere che confluivano nel camerone. Il bracciosu fronte Geraci, dove solo pochi anni prima iVentimiglia avevano promosso interventi e miglio-rie, parzialmente demolito, fu saldato alla nuovafabbrica24. Nella stessa linea si procedette ad operedi sbancamento per abbassare il piano di calpestiodelle nuova carretteria e della contigua cantina, inparte ricavati nello spazio della chiesa di San Biagio,di cui furono sacrificati il catino absidale e l’altare25
[fig. 3]. La ricostruzione prese avvio dal corpo prin-cipale su via Toledo e proseguì con i bracci laterali.Al piano nobile l’assetto funzionale fu invertito: nel-l’ala occidentale si collocò l’appartamento di rap-presentanza, nell’ala orientale quello privato26. Gli intagli scultorei del prospetto furono eseguiti daGaetano Coppolino27, chiamato, per volontà delMarvuglia, a lavorare una pietra proveniente da unanuova cava aperta fuori porta, nel territorio di
Ficarazzi28. Il materiale, usato anche per altre partidella fabbrica, creò alcuni inconvenienti. Gli “sta-glianti” non lo giudicarono idoneo allo squadro eall’intaglio e pretesero un incremento dei compensipattuiti. Per dirimere la controversia fu chiamatol’architetto Salvatore Attinelli29, che dispose la revi-sione dei prezzi delle sole parti di fabbrica edificatecon la pietra di Ficarazzi, ritenuta mirabile per «for-tezza» ma poco «maniabile […] inconsueta […] cosìponderosa che per trasporti per terra e mare biso-gnano più manovali» e solo apparentemente simile aquella di Santa Maria di Gesù, comunemente usatain cantiere ed estratta da una cava in via di esauri-mento di proprietà dei Ventimiglia. Tra le parti sog-gette a revisione dei prezzi, la relazione annovera levolte dello scalone d’onore e di sostegno alle rampee quelle che coprivano gli ambienti a luce maggiore,come la cavallerizza e la pagliarola. Il perito specifi-cava che nessuna maggiorazione era dovuta per «lipiccoli dammusi di mattoni in coltello e gesso»impostati sulle poste della cavallerizza. Escluse dallarevisione dei prezzi anche le volte a botte «regalinefatte di mattoni a foglie», poste a copertura delle bot-teghe e dei locali retrostanti e usate anche per le veledelle crociere dei portici e di altri ambienti di picco-le dimensioni. Attinelli specificava a riguardo chel’esecuzione di volte di mattoni disposti di taglio(tipo lamia) o “in plano” (tipo tabicadas30), volute dalMarvuglia, non aveva comportato oneri imprevisti oaggiuntivi, lasciando intendere che entrambe le tec-niche rientravano nel novero delle consuete pratichedi cantiere. In particolare, l’uso delle volte in matto-ne “in folio”, finora accertato per il Quattro eCinquecento isolano e poco documentato per le sta-gioni successive, appare in questa sede opzione elet-tiva per coperture voltate di dimensioni variabili cherichiedevano facile e veloce esecuzione (volte dellebotteghe31). Nella sua relazione Attinelli fa anchecenno ad una «lite col Cancelliere», che rese necessa-ria una revisione del “modello” di fabbrica32. Allostato dell’arte la variante imposta dal monasteroappare l’unica plausibile ragione della singolareasimmetria che il palazzo proponeva tra le paretioccidentale e orientale del primo cortile [figg. 4-5]. Dalla relazione dell’Attinelli e da altri coevi docu-menti sulla fabbrica emerge con chiarezza il ruoloegemone del Marvuglia nella direzione del cantiere.Sebbene Vanni sia indicato nei contratti di appalto«director principal costrutionis d.i palatii»33, il suo
44
apporto, successivamente all’apertura del cantiere,appare limitato ad una serie di atti formali che neescludono una incisiva mansione direttiva.Significativo il confronto tra i compensi corrisposti aidue tecnici. Nel 1780 Vanni riceveva un’onza34,Marvuglia circa 60, poco più della metà di quantopercepì tra il luglio del 1777 e il triennio successivo.La prima tranche di lavori murari, stimata nel settem-bre del 1780, ammontava a 3200 onze, a fronte di unonere totale del palazzo che Villabianca stimò in100.000 scudi (circa 40.000 onze) 35. Nel 1784 Marabitti assestava «lo tabellone dimarmo bianco con i suoi trofei» e il principe diBelmonte rientrava da Roma per l’«apertura festivadel novello palazzo»36. A quella data si lavoravaancora alle finiture: «mattoni stagnati di Napoli»,
stucchi e intagli «stile raffaele», marmi bianchi erossi, arredi «con foglie di Venezia» e «lastri diGermania», riferimenti culturali molteplici che evo-cano un internazionalismo sincretico, base e misuradell’originale contributo della fabbrica al classici-smo settecentesco palermitano37.
Tra rappresentazione e restituzione38
Della FacciataQuando Marvuglia viene chiamato a dirigere il can-tiere di palazzo Belmonte, i suoi interventi su proget-ti già predisposti da altri architetti sono numerosi ecostituiscono una percentuale considerevole nel com-plesso della sua opera39. Riguardo al suo contributo aldisegno del fronte principale di palazzo Belmonte,vale la pena di soffermarsi ancora, per alcune consi-
Fig. 3. Palermo. Palazzo Belmonte, planimetria generale e pianta del piano terra. Ipotesi di configurazione tardo settecentesca (restituzione gra-fica di A. Belvedere).
45
Lexicon - n. 16/2013
Fig. 4. Palermo. Palazzo Belmonte, sezioni e profili. Ipotesi di configurazione tardo settecentesca (restituzione grafica di A. Belvedere).
46
derazioni che emergono con chiarezza dalla letturadella fabbrica proposta da Cardella nel 1933 e daidisegni che Dufourny redasse negli anni del suo sog-giorno palermitano [figg. 6-7]. Circa il rapporto tral’ordine gigante del piano superiore e la zona basa-mentale, difficile da leggere correttamente senzaun’attenta osservazione della sezione [figg. 4, 8], cosìscrive Cardella: al piano terra, «ogni binato di lesenerestava schiacciato dalla mole delle grandi parastre(sic) sovrastanti. Ecco, allora, che con una raffinatissi-ma sagacia, egli porta un po’ in avanti tutta la zonabasamentale offerta dal muro di prospetto del pianoterreno; in modo, appunto, da far pensare che quellesmisurate parastre ioniche venissero sorrette, nondagli esili binati di lesene, ma dal grosso muro adesse retrostante»40. Questo espediente consente al
Marvuglia di creare un vero basamento in leggeroaggetto rispetto all’edificato sovrastante, ottenendoquell’effetto di solidità e di coerenza strutturale ade-guato all’importanza del fronte sulla via Toledo. Di grande interesse è anche il dispositivo messo inatto per alleggerire l’impatto ottico della grande tra-beazione – la cui altezza doveva essere proporziona-ta al gigantismo delle paraste – senza tradire i cano-ni classici. Eliminato preliminarmente il fregio dori-co disegnato dal Vanni, la soluzione ideata daMarvuglia fu quella di accogliere le aperture delpiano superiore all’interno della trabeazione, spez-zandola in corrispondenza delle aperture stesse ealleggerendo in tal modo il carico ottico del corona-mento: una soluzione che ha un precedente illustrenella facciata di palazzo Valmarana a Vicenza, ad
Fig. 5. Palermo. Palazzo Belmonte, pianta del piano nobile e del piano superiore. Ipotesi di configurazione tardo settecentesca (restituzione grafi-ca di A. Belvedere).
47
Lexicon - n. 16/2013
opera del Palladio41. Dufourny rileva con attenzionequesta soluzione, con alcune “correzioni” che appa-iono dettate dal desiderio di conferire alla facciatauna più marcata orizzontalità42. Il confronto tra ildisegno di facciata attribuito al Vanni e il disegnodel Dufourny, tra l’accentuato verticalismo di quel-la prima soluzione e la serena orizzontalità dellaseconda, dà la misura del cambiamento di sensibili-tà e di gusto maturato nel volgere di pochi decenni43.
Delle preesistenzeLa tesi di una fabbrica ricostruita dalle fondamenta,tramandata dal Villabianca e ripresa da numerosi stu-diosi dei secoli scorsi, è stata accolta in tempi relativa-mente recenti anche da Vincenzo Capitano che, nelsottolineare la «coerente unità strutturale» osservatanel rilievo dei resti postbellici dell’edificio, suggeriscel’ipotesi di «eventuali compresenze artistiche tali dagiustificare le notate compromissioni formali»44.
Figg. 6-7. L. Dufourny, Plan du Palais de Belmonte (Palerme); Elevation et coupe du Palais Belmonte (Palerme), anni Novanta delSettecento (Paris, Biblothéque Nationale, Fondo Dufourny VB 132 N, t. 3, f. 65.403-404).
48
I dati emersi dalla ricerca archivistica, già esposti,suggeriscono che la tesi della “fabbrica ex novo” siaascrivibile a una tradizione celebrativa nei riguardidell’augusto committente piuttosto che alla realtà diuna grande architettura in una città stratificata ecomplessa come Palermo.Salvatore Cardella, che osserva il palazzo un decen-nio prima della sua riduzione in macerie, manifestacon chiarezza le sue perplessità: «l’esuberanza deco-rativa del piano nobile non s’adegua né a quel carat-tere di sobrietà né a quella unità stilistica che mirabil-mente definiscono la facciata principale del palazzo.... le varianti architettoniche che si notano tra le fac-ciate che cingono il primo tratto di cortile ed il secon-do … insieme ancora alla disorganicità tra la facciatadel secondo tratto di cortile esposta a sud e quelleimmediatamente laterali, fanno ben sospettare chenon soltanto le opere decorative ma pure le operecostruttive non fossero tutte nate in un unico perio-do»45. I risultati del nostro studio rendono conto diquesta sua intuizione: alle spalle della nuova elegan-
te facciata sul Cassaro, i fronti longitudinali sulprimo cortile – liberi da quelle esigenze di rappresen-tatività demandate alle quinte trasversali – avevanouno sviluppo diseguale, mostrando pertanto ildispiegarsi degli ambienti interni con un disegnomeno ricercato. L’ala ovest era infatti a tre elevazio-ni, cosi come il corpo principale sulla via Toledo,mentre l’ala est non aveva una terza elevazione masolo piccole “soprastanze” [figg. 4-5]. Nel secondocortile, i corpi di fabbrica avevano invece due soleelevazioni, presentandosi come un insieme piùarmonico e compatto, con la ripresa – in scala ridotta– delle paraste ioniche “alla moderna” e del bugnatoliscio che compaiono nella facciata sul Cassaro. Lamaggiore attenzione compositiva era inoltre quiassociata a una monumentalità progressivamentecrescente verso lo sfondo, con lo scalone inquadratoda fontane, statue allegoriche e quadri in stucco46. Etuttavia, la seduzione esercitata dalla magnifica suc-cessione di spazi coperti e scoperti e dagli elegantifondali posti lungo l’asse di percorrenza era cosìpotente da far passare tali irregolarità in secondopiano. «It is not very large but the most regular andin the best taste of any I have here seen» – osserval’architetto inglese Cockerell nel 1812, riferendosi inparticolare all’effetto particularly pretty della vedutaassiale47 [fig. 9]. Analoghe osservazioni ritornano neidisegni di Hittorff pubblicati nel 183548 [fig. 10].Elaborati “progettuali” – più che restituzioni obietti-ve – essi trascurano tuttavia molti dettagli importan-ti, come ad esempio la differenza di sezione tra i duecortili che non sfugge, invece, a Dufourny. Con ilpassaggio dalla sezione più grande a quella più pic-cola si configurava infatti una sorta di raffinata strut-tura “a cannocchiale” che rafforzava la prospettivalungo l’asse centrale mettendone a fuoco il punto diarrivo, costituendone uno dei punti di forza49.
Della distribuzioneNel corso del Settecento, soprattutto in Francia, ladistribuzione degli edifici acquisisce uno statutodisciplinare sempre più rilevante, affiancandosi allacostruzione e alla decorazione. Il lavoro dell’architet-to, homme de l’art per eccellenza, chiamato ad appli-care rigorosamente le regole di un codice esteticocondiviso, si arricchisce di una dimensione umana epratica, aprendo la riflessione alle necessità della vitaquotidiana e appropriandosi di un sapere che eraappartenuto prima esclusivamente alla committen-
Fig. 8. Palermo. Palazzo Belmonte, particolari del prospetto e dellasezione (da V. Capitano, Giuseppe Venanzio Marvuglia…, cit.).
49
Lexicon - n. 16/2013
Fig. 9. C.R. Cockerell, Palace of the Prince of Belmonte in the via Toledo, Palermo, 1812. (London, Royal Institute of British Architects,Library Drawings Collection, Ref No RIBA 67133).
Fig. 10. Palermo. Palazzo Belmonte, pianta del piano terra e sezio-ne longitudinale (da J.I. Hittorff, L. Zanth, Architecture modernede la Sicile…, cit.).
za50. Così, se il richiamo all’antichità rimane il riferi-mento essenziale per le regole di composizione e perl’ordonnance delle facciate, la crescente importanzaattribuita alle commodités influenza e orienta in mododeterminante la distribuzione degli spazi interni.Come è noto, lo sviluppo delle teorie francesi sull’ar-te della distribuzione, da François Blondel in avanti,viene seguito con attenzione da committenti e archi-tetti di tutte le regioni d’Europa. La restituzione del-l’organizzazione planimetrica del piano nobile dipalazzo Belmonte mostra come nel corpo principalee nell’ala ovest, lì dove la maggiore profondità delcorpo di fabbrica lo consentiva, era stato adottato ildispositivo dell’appartamento demi-double – cioèdoppio in profondità con alcune stanze non passan-ti – generando una differenziazione dei percorsidestinati ai proprietari, ai domestici, ai visitatori. Inparticolare al terzo e ultimo piano, dove minorierano le esigenze di rappresentanza, la «camera dinegozio», la «camera del camino» – con «apparato diseta alle pareti e suo camino di marmo» – e le altrecamere con affaccio sul primo cortile non erano pas-santi [fig. 5]51. Lo stesso ruolo di differenziazione deipercorsi è svolto dalla moltiplicazione delle piccolescale, spesso anguste e realizzate in legno, che colle-gavano due o più livelli. Al piano nobile, tra le stan-
50
1 Questo saggio è frutto di una stretta collaborazione tra i due autori: i primi due paragrafi del saggio sono stati redatti da Sabina Montana, i successivi daAntonio Belvedere. Il palazzo oggetto di studio si trova nell’isolato compreso tra corso Vittorio Emanuele, vicolo del Gran Cancelliere e vicolo San Biagioe ha il fronte principale prospiciente piazza Bologni. La fabbrica, ricostruita nell’ultimo quarto del Settecento per volontà di Giuseppe EmanueleVentimiglia e Statella principe di Belmonte, fu venduta un cinquantennio dopo al capitano marittimo e barone di Colobria Giovanni Riso. Il palazzo, adi-bito poi a sede palermitana del Partito Fascista, subì i bombardamenti del 1943 e altrettanto distruttive demolizioni nel corso degli anni Sessanta; a parti-re dalla metà degli anni Novanta è stato restaurato, restituito alla pubblica fruizione e adibito a Museo Regionale d’Arte moderna e contemporanea.2 Sugli Afflitto: C. TRASSELLI, Note per la storia dei Banchi in Sicilia nel XV secolo, parte II, I banchieri e i loro affari, pp. 101-128. Circa i rapporti tra le fami-glie Castrone e Afflitto e i relativi palazzi: F. SCADUTO, Architettura committenza e città nell’età di Filippo II. Il palazzo Castrone a Palermo, Palermo 2003,pp. 15-17. 3 Nel 1407 Pietro Afflitto, imparentato con i Castrone, banchiere e uomo di fiducia del re, anche amministratore della Tesoreria per la Secrezia diPalermo, acquistò da Isolda Aragona un ospizio grande – dotato di portici, camere, sale e botteghe – che nel 1428 dotò di un prospetto unitario confinestre al piano nobile simili a quelle dei vicini Ospedale Grande e palazzo Castrone. Tra le parti d’intaglio anche una finestra “a colonna”, postapresumibilmente in posizione centrale. Nell’ultimo ventennio del Quattrocento Bernardo Afflitto, successo a Pietro, affidò al fabricator AntonioBelguardo il compito di promuovere nuovi interventi nella fabbrica e in questa stagione furono costruite le citate finestre fatte su modello di quelledel vicino palazzo Castrone. Cfr. Archivio di Stato di Palermo (ASPa), Archivio Belmonte, vol. 499, cc. nn.; F. SCADUTO, Architettura committenza e…,cit., pp. 17, 32 note 26 e 27. Sul coinvolgimento di Antonio Belguardo nel cantiere di palazzo Afflitto: F. MELI, Matteo Carnilivari e l’architettura delQuattro e Cinquecento in Palermo, Roma 1958, p. 271, doc. 88. Il contratto tra Bernardo Afflitto e il maestro muratore Anteopus de Cara per la costru-zione delle finestre è trascritto in ivi, p. 270, doc. 86.4 F. SCADUTO, Architettura committenza e…, cit., p. 73.5 ASPa, Archivio Belmonte, vol. 499, cc. nn.; vol. 367, c. 172 e sgg. Sul Cassaro, ad ovest di palazzo Afflitto, Giovanna d’Aragona e Settimo, marchesadi Giarratana, costruì, tra il terzo e quarto decennio del Seicento, il palazzo poi passato ai Ventimiglia di Geraci. Sulla fabbrica: G. CARDAMONE, Ilpalazzo dei Ventimiglia di Geraci, in L’uso dello spazio privato nell’età dell’Illuminismo, atti del convegno (Firenze, 9-11 giugno 1994), a cura di G. Simoncini,2 voll., Firenze 1995, II, pp. 579-588. Sul vicino monastero di Montevergini: ID., Un cantiere palermitano dell’età barocca: la chiesa di S. Maria diMontevergini, Palermo 1991; ID., La fondazione quattrocentesca della chiesa di S. Maria di Montevergini a Palermo, in «Schede medievali», 38, gennaio-dicembre 2000, pp. 107-120. 6 ASPa, Archivio Belmonte, vol. 499, cc. nn.; vol. 367, c. 172 e sgg. Su Carlo Infantolino: M.C. RUGGIERI TRICOLI, Infantolino Carlo, in L. SARULLO, Dizionariodegli artisti siciliani, I, Architettura, a cura di M.C. Ruggieri Tricoli, Palermo 1993, ad vocem. Per la storia del titolo e feudo di Belmonte: F.M. EMANUELE
E GAETANI MARCHESE DI VILLABIANCA, Della Sicilia Nobile, 5 voll., Palermo 1754-1775, I, pp. 81-82. Erede di Francesco Ventimiglia e Rossell fu il figlioGaetano, che s’investì del titolo di Belmonte nel 1697. A partire dal 1724 subentrarono i principi di Villadorata, Vincenzo (senza investitura), fratellodi Gaetano, e la moglie Anna Maria Statella. Alla morte di Vincenzo, nel 1725, eredità e titoli passarono al figlio Giuseppe.7 P. LA PLACA, La Reggia in Trionfo…, [Palermo 1736] 1992. Il disegno a stampa porta in calce l’indicazione: Nicolò Palma inventor, Giuseppe Vasi scultor.8 Sull’apporto di Nicolò Palma alla cultura architettonica palermitana si veda S. PIAZZA, Architettura e nobiltà. I palazzi del Settecento a Palermo, Palermo2005, pp. 128-129. 9 M.R. NOBILE, Architectura Von den funf Seülen di Gabriel Kramer, in «Il disegno di Architettura», 34, 2008, pp. 21-26; A. KRÄMER, Architettura e decora-zione: fonti e modelli del Barocco in Sicilia orientale, in «Palladio», 21, 1998, pp. 47-70.
ze “appartate”, vi era la «camera delle colonne» – inposizione privilegiata sul passetto centrale – con seiaffacci equamente ripartiti sui due cortili e utilizzatacome salle à manger, «mattonata di mattoni di bardi-glio e coperta da volta pittata con quadrone figuratoal centro, con pareti a granito munite di sei pilastrifinti e due colonne di selce nel centro»52. Per gli spazidi rappresentanza la consueta enfilade di anticamereda attraversare per raggiungere la galleria del pianonobile era – a palazzo Belmonte – davvero rimarche-vole: oltre cinquanta metri di percorso, con sala e treanticamere di altezza pari a quella della galleria, euna prospettiva adeguatamente lunga per rappre-
sentare degnamente la magnificenza del principe edel suo casato. Sulla parete ovest della grande galle-ria – secondo la testimonianza di Cockerell – unaimponente edicola trabeata con due nicchie lateraliposte ai lati di essa ospitavano medaglioni in basso-rilievo con i profili del principe e della principessa diBelmonte. Al centro dell’edicola, su due mezzecolonne, troneggiavano i busti della coppia reale«with their attributes: Fidelity and Love»53.
*Dottorando di ricerca, Università degli Studi diPalermo**Dottore di ricerca, Università degli Studi di Catania
51
Lexicon - n. 16/2013
10 Il Belmonte nominò erede universale il nipote undicenne Giuseppe Emanuele Ventimiglia e Cottone, figlio del fratello Gaetano. Un profilo biograficodell’erede è tracciato in G. GIARRIZZO, Belmonte Giuseppe Emanuele Ventimiglia e Cottone principe di, in Dizionario Biografico degli Italiani, VIII, Roma 1966, advocem. Il testamento fu dato in Napoli il 7 marzo 1776; una copia è in ASPa, Notai Defunti, not. Gaspare Sarcì e Papè, vol. 10379, cc. 684r-700r.11 Di Alessandro Vanni dà notizia il Gallo, che ne sottolinea le nobili origini, la cultura eletta e l’interesse per la matematica, la pittura, il disegno el’architettura. Cfr. A. GALLO, Notizie intorno agli Architetti Siciliani…, ms. della prima metà del XIX sec. della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana(BCRS), ai segni XV H 14, f. 1021. Ulteriori acquisizioni sull’architetto in G. LEONE, Il collegio di Maria a Monreale e Alessandro Vanni “architetto”: ipote-si per un progetto , in «Lexicon Storie e architettura in Sicilia», 0, 2000, pp. 69-82. Il profilo professionale di Giuseppe Venanzio Marvuglia è stato ogget-to di numerosi studi, tra cui, oltre ai testi citati infra: U. STACKE, L’architettura di Giuseppe Venanzio Marvuglia in Sicilia. Dallo stato degli studi a un pro-gramma di ricerca, in L’architettura del Settecento in Sicilia, a cura di M. Giuffrè, Palermo 1997, pp. 213-222; M. GIUFFRÈ, Classicismo e neoclassicismo inGiuseppe Venanzio Marvuglia, in «Napoli nobilissima», s. IV, 28, 1989, pp. 122-128; V. PALAZZOTTO, Giuseppe Venanzio Marvuglia e l’apprendistato roma-no, in L’architettura del Settecento…, cit., pp. 223-230; V. CAPITANO, Gli interventi di Giuseppe Venanzio Marvuglia nelle preesistenze architettoniche, in Ivi,pp. 231-242; P. CASELLI, Uno scritto inedito di Giuseppe Venanzio Marvuglia, in Dal tardo barocco ai neostili. Il quadro europeo e le esperienze siciliane, atti dellagiornata di studio (Catania, 14 novembre 1997), a cura di G. Pagnano, Catania 2000, pp. 51-62.12 Il disegno è conservato tra le carte del Marvuglia presso l’archivio Palazzotto. L’attribuzione al Vanni, proposta dal Capitano, non è stata finoracontestata. Cfr. V. CAPITANO, Giuseppe Venanzio Marvuglia architetto ingegnere docente, 3 voll., Palermo 1984, I, p. 94. 13 Brani autografi di un trattato inedito di architettura civile di Giuseppe Venanzio Marvuglia con prefazione di Agostino Gallo, ms. della prima metà del XIXsec. della Biblioteca Comunale di Palermo (BCPa), ai segni Qq D 69, ff. 93r- 94r.14 Ivi, f. 95r-v.15 L.A. MURATORI, Della pubblica felicità, oggetto de’ buoni principi. Trattato di Ludovico Antonio Muratori…, Lucca 1749, p. 406. 16 Sui fatti si veda S. PIAZZA, Gli interventi di Fuga nei palazzi palermitani e il ruolo della committenza aristocratica nel dibattito architettonico coevo, inFerdinando Fuga 1699-1999 Roma, Napoli, Palermo, a cura di A. Gambardella, Napoli 2001, pp. 161-168. 17 Notice sur la vie et les ouvrages de M. Marvuglia…, 2 marzo 1805, pubblicata in V. CAPITANO, Giuseppe Venanzio Marvuglia…, cit., I, pp. 17-21; J.I.HITTORFF, L. ZANTH, Architecture moderne de la Sicile…, [Paris 1835] Palermo 1983, p. 50. La storia di palazzo Afflitto porta ad escludere un interventodel Fuga negli anni del suo primo soggiorno palermitano (1729). L’assenza di riscontri documentari rende infondata l’ipotesi di un coinvolgimentodell’architetto in occasione della sua successiva visita in città (1767) e improbabile una collaborazione con i tecnici palermitani negli anni in cui il can-tiere della cattedrale alimentava tra i due schieramenti una forte competizione. Sui fatti si veda: S. PIAZZA, Gli interventi di Ferdinando Fuga…, cit., p.165. 18 G. LEONE, Il collegio di Maria a Monreale…, cit., p. 76.19 Con particolare riferimento al “passetto volante” presente anche nei palazzi liguri Balbi-Senarega e Doria Tursi. Cfr. S. PIAZZA, Architettura e nobil-tà…, cit., pp. 40, 99. Quanto all’influenza della cultura piemontese: J. HITTORFF, L. ZANTH, Architecture moderne de la Sicile…, cit., p. 50. 20 J.B.C. LESUEUR, F. CALLET, Architecture italienne, ou Palais, maisons et autres édifices…, Paris 1827. Si considerino in particolare le analogie tra la tavo-la IX dell’Architecture italienne…, riferita al palazzo dell’Università di Torino e la figura XIV dell’Architecture moderne de la Sicile relativa al palermita-no palazzo Cattolica, assumibile come matrice prima dell’impianto a cortili e portici di palazzo Belmonte. 21 ASPa, Notai Defunti, not. Domenico Gaspare Sarcì e Papè, vol. 10379, cc. 684r- 700r.22 ASPa, Notai Defunti, not. Domenico Gaspare Sarcì e Papè, vol. 15702, cc. 112r-131v.23 I lavori di demolizione appresso elencati comportarono una spesa di oltre 1426 onze e sono riportati in ivi, cc. 132r-223r. 24 Ivi, c. 177. L’esame comparato delle fonti suggerisce che la quinta occidentale del primo cortile fosse preesistente e inglobata nella nuova fabbricadallo spiccato fino a un’altezza contenuta entro il primo livello. Proseguendo a nord, fino a delimitare da occidente la stanza detta “del guardapor-tone”, l’asse murario si interrompeva in prossimità delle botteghe sul Cassaro, dove il sistema modulare delle botteghe introduceva un nuovo passo.Cfr. infra pianta del Dufourny. Vincenzo Capitano rilevò nella stessa ala «tracce di vecchi affreschi del tardo Cinquecento o dei primi del Seicento neivuoti tra i rinfianchi delle volte di copertura del piano terra». V. CAPITANO, Giuseppe Venanzio Marvuglia…, cit., I, p. 92. 25 ASPa, Notai Defunti, not. Domenico Gaspare Sarcì e Papè, vol. 15731, cc. 464r-584r. 26 ASPa, Notai Defunti, not. Domenico Gaspare Sarcì e Papè, vol. 15702, cc. 132r-344r. 27 Forse parente di Francesco Coppolino, scultore di legno palermitano noto per i suoi interventi all’altare maggiore della chiesa madre di Alcamo.Su Francesco si veda F. PIPITONE, Coppolino Carlo, in L. SARULLO, Dizionario degli artisti siciliani, III, Scultura, a cura di B. Patera, Palermo 1994, ad vocem. 28 I dati sul cantiere appresso riportati, ove non diversamente specificato, sono tratti da ASPa, Notai Defunti, not. Giuseppe Sarcì e Papè, vol. 15702,cc. 113r, 222v-223r, 282r-285v, 329v-330r, 343r-350r; vol. 15709, cc. 414r-418v; vol. 15731, cc. 464r-584r. 29 Su Salvatore Attinelli si veda B. DE MARCO SPATA, Salvatore Attinelli, in L. SARULLO, Dizionario degli artisti siciliani, I, Architettura, cit., ad vocem. 30 Sulle volte tabicadas si veda M.M. BARES, Temi costruttivi: le crociere di Santa Maria del Gesù a Modica, in Francescanesimo e cultura negli Iblei, a cura diC. Miceli, C.D. Ciccarelli, Palermo 2006, pp. 15-18; M.M. BARES, M.R. NOBILE, Volte tabicadas nelle grandi isole del Mediterraneo: Sicilia e Sardegna (XV-XVIII secolo), in actas del simposio internacional sobre bóvedas tabicadas (Valencia, 26-28 mayo de 2011), a cura di A. Zaragozá Catalán, R. Marín,Valencia 2012, pp. 119-131.31 Le botteghe furono locate già a partire dal 1780. Relazione generale dell’annuo patrimonio…, ASPa, Archivio Belmonte, vol. 367, cc. nn.
52
32 ASPa, Notai Defunti, not. Giuseppe Sarcì e Papè, vol. 15702, c. 348. Già nel primo decennio del Settecento il monastero del Cancelliere si era oppo-sto alla sopraelevazione dell’ala del palazzo (ASPa, Archivio Belmonte, vol. 499, cc. nn.).33 ASPa, Notai Defunti, not. Giuseppe Sarcì e Papè, vol. 15702, c. 113r.34 Relazione generale dell’annuo patrimonio della casa…, cit.; ASPa, Notai Defunti, not. Giuseppe Sarcì e Papè, vol. 15707, cc. 355r-v. 35 V. CAPITANO, Giuseppe Venanzio Marvuglia…, cit., I , p. 92. Sulla stima del 1780: ASPa, Notai Defunti, not. Giuseppe Sarcì e Papè, vol. 15702, cc. 226r-344r.36 V. CAPITANO, Giuseppe Venanzio Marvuglia…, cit., I , p. 92.37 Un quadro sintetico dei lavori di finitura è in ASPa, Archivio Belmonte, vol. 1403, cc. 84r e sgg.38 Per la restituzione grafica ci siamo avvalsi delle descrizioni del 1833 (Relazione dell’arch. Arcangelo Lauria del 6 settembre 1833, in ASPa, ArchivioBelmonte, vol. 1762, fasc. 2, c. nn.) e del 1937 (Aurelio Mastrogiacomo, ingegnere capo del Comune di Palermo, Archivio Centrale dello Stato, Roma,Fondo Partito Nazionale Fascista, Carteggio delle Federazioni provinciali, Servizi vari, Serie II, busta 1258). I documenti grafici in nostro possesso – oltrea quelli noti di Hittorff (1824/1835), e Capitano (1984) – comprendono il rilievo di Dufourny (1791); la tavola di Cockerell (1812) conservata al RoyalInstitute of British Architects; le piante allegate alla relazione di Mastrogiacomo (1937); una pianta catastale del piano superiore degli anni Trenta delNovecento; le planimetrie del recente allestimento museale forniteci dalla direzione del Museo Riso. 39 Si veda V. PALAZZOTTO, Il rilievo nel ’700: Giuseppe Venanzio Marvuglia (1729-1814), Palermo 1990, pp. 5-6.40 S. CARDELLA, Il Palazzo Riso, in «Panormus», 11 giugno 1933, s.p.41 Questo rimando si ritrova in Ivi e in V. CAPITANO, Giuseppe Venanzio Marvuglia…, cit., p. 94.42 L. DUFOURNY, Notes rapportées d’un voyage en Sicile, BNF Paris, Cabinet des estampes, UB 236 – tomo VI – Il f. 125.631 costituisce l’intestazione deidisegni contenuti nelle due pagine successive e contiene la seguente dicitura: «Palais de Belmonte, fait en 1776 environ sur les dessins du Prince SanVincenzo aidé du Cav. Fuga […] dirigée par Marvuglia qui a fait aussi les dedans». I fogli successivi – 125.632 e 125.633 – contengono rispettivamentela pianta del piano terra e la sezione longitudinale (disegni in situ, non contenenti indicazioni al margine). Nella raccolta intitolata Topographie del’Italie, sono contenuti invece i disegni in scala, rispettivamente ai ff. 65.403 (Plan du Palais de Belmonte) e 65.404 (Elévation et coupe du PalaisBelmonte). I grafici, che non contengono alcuna datazione, sono stati eseguiti durante il soggiorno palermitano di Dufourny, tra il 1788 e il 1792. Laconsultazione del fondo Dufourny è oggi possibile solo in versione microfilmata. Per tutte le informazioni generali circa i formati, le tecniche di ese-cuzione, le copie a opera dei collaboratori di Dufourny si veda G. PAGNANO, I disegni di Dufourny alla Bibliothèque Nationale di Parigi, in «Il Disegno diarchitettura», 2, 1990, pp. 13-16.43 Come rovescio della medaglia, però, queste correzioni portano Dufourny ad incorrere in errore quando, in sezione, rappresenta i corpi di fabbricainterni più alti del corpo principale sul Cassaro. 44 V. CAPITANO, Giuseppe Venanzio Marvuglia…, cit., I, p. 92. L’autore passa in rassegna le tesi sostenute dagli studi sul Marvuglia di Bozzo (1851),Caronia Roberti (1935) e Comandé (1958). 45 S. CARDELLA, Il Palazzo Riso…, cit, 1933, s.p.46 Questo dispositivo scenografico sopperiva forse anche alla impossibilità di aprire vedute in direzione nord, considerato che – in ragione dell’accen-tuato dislivello del terreno – il piano terra della fabbrica era completamente interrato. Tra l’attuale via Vittorio Emanuele (via Toledo) e la piazza delGran Cancelliere vi è un salto di quota di circa sette metri. 47 C.R. COCKERELL, Palace of the Prince of Belmonte in the via Toledo, Palermo 1812 (London, Royal Institute of British Architects, Library DrawingsCollection, Ref No RIBA 67133).48 J.I. HITTORFF, Architecture moderne…, cit., tav. 54. Si veda F. SCADUTO, S. PIAZZA, Dal cortile allo scalone: gli spazi della celebrazione nei palazzi nobiliari diPalermo, in L’uso dello spazio…, cit., pp. 563-577, p. 565. 49 Le numerose “correzioni” introdotte dall’architetto franco-tedesco per illustrare i monumenti della Sicile moderne risentono del formalismo beaux-arts, foriero dell’incalzante eclettismo del XIX secolo, e spesso sono state fuorvianti per una corretta lettura degli edifici da lui rappresentati. Moltopiù attento alla realtà dei luoghi appare il rilievo di palazzo Belmonte che Dufourny aveva eseguito una trentina di anni prima. 50 Si veda M. ELEB-VIDAL, A. DEBARRE-BLANCHARD, Architectures de la vie privée, XVIIe-XIXe siècles, Bruxelles 1989.51 Relazione dell’arch. Arcangelo Lauria, cit., s.p.52 Ivi.53 C.R. COCKERELL, Palace of the Prince…, cit.