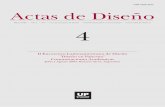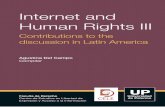L'urna di S. Rosalia come paradigma della storia di Palermo
-
Upload
universitaeuropeadiroma -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of L'urna di S. Rosalia come paradigma della storia di Palermo
Ciro Lomonte
L’urna argentea di S. Rosalia,
paradigma della storia di Palermo
Antoon Van Dyck, Santa Rosalia,
Palazzo Abatellis, Galleria Interdisciplinare Regionale della Sicilia, Palermo
Chiunque si occupi di arte – come studioso o come homo faber – sa bene che i capolavori non
nascono per caso. Ci sono contesti sociali, sistemi di valori, squadre di talenti (nei vari settori del
mondo del lavoro), che consentono la gestazione e l’irrompere nella storia dell’umanità di un’opera
magistrale. C’è inoltre un terreno propizio in cui coltivare le doti dei singoli componenti del gruppo
di lavoro, perché l’arte è una virtù dell’intelletto pratico che richiede apprendistato presso maestri
capaci ed esercizio prolungato; matura con l’ampliarsi e l’approfondirsi della perizia ideativa ed
esecutiva; si evolve man mano che si approssima con strumenti migliori alla conquista dello
splendore della bellezza, soprattutto quando questa è cercata nella mimesi della natura o dell’essere
umano.
Sono aspetti che vanno trasmessi con cura ai giovani che scelgono l’arte come campo
privilegiato dei propri studi, come nel caso degli allievi del Master di II livello in Storia e
Tecnologie dell’Oreficeria, giunto alla felice conclusione della seconda e – per il momento – ultima
edizione. Troppo spesso si guarda erroneamente ai capolavori del passato come se fossero frutto di
un singolo genio, che – in quanto tale – non potrebbe non essere in anticipo rispetto alle concezioni
dei suoi contemporanei ed in atteggiamento trasgressivo nei confronti delle loro regole. Molto
spesso invece l’artista del passato era un umile e sapiente esecutore delle richieste dei clienti, che si
sforzava di assecondare al meglio, anche perché erano loro a fornirgli le idee da trasformare
egregiamente in opere idonee allo scopo.
Esaminare a tutto tondo un’opera d’arte, con l’aiuto di tutte le discipline oggi coinvolte,
permette di penetrare in un mondo più o meno lontano dall’osservatore e di trarne suggerimenti per
l’arte contemporanea, al di là dei luoghi comuni imperanti.
L’ombra di una capitale
Secondo i dati ISTAT, con i suoi 650.000 abitanti, Palermo è ancora il quinto comune italiano
per popolazione, dopo Roma, Milano, Napoli e Torino. L’area metropolitana, che comprende 26
comuni oltre il capoluogo siciliano, supera il milione di abitanti.
La Palermo odierna – imbruttita e congestionata – non è certo paragonabile alla meravigliosa
capitale del Regno di Sicilia che ammaliava quei numerosi viaggiatori che la visitarono tra il XII e
il XIX secolo. Ne conserva le vestigia, soffocate da uno sviluppo urbanistico deprecabile, benché
frutto di pianificazioni succedutesi nell’arco di quasi cento anni – tra il 1866 e il 1962 – e non certo
di abusivismo. Pianificazioni promosse e realizzate da amministratori e progettisti sovente non
palermitani.
Pianta di Palermo di Gaetano Lossieux (1818).
Ma esistono ancora i palermitani? Sembrerebbe di no, per le ragioni che tenteremo di
spiegare. La città è cresciuta rapidamente dopo l’istituzione della Regione Siciliana, passando dai
380.000 abitanti censiti nel 1931 ai 700.000 del 1981. Il tipo di urbanesimo che si è verificato nella
città è stato caratterizzato da un’immigrazione prevalentemente siciliana, dalle campagne verso il
capoluogo, contestualmente all’emigrazione dei giovani più istruiti verso l’Italia settentrionale e
altre nazioni. Emigrazione che continua ai nostri giorni.
Ciò ha comportato una sostanziale diversità rispetto alle altre grandi città italiane. Gli
immigrati non hanno trovato sul posto un nucleo di cittadini che trasmettessero loro l’orgoglio di
un’identità forte. I nuovi arrivati, specie dopo la concessione dell’Autonomia Siciliana con lo
Statuto del 1946 e la conseguente crescita smisurata dell’impiego nel settore terziario, hanno
costituito una comunità priva di carattere proprio. Ne è derivato un meticciato anomalo, che si è
riflesso nella quasi assoluta indifferenza di fronte al cosiddetto “sacco di Palermo”, vale a dire la
speculazione edilizia che – con l’avallo del Piano Regolatore del 1962, il primo in Italia ai sensi
della Legge Urbanistica Nazionale del 1942 – ha sfigurato impietosamente la Conca d’Oro, la
bellissima piana sul mare, circondata da una corona di alture boscose, coltivata prevalentemente ad
agrumi, gli alberi dai pomi d’oro come quello custodito nel Giardino delle Esperidi.
Non è che le periferie costruite negli ultimi settant’anni a Roma, Milano, Napoli e Torino
siano capolavori di architettura. Però almeno esistono i romani, i milanesi, i napoletani, i torinesi,
con lingua, letteratura e tradizioni proprie, che sono state assimilate dagli immigrati e che
costituiscono una base valida per la rivendicazione di un decoro urbano espressione del genius loci.
Su queste basi andrebbero programmati accurati interventi di rigenerazione urbana, prima che tutte
le grandi città italiane accettino di essere omologate alle anonime metropoli tipiche dei Paesi
emergenti, con grattacieli eco-insostenibili e vialoni per il solo traffico veicolare.
Un ruolo importante per la nascita di una consapevolezza nuova negli abitanti della città lo
hanno avuto le pianificazioni recenti relative al centro storico di Palermo, diviso in quattro
“mandamenti” dalla croce viaria del Cassaro e di via Maqueda. Secondo alcune stime, con i suoi
250 ettari, si tratta del centro storico omogeneo più grande d’Europa. Nel 1983 è stato elaborato il
Piano Programma, che forniva i criteri di base per progettare piani particolareggiati sui “contesti”
storici, aree fortemente connotate dal punto di vista morfologico, di circa 20 ettari l’una.
Abbandonata questa filosofia di intervento, nel 1993 è stato redatto il Piano Particolareggiato
“Esecutivo”, quello che ancora governa il recupero degli edifici del quadrilatero preottocentesco
con precisa valenza normativa.
Palermo, ponte dell’Ammiraglio (1113). Fino al 1938 consentiva di superare il fiume Oreto.
Al di là delle valutazioni sui due Piani, il dato importante è che essi hanno contribuito
significativamente alla scoperta dell’antica capitale da parte di cittadini avvezzi solo al brutto
architettonico. Ciò ha segnato una tappa importante nella crescita dell’interesse per la storia di
Palermo, nell’amore per i gioielli artistici creati nei secoli precedenti e nello sviluppo graduale di
un’identità cittadina condivisa da tutti.
I nuovi palermitani reclamano con
insistenza una qualità della vita che non
c’è. Il disegno del territorio non è
ininfluente sulla vivibilità e
sull’erogazione di servizi di una città.
Palermo ha urgente bisogno di un nuovo
Piano Regolatore coraggioso. L’edilizia
costruita negli ultimi decenni è quasi
tutta di scarsa durata, da un punto di vista
strutturale, perché il cemento armato non
è eterno. Andrà quindi sostituita, presto o
tardi. Gli amministratori cittadini
dovrebbero approfittarne per promuovere
una rigenerazione urbana che cancelli
nella misura del possibile gli errori fatti
dal 1860 ad oggi e utilizzi le potenzialità
della città antica e della sua rete di rela-
Palermo, S. Giovanni dei Lebbrosi.
zioni con il territorio circostante per dare un nuovo volto, bello e funzionale, alla città intera,
superando la dialettica centro-periferia.
Il cielo su Palermo è sempre di una bellezza che lascia attoniti. È la terra che è stata
martoriata. L’ascrizione di alcuni luoghi storici della città fra i Patrimoni dell’Umanità UNESCO
sotto la denominazione del sito “Cattedrali e chiese Siculo-Normanne di Palermo, Monreale e
Cefalù”, potrebbe favorire l’incremento dei flussi turistici migliori. Ma i turisti verranno più
volentieri e in numeri maggiori se troveranno una città ben curata.
Il Teatro del Sole
Un evento non trascurabile nella creazione di una rinnovata identità palermitana, estesa a tutta
la cittadinanza, è il cosiddetto “Festino”. In passato i palermitani usavano diminuitivi più o meno
ironici per designare fatti eclatanti. Così la manciatina era in realtà un’abbuffata, la fuitina una
tragedia familiare, l’ammazzatina una strage, ... Mentre ‘u Fistinu era la festa principale della città,
quella per ‘a Santuzza, la patrona principale.
La manifestazione nasce nel 1625 per celebrare il ritrovamento su Monte Pellegrino delle ossa
di S. Rosalia il 15 luglio 1624. I frammenti dello scheletro, riconosciuti come reliquie della santa
eremita di famiglia normanna da una commissione istituita dal Card. Giannettino Doria,
arcivescovo genovese estremamente ligio alle norme canoniche nell’esame dell’autenticità delle
reliquie, vengono portate in processione e contribuiscono alla scomparsa della peste dalla città.
Negli anni successivi la festa assume proporzioni grandiose. Forse sarebbe meglio dire le
feste, perché erano due, in parallelo: una celebrazione era a carico della gerarchia ecclesiastica,
l’altra era organizzata dal Senato di Palermo (l’amministrazione civica di allora).
Il culmine della festa religiosa era costituito dalla processione dell’arca d’argento nella quale
vennero custoditi i resti venerati dello scheletro. L’apice di quella civica si toccava con la sfilata del
Carro di S. Rosalia, a forma di galeone, ed allo spettacolo di fuochi pirotecnici che veniva
rappresentato alla Marina, di fronte alle mura della Città. La sceneggiatura era a carico di un
letterato palermitano che il Senato incaricava sulla base dell’autorevolezza acquisita, diverso ogni
anno. Non si trattava quindi di una semplice esibizione di botti colorati, con “masculiata” finale. Si
costruiva un’apposita scenografia, con fortini, vulcani e tutto quello che avesse a che fare con la
vicenda che si sceglieva di raccontare di volta in volta al popolo entusiasta. I botti facevano parte
della storia.
Si tenga conto che il rinvenimento prodigioso delle spoglie della Santa avviene in un periodo
in cui la città è già da tempo un vivacissimo cantiere che la trasforma in una magniloquente
successione di quinte urbane, il cosiddetto Teatro del Sole1. Nel Quattrocento, sotto la dominazione
aragonese, Palermo si era ammodernata, dotandosi di edifici e luoghi rappresentativi delle autorità
civili e religiose. Dopo il 1535, anno dell’ingresso di Carlo V nella capitale del Regno di Sicilia, il
programma di trasformazione della città riceve un impulso rinnovato, all’insegna delle manie di
grandezza della nobiltà siciliana che edificava i propri palazzi nella sede del riaperto Parlamento.
I Viceré obbediscono alla strategia della Corona spagnola, soprattutto dopo l’unificazione
conclusa da los Reyes Catolicos nel 1492, l’anno della presa di Granada, ultima piazzaforte islamica
nella penisola iberica, e della scoperta dell’America2. L’abbellimento di Palazzi Reali e la
sistemazione degli assi viari risponde all’immagine che si vuole dare del governo dell’Impero,
rispettoso delle identità locali e allo stesso tempo orgoglioso dei propri principi politici, identici,
applicati da un capo all’altro del globo terrestre.
Il Cantone meridionale, quello della Primavera, di Carlo V e di Santa Cristina.
Il Cantone occidentale, quello dell’Estate, di Filippo II e di Santa Ninfa.
Sul finire del XVI secolo il governo spagnolo decide di creare un nuovo asse viario che
incroci l’antica plateia che tagliava in due – dalle origini – la città fenicia, fondata intorno all’VIII
secolo a.C., per dare un maggiore sfogo alle pressanti richieste degli aristocratici di nuove aree per
1 MARCELLO FAGIOLO, MARIA LUISA MADONNA, Il Teatro del Sole. La rifondazione di Palermo nel Cinquecento e
l’idea della città barocca, Officina Edizioni, Roma 1981. 2 JOAN LLUÍS PALOS PEÑARROYA, La mirada italiana. Un relato visual del imperio español en la corte de sus virreyes
en Nápoles, València, PUV, 2010. L’autore, un professore catalano di Storia Moderna presso l’Universitat de
Barcelona, ha avviato negli ultimi anni delle ricerche negli archivi di Palermo sull’attività dei Viceré.
la costruzione dei loro palazzi ed allo stesso tempo rendere più scorrevole la circolazione all’interno
della città. Tale strada, progettata nel 1577 e completata nel 1599, prende il nome da colui che ne
decide il tracciamento, Bernardino de Cárdenas y Portugal, duca di Maqueda, viceré dal 1598 al
1601.
L’incrocio tra le due strade diviene il pretesto per una grandiosa macchina scenografica: i
Quattro Canti (detti anche piazza Vigliena, Ottagono del Sole o Teatro del Sole). Il nome proprio è
piazza Vigliena, in omaggio al viceré don Juan Fernández Pacheco, marchese di Villena e duca di
Ascalón. Le fonti antiche la ricordano come Ottangolo o Teatro del Sole perché durante le ore del
giorno almeno una delle quinte architettoniche è illuminata dal sole. Sulle terre dell’Impero
spagnolo il sole non tramontava mai. Questa affermazione è tradizionalmente attribuita a Carlo V
d’Asburgo (I di Spagna) che ebbe un ruolo fondamentale agli occhi della nobiltà siciliana, a cui
concesse larghi privilegi in cambio di fedeltà alla Corona spagnola. Non a caso la monumentale
Porta Nuova venne eretta, al posto della precedente, per ricordare il suo ingresso a Palermo. Non a
caso inoltre la prima statua dei Quattro Canti è quella di Carlo V in abiti da imperatore romano,
ritratto nell’atto di giurare fedeltà ai patti stipulati con gli aristocratici locali3.
Il Cantone settentrionale, quello dell’Autunno, di Filippo III e di Sant’Oliva.
Il Cantone orientale, quello dell’Inverno, di Filippo IV e di Sant’Agata.
Il progetto di piazza Vigliena era ispirato al crocevia delle Quattro Fontane di Roma,
realizzato da papa Sisto V in forme molto più dimesse della successiva versione palermitana. La
piazza di Roma era parte integrante di un’espansione cinquecentesca, quella palermitana è invece il
centro geometrico e simbolico dell’intera città barocca.
I Quattro Canti propriamente detti sono i quattro prospetti scultoreo-architettonici, quasi
retablos concavi a scala urbana, che delimitano lo spazio dell’incrocio. Realizzate tra il 1609 e il
1620, le quattro facciate presentano un’articolazione su più livelli, con una decorazione basata
3 La prima versione in bronzo, quella di Scipione Li Volsi, non piacque al Senato, che la collocò a piazza Bologni.
sull’uso degli ordini architettonici e di inserimenti figurativi che, dal basso verso l’alto, si
susseguono secondo un principio di ascensione dal mondo della natura a quello del cielo4. Ogni
prospetto corrisponde ad uno dei Mandamenti, i distretti amministrativi in cui viene divisa la città
dopo il taglio di via Maqueda: Palazzo Reale, Monte di Pietà, Castellammare, Tribunali.
Nelle feste principali, la piazza veniva addobbata con arconi di cartapesta appositamente
disegnati dagli architetti del Senato e realizzati da uno stuolo di artigiani, trasformandosi in un
ottagono o un cilindro decoratissimo, un vero e proprio teatro a cielo aperto. Ricorda il Globe
Theater di Londra, anche se i posti per il pubblico – eccetto alcune finestre e balconi – si trovano
per strada e non sul perimetro costruito. Le processioni partivano dalla Cattedrale percorrendo la
croce viaria fortemente simbolica e facendo tappa più volte nel cuore della scenografia urbana, nel
quale il sole, la luna e le stelle erano protagonisti.
Gli argentieri al lavoro
Per le notizie sulla cassa reliquiario di Santa Rosalia riproponiamo quasi integralmente in
questo paragrafo il fondamentale saggio di MARIA CONCETTA DI NATALE, L’arca d’argento5. In
qualche punto abbiamo adattato il testo agli scopi delle nostre riflessioni.
Il 15 luglio 1624 si verifica l’invenzione delle sacre ossa di Santa Rosalia all’interno di una
grotta di Monte Pellegrino. Il 15 agosto 1624 il Senato di Palermo assume la Santa come
protettrice. Il 22 febbraio del 1625 si ha il riconoscimento ufficiale dei resti della patrona di
Palermo, mentre l’epidemia di peste andava scemando. Le reliquie, già esaminate dai medici dal
15 al 18 febbraio, per volere dell’Arcivescovo Giannettino Doria, furono poste in un cofano
rivestito di velluto cremisino e poi in una cassa di tela d’argento e trasferite dal palazzo
Arcivescovile alla Cattedrale.
Il 3 marzo 1625 il Senato di Palermo commissiona
un’arca argenti et cristalli, la prima cassa Gloriosae
Sanctae Rosaliae. La base lignea è dovuta ai maestri
intagliatori Apollonio Mancuso e Nicolò Viviano, la parte
in cristallo ai maestri Desiderio Pillitteri e Giovanni Di
Pietro, quella d’argento a maestro Francesco Liceo. La
cassa viene stimata nel 1627 dai consoli della maestranza
degli orafi e argentieri di Palermo, Giovanni Pietro
Tigano e Girolamo Timpanaro, e dai consiglieri Paolo di
Florio e Vincenzo Bruno e contiene le reliquie della Santa
fino a quando, trasferite queste nella nuova arca realizzata
nel 1631, non vi fu inserito in sostituzione il braccio di
Sant’Agata. Santa Rosalia, in quest’urna, che giunge
rimaneggiata attraverso i secoli, era caratterizzata oltre
che dalle rose, suo principale attributo iconografico, dal
giglio, che teneva già in mano, simbolo di purezza da un
lato e parte integrante del suo nome dall’altro, Rosa-
lilium.
Questa prima arca è conservata nella cappella delle
reliquie della Cattedrale, ove viene indicata come cassa L’urna di Santa Rosalia del 1625.
4 Il “retablo” (in italiano cona o ancona) è una macchina teatrale posta nell’abside delle chiese, dietro l’altare maggiore,
a prefigurare la Gerusalemme Celeste. L’architettura della facciata, specie nelle cattedrali spagnole dal Cinquecento al
Settecento, contiene numerose statue, bassorilievi e decorazioni, eloquenti nella loro capacità evocativa delle storie
narrate. A Palermo l’intera abside della Cattedrale – non solo il fondo, anche le pareti laterali –viene rivestita in tal
modo da Antonello Gagini e dai suoi aiuti, con la grandiosa “Tribuna” smantellata alla fine del XVIII secolo. 5 Si trova in MARIA CONCETTA DI NATALE, S. Rosaliae patriae servatrici, con contributi di Maurizio Vitella, fotografie
di Enzo Brai, Cattedrale, Palermo 1994.
reliquiaria di Sant’Agata, essendo stata appunto adibita a contenerne il braccio. Questa, troppo
semplice per il nuovo gusto, ormai tendente al barocco, viene sostituita con l’altra ben più ricca.
Le reliquie di Santa Rosalia sono poste dunque in una prima cassetta nel 1624, nell’urna di
cristallo e argento nel 1625 e nel monumentale reliquiario a sarcofago d’argento nel 1631,
disegnato da Mariano Smiriglio.
La nuova vara (un fercolo processionale che contiene i resti mortali della Santa e non solo la
sua effige) è una cassa con relativo coperchio, compositivamente simmetrica, secondo analoghi
schemi del periodo. Si può idealmente suddividere in tre parti sovrapposte con figurazioni e ornati
diversi: il supporto di base, il corpo centrale e la copertura apicale. La prima è costituita da una
massiccia e geometrica pedana di sostegno, su cui è al centro il fusto che regge l’intera opera,
mentre agli angoli sono ignudi quattro putti alati in piedi a tutto tondo. Sembra che il carico
dell’arca graviti sul loro capo. Con una mano equilibrano il peso e con l’altra tengono uno scudo,
nel cui campo è cesellata una rosa, tipico simbolo di Santa Rosalia.
Ai due fianchi della base stanno due aquile coronate ad ali spiegate, simbolo del Senato di
Palermo, poggianti su due tabelle a mo’ di cartagloria nel cui vano sono incisi i motivi e i
committenti dell’opera.
Tra le zampe dei due maestosi volatili è una valva della conchiglia di pellegrino, che allude
ad una delle più note caratteristiche della Santa.
La conchiglia, talora posta a mo’ di borchia sul mantello dei fedeli che si recavano nel
Santuario di San Giacomo a Santiago di Campostella, diviene generico simbolo del pellegrino. Non
è casuale che venga attribuita proprio a Mariano Smiriglio parte della costruzione dell’ospedale di
San Giacomo di Palermo, portata avanti nel 1621 per volontà del viceré Conte di Castro, che reca
sulla facciata le simboliche conchiglie riferentisi a quel Santo.
L’attuale urna di Santa Rosalia, 1631.
La parte centrale della ricca macchina processionale, che costituisce il corpo principale
dell’intera architettura, pur nell’uniforme e scandito riproporsi dei singoli elementi nei quattro lati,
mostra una vivacità armonica e coinvolgente, che non finisce di stupire l’osservatore. In ognuna
delle quattro facce è un quadro sfondato prospetticamente, analogo a esemplari marmorei di
produzione gaginesca (i cosidetti “teatrini”) in cui si svolgono scene della vita della Santa,
contenente anche elementi a tutto tondo e retto da due angioletti seduti sulla balza inferiore. Non si
deve dimenticare che l’abside della Cattedrale di Palermo era a quell’epoca ancora ornata dalla
maestosa tribuna marmorea di Antonello Gagini e dei suoi aiuti, che presentava numerose scene
inserite in riquadri dalla stessa tipologia.
Se però tale composizione è sufficiente a riempire i lati più corti, in quelli più lunghi è stato
necessario porre ai lati della scena centrale due grandi riquadri lavorati a sbalzo con stilizzati
elementi floreali. Il disegno di questi pannelli della balza inferiore, con maggior evidenza di quella
superiore, immediatamente rimanda a coeve opere in corallo e rame dorato con motivi a baccelli
del tutto analoghi, in linea con le diffuse tendenze del primo Seicento, preludio al florido Barocco,
che proprio in Sicilia ha avuto in settori vitali come quelli dell’argenteria, dell’oreficeria e del
corallo uno dei momenti più felici e prolifici, esprimendosi con peculiarità materiali e formali di
notevole rilievo. La balza superiore presenta oggi agli angoli l’inserimento di quattro elementi
cerofori pure in argento, aggiunti di recente.
La parte superiore è costituita da un basamento quadrangolare nelle cui facce laterali sono
quattro scene della vita di Santa Rosalia e altre due in quella frontale e in quella posteriore. Negli
spazi tra l’una e l’altra scena sono testine di cherubini alate. La parte culminante ha un andamento
più decisamente longitudinale. In alto è l’immagine della Santa in abiti di monaca basiliana con la
croce patriarcale nella mano sinistra e la tipica corona di rose sul capo, nell’atto di schiacciare un
drago. Si ripete ancora una volta la simbolica lotta del bene e del male, della Santa Vergine contro
le forze negative che ricorda non a caso quella analoga di Maria con il serpente, e
dell’immancabile vittoria per l’intercessione divina, in questo caso verisimilmente di Rosalia,
pellegrina palermitana, sulla peste che attanagliava la città.
Gli abiti basiliani indossati dalla Santa fanno
riferimento alla sua presunta presenza, come poi
tramanderà Antonino Mongitore, quale “Monaca
Basiliana nel Monastero del Salvatore”, poiché “un fabro
muratore vi trovò una bissoletta... con un pezzo di legno
creduto della croce del Signore e un pezzo di carta scritta
con greca iscrizione”, che venne tradotta dal P. Giordano
Giustiniani della Compagnia di Gesù, che pensava fosse
stata scritta da Santa Rosalia.
L’iscrizione riportata in latino e greco in una lapide della
chiesa del SS. Salvatore è la seguente: Ego Soror Rosalia
Sinibaldi pono hoc Lignum Domini mei in hoc Monasterio
quod semper secuta sum6. Non a caso Giordano Cascini,
partecipe testimone oculare della ricognizione sulle ossa e
autorevole padre gesuita, ripropone un’incisione con
Santa Rosalia in abiti basiliani, già presente nella tavola
con Sant’Elia e le Sante Oliva e Venera, proveniente dalla
Martorana al Museo Diocesano di Palermo, e in quello
già della Chiesa del Gesù a Casa Professa, di cui rimane
una copia più tarda7.
Immagine di Santa Rosalia alla sommità dell’urna.
Cascini fornisce una particolareggiata descrizione di tutte le parti della vara: «In quest’arca
dunque primieramente si vede la vita di S. Rosalia ripartita in diece luoghi, parte espressa colle
statue massiccie, e parte scolpita di alto rilievo, che vien’iui dichiarata con breui motti»8. Il padre
gesuita illustra il suo volume del 1651, con incisioni tratte da opere che forniscono l’ispirazione
6 Io, Suor Rosalia Sinibaldi, pongo questo Legno del mio Signore in questo Monastero, alla sequela del quale sono
sempre stata [NdA]. 7 Recenti restauri e ricerche d’archivio fanno dubitare che la tavola suddetta contenesse originariamente l’immagine di
Santa Rosalia: l’appartenenza della vergine eremita all’ordine basiliano potrebbe risultare quindi artefatta [NdA]. 8 GIORDANO CASCINI, Di S. Rosalia Vergine palermitana Libri tré, Palermo 1651, p. 336. Il Cascini riporta tutte le
scritte che accompagnano le storie della vita della Santa nella vara.
iconografica o che comunque rimandano, più o meno puntualmente, alle scene della vita della
Santa raffigurate nella vara, per le quali è lecito argomentare un suo significativo contributo alla
nuova formulazione iconografica.
Si avrà così una particolare tematica sia pittorica sia scultorea, che per secoli rielaborerà
variamente queste storiette, arricchendo il corpus delle immagini relative alla Santa dopo il 1624.
È particolarmente significativo che già in occasione della processione del 9 luglio 1625 analoghe
storie della vita di Santa Rosalia, divise in sei quadri, venissero raffigurate nell’arco trionfale della
Nazione Fiorentina, come si rileva dalla descrizione di Onofrio Paruta, figlio di Filippo.
«Nel primo luogo, che contiene la
vocatione di S. Rosalia al romitorio, doue la
Madre di Dio, e il fanciullo Giesù, la inuiano
ben accompagnata dagl’Angeli v’ha questo
breue Solitariae vitae consilium Dei Parens ac
Puellulus volentes propitij caelesti sospitant
comitatu». La scena squadrata e statica,
nell’ideazione di tipologia gaginiana, è secondo
usi già collaudati, ambientata in un interno
dove, sorretto da angeli, compare al centro un
baldacchino a mo’ di edicola votiva con Maria
dal capo nimbato, nel cavo di una simbolica
conchiglia, che sostiene il Bambino
benedicente.
Vocazione di Santa Rosalia.
A sinistra è un grande angelo in armatura, mentre quello di destra, come si evince dai due
buchi sullo sfondo è mancante. Lo si può peraltro vedere ben delineato nell’incisione della vara del
testo del 1748 di Joannes Stiltingus, anche lui non certo casualmente theologo gesuita. Il pavimento
mattonato e il soffitto a cassoni lignei segnano un andamento prospettico che consente ai lati la
compilazione di due simmetriche aperture ad arco oltre le quali si vede un paesaggio alberato.
L’iconografia e l’impostazione della scena sono tratti dal dipinto raffigurante l’Incoronazione di
Santa Rosalia di Riccardo Quartararo di Palazzo Abatellis, già nella cappella di Santa Rosalia
all’Olivella di Palermo, di cui il Cascini riporta l’incisione.
«Nel secondo – continua Cascini – vi è la sua entrata nella grotta di Quisquina, dou’ella
intaglia la sua impresa nella rocca facendo intanto fuggire i maligni spiriti v’ha quest’altro
Quisquinae Specus ingressa summam consilij sui saxo insculpsit bello stygijs hostibus indicto».
L’andamento ovolare delle rocce dell’antro della Quisquina, in cui sulla sinistra scompostamente
svolazzanti s’agitano scacciati diavoli, contrasta con le due figure centrali, imponenti e salde nella
fede che impersonano. A sinistra l’angelo che allontana le forze del male e a destra Rosalia con
sasso e scalpello che ha appena terminato di scolpire sulla roccia la nota scritta Ego Rosalia
Sinibaldi Quisquilie et rosarum domini filia amore D(omi)ni mei lesa Cristi in hoc antro habitari
decrevi. I due buchi nell’angolo superiore a destra lascerebbero presupporre la presenza
verosimile di un angioletto. La scacciata del maligno tentatore in volontario isolamento è il
momento che figurativamente traduce l’inizio del viaggio di salvezza spirituale attraverso la
mortificazione e l’allontanamento dalle pulsioni terrene, che trova un nobile precedente
nell’episodio di Cristo tentato nel deserto (Luca 4,1-13).
«Nel terzo sono i vicendevoli offitij degl’Angeli tra ‘l Signore e lei, mentre ora, manda, e
riceue presenti di fiori, e si dice così Preces Deo, rosarum instar, in calathis mittit; Angelorum
obsequia, et munera florum refert». Le tre figure centrali scandiscono lo spazio dando forme e
contenuti diversi alla scena. Dall’alto di una volta inesistente tra nugoli di testine di cherubini
alate che fanno capolino dalle nubi, una indefinita presenza ultraterrena invia raggi lanceolati
nello scomparto inferiore, dove due angeli mediano l’offerta vicendevole dei fiori alla Santa, la cui
compostezza delle vesti e dei capelli, in contrasto con il turbinio del panneggio e la vivace e ariosa
capigliatura di quelli, ne esalta la centralità scenica e spirituale. L’iconografia e l’impostazione di
questa scena sono tratte dal dipinto di Riccardo Quartararo, già nel soffitto della chiesa di Santa
Caterina all’Olivella, riproposto in un’incisione nel volume del Cascini.
Santa Rosalia alla Quisquina. Santa Rosalia servita dagli angeli.
«Nel quarto, dou’ella vien coronata dal fanciullo Giesù ch’è in seno della Verg(ine) Madre,
co’(n) assistenza degli Angeli, dei Sa(n)ti Apostoli Pietro, e Paolo, e delle quattro Vergini Padrone
di Palermo, vi so(no) queste parole. Aureas floreasq(ue); corollas a Diurno infantulo capit fauent
caeli proceres, et Virgines Panormi Praesides. Queste quattro historie sono nelle fronti, e in su i lati
dell’Arca». Questa quarta scena ricalca ideativamente la prima per l’interno pavimentato e il
soffitto a cassoni, che permettono la fuga prospettica, l’angelo all’angolo (stavolta a destra), gli
sfondati arcuati nelle pareti laterali, ma si risolve in una maggior vivacità nel gruppo composito di
sinistra.
Da una matrice aerea di nuvole emergono
angeli che suonano strumenti a fiato e Maria
che sorregge e amorevolmente con la mano
invita il Figliuolo a incoronare di fiori la Santa,
dalla cui veste fuoriesce un cinto nodoso che
allude alla sua “francescana” umiltà. Un
grosso buco in basso a destra potrebbe essere
quel che resta degli altri personaggi ricordati
dal Cascini. I Santi Pietro e Paolo erano
presenti nel dipinto raffigurante
l’Incoronazione di Santa Rosalia di Tommaso
de Vigilia del 1494, già nella chiesa di Santa
Rosalia di Bivona, riproposto in una incisione
del volume del Cascini, caratterizzata tuttavia
da un’impostazione diversa rispetto a quella
della formella d’argento della vara.
Santa Rosalia incoronata da Gesù Bambino.
«Altre sei sono scolpite sopra nel couerchio rileuato cioè. La prima, come è richiamata dagli
Angeli dalla grotta di Quisquina, a quella d’Ercta, o Pellegrino; le parole son queste E Quisquinensi
spelunca ad Erctensem ab Angelis euocatur». La traduzione grafica dell’artista, di grande
immediatezza e aderente alla realtà, trova corrispondenza nella rispettiva incisione del testo del
Cascini. L’angelo quasi trae dalla grotta della Quisquina la Santa eremita e indica la nuova
destinazione. Rosalia si piega nell’uscire dall’antro, forse non tanto per un atteggiamento
rispettoso, quanto perché in effetti il suo ristretto orifìcio obbliga a tale esercizio. Sul Pellegrino è
un altro angelo pronto ad accoglierla, suggellando la volontà superiore che la spinge al
trasferimento. Anche qui va notato sullo sfondo del mare un sole radioso e sicuramente emergente,
perché tale deve essere, trovandosi alla destra del monte in quella fase, simboleggiando anche
l’inizio di un nuovo percorso di fede e devozione per Palermo.
Santa Rosalia esce dalla Quisquina. Santa Rosalia si trasferisce sul Pellegrino.
«La seconda come colla guida dei medesimi Angeli ritorna di là in Palermo, e al monte; si
esplica così Panormum regreditur in Erctae montem secessura». Anche qui la presenza degli angeli
è di conforto per la Santa, che nella costante presenza di essi può ravvisare la certezza della
volontà divina nelle sue scelte. Quello di sinistra indica il nuovo monte e con l’altra mano sostiene
il bastone cui la pellegrina si appoggia. Questa in abiti basiliani regge un Crocifisso. Un libro e
una corona sono in mano all’altro angelo, che la segue. L’iconografia e l’impostazione della scena
rimandano a un bassorilievo già esistente in Bivona e riproposto in un’incisione del volume del
Cascini. Altra simile iconografia presenta il dipinto raffigurante Santa Rosalia pellegrina della
Chiesa dell’Annunziata di Caccamo, attribuito a Vincenzo La Barbera, che reca la precoce data
1624. Anche qui la Santa, in abiti monacali, con in una mano il rosario e nell’altra il Crocifisso, è
accompagnata da due angeli che recano uno il giglio e l’altro un cesto di rose. Nello stesso anno
Vincenzo La Barbera, inspirandosi a Van Dyck, dipinge Santa Rosalia che intercede per Palermo,
oggi al Museo Diocesano della città, e appena più tardi la replica dello stesso soggetto della
Confraternita di Santa Rosalia ai Quattro Santi Coronati di Palermo, dando l’avvio a diversi
dipinti con quest’ultima impostazione. La Santa Rosalia che intercede per Palermo del Museo
Diocesano è da identificare, secondo Paolo Collura, con il dipinto commissionato al La Barbera
dal Senato di Palermo il 27 luglio 1624 che venne portato in processione il 4 settembre dello stesso
anno.
In questa seconda scena della vara sono taluni simboli peculiari dell’iconografia di Santa
Rosalia. Il bastone da pellegrino è appoggio anche per il divino viandante di Emmaus (Luca 24,
13-35) e al cammino di beatificazione della Santa contribuisce idealmente il Crocifisso: come Gesù
al Calvario, così Rosalia all’Ercta in un’ascesa riscattante e spirituale. Il libro è il simbolo del
testo sacro delle certezze ultraterrene, da cui la Santa trae forza spirituale. La corona del rosario
mariano, offerta dalla Vergine a San Domenico e da questi chiamata “corona di rose di Nostra
Signora” è elemento che accomuna simbolicamente S. Rosalia alla Madonna. «Egli è cosa
certissima, – scrive in proposito Cascini – che questa diuozione ordinata, secondo li quindici
misteri chiamati del Rosario, che comprendono la vita del Nostro Signor Giesù Christo, e della sua
Santissima Madre Maria, i quali dal gaudio, dal dolore, e dalla gloria si nominano, e si compartono
in tre cinquantine d’Aue Marie, che fanno il numero di 150, adeguato alii 150 salmi de Salterio, con
l’aggiunta di 15 Patri Nostri, fu dal Patriarca S. Domenico istituito»9. Le rose, noto simbolo
mariano, rimandano da un lato al suo nome, Rosalia, e dall’altro appunto al rosario, in riferimento
9 La genesi storica della devozione del Rosario è più complessa e articolata. In realtà questa pratica nasce nell’Ordine di
S. Benedetto, si consolida tra i Certosini e si espande grazie all’Ordine dei Predicatori. L’attribuzione della paternità del
Rosario a S. Domenico di Guzmán è una leggenda popolare, anacronistica, che può essere spiegata per il ruolo
fondamentale che ebbe nella strutturazione della preghiera mariana un altro Domenico, di Prussia, entrato nella Certosa
di Treviri nel 1409. Il consolidamento e la diffusione del Rosario si debbono ad Alain de la Roche, un domenicano nato
a Dinan (Bretagna) intorno al 1428 [NdA].
al quale le rose bianche ricordano i misteri gaudiosi, quelle rosse i misteri dolorosi, quelle giallo
oro i gloriosi; in diretto riferimento alla Santa, Cascini ritiene le bianche attributo della sua
verginità, le rosse del suo volontario martirio e le gialle della sua gloriosa sapienza. Insieme ai
resti di Santa Rosalia vennero peraltro rinvenuti taluni grani di una corona di rosario e un piccolo
e leggero Crocifisso d’argento «che non parerà ricchezza in una povera romita».
Giordano Cascini così continua la sua
dettagliata descrizione dell’arca: «La terza
co(n)tiene gl’essercitij da romita, penitenze,
asprezze, e si dice. Assiduae exercitationes,
victus, cultusq(ue); asperitas». La scena,
analoga all’incisione dallo stesso soggetto del
libro del Cascini, tratta e sculptura Bivonensi,
si svolge tutta all’interno della grotta, anche se
due fessure interrompono l’unità dello sfondo
di rocce dove s’erpicano arbusti. Da uno si
scorge un paesaggio alberato e rupestre e
l’altro, muto, contrasta con l’immagine della
Santa inginocchiata e orante. Al centro è un
grosso masso disposto ad altare con il
Crocifìsso in evidenza e alla sua base il libro
Santa Rosalia incoronata da Gesù Bambino.
aperto da un lato e dall’altro la lucerna, che non solo illumina l’ambiente, ma media
simbolicamente la luce divina.
Per terra sono i simboli della penitente, altri suoi usuali attributi iconografici, la catena, il
sasso, il cespo, per mortificare il corpo e purificare l’anima. Al centro sta il teschio, con libri chiusi
accanto, “simboli di morte”, come scrive Maurizio Calvesi, “del tempo che porta la corruzione e il
disfacimento”, ma se “la morte trionfa sulle cose umane, cosa trionfa sulla morte del peccato...?
L’amore in Cristo, che garantisce la vita eterna”, ed ecco dunque pure presente la corona del
rosario, che allude a Maria, mediatrice del divino Figliuolo.
Santa Rosalia in contemplazione. Santa Rosalia recita il Rosario.
«La quarta è il suo ammirabile nascondimento nel buco della grotta Erctense, doue sta
contemplando espresso così In Pretensi foramine abdita liberius caelo fruitur». In questa scena
Santa Rosalia, come pure nella relativa incisione del libro del Cascini, postasi seduta sull’uscio del
suo antro più liberamente si volge al cielo, additato all’austero angelo, sulla destra, che l’assiste,
contrapponendosi all’irrequietezza dei diavoli, che volteggiano sul paesaggio di scorcio. Ai diavoli
e alle vicende terrene la Santa volge dunque le spalle e con lo sguardo rivolto al cielo, e, meditando
sul libro aperto delle verità celesti, affida la sua anima a Dio.
«La quinta ha S. Rosalia, che recita la sua misteriosa corona alla Madre di Dio così dichiarata
Coronam laudum Deiparae profert, solennem posteris orandi ritum». Qui Santa Rosalia offre il
rosario alla Madonna con il Bimbo divino che in un contesto di nubi appare su un sasso a forma di
rustico altare, alla base del quale è ripetuto il simbolico teschio. La corona del rosario qui con
evidenza si pone come lo strumento devoto di meditazione e intercessione tra le umane e mortali
vicende terrene e il desiderato raggiungimento, tramite Maria, della salvezza eterna.
Il padre gesuita così conclude la sua
descrizione delle scene della cassa: «La sesta
finalmente contiene la morte di S. Rosalia da
gran Solitària sola fra gl’Angeli, e le parole
sono queste Sola assidentibus Angelis Deo
spiritum reddit».
È questa la scena culminante, in cui le
vicende terrene vissute semplicemente, ma
intense spiritualmente, si esauriscono per
continuare al di là dei limiti transeunti dello
spazio e del tempo. Sulla sinistra è la figura
sdraiata e senza vita della Santa con il capo
appoggiato su una mano, mentre con l’altra
tiene il Crocifisso e il rosario.
Morte di Santa Rosalia.
Dal corpo s’irradia la sua anima figurata che un angelo conduce a Dio, mentre due putti
alati si fanno incontro reggendo una corona che definitivamente sancisce la sua supremazia
spirituale, facendo del suo mortificante romitaggio lo strumento della salvezza e trasformando la
donna in santa.
Gli scudi che ornano attualmente l’arca non
contengono tutte le scene e le iscrizioni riportate dal
Cascini, ma sono tutti ugualmente ornati solo da una
grande rosa incisa. La sostituzione dei primitivi scudi
dovette comunque avvenire in data anteriore alla
pubblicazione di Joannes Stiltingus del 1748,
comparendo infatti già le semplici rose a tutto campo
entro gli scudi in una delle incisioni della vara che
ornano il volume. Non si può fare a meno di notare come
nell’incisione i putti reggiscudo vengano
“opportunamente” coperti all’inguine da un drappo
nella realtà inesistente, significativo segno di un certo
“pudore”.
Cascini nota come «gl’altri Angeli poi distribuiti in
altri luoghi della Santa arca con corone, e trofei, et altri
ornamenti la rendono molto vaga, e venerabile, ma
sopratutto la statua della medesima S. Vergine». I putti
risultano oggi privi di qualsiasi elemento decorativo o
iconografico, ma i buchi che presentano nelle mani ne
tradiscono la scomparsa. Si tratta di una delle lacune
meritevoli di approfondimento nel caso di un auspicabile
Uno dei quattro puttini reggiscudo.
intervento di restauro.
L’arca venne realizzata dagli argentieri Giuseppe Oliveri, Francesco Rivelo, Giancola
Viviano, Matteo Lo Castro, con la collaborazione di Michele Farruggia e Francesco Roccuzzo, su
disegno dell’architetto del Senato di Palermo Mariano Smiriglio. L’opera, definibile tecnicamente
reliquiario a sarcofago, presenta insieme le tipologie dell’arca reliquiaria e della macchina
processionale. Si trattava certamente di una cassa ben più ricca della prima, che presentava la
tipologia del reliquiario ad urna, disegnata dal famoso architetto del Senato palermitano, che,
come tanti altri, non disdegnava certo di fornire disegni per opere di un’arte ormai solo
convenzionalmente detta minore o per apparati effimeri.
Si ricordano in proposito i disegni per le mazze d’argento del Senato del 1628, per la sella
del 1627 eseguita da A. Bolognese, nonché per l’architettura effimera realizzata per la Nazione dei
Napoletani in occasione del primo Festino di Santa Rosalia del 1625.
Una più precisa individuazione del contributo del Viviano a questa suprema opera d’equipe,
ricordato nella relazione del Barbavara, che certamente non a caso era un abile orafo10
, per lavori
di gettito e rilievo, cioè fusione oltre che rilievo, è stata offerta da un altro documento attestante
che i putti laterali dell’arca reliquiaria di San Gerlando di Michele Ricca del 1635 sono stati
realizzati dallo stesso, nell’atto definito sculptor. Non a caso Maria Accascina scriveva a proposito
del Viviano: «egli fa parte di quel gruppo di scultori impegnati a vari lavori eseguiti nel primo
trentennio del ‘600 e a lui più bronziere che argentiere, possiamo confermare l’attribuzione delle
quattro statuette di angeli che sorreggono la cassa» di Santa Rosalia11
. Proprio in qualità di
bronzista a Giancola Viviano erano state commissionate dal Senato di Palermo nel 1629 le due
statue in bronzo dell’ “ottangolo di piazza Villena” di Filippo II e Filippo III, forse mai realizzate.
Si deve inoltre rilevare che dell’arca di San Gerlando esiste a Palazzo Abatellis (inv. 5252) un
disegno preparatorio che sul retro reca il riferimento a Pietro Novelli, rimandando dunque
l’ideazione dell’arca gerlandiana ad uno dei più grandi artisti del Seicento palermitano. Peraltro
nella collezione Sgadari di Lo Monaco esistevano ben due disegni, oggi conservati pure a Palazzo
Abatellis (inseriti nella carpetta Novelli n. 4 e n. 12), che Gallo riteneva fossero da riferire alla
vara dell’Immacolata della Basilica di San Francesco d’Assisi. Il primo disegno, secondo Santina
Grasso, potrebbe invece riferirsi ad un’ideazione di Mariano Smiriglio della vara di Santa Rosalia;
il secondo reca l’iscrizione del Gallo Pietro Novelli Pittore e Architi (sic) inv e dis. Il Novelli oltre
che della vara di San Gerlando si occupò anche di altre opere d’arte decorativa, elargendo disegni
ai più famosi argentieri dell’epoca, come quello, perduto, per il repositorio della Cappella Palatina
di Palermo, un’urna del Santo Sepolcro, del Giovedì Santo che, realizzata nel 1644 dal messinese
Giuseppe Ferro, è oggi esposta nel tesoro della chiesa; rimane, invece, conservato alla Galleria
Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis (inv. 1565/6), il suo disegno per l’elsa di una spada.
Il rilievo centrale con l’Incoronazione della Santa è attribuito dall’Accascina a Giuseppe
Oliveri «da considerare forse come il capogruppo»12
. Questi, documentato dal 1618 al 1663, lavora
nel 1618 per la confraternita di Sant’Alberto, nel 1628 per Donna Caterina Arrighetti, e prima del
1636 per il Principe di Valguarnera.
10
D. Camillo Barbavara era un abile orafo palermitano, autore del reliquiario per i capelli della Vergine del 1627 ornato
di smalti policromi e della Manta d'oro, smalti e gemme della Madonna del vessillo della Cattedrale di Piazza Armerina
del 1632. Il Barbavara è sepolto nella Chiesa di San Matteo di Palermo. Cfr. MARIA CONCETTA DI NATALE, Le vie
dell'oro dalla dispersione alla collezione, in Ori e argenti di Sicilia, dal Quattrocento al Settecento, Catalogo della
Mostra a cura di M.C. Di Natale, Electa, Milano 1989, p. 33. 11
MARIA ACCASCINA, Oreficeria di Sicilia dal 12. al 19. secolo, S. F. Flaccovio, Palermo 1975, p. 244. 12
Ibidem, p. 245.
Le aquile con le targhe recanti le iscrizioni relative al cardinale Giannettino Doria e alle
altre autorità presenti all’inaugurazione sono riferite dall’Accascina a Francesco Rivelo, anche lui
ricordato nel documento per lavori di fusione e autore della cassa reliquiaria di Sant’Onofrio a
Sutera. Dal confronto con quest’ultima vara l’Accascina trae conclusione che possano essere a lui
riferite «le figure di angioletti scomposti»13
.
L’unico marchio di argentiere che la prof.ssa Di Natale ha potuto rilevare è FR, relativo a
Francesco Rivelo. Compaiono invece in più parti il marchio di Palermo, l’aquila a volo basso con
la sigla RUP (Regia Urbs Panormi) e le iniziali del console GB, che l’Accascina pensa di poter
riferire a Giovanni Berlinghieri, che, come console, nel 1624 vidimò la cassa reliquiaria di San
Gerlando e al quale la studiosa riferisce il “fregio con baccellature” dell’arca di Santa Rosalia14
.
Il Senato di Palermo realizzò nella Cattedrale una ricca cappella alla quale si diede principio
il 20 gennaio 1626. I lavori della cappella durarono fino al 1635.
Dopo la deprecabile distruzione della cappella di Santa
Rosalia, di cui sopravvivono la vara d’argento, la statua di
Bartolomeo Travaglia del 1638, pochi frammenti marmorei al Museo
Diocesano di Palermo e una grata con l’iscrizione, il fercolo venne
posto in quella attuale dedicata alla Patrona, anch’essa chiusa da
un’altra “grata” esterna, esemplata sull’antica interna, e riccamente
adorna di suppellettili liturgiche, come le numerose lampade
d’argento che pendono dalla volta. Quando veniva chiusa la vara
dalla cancellata si poneva davanti ad essa un paliotto ove era
dipinta su tela la Santa nella grotta del Monte Pellegrino, pure
ornata da marmi mischi. Nel 1803 venne realizzato per la cappella di
S. Rosalia anche un altare tutto in lamina d’argento su anima lignea
con davanti un paliotto dello stesso materiale, in cui è raffigurata la
Santa.
L’aquila o l’albatro?
La scoperta dei nomi degli artigiani impegnati nella realizzazione della vara di S. Rosalia fa
parte del meticoloso lavoro svolto negli ultimi decenni della prof.ssa Maria Concetta Di Natale,
continuatrice dell’opera di Maria Accascina, volto a far uscire dall’ombra tante figure di valenti
maestri con le rispettive botteghe15
.
L’indagine scientifica ha rivelato i nomi dei componenti della squadra che ha curato progetto
e realizzazione di questo capolavoro dell’oreficeria palermitana. Nel delineare il profilo dei
protagonisti dell’impresa bisogna evitare per correttezza l’enfasi celebrativa, sottolineando che
costoro non si consideravano dei geni. Sarebbe anacronistico attribuire ad artisti del Seicento, che si
premuravano di servire con la maggiore perizia possibile i propri clienti, quanto Charles Pierre
Baudelaire scrive del poeta, paragonandolo all’albatro. Questo imponente uccello marino domina
col suo volo gli spazi ampi: le sue grandi ali lo rendono regale nel cielo, ma se gli capita di essere
catturato dai marinai si muove goffo e impacciato sul ponte della nave e diventa oggetto di scherzi e
di disprezzo. Proprio le grandi ali lo rendono sgraziato nel camminare sulle zampe.
Anche il poeta, divenuto nella concezione post illuminista trasgressivo e maledetto, è abituato
alle grandi solitudini e alle grandi profondità delle tempeste interiori e in queste dimensioni domina
sovrano. Anche lui, come l’albatro, può sembrare goffo e impacciato nella realtà quotidiana, nella
quale non si muove a suo agio. Il poeta insomma ha il dominio della realtà fantastica, ma nella
13
Ibidem, p. 258. 14
Ibidem, p. 244. 15
Il denso saggio della prof.ssa Di Natale sull’urna di S. Rosalia, pubblicato nel 1994, si trova anche sul sito
dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia (OADI), intitolato a Maria Accascina e pensato come strumento
scientifico del Dipartimento di Beni Culturali – Studi Culturali dell’Università degli Studi di Palermo per ampliare la
ricerca nel settore specifico.
realtà materiale è un incapace e riceve l’incomprensione e il disprezzo degli uomini, esattamente
come accade all’albatro.
Il poeta, secondo Baudelaire, è venuto sulla terra per interpretare la realtà alla luce del suo
sogno, ribelle alle convenzioni, inabile alla vita pratica, destinato a gettare il discredito sulle comuni
passioni, a sconvolgere i cuori, a testimoniare per mezzo dell’arte un mondo magicamente e
idealmente perfetto.
Ecco come Baudelaire formula il mito bohemien dell’artista maledetto, che ha influenzato non
poco la concezione dell’arte dominante nella cultura contemporanea.
L’ALBATROS Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. A peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d’eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid! L’un agace son bec avec un brûle-gueule, l’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait! Le poëte est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l’archer; exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l’empêchent de marcher.
L’ALBATRO Spesso, per divertirsi, gli uomini d’equipaggio catturano gli albatri, vasti uccelli dei mari, che seguono, indolenti compagni di viaggio, il naviglio che scivola sopra gli abissi amari. Appena li han deposti sul ponte delle navi, questi re dell’azzurro son vergognosi e incerti, e con pena le ali immense, bianche e gravi, si trascinano appresso come dei remi inerti. Com’è goffo e grottesco, lui così bello prima! L’instancabile alato, com’è debole al suolo! Chi gli caccia nel becco una pipa e chi mima, zoppicando, l’infermo già così alto in volo! Al principe dell’aria il poeta si eguaglia, che sfida le tempeste, d’ogni dardo sprezzante; esiliato per terra in mezzo alla marmaglia, gli impediscono il passo le ali di gigante16.
Non è affatto facile uscire oggi dalle sabbie mobili dei luoghi comuni e comprendere cos’è
l’arte, cos’è l’artista e cos’è l’artigiano17
. A maggior ragione risulta indispensabile liberarsi dalle
16
Da CHARLES PIERRE BAUDELAIRE, Les fleurs du mal. Ringraziamo Gabriella Rouf per la traduzione.
catene della retorica classicista o romantica, che hanno imprigionato tre secoli di produzione
creativa e di critica d’arte, in forme diverse a seconda che si tratti di autori decadentisti come
Baudelaire o di astuti imbonitori come Maurizio Cattelan. Ai nostri giorni la pseudo arte
contemporanea è incatenata dalle logiche della finanza e soltanto l’artigianato sembra davvero
libero di accogliere le richieste della committenza per produrre bellezza, una bellezza che rende
migliore la vita quotidiana.
Nel punzone della Regia Urbs Panormi c’è un’aquila, non un albatro. È il simbolo della città
e il marchio delle maestranze degli orafi e degli argentieri palermitani. L’aquila di Palermo,
ampiamente rappresentata nell’urna e nella cappella di S. Rosalia, può essere presa come metafora
dell’arte libera e rinnovata: fiera delle proprie doti e caparbia nel metterle a frutto; acuta nella
visione del mondo e capace di innalzarsi più di tutti, sino a scrutare il sole ad occhi aperti;
instancabile nei propri voli e nel procurare il cibo alla nidiata; insofferente alla sola ipotesi di
rimanere a razzolare in un’aia; amante delle sfide da combattere alla luce del giorno e non dei
tranelli da tendere nelle tenebre.
L’orgoglio di un artista va esercitato nell’abilità di trarre spunto dalle piccole cose per farne
grandi opere, per la gioia degli esseri umani, diversamente da quanto succede abitualmente nella
nostra epoca.
Il declino del Festino
A fine maggio del 1860 le camicie rosse conquistano Palermo. La città, teatro dei
combattimenti tra le truppe borboniche da un lato e Garibaldi appoggiato dagli insorti dall’altro,
rimane un campo di macerie e di barricate, che ostruiscono in particolare la strada principale, il
Cassaro, sulla quale si sarebbero dovute svolgere a luglio le sfilate del Festino. Con questo pretesto,
il governo dittatoriale garibaldino impedirà le celebrazioni per S. Rosalia del 1860. Fino al 1868 il
Festino si celebra solo in qualche anno e in maniera ridotta. La manifestazione era troppo pericolosa
per il fragile equilibrio che si era venuto a creare. I palermitani hanno il sangue caldo e – una volta
scoperto che i “liberatori” non erano per nulla migliori dei Borboni – iniziano a scalpitare, con
reazioni violente che toccano il culmine nella Rivolta del Sette e Mezzo del 1866.
Dopo il 1868 si riprende a festeggiare S. Rosalia, ma in tono minore. Le celebrazioni di luglio
si trasformano sempre più in una malinconica sagra paesana, con le tipiche esibizioni di cantanti di
musica leggera e le passeggiate con i bambini alle giostre del Foro Italico. Quest’ultimo, triste copia
della cinquecentesca Strada Colonna, era stato allontanato di circa 200 metri dalla nuova linea di
17
Cfr. CIRO LOMONTE e GUIDO SANTORO (a cura di), Ritorno al futuro. Antichi saperi per nuove occupazioni, Arces,
Palermo 2012.
costa, un’informe spianata ottenuta con le macerie della Seconda Guerra Mondiale, che ha sfigurato
l’elegante lungomare precedente. L’enorme distesa serviva, fino agli anni Novanta del secolo
scorso, ad una specie di Luna Park. Oggi l’area è ancora amorfa, ma perlomeno è stato realizzato un
ampio prato – di circa 33.000 metri quadri – per il tempo libero dei palermitani. Qui si svolge la
notte del 14 luglio lo spettacolo dei “giochi di fuoco”.
Il Festino rinasce a luglio del 1974, in occasione dei 350 anni dal ritrovamento delle ossa della
Santuzza18
, con una discreta dignità, non paragonabile ai fasti dei secoli precedenti. Di quel Festino
è degno di nota il carro progettato dall’arch. Rodo Santoro, a forma di poppa di vascello, ispirandosi
a quello dell’arch. Paolo Amato del 1701. Anche la sfilata storica venne curata attentamente da
Santoro, apprezzato scenografo e profondo conoscitore della storia.
Da allora ad oggi c’è stato un crescendo nella regia della sfilata del 14 sera, senza un preciso
rapporto con la tradizione originaria del Festino. Quelle che non sono rinate del tutto sono le
manifestazioni religiose. È interessante a tal proposito fare un confronto fra tre processioni: quella
dell’Immacolata, quella del Corpus Domini e quella di S. Rosalia.
La Festa dell’Immacolata
Prima di parlare della festa dell’8 dicembre, tenuto conto che la Madonna Immacolata è la
patrona dell’Arcidiocesi di Palermo a partire dalla stessa peste del 162419
, mentre S. Rosalia è
patrona principale della città, fermiamoci alla descrizione di un’opera tanto preziosa quanto
misteriosamente ignorata nelle guide turistiche. Nel 1647 viene realizzato a Palermo un altro
capolavoro degli argentieri locali, la statua dell’Immacolata Concezione, che da allora viene
conservata in una cappella chiusa della Basilica di S. Francesco d’Assisi da un pesante drappo nero
e da una robusta cancellata con tre catenacci. Una chiave è conservata dal guardiano e parroco della
Basilica di S. Francesco, una dal decano dei nobili della città, una – a partire dal 1874, a causa delle
funeste leggi eversive del 1866 – dal sindaco.
L’immagine rimane nascosta tutto l’anno agli occhi dei fedeli, che possono ammirarla
soltanto durante la Novena dell’Immacolata, dopo che i tre custodi delle chiavi aprono la cappella
nel corso di una solenne cerimonia. La Confraternita del Porto e Riporto può allora spostare la vara
vicino all’altare.
L’esistenza di una statua dell’Immacolata nella Basilica di S. Francesco è documentata sin
dalla processione dell’8 dicembre del 1624. Si descrive “l’immagine della Beatissima Vergine di
argento massizzo”. Ciò viene confermato da un atto notarile del 1649, nel quale si notifica che le
mani e i piedi dell’attuale statua di argento provengono dal simulacro più antico e che la testa di
quest’ultimo venne fusa perché non era proporzionata all’altezza dell’attuale. Col materiale
risultante viene eseguita l’attuale.
L’attuale statua dell’Immacolata viene consegnata il 30 novembre 1647. Nell’osservare la
vecchia statua, che aveva in argento solo la testa, i piedi e le mani, Giovanni Battista De Leonardi
(originario di Venezia) concepisce il desiderio e il voto di fare eseguire una statua dell’Immacolata
tutta in argento, anche come ringraziamento alla Vergine per la nascita di un nipote, figlio del
protomedico del Regno, D. Paolo Pizzuto, e di Angela De Leonardi, figlia di Giovanni Battista.
Presi gli accordi necessari, sia con il Convento di S. Francesco, che doveva fornirgli le parti in
argento dell’antica statua, sia col P. Francesco Scichili, suo cognato, che doveva fornire la maggior
parte del capitale necessario, il Sig. De Leonardi il 26 ottobre del 1646 fa iniziare i lavori per
l’esecuzione della statua. P. Filippo Rotolo avanza l’ipotesi che il gruppo degli argentieri fosse
18
Nel 2024, fra 11 anni, si riuscirà a commemorare come si deve il 400° anniversario? 19
Cfr. FILIPPO ROTOLO, La cappella dell’Immacolata nella Basilica di S. Francesco a Palermo, Basilica S. Francesco
d’Assisi, Palermo 1998, pp. 72-78. Nel 1624 il Senato palermitano si assume l’impegno, ratificato solennemente nel
1655, di fare a proprie spese la festa dell’Immacolata, di presenziare ufficialmente alla festa e di invitare gli arcivescovi
e i viceré che si avvicendavano a Palermo a rinnovare il giuramento e il voto, non solo di accettare nella fede il
privilegio di Maria, ma anche di difenderlo “fino all’effusione del sangue” o “fino all’estremo della vita”.
costituito dagli stessi maestri che avevano realizzato l’arca di S. Rosalia: Giuseppe Oliveri,
Francesco Rivelo, Giancola Viviano e Matteo Lo Castro20
.
I lavori vengono eseguiti nell’abitazione del De Leonardi. Le spese occorrenti sono affrontate
in gran parte dal P. Francesco Scichili, mentre il De Leonardi vi spende solo 100 onze, oltre alla
assidua assistenza e il “disturbo”.
L’esecuzione dura circa un anno. Testa, mani e piedi sono piene, in fusione d’argento. Tutto il
resto è un prodigio di cesello finissimo, in quanto si tratta di sottili lastre d’argento modellate e
poste su un’anima di ferro che dà stabilità al tutto. Alla base si trovano due vedute di città: Venezia
– in onore del donatore – (con la scritta Omnia bona pariter cum illa) e Palermo (con il testo Tua
sub umbra Panormus foelix). «L’abilità tecnica dell’argentiere palermitano si evidenzia in dettagli
quali il minuzioso viluppo delle pieghe del manto, le squame del serpente, la presenza in un lembo
del manto di una stella cometa, che allude in questo caso, non posta sul petto, non a quelle usuali
attributo mariano, stella matutina o stella maris, ma piuttosto a quella che fu segno della nascita di
Gesù»21
.
L’8 dicembre del 1647 viene condotta in processione, con l’intervento del cardinale Trivulzio,
Presidente del Regno. Il 30 successivo, con atto in notaio Pietro Catalano, Giovanni Battista De
Leonardi dona al Convento di S. Francesco la statua dell’Immacolata d’argento di altezza naturale
(m. 1,75), con corona imperiale, con una gemma in fronte della corona imperiale, con un suo
piedistallo in argento e una vara di legno indorata e intagliata. La donazione veniva fatte a queste
condizioni:
20
FILIPPO ROTOLO, op. cit., p. 88. 21
Cfr. MARIA CONCETTA DI NATALE, L’Immacolata nelle arti decorative in Sicilia, in Bella come la luna, pura come il
sole. L’Immacolata nell’arte in Sicilia, a cura di MARIA CONCETTA DI NATALE e MAURIZIO VITELLA, Provincia
Religiosa di Sicilia dei Frati Minori Conventuali, Palermo 2004, p. 74.
1. che il convento si riteneva obbligato a custodirla in una cappella, ad apporvi una grata
con due catenacci e due chiavi, delle quali una doveva essere custodita dallo stesso Giovanni
Battista De Leonardi, e alla sua morte dal Protomedico D. Paolo Pizzuto, suo genero, e quindi dai
successori, e in caso di estinzione di questi eredi, da Giovanni Andrea di Notandrea, e ancora in
caso di estinzione, dal Ministro della Compagnia di S. Lorenzo in S. Francesco; l’altra chiave
doveva essere custodita dal P. Francesco Scichili e alla sua morte dal più anziano del convento;
2. che il convento doveva designare un frate per assistere il P. Scichili, che era anziano;
3. che il convento non poteva né alienare, né prestare, né far uscire la statua se non per
utilità pubblica e con l’obbligo di redigere il documento relativo;
4. che in caso di frode perpetrata dal convento, la donazione si intendeva fatta alla
Cattedrale;
5. che il convento si debba ritenere soltanto custode e non proprietario della statua;
6. che la processione passi ogni due anni davanti alla casa di Paolo Pizzuto.
La statua è la stessa giunta sino ai nostri giorni, con qualche modifica. Nel 1844, per es.,
l’argentiere Giacomo D’Angelo aggiunge un globo attraversato dalla fascia zodiacale con i simboli
delle costellazioni. Durante la Seconda Guerra Mondiale la Soprintendenza ai Monumenti della
Sicilia trasferisce la statua in un rifugio costruito all’interno del Palazzo Reale. In effetti la basilica
subirà danni ingenti nel corso dei bombardamenti del maggio 1943. Nel 1993 viene affidato alla
Ditta del Comm. Salvatore Di Cristofalo, che si fa carico delle spese, un delicatissimo intervento di
restauro della statua, che manifestava un degrado evidente. I lavori vengono eseguiti dai maestri
argentieri Piero Accardi e Gioacchino Di Cristofalo, insieme ai maestri cesellatori Giuseppe Scafidi
ed Emilio Marchesini22
.
La statua della Vergine Immacolata obbedisce all’iconografia affermatasi nella seconda metà
del Cinquecento: una giovane donna a mani giunte, con lo sguardo assorto (in questo caso rivolto ai
fedeli), la luna ai suoi piedi e una corona di dodici stelle. La riflessione teologica sul Concepimento
di Maria, unica creatura umana preservata dalla macchia dei progenitori, viene trasferita alla
raffigurazione artistica attingendo a due passi della Sacra Scrittura: il Cantico dei Cantici23
e
l’Apocalisse24
.
La vara viene portata ogni anno in processione il pomeriggio dell’8 dicembre. Il faticoso
trasporto a spalla è a carico della Confraternita del Porto e Riporto. Il percorso prevede, dopo
l’uscita del simulacro d’argento dalla Basilica di S. Francesco d’Assisi, una tappa davanti alla
colonna dell’Immacolata di piazza S. Domenico, dove l’arcivescovo di Palermo tiene un sermone e
i vigili del fuoco salgono in cima alla colonna per il tradizionale omaggio floreale alla Madonna.
Infine la processione prosegue fino alla Cattedrale, dove l’immagine, accompagnata da una
considerevole folla di fedeli, viene accolta da una moltitudine festante che esplode in canti e grida
di gioia per il singolare privilegio di Maria.
In queste manifestazioni di esultanza rimane molto chiaro l’insegnamento del Secondo
Concilio di Nicea (787): «L’onore reso all’immagine passa a colui che essa rappresenta; e chi
adora l’immagine, adora la sostanza di chi in essa è riprodotto». Nell’uso delle immagini per
stimolare la devozione si adora Dio, in Sé Stesso o nei suoi santi, non si idolatrano le immagini.
Sarebbe bello verificare in che misura committenti ed esecutori dell’opera avessero in mente
l’impiego dell’argento, metallo che restituisce un’intensa luminosità lunare, con il tipico alone
vaporoso, per simboleggiare tanti insegnamenti della Scrittura e dei Padri della Chiesa. Dio è il
Sole, l’unico che risplende di luce propria. La Chiesa, Maria, i santi, sono come la luna, che riflette
la luce del sole.
È significativo che la vara passi davanti alla maestosa basilica dei Frati Predicatori. Bisogna
tenere in considerazione che la verità del Concepimento di Maria senza trasmissione del peccato
22
Cfr. FILIPPO ROTOLO, op. cit., pp. 83-96. 23
«Tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia» (Ct 4,7). 24
«Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo
una corona di dodici stelle» (Ap 12, 1).
originale, proclamata dogma solo nel 1854, era stata difesa con le unghia e con i denti dai figli di S.
Francesco d’Assisi (specialmente i conventuali), seguendo le argomentazioni del beato francescano
Giovanni Duns Scoto, e osteggiata dai domenicani, in virtù della necessità universale della
Redenzione dalla colpa originale insegnata dal loro illustre confratello, S. Tommaso d’Aquino.
La colonna di piazza S. Domenico risale al 1724, quando i Frati Predicatori affidano
all’architetto domenicano Tommaso Maria Napoli il compito di redigerne il progetto e di recarsi a
Vienna per sottoporlo all’imperatore Carlo VI d’Asburgo, in quel momento Re di Sicilia. Il motivo
principale del viaggio era però ottenere il finanziamento dell’opera da parte del sovrano.
L’imperatore concede il sostegno economico, a patto che l’immagine sulla colonna fosse quella
dell’Immacolata Concezione e non quella della Vergine del Rosario come inizialmente previsto25
. È
possibile che Napoli abbia incontrato l’arch. Joseph Emanuel Fischer von Erlach per discutere
dell’opera. A quanto pare si tratta della più antica colonna dell’Immacolata del mondo.
Tre manifestazioni a confronto
La processione dell’Immacolata è la più amata da quel che rimane dei palermitani. La stessa
cosa non può dirsi della processione del Corpus Domini, che fra l’altro si colloca di solito in una
domenica del mese di giugno, quando è iniziata da tempo la stagione balneare e gran parte delle
famiglie passa almeno il fine settimana fuori città26
. Sfila ancora un buon numero di chierici,
religiosi e confraternite, ma i laici presenti sono pochi. E lo scenario del percorso, da S. Domenico
alla Cattedrale, non potrebbe essere più desolante.
La processione meno sentita di tutte è quella del 15 luglio, dietro all’urna di S. Rosalia, dalla
Cattedrale sino a piazza Marina, dove l’arcivescovo pronunzia un sermone. Perché? C’è oggi meno
devozione per la Santuzza? Anche se si levano voci contro l’autenticità delle reliquie e
dell’agiografia romanzesca che è stata elaborata dopo il 1624, la devozione rimane più o meno
intatta nei ceti popolari, com’è attestato dalla partecipazione di massa alla tradizionale acchianata
(salita) di Monte Pellegrino che si fa il 4 settembre, memoria liturgica della Santa. Molti praticano
ancora questo pellegrinaggio, a piedi o in ginocchio, percorrendo la strada antica che porta al
Santuario.
La scarsa adesione al Festino (alcuni cittadini, anche di età venerabile, non vi hanno mai preso
parte nella loro vita) è probabilmente dovuta al tipo di emigrazione che abbiamo descritto all’inizio.
Come pure al tentativo di cancellare la storia locale operato con successo da chi ha fatto l’Unità
d’Italia.
Come ha scritto qualcuno27
, dal 1860 in poi l’intero Meridione – e Palermo non è
un’eccezione – è stato privato di tre generazioni di padri, energici e consapevoli della propria
identità, che sono stati costretti ad emigrare. Il Festino di S. Rosalia è una delle cartine di tornasole
che consente di cogliere la salute della società civile di Palermo e il suo grado di asservimento ad
interessi altrui.
25
Cfr. SIMONETTA LA BARBERA, La colonna dell’Immacolata, in Bella come la luna, pura come il sole. L’Immacolata
nell’arte in Sicilia, a cura di MARIA CONCETTA DI NATALE e MAURIZIO VITELLA, Provincia Religiosa di Sicilia dei
Frati Minori Conventuali, Palermo 2004, pp. 121-132. 26
Una difficoltà analoga si registra per la tradizionale messa in onore di S. Eligio, patrono di orafi ed argentieri, che
viene celebrata la domenica più vicina al 25 giugno. 27
Cfr. PINO APRILE, Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero “meridionali”,
Piemme, Milano 2010.