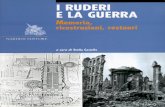Sui reliquiari a braccio di San Sebastiano in Acireale: storia e restauri
Un illustre inedito. L’ICR e la prima campagna di restauri dei soffitti della Cappella Palatina di...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
Transcript of Un illustre inedito. L’ICR e la prima campagna di restauri dei soffitti della Cappella Palatina di...
L’OFFICINA DELLO SGUARDO
scritti in onore di Maria Andaloro
a cura di
Giulia Bordi, Iole Carlettini, Maria Luigia Fobelli, Maria Raffaella Menna, Paola Pogliani
I LUOGHI DELL’ARTEIMMAGINE, MEMORIA, MATERIA
©Proprietà letteraria riservata
Gangemi Editore spaPiazza San Pantaleo 4, Romawww.gangemied i tore . i t
Nessuna parte di questapubblicazione può esserememorizzata, fotocopiata ocomunque riprodotta senzale dovute autorizzazioni.
Le nostre edizioni sono disponibiliin Italia e all’estero anche inversione ebook.Our publications, both as booksand ebooks, are available in Italyand abroad.
I volumi sono stati pubblicati grazie ai contributi di
redazione scientificaSimone PiazzaconMichele BenucciChiara BordinoIvana BrunoDaniela Sgherri
Elaborazione delle immaginiDomenico Ventura
TECNO-ART, ASCOLI PICENO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEI BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VITERBO
DIPARTIMENTO DI LETTERE ARTI E SCIENZE SOCIALI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. “D’ANNUNZIO” DI CHIETI
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA SICILIA
ISBN 978-88-492-2753-6
In copertina: Pittura, architettura, paesaggio. Contaminazioni, abrasioni, innesti. Immagini, 2014 (particolare).
L’OFFICINA DELLO SGUARDOScritti in onore di Maria Andaloro
a cura diGiulia Bordi, Iole Carlettini, Maria Luigia Fobelli,
Maria Raffaella Menna, Paola Pogliani
Volume 2
IMMAGINE, MEMORIA, MATERIA
Indice
V. L’ESTETICA E LO SGUARDO
L’immagine dell’immagine 13LUCIA PIZZO RUSSO
L’immagine ibrida 21ELIO FRANZINI
Epistemologia dell’ornamento. Un’ipotesi di lavoro 27MASSIMO CARBONI
Icona e immagine 33GIUSEPPE DI GIACOMO
Icone moderne 39VICTOR I. STOICHITA
Il Fayum di Alberto Giacometti 45ELENA TAVANI
L’ultima spiaggia del monumento. Per una tipologia della contro-monumentalitàcontemporanea 55ANDREA PINOTTI
VI. L’OPERA �EL TEMPO
Mostri marini con e senza ali: considerazioni sul ‘grande pesce’ che ingoiò Giona 63FRANCESCA POMARICI
«In forma di teatro». Lo spazio liturgico antelamico in diocesi di Parma: nuove scoperte tra rimozioni e rilavorazioni 69CARLOTTA TADDEI
Paraíso e infierno en Gormaz: una iglesia a los pies de un castillo 75MILAGROS GUARDIA
Sfortuna del San Ludovico di Tolosa di Donatello: lo spazio negato 85LAURA CAVAZZINI
Segnalazioni del ‘Maestro dell’Adorazione di Glasgow’ 91RICCARDO NALDI
Giovanni Bellini introduce l’Anticristo 101ENZO BILARDELLO
Il disegno nascosto di Giovanni Santi 107MARIA ROSARIA VALAZZI
Uno sguardo su Maria. Iconografia mariana nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma 113BARBARA FABJAN
Raffaello, Polidoro e lo Spasimo di Sicilia: un caso di scuola 119ANDREA DE MARCHI
La Pietà di Michelangelo: nuove ricerche su una Madonna coronata in San Pietro 127PIETRO ZANDER
Visione nordica e allegoria italiana nella Battaglia di Mühlberg di Enea Vico 141ENRICO PARLATO
Recomposition: Blade and Glue in Some Drawings by Ludovico Carracci 147GAIL FEIGENBAUM
Un nuovo quadro di Marco Benefial ‘che si direbbe di Carlo Maratta’ 153LILIANA BARROERO
VII. SEG�I E PERCORSI DELLA MEMORIA
Edizioni moderne, problemi antichi: la gloria del μεγαλόψυχος (Isocrate, Evagora 3) 161MADDALENA VALLOZZA
Peristili e cortili porticati nelle domus aristocratiche della Roma tardo-antica: alcuni esempi da ricerche recenti 167CARLO PAVOLINI
Note sulle iscrizioni ‘damasiane’ della basilica di Sant’Ippolito a Porto 173VINCENZO FIOCCHI NICOLAI
Johannes, monaco di San Pietro in Ciel d’Oro, e l’armarium dimenticato di San Savino a Piacenza 181STEFANIA BABBONI
L’immagine di Lemno in Italia tra XV e XVII secolo 185MARINA MICOZZI
Un’impresa per la Virtù. Accademia e parodia nella Roma farnesiana 191PAOLO PROCACCIOLI
I manoscritti di Antonio Bruzio (1614-1692) sulla basilica di San Giovannia Porta Latina 197ALIA ENGLEN
Immagini come documenti. Il caso del Fiume del terrestre Paradiso (1652) di Niccolò Catalano con le incisioni di Francesco Curti 205GIOVANNA SAPORI
Luoghi di memoria e memoria dei luoghi: Costantinopoli e le mura terrestri nei diari del reverendo John Covel (1670-1677) 213ALESSANDRA RICCI
Su alcuni disegni di un frammento della serie dei Rilievi ‘Valle-Medici’ con personificazioni di nationes e civitates 221STEFANO DE ANGELI
Temi di metodo. Mengs, il Barocco e il Naturalismo spagnolo: una riflessione e un interrogativo 227ROSANNA CIOFFI
Survey of Iasos by Royal Navy, 1822 231FEDE BERTI
Le torri di Vlanga Bostani: un tratto perduto delle mura marittime di Costantinopoli nei disegni di Mary Adelaide Walker 237ANDREA PARIBENI
«Ai tempi del potente re Ruggero…». Aubin-Louis Millin a Santa Maria del Patir 245ANNA MARIA D’ACHILLE, ANTONIO IACOBINI
La «stanza di re Ruggero» del Palazzo reale di Palermo dalla destinazione d’uso alla fortuna nell’arte dell’Ottocento 257IVANA BRUNO
Cassette, pissidi, olifanti. Un taccuino inedito di Ugo Monneret de Villard 265SILVIA ARMANDO
Alla ricerca di Cimabue: i disegni di Ingres ad Assisi 271IOLE CARLETTINI
Calamatta: l’ideale d’artista ne Les Maîtres Mosaïstes di George Sand 277ROSALBA DINOIA
Pavel A. Florenskij e il discorso sull’icona 283MARIA LUIGIA FOBELLI
La ‘questione delle origini’: un dibattito nella Viterbo neomedievalista 291MARIA TERESA MARSILIA
Wrap Museum: un progetto di Christo per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma 297STEFANO MARSON
Persistenti memorie. Segmenti identitari dell'arte contemporanea nell'area del Mediterraneo 303PATRIZIA MANIA
VIII. CRITICA, STRUME�TI E METODI DEL RICO�OSCIME�TO
Il riconoscimento come ricostituzione. Per un’edizione commentata della Teoria del restauro di Cesare Brandi 311MARIA IDA CATALANO
Appunti sul ‘restauro preventivo’, oggi 317PIETRO PETRAROIA
L’occhio del fotografo e l’occhio del restauratore 325GIOVANNA MARTELLOTTI
Il restauro scientifico per le opere d’arte decorativa 331MARIA CONCETTA DI NATALE
Fragili oggetti riscoprono antichi contesti 337ROSALIA VAROLI PIAZZA
Percorsi inediti del restauro in Italia negli anni Quaranta del Novecento: Federico Zeri e Mario Modestini 343SILVIA CECCHINI
Politica e accademia: Lionello Venturi, Roberto Longhi e la successione a Pietro Toesca nell’ateneo romano 347VALENTINO PACE
Il dibattito tra arte e architettura in Italia negli anni della ricostruzione (1945-1955) 353ELISABETTA CRISTALLINI
Proposta per una nuova organizzazione museale 359FRANCESCO ANTINUCCI
Niğde Müzezi 365FASLI AÇIKGÖZ
Uso e abuso dei GIS: dal bene immobile alle collezioni museali 367ELENA LATINI
Conservazione preventiva e controllo climatico nei musei: un viaggio fra Viterbo, Teheran e Città del Vaticano 371HAYDÈE PALANCA
La chiesa di Santa Maria Assunta a Monterano: fonti documentarie, stratigrafia, fasi costruttive 375MICHELE BENUCCI, GIUSEPPE ROMAGNOLI
Rilievo morfologico e rappresentazione dell’architettura rupestre 385MARCO CARPICECI
Un futuro per il passato: un tell tra ricerca, conservazione e fruizione 391ISABELLA CANEVA
Dendroprovenienza dei legni dei supporti dipinti (IV-XV secolo) e delle sculture in area mediterranea 397MANUELA ROMAGNOLI
Il contributo delle Scienze della Terra nei beni culturali 403GINO MIROCLE CRISCI, MAURO FRANCESCO LA RUSSA, DOMENICO MIRIELLO
Il MLAC Museo Laboratorio di Arte Contemporanea all’Università degli Studi della Tuscia (1992-1997) 407SIMONETTA LUX
La formazione universitaria nel settore della Conservazione dei beni culturali: qualche riflessione 413GIOVANNI SOLIMINE
L’arte del restauro, eccellenza made in Italy: dalla mente alla mano 421LIDIA RISSOTTO
Al di fuori dei percorsi accademici 427RAFFAELLA PASCUCCI
IX. DAI PO�TEGGI
Lazur de graico colore: sui sentieri del lapislazzulo 431GIOVANNA VALENZANO
I primi due strati dipinti della parete-palinsesto di Santa Maria Antiqua: nuove osservazioni di carattere tecnico-esecutivo 437WERNER MATTHIAS SCHMID
Pittori e mosaicisti nei cantieri di Giovanni VII (705-707) 443PAOLA POGLIANI
L’uso di sagome per dipingere: il ciclo dei Santi Quirico e Giulitta nella cappella di Teodoto in Santa Maria Antiqua al Foro Romano 451VALERIA VALENTINI
Nella basilica di San Pietro a Tuscania, il più antico disegno di cantiere conosciuto del Medioevo italiano? 457RENZO CHIOVELLI
«Prestarsi con tutto amore ed impegno per le cose patrie»: il barone Mandralisca e i restauri ottocenteschi dei mosaici di Cefalù 465VINCENZO ABBATE
Un illustre inedito. L’Istituto Centrale per il Restauro e la prima campagna di restauri dei soffitti della Cappella Palatina di Palermo (1948-1953) 473FRANCESCA ANZELMO
L’esperienza del Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e il Restauro ‘Michele Cordaro’ nel cantiere di studio del frammento musivo con l’Angelo dalla Navicella di Giotto 479CLAUDIA PELOSI
L’icona musiva di san Sebastiano nella basilica romana di San Pietro in Vincoli. Analisi critica con l’ausilio dell’indagine digitale riflettometrica 487GABRIELE BARTOLOZZI CASTI
Impurezze associate al litargirio in cicli pittorici medievali 495PIETRO MOIOLI, CLAUDIO SECCARONI
Una statua di età giulio-claudia dal Palatino: studio delle tecniche di esecuzione 501SILVIA BORGHINI
The Conservation Work on the Mosaics of the Amazons Villa from Early Byzantine Period, Şanlıurfa-Turkey 507Y. SELÇUK ŞENER
An example of rock-hewn church restoration in Cappadocia: Ürgüp Kayakapı rock church 513BEKIR ESKICI
A propósito de la reciente restauración del claustro de Santa María de Ripoll y del hallazgo de una imagen medieval de estuco 519IMMACULADA LORÉS I OTZET
Restauro di un tratto crollato delle mura medievali di Tarquinia presso la chiesa di Santa Maria in Castello. Metodologia di analisi e di intervento 527MARINA A.L. MENGALI
OMAGGI 533RODOLFO FIORENZA, GAETANO ALFANO, DOMENICO VENTURA
La signora del viaggio 541A Maria Andaloro ΔέσποιναPIETRO LONGO
Corsi tenuti da Maria Andaloro nelle Università di Chieti e Viterbo 545
Maria Andaloro. Bibliografia 1970-2013 547
473
È conoscenza ormai diffusa che, tra il 1948e il 1953, l’ICR (Istituto Centrale del Restau-ro)1 di Roma eseguì, sotto la direzione di Ce-sare Brandi, il primo restauro globale dellecoperture lignee della Cappella Palatina di Pa-lermo, intervenendo tanto sulle pitture quantosul supporto ligneo. Tuttavia ancora oggi, dopooltre un cinquantennio, poco si conosce dell’o-perato dei restauratori diretti da Brandi2.
Questo perché, stranamente controtenden-za rispetto all’orientamento generale del gio-vane Istituto3 di rendere note le nuovemetodologie di restauro attraverso mostre epubblicazioni − alle quali si riconosceva unaimportante funzione per il dibattito nazionale(e internazionale) sulla conservazione e il re-stauro4 − e a differenza dunque di altri rilevan-ti restauri condotti dall’ICR prima e subitodopo la guerra5, nulla che riguardasse i soffittipalermitani viene dato alle stampe.
Le ragioni di questo silenzio rimangono dif-ficili da determinare. Al contrario, le carte e ladocumentazione fotografica conservate rispetti-vamente presso l’Archivio storico-amministra-tivo6 e l’Archivio fotografico documentazionerestauri7 dell’allora ICR, oggi ISCR (Istituto Su-periore per la Conservazione ed il Restauro) diRoma, sono ricchissime di informazioni e con-sentono una puntuale ricostruzione sia del per-corso temporale dei lavori sia dei criterimetodologici degli interventi.
Si presentano qui le linee generali dellescelte intraprese in quell’occasione dai restau-ratori, un assaggio del loro importante contri-buto alla nostra conoscenza attuale delle pitturedei soffitti di Palermo, straordinari testimonidell’arte medioevale in Europa e nel mondoislamico8. In seguito agli ultimi restauri sull’in-
tero complesso della Palatina (2005-2009)9 edopo le due importanti recenti pubblicazionimonografiche sull’edificio10, appare infattisempre più chiaro il ruolo di spartiacque trapassato e presente rappresentato dai lavori ese-guiti da Brandi e i suoi restauratori, in partico-lare per i numerosi recuperi di pitture originali.
La natura dei documenti d’archivio del-l’ISCR è varia. Accanto a quelli prettamenteburocratici si trovano anche relazioni tecnichesui restauri eseguiti11, un quaderno di appuntigiornalieri ad uso dei restauratori12 e alcunecarte relative ai risultati di analisi di laborato-rio13. I lavori iniziano nell’agosto del 1948 esi concludono nel dicembre del 1953 tra nu-merose interruzioni − protrattesi in alcuni casianche per un intero anno − dovute principal-mente a problemi di ritardo nello stanziamentodei fondi14.
Le difficoltà economiche dell’Italia tutta inquel periodo sono ben note. Tuttavia, come te-stimoniano le carte d’archivio, altissimo ful’impegno per la realizzazione di questi restaurisia da parte della Soprintendenza che dell’Isti-tuto. E del resto, non è forse un caso che tra gliattori principali di questo intervento, accantoall’ICR nella figura di Cesare Brandi, si distin-sero due personaggi importanti del panoramadella conservazione e del restauro dei monu-menti italiani nel periodo pre e post-bellico, va-le a dire Mario Guiotto e Armando Dillon,quest’ultimo succeduto al primo nell’incaricodi Soprintendente ai Monumenti della SiciliaOccidentale15.
Durante i cinque anni di lavoro Brandi sireca alla Palatina diverse volte per seguire, mo-nitorare e valutare da vicino il lavoro dei suoi re-stauratori, molti dei quali erano ex-allievi diplomati
UN ILLUSTRE INEDITO. L’ISTITUTO CENTRALE PER IL
RESTAURO E LA PRIMA CAMPAGNA DI RESTAURI DEI SOFFITTI
DELLA CAPPELLA PALATINA DI PALERMO (1948-1953)
Francesca Anzelmo
nel corso dei primi due cicli della scuola dell’I-stituto. Restauratori formatisi dunque secondogli orientamenti fondativi dell’ICR e sull’iterdelle elaborazioni di pensiero dello stesso Brandi16.
L’innovativo profilo teorico e metodologicodel giovane Istituto emerge immediatamentegià ad una prima analisi della documentazionecartacea e fotografica conservata all’ISCR.
Vi si colgono tutti gli elementi di unavisione nuova dell’intervento di restauro intesocome azione critica, nell’ambito del quale, aifini di una corretta definizione della metodologiada adottare, diventano necessari una serie dipassaggi propedeutici all’intervento diretto, fi-nalizzati ad una conoscenza approfondita del-l’opera. Veniamo a sapere ad esempio che ilavori furono preceduti sia da una campagnadi indagini preliminari sui materiali costitutividelle pitture dei soffitti (tanto quelle originaliquanto le ridipinture successive) sia da unostudio delle vicende conservative17. Il valoreattribuito da Brandi ad una adeguata docu-mentazione dello stato conservativo dell’operaprima dell’inizio dei restauri, così come degli
interventi eseguiti, si coglie nell’importanzaassegnata alle riprese fotografiche (in bianco enero e a colori) alle quali Brandi fa spesso ri-ferimento nelle sue lettere al soprintendente eai restauratori18. Queste fotografie, adempiendopienamente alle esigenze di documentazioneper le quali furono realizzate, si sono rivelateuno strumento efficacissimo per la ricostruzionedegli interventi.
Senza dubbio la pubblicazione di tuttoquesto materiale fotografico (si tratta di centinaiadi foto) costituirebbe uno strumento utilissimoper i futuri studi sulle pitture19. Al momentoperò l’unica possibilità è la consultazione inloco20. È tuttavia possibile farsi un’idea dell’o-perato dell’ICR raffrontando il catalogo di im-magini della monografia di Monneret de Villard− nel quale si fotografa lo stato dei soffittiprima degli interventi del 1948-195321 – con ladocumentazione fotografica a colori presentenelle pubblicazioni di Francesco Gabrieli eUmberto Scerrato e di Ernst Grube e JeremyJohns, dove si trova documentata una partedelle pitture restaurate dall’Istituto22.
474 FRANCESCA ANZELMO
FIG. 1 Palermo, Cappella Palatina, soffitto della navata centrale, 1143 ca. Integrazione a tratteggio eseguita durante i restauri dell’ICRcondotti fra il 1948 e il 1953 (da F. GABRIELI, U. SCERRATO, Gli arabi in Italia, p. 80, fig. 84)
475L’Istituto Centrale per il Restauro e la prima campagna di restauri dei soffitti della Cappella Palatina di Palermo (1948-1953)
Ritornando alle carte d’archivio, gli scambidi lettere tra il direttore dell’Istituto e i restauratorisono inoltre interessanti perché restituisconoassaggi del clima di condivisione di riflessioniche animava l’Istituto23 nonché «delle prime si-stemazioni di metodo che Brandi andava ope-rando»24 e che avrebbero trovato un loro ordi-namento nella sua Teoria del Restauro del196325. Nelle carte, si scorgono infatti, calatisulle contingenti esigenze del versante operativo,ragionamenti sui criteri di intervento da adottareper le ridipinture e sul trattamento delle grandie piccole lacune da integrare con la giovanissimatecnica del tratteggio verticale (fig. 1)26.
I documenti scritti e le fotografie pre epost-restauro fanno risaltare inoltre quello chepare essere stato il macro obiettivo fondamentaledell’intervento dell’Istituto, ovvero il recuperodelle pitture originali.
Molti sono in effetti i dipinti – in alcuni
casi si tratta di interi brani pittorici – che i re-stauratori riportano alla luce rimuovendo le ri-dipinture.
Tra le pitture originali recuperate figuranoad esempio alcune composizioni iconografichedi contenuto narrativo che, per quanto non deltutto ‘decifrate’ nel loro possibile significatooriginario, ampliano in modo interessante il pa-norama dei soggetti dipinti27.
In altri casi, i recuperi si sono rivelati utiliin relazione agli aspetti legati allo stile dellepitture.
A questo proposito, interessanti considera-zioni ha stimolato il singolare personaggio delsoffitto settentrionale, celato per lungo tempoal di sotto di ridipinture (XVIII secolo? XIXsecolo?) eliminate dall’Istituto (figg. 2-3)28.Nei tratti del volto di questa figura è stata rico-nosciuta una tipologia assente nelle pitture del-la navata centrale e si è ipotizzata la presenza
FIG. 2 Palermo, Cappella Palatina, pitture del soffitto della navatalaterale nord prima del restauro (da U. MONNERET DEVILLARD, Le pitture musulmane, fig. 10)
FIG. 3 Palermo, Cappella Palatina, pitture del soffitto della navatalaterale nord recuperate dai restauratori dell’ICR durante irestauri condotti fra il 1948 e il 1953 (foto dell’autore)
di uno «stile insulare» tra le pitture di matriceislamica della Cappella29.
A volte la rimozione dei rifacimenti ha por-tato alla luce quello che potrebbe essere consi-derato un disegno preparatorio, offrendoelementi di riflessione sia sui procedimenti tec-nici sia di confronto con altre pitture medievali,in particolare di tradizione islamica30.
È vero che alcuni casi di recupero possonoapparire oggi un po’ troppo ostinati se si con-sidera lo stato estremamente lacunoso e piattodegli originali svelati31. Forse talvolta sarebbestato più opportuno non rimuovere le ridipin-ture delle quali, tuttavia, lo abbiamo già ricor-dato, rimane una testimonianza importantenella ricca documentazione fotografica relativaallo stato delle pitture prima dell’intervento.
È stata inoltre evidenziata la poca accortez-za di certi risarcimenti pittorici che hanno ri-costruito in modo goffo porzioni più o menopiccole di pittura (oggetti, parti del viso ecc.)32.Fortunatamente si tratta di casi rari rispetto alla
vastità e allo stato conservativo del tessuto pit-torico restaurato a quel tempo. Quasi sempre,fra l’altro, questo tipo di integrazioni pittoricherisultano facilmente circoscrivibili33.
Se si escludono i pochi casi di scelte ope-rative in parte discutibili, credo si possa essered’accordo nel riconoscere ai restauri dell’ICRil merito di aver offerto al mondo accademicola ricchezza e la varietà di temi che sono statifondamentali per i successivi studi sulle pitturepalatine. Nella valutazione ‘a posteriori’, nonbisogna del resto trascurare anche la partico-lare attenzione con la quale sono state restau-rate quelle rifiniture decorative delle pittureche non erano più molto leggibili. Mi riferiscoad alcuni particolari della decorazione dellevesti, delle aureole, dei corpi degli animali,che l’accurata pulitura, attentamente calibratasul criterio, essenziale per l’ICR, di non giun-gere mai al puro colore, ci ha restituito, donan-doci importantissimi dettagli di stile e qualitàartistica34.
476 FRANCESCA ANZELMO
1 Oggi ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione edil Restauro).
2 Alcune notizie su questi restauri si trovano in: L. TRIZ-ZINO, La Cappella Palatina di Palermo. Dalle OpereFunzionali al restauro. Dal Ripristino alla Tutela, Palermo1983, p. 29; M. LI CASTRI, T. CAMPISI, G. FATTA,Timbered Roofs and Ceilings of the Palatina Chapel inPalermo, in Proceedings of the 15th International Symposiumof the IIWC, Istanbul, Turkey, September 20th 2006 (fonteinternet: http: //www.icomos.org/iiwc/2006.htmP); P. PA-STORELLO, C. TOMASI, Conservazione e presentazioneestetica della Cappella Palatina di Palermo, in Die CappellaPalatina in Palermo. Geschichte, Kunst, Funktionen, For-schun ser ebnisse der Restaurierun H. im Auftra der StiftunWürth von Thomas Dittelbach, Künzelsau 2011, pp. 329-342, in part. pp. 334-335.
3 Sulla nascita (1939) e sulle attività dell’Istituto Centraledel Restauro cfr. La teoria del restauro nel Novecento: daRiegl a Brandi. Atti del Convegno Internazionale, Viterbo,12-15 novembre 2003, a cura di M. Andaloro, Firenze2006; Omaggio a Cesare Brandi nell’anno del centenariodella nascita, a cura di C. Bon Valsassina, Firenze 2008.
4 Vedi A. ALTIERI, G. PRISCO, Il Bollettino dell’IstitutoCentrale del Restauro (1950-1967), in Omaggio, cit., pp.113-122.
5 Cfr. M.I. CATALANO, Brandi e il Restauro. Percorsidel pensiero, Fiesole 1998, pp. 42-54; G. FAZIO, P. MI-RACOLA, Protezione e recupero del patrimonio culturaledurante la Guerra, in Omaggio, cit., pp. 189-198.
6 Archivio storico-amministrativo, Istituto Superiore per
la Conservazione ed il Restauro (d’ora in poi ASAISCR),‘Cappella Palatina’, classificazione ‘II A1’, titolo ‘Palermo’.Il primo documento è del 22 maggio 1948; l’ultimo,invece, del 15 dicembre 1953.
7 Archivio fotografico documentazione restauri, IstitutoSuperiore per la Conservazione ed il Restauro (d’ora inpoi: AFDRISCR): otto Faldoni segnati come N.AS 0266/01(D1188), N.AS 0266/02 (D1188), N.AS 0266/03, N.AS0266/04 (D1188).
8 I risultati delle ricerche d’archivio sui lavori dell’ICRnei soffitti palatini sono presentati in modo dettagliatodalla sottoscritta: I soffitti della Cappella Palatina diPalermo e l’Orizzonte Mediterraneo, tesi di dottorato inMemoria e materia dell’opera d’arte attraverso i processidi produzione, storicizzazione, conservazione, musealiz-zazione, XXV ciclo (Università degli Studi della Tuscia),tutor Maria Andaloro, Viterbo 2013.
9 P. PASTORELLO, C. TOMASI, Conservazione e pre-sentazione estetica, cit., pp. 329-342. Alcune interessantiosservazioni sull’ultimo restauro 2005-2008 si trovano inJ. JOHNS, Le pitture del soffitto della Cappella Palatina,in La Cappella Palatina a Palermo, a cura di B. Brenk,Modena 2010, vol. I Saggi, p. 393 (Mirabilia Italiae, 17).
10 La Cappella Palatina a Palermo, a cura di B. Brenk,voll. 4 (Saggi, Schede e Atlante fotografico), Modena2010 (Mirabilia Italiae, 17); Die Cappella Palatina, cit. Èin corso di pubblicazione un’altra importante monografiasui soffitti: L. KAPITAIKIN, The Twelfth-Century Paintingsof the Ceilings of the Cappella Palatina, Palermo, Tesi diDottorato, University of Oxford, anno 2011.
477L’Istituto Centrale per il Restauro e la prima campagna di restauri dei soffitti della Cappella Palatina di Palermo (1948-1953)
11 Le relazioni tecniche, molto dettagliate e accompagnateda fotografie e/o da grafici. Insieme ad alcune lettere epreventivi, forniscono diverse informazioni sui materialiutilizzati per il restauro. Vedi F.M. ANZELMO, I soffittidella Cappella Palatina, cit.
12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 Il restauro viene eseguito dalla Soprintendenza ai Mo-
numenti con fondi stanziati dal Ministero della PubblicaIstruzione-Direzione Generale delle Antichità e Belle Artialla Regione Sicilia (ASAISCR, II A1, Prot. 168, 2 febbraio1951). Delle 2.500.000 lire (ASAISCR, II A1, Prot. 282,22 maggio 1948) previste, solo 1.050.000 lire vennero ef-fettivamente messe a disposizione per il restauro delsoffitto centrale nel febbraio del 1949 (ASAISCR, II A1,23 febbraio 1949). Difficoltà maggiori incontrarono ilavori alle coperture delle navate laterali per la quali,stando ai documenti, furono alla fine previste circa 500mila lire (ASAISCR, II A1, Prot. 112, 18 febbraio 1952).
15 Vedi G. SCATURRO, Danni di guerra e restauro deimonumenti. Palermo 1943-1955, Tesi di Dottorato in Con-servazione dei Beni Architettonici, XVI ciclo (2004-2005),Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in part. pp.32-122.
16 Sui nomi dei restauratori si veda F. ANZELMO, Isoffitti della Cappella Palatina, cit. Sulla scuola dell’Istitutoai tempi di Cesare Brandi vedi: C. BONVALSASSINA,Restauro made in Italy, Milano 2006, pp. 37-46; M.L.S.SPAMPINATO, La Scuola di Brandi, in Omaggio, cit.,pp. 123-126.
17 Vedi F.M. ANZELMO, I soffitti della Cappella Palatina,cit.
18 Ibidem.19 Fatta eccezione per alcuni scatti, le fotografie non ri-
traggono singolarmente i numerosi e diversi pannelli dei tresoffitti, quanto piuttosto insiemi di pannelli di una determinataporzione di questa o di quella copertura. Non è dunque pos-sibile esaminare le pitture nei dettagli. Gioverà senza dubbioalla ricerche future il lavoro di digitalizzazione di tutte lefotografie relative ai restauri, in corso presso l’ISCR.
20 Nel catalogo digitale relativo alle tipologie di vesti,copricapo e motivi ornamentali dei tessuti dipinti neisoffitti, allegato alla tesi di Dottorato della sottoscritta(supra, nota 8), sono state riportate anche informazioni ri-guardanti i restauri dell’ICR. Si è voluto in questo modofornire un primo contributo per una più corretta letturadelle pitture che ne costituiscono l’oggetto.
21 U. MONNERET DE VILLARD, Le pitture musulmaneal soffitto della Cappella Palatina di Palermo, Roma1950. Sulla campagna fotografica realizzata tra luglio1947 e maggio 1948 e pubblicata da Monneret de Villardvedi gli studi di Silvia Armando. S. ARMANDO, UgoMonneret de Villard (1881-1954) and the establishment ofIslamic Art Studies in Italy («Muqarnas» 2013, c. s.).
22 F. GABRIELI, U. SCERRATO, Gli Arabi in Italia,Milano 1979; E. J. GRUBE, J. JOHNS, The Painted Ceilingsof the Cappella Palatina (Supplement I to Islamic Art),
Genova-New York 2005, p. 26, plates I-LV. Un altroimportante catalogo a colori è conservato presso il KhaliliResearch Centre dell’Università di Oxford (una copia è stataanche digitalizzata). Cfr. J. JOHNS, Le pitture del soffitto,cit., p. 392; A.L. KAPITAIKIN, The Twelfth-Century Paintingsof the Ceilings, cit. Sulle pitture in seguito all’ultimo restauro(2005-2008) vedi La Cappella Palatina, Atlante, cit.
23 Cfr. C. BONVALSASSINA, Restauro, cit., pp. 39-55.24 C. Brandi, Il restauro. Teoria e pratica, a cura di M.
Cordaro, con postfazione di G. Basile, Roma 2005, p. XVI. 25 C. BRANDI, Teoria del restauro, Roma 1963. 26 Vedi documenti in F. ANZELMO, I soffitti della
Cappella Palatina, cit. Sulla tecnica del tratteggio cfr.Mostra dei frammenti ricostruiti di Lorenzo da Viterbo,catalogo a cura di C. Brandi, Roma 1946; M.I. CATALANO,Brandi e il Restauro. Percorsi del pensiero, Firenze 1998,pp. 42-54. Sebbene certi criteri del tratteggio verticale delrestauro dei soffitti palatini degli anni 1948-1953 sianostati ulteriormente perfezionati dalle più recenti sistemazionidella tecnica, il lavoro di quegli anni è di fatto entrano aparte della storia dei restauri ed è stato a sua volta restauratonel corso dell’ultima campagna di lavori. Vedi P. PASTO-RELLO, C. TOMASI, Conservazione e presentazioneestetica, cit., pp. 334-335.
27 Solo per citare un esempio, ricordiamo i due pannellialla base del muqarnas con la rappresentazione curiosa diun Cavaliere in fuga da un leone recuperati al di sotto difigure di Santi (XVI secolo?) molto rimaneggiate. Cfr. U.MONNERET DE VILLARD, Le pitture musulmane, cit.,figg. 20, 24 (prima dei restauri ICR) e La CappellaPalatina, cit., vol. Atlante, figg. 478, 530 (stato attuale delpannello dopo il restauro dell’ICR). L’iconografia dellacomposizione pittorica originale dei due pannelli, per laquale non sono stati rintracciati al momento paralleli im-mediati in ambito artistico, è stata esaminata da J. Johnsanche in relazione alle favole del ciclo del Kalila wa-Dimna, le cui prime illustrazioni di ambito arabo pervenuterisalgono al 1220 e appartengono al settore della miniatura.Vedi J. JOHNS, Schede soffitti, in La Cappella Palatina aPalermo, cit., pp. 567-568.
28 F. ANZELMO, I soffitti della Cappelle Palatina, cit. 29 J. JOHNS, Schede soffitti, in La Cappella Palatina a
Palermo, cit., vol. Schede, p. 439. 30 Vedi La Cappella Palatina a Palermo, cit., vol. Atlante,
figg. 932-933; J. JOHNS, Schede soffitti, in La CappellaPalatina a Palermo, cit., vol. Schede, p. 637; L. KAPI-TAIKIN, The Twelfth-Century Paintings, cit., vol. I, pp.47-50.
31 Vedi ad esempio: La Cappella Palatina a Palermo,cit., vol. Atlante, fig. 965.
32 J. JOHNS, Le pitture del soffitto della CappellaPalatina, in La Cappella Palatina a Palermo, cit., vol.Saggi, p. 392.
33 Ibidem. 34 Molti di questi dettagli accuratamente restaurati dal-
l’Istituto sono riportati nel catalogo digitale delle pitturedei soffitti. Cfr. supra, nota 20.