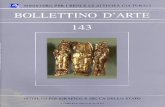I Monumenti della Patria: restauri monumentali nell'Italia unita (1861-1961). Il completamento del...
Transcript of I Monumenti della Patria: restauri monumentali nell'Italia unita (1861-1961). Il completamento del...
architettura e arteDeL principato meDiceo
€ 75,00
a
rchi
tett
ura
e a
rte
del p
rinc
ipat
o m
edic
eo
a cura di Ferruccio canali
Vasari, gli Uffizi e Michelangelo: dall’ ‘invenzione’ del Rinascimento
al mito di Firenze
La Società di Studi Fiorentini ha inteso ricordare con questi due “Bollettini SSF” – il n.22 e il n.23, riuniti sotto un unico titolo “Architettura e Arte del Principato mediceo [1512-1737]. Vasari, gli Uffizi e Michelangelo: dall’’invenzione’ del Rinascimento al mito di Firenze” – la ricorrenza dei 500 anni dalla nascita di Giorgio Vasari (1511-2011) e i 450 anni dalla morte di Michelangelo Buonarroti (1564-2014), due Artisti e Architetti sommi che hanno contribuito, attraverso il Genio (Michelangelo) e la Norma (la sistematizzazione vasariana), alla Cultura dell’Umanità, con lasciti che sono poi rimasti fermenti vitali per le epoche successive e nei contesti più vari. Da una parte il ‘racconto’ delle “Vite” vasariane, quale fonte primaria per la nascita della moderna Storia dell’Arte e l’impianto della Galleria degli Uffizi, quale concretizzazione somma, nei secoli successivi, di quel racconto; dall’altra la Bellezza e l’Armonia raggiunte dalle forme michelangiolesche, sono divenute acquisizioni che hanno interessato generazioni di Uomini, che si sono avvicinati all’Arte e alla Cultura del Principato mediceo, specie nella sua ‘stagione dell’Oro’ cinquecentesca, cercandone modelli e suggestioni ritenute sempre spendibili nella Contemporaneità. Una stagione che ha dunque raggiunto vertici sommi, sia di produzione teorica sia artistica, e che ha costituito un vero e proprio “Indimenticabile Antico” per tutta l’Umanità.
Timed to coincide with the 500th anniversary of the birth of Giorgio Vasari (1511-2011) and the 450th anniversary of the death of Michelangelo Buonarroti (1564-2014), issues n.22 and n.23 of the SSF Bulletins have been united under the singular title of “Architecture and Art of the Medici Principality (1512-1737): Vasari, the Uffizi and Michelangelo From the invention of the Renaissance to the myth of Florence”. Within these issues the Society of Florentine Studies wishes to remember these two master artist-cum-architects who, through the genius of Michelangelo and the systemisation of Vasari contributed to the heritage of Humanity, leaving a legacy which proved vital to the fermentation of future generations in numerous different contexts. Through the “Lives of the Artists”, a primary source of the birth of modern Art History, and the systemisation of the Uffizi Gallery, Vasari left a legacy, both written and systematic, which was to be cemented over the following centuries. Michelangelo, on the other hand, gifted the world with the beauty and harmony achieved through his forms. These legacies affected generations of men who, in a quest to find models or examples for the contemporary world, looked to the art and culture of the Medici principality, especially in its “Golden Age”. It was an age that reached the highest apex both in theoretical and artistic terms, and that created a truly “Unforgettable Ancientness” for all mankind.
2013
222014
232013
222014
23
BoLL
etti
no
DeL
La S
oc
di Maria Margherita Bulgarini
BoLL
etti
no
SSF
So
cie
tÀ D
i Stu
Di F
ior
enti
ni
ietÀ
Di S
tuD
i Fio
ren
tin
i
SocietÀ Di StuDi Fiorentinianno 2013-2014
La Società di Studi Fiorentini è una Associazione culturale, che si prefigge la promozione, con spirito scientifico, di studi di argomento fiorentino, favorendo la conoscenza della illu-stre civiltà fiorentina presente anche in altre realtà geografiche. L’Associazione promuove cicli di conferenze, dibattiti, convegni i cui esiti confluiscono nella pubblicazione di scritti e saggi raccolti in collane di studi («BSSF - Bollettino della Società di Studi Fiorentini» e «Letture»). La Società si rivolge pertanto a tutti coloro che, avendo a cuore i molteplici aspetti della ‘Fiorentinità’, siano interessati, associandosi ad essa, a seguire il progresso degli studi o a inviare i loro personali contributi scientifici.
The Società di Studi Fiorentini (Florentine Studies Society)) is a cultural Association that promotes scholarly studies concerning Florentine topics, which aim at giving greater insight to the illustrious Florentine civilisation and of its presence in other geographical areas. The Association promotes conferente cycles, debates, meetings and publishes all papers and essays delivered in a studies series («BSSF - Bollettino della Società di Studi Fiorentini» and «Let-ture»). The Society, therefore, addresses to all those who, taking to heart the multiple aspects of ‘Florentinism’ (Fiorentinità), are interested in becoming a member in order to follow the studies progress; or to those who wish to submit and share their own personal scientific con-tributions.
Società di Studi Fiorentinie.mai: [email protected] <http://www.societastudifiorentini.it> Facebook: societastudifiorentini ovvero societastudifiorentini
Per associarsiAssociazione Studi FiorentiniVia del Pino, 3 - 50137 FirenzeConto Corrente Postale: 14048508IBAN: IT25 D076 0102 8000 0001 4048 508
L’adesione dà diritto al Socio: di ricevere il numero dell’anno relativo del «Bollettino della Società di Studi Fiorentini»; di partecipare alle iniziative societarie; di collaborare alle pubblicazioni, previa accettazione dei saggi da parte della Redazione del «Bollettino» sulla base della programmazione editoriale. L’ammontare dell’associazione è stabilito di anno in anno. Per Enti, Biblioteche, Musei, etc., tale quota è sempre assimilata a quella prevista per i Soci Sostenitori.
Quote per gli anni 2013 e 2014Socio Sostenitore (e per Soci eletti nelle diverse cariche sociali): € 80.00Socio Ordinario € 40.00
Presidente
Virgilio Carmine Galati
economo
Ferruccio Canali
consiglio direttivo
Soci fondatoriFerruccio CanaliGiorgio CaselliCarlo FranciniVirgilio Carmine GalatiFrancesco Quinterio ( )
Soci designatiValerio Cantafio CasamaggiGiovanna De LorenziOlimpia NiglioCarlo PicchiettiAlessandro Uras
anno 2013 vicePresidente
Valerio Cantafio Casamaggi
direttore scientifico
Ferruccio Canali
collegio dei Probiviri
Giorgio Zuliani (Presidente)Enrica MaggianiGabriele Morolli
collegio dei revisori dei conti
Paola Pesci (Presidente)Bombina Anna GodinoAntonella Valentini
Presidente
Virgilio Carmine Galati
economo
Ferruccio Canali
consiglio direttivo
Soci fondatoriFerruccio CanaliGiorgio CaselliCarlo FranciniVirgilio Carmine GalatiFrancesco Quinterio ( )
Soci elettiGiuseppe ContiGiovanna De LorenziCarlo PicchiettiStefano PaganoAlessandro Uras
vicePresidente
Alessandro Uras
direttore scientifico
Ferruccio Canali
collegio dei Probiviri
Giorgio Zuliani (Presidente)Enrica MaggianiOlimpia Niglio
collegio dei revisori dei conti
Paola Pesci (Presidente)Bombina Anna GodinoAssunta Mingrone
anno 2014
ARCHITETTURA E ARTE DEL PRINCIPATO MEDICEO (1512-1737)MICHELANGELO E LA FORTUNA DELLA FIRENZE
DEL CINQUECENTO
a cura di Ferruccio Canali
ANNO 2014 NUMERO 23
Collana di studi storici
per i 450 anni dalla morte di Michelangelo Buonarroti
(1564-2014)
BOLLETTINO SSFDELLA SOCIETÀ DI STUDI FIORENTINI
«BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ DI STUDI FIORENTINI»
comitato di lettura e di redazioneferruccio canali, valerio cantafio casamaggi, virgilio carmine galati, stefano pagano, francesco quinterio (†), alessandro uras direttore scientifico: ferruccio canali
soci corrispondentimaria beatrice bettazzi (emilia), vittoria capresi (il cairo-egitto), tommaso carrafiello (napoli-campania), bombina anna godino (calabria), enrica maggiani (liguria), olimpia niglio (kyoto-giappone), valentina orioli (romagna), massimiliano savorra (molise), leonardo scoma (sicilia), simona talenti (salerno-campania), karin templin (inghilterra), maria antonietta uras (sardegna), vincenzo vandelli (emilia), giorgio zuliani (trieste e istria)
comitato scientifico italianoferruccio canali (università di firenze), giuseppe conti (università di firenze), giovanna de lorenzi (università di firenze), virgilio carmine galati (università di firenze), valentina orioli (università di bologna), massimiliano savorra (università del molise), simona talenti (università di salerno), ulisse tramonti (università di firenze), stefano zagnoni (università di ferrara)
comitato scientifico internazionalevittoria capresi (università germanica al cairo – egitto), romeo carabelli (università di tours – francia), roberto goycoolea prado (università alcalà di madrid - spagna), adriano marinazzo (muscarellle museum of art - va,usa) olimpia niglio (università di kyoto-giappone), david rifkind (università di miami - fl,usa), karin templin (school of architecture and landscape, kingston university, londra)
Proprietà letteraria e artistica: divieto di riproduzione e di traduzioni. La Direzione della Collana Editoriale, i Membri dei Comitati Scientifici e l’Editore non si assumono responsabilità per le opinioni espresse dagli Autori, né per la corresponsione di eventuali Diritti di Riproduzione gravanti sulle singole immagini pubblicate (i costi di tali eventuali Diritti d’Autore ricadranno infatti unicamente sull’Autore/i del saggio/i liberando sia la Direzione editoriale sia l’Editore di ogni eventuale obbligo al proposito); tale liberatoria resta comunque valida unicamente per l’edizione del contributo scientifico cui tali immagini sono connesse. È la Redazione che si prende cura della correzione delle bozze, per cui i testi consegnati dagli Autori vengono considerati definitivi. L’invio di contributi per la pubblicazione non implica né l’edizione degli stessi (per ogni contributo una “Valutazione di accettazione” verrà espresso dalla Direzione o dal Curatore/i che possono consigliare o ritenere indispensabili integrazioni o puntualizzazioni sia scientifiche sia bibliografiche sia redazionali da parte degli Autori, tanto da poter eventualmente esprimere anche parere negativo alla pubblicazione del materiale inviato); né una loro edizione immediata (i tempi verranno infatti stabiliti di volta in volta sulla base delle priorità o delle esigenze editoriali indicate dalla Direzione o dal Curatore/i, in relazione alla preparazione di numeri monografici). I materiali grafici e fotografici inviati, oltre che i testi, verranno comunque soggetti, sia come dimensione di pubblicazione sia come numero, al progetto editoriale approntato. Non si restituiscono i dattiloscritti, né le immagini, né i disegni pubblicati o non; il materiale inviato viaggia a rischio del mittente. La pubblicazione di foto, disegni e scritti da parte degli Autori implica la loro totale rinuncia alla corresponsione di ogni compenso di Diritto d’Autore o di rimborso spese sia da parte della Direzione sia da parte dell’Editore, trattandosi di pubblicazione scientifica e senza fini di lucro. Al momento dell’edizione le presenti condizioni si considerano accettate, anche tacitamente, da parte degli Autori a partire dalla consegna dei testi per la stampa (che da parte degli Autori è quella di inoltro alla Direzione al Curatore/i).
referee - peer reviewI contributi scientifici inviati vengono valutati, per conto della Direzione e del Curatore, ai fini della procedura di peer review, da un Lettore interno, membro della Redazione, e da un secondo Lettore, individuato come Esperto (adottando la procedura di clear peer review, con indicazione, in ogni saggio, dei due Lettori). Segue poi un la valutazione finale da parte di un Lettore anonimo (blind peer review).
ARCHITETTURA E ARTE DEL PRINCIPATO MEDICEO (1512-1737) MICHELANGELO E LA FORTUNA DELLA FIRENZE DEL CINQUECENTO«Bollettino SSF» », 23, 2014ideazione e cura scientifica di Ferruccio Canaliprogetto e cura grafica: sbaf – firenze (Ferruccio Canali e Virgilio Carmine Galati)revisione editoriale: Maria Natalina Brigliadorirevisioni e traduzioni in inglese: Karin Templin
copertina, logo e fascetta grafica: Virgilio Carmine GalatiI disegni presenti in questo volume sono di Ferruccio Canali (pp. 8, 114, 260); Virgilio C.Galati (pp. 6, 278)
Il «Bollettino» è stato registrato presso il Tribunale di Firenze al n.4777 del 2 marzo 1998 fino all’anno 2002. Poi è stato trasformato in “Collana editoriale” non potendo garantire regolari uscite periodiche. Il «Bollettino» è registrato nel sistema U-GOV (sistema per la governance degli Atenei universitari italiani del “Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica”) con codice: ISSN 1129-2800. Il “Bollettino” è compreso nella “Lista delle Riviste Scientifiche” dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca della Repubblica Italiana) aggiornata al 10 febbraio 2014.
Finito di stampare nel Novembre 2014 da Litografia I.P., Via Giovanni Boccaccio 26 rosso, 50133 Firenze
ISSN 1129-8200 - ISBN 978-88-89999-84-4
Copyright 2014 by emmebi edizioni firenze-Proprietà letteraria riservata.
77BOLLETTINO SSF, 23, 2014
Molte fabbriche monumentali, assai note e ormai oggi parte dell’immaginario collettivo, sono il frutto, in verità, di stratificazioni, completamenti e modificazioni avvenute nei secoli; trasformazioni che sono ovviamente ‘sfuggite’ alla mano del
«STUDIATA L’OPERA DEL BUONARROTI ... SE NE INTENDONO SEGUIRE LE ORME»: IL COMPLETAMENTO DEL VESTIBOLO
MICHELANGIOLESCO DELLA BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA E I PARERI DI ADOLFO AVENA, LUCA BELTRAMI, GIACOMO BONI,
GUGLIELMO CALDERINI, GUSTAVO GIOVANNONI, GIUSEPPE POGGI ED ERNESTO BASILE (1880-1905)
Le cautele ministeriali e il dibattito nella Cultura fiorentina (con il coinvolgimento di Guido Carocci, giuseppe Castellucci, luigi del Moro, Cesare spighi ed Agenore socini)
Ferruccio Canali
abstract: Anche il Vestibolo - o Ricetto, cioè l’ambiente d’ingresso con la grande scala centrale “ovata” – della Biblioteca Medicea Firenze appare oggi come il frutto di un intervento di «Restauro di completamento» compiuto tra la fine dell’Ottocento e i primissimi anni del Novecento (1905), per restituire all’incompiuta fabbrica di Michelangelo la sua ‘doverosa’ unitarietà. Duramente stroncato dalla Critica successiva, quell’intervento – progettato da Cesare Spighi e realizzato però da Giuseppe Castellucci, con il coordinamento del Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana Agenore Socini e sotto la supervisione di Giacomo Boni della Direzione delle Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione - venne eseguito, in riferimento alla parte sommitale interna e alle pareti esterne, con le attenzioni filologiche e con le cautele allora ritenute più scientifiche così da essere approvato dal alcuni dei maggiori Architetti del momento interpellati dal Ministero, come Adolfo Avena, Luca Beltrami, Giuseppe Calderini, Gustavo Giovannoni, Giuseppe Poggi ed Ernesto Basile.
The Vestibule or Ricetto - that is the environment entry with the large central staircase “ovata” – of the Mediceo Laurenziana Library in Florence appears today as the result of an intervention, “Restoration of completion” made in the late Nineteenth and the early years of the Twentieth century (1905), to return the unfinished project of Michelangelo its ‘rightful’ unity. Critics panned hard by the next, that intervention - designed and built by Caesar Spighi but realized by Giuseppe Castellucci, in coordination with the Directors of the “Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana” Luigi del Moro and Agenore Socini, and under the supervision of Giacomo Boni for the “Direzione delle Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione” - was carried out, referring to the top part of the interior and exterior walls, with philological care and caution then considered the most scientific way to be approved by some of the leading architects of the time surveyed by the Ministry, as Adolfo Avena, Luca Beltrami, Giuseppe Calderini, Gustavo Giovannoni, Giuseppe Poggi and Ernesto Basile.
peer review: virgilo c. galati e sara romano.
1 Riguardo alla questione della terminazione del Ricetto nella sua porzione più alta, si era aperta una disputa già nel 1525 tra Michelangelo e il committente, papa Clemente VII Medici: «poco prima del 29 novembre Michelangelo scrive a Roma di essere “risoluto a fare il ricetto”, nella stessa data Clemente VII obietta al progetto michelangiolesco che “le finestre sopra tetto [cioè quelle poste alla quota più alta, svettante rispetto alla copertura della vicina Biblioteca] con quelli occhi di vreto [cioè i lucernari] nel palco [il soffitto]” sebbene “cosa bella et nova” sono di assai difficile manutenzione ... Il 23 dicembre Clemente VII fa rispondere che “alzando el muro [sommitale] duo braccia per fare le finestre” come propone Michelangelo occorre verificare “s’el reggerà el peso et farà danno alla fabrica” ... Esclusa dunque da Clemente VII nel novembre 1525 la proposta di abolire il piano superiore [cioè di non alzare la quota del Ricetto], spostando gli occhi sul tetto [cioè di fare il lu-cernaio] ... Michelangelo accetta la controproposta di sopraelevare di due braccia il corpo del Ricetto, rinunciando così all’u-nitarietà esterna della fabbrica [Ricetto/Biblioteca]: la scelta in favore di una copertura piana invece di una più ingombrante a volta, permetteun’ulteriore elevazione che, al gennaio 1526 ... deve essere definita [progettualmente] in tutto ... Infatti, il 2 gennaio 1526 [viene comunicato a Michelangelo] di “esser[si] cominciato a fondare e’ ricetto”» (con riferimento al “Carteggio michelangiolesco” in B.contardi, Biblioteca Laurenziana [1519-1559] in g.c.argan e b.contardi, Michelangelo architetto, Milano, 1990, pp.186-187). Però, una serie di travagli economici per il Papa (culminati poi nel Sacco di Roma con la discesa dei Lanzichenecchi del 1527) facevano comunicare all’Architetto già nel luglio del 1526 che il Pontefice «“nella libreria per hora non vole si spenda tanto” e il 16 ottobre che “del palco della libreria per ora nonne vole fare niente”»; una situazione che si
primo Progettista, ma che costituiscono ormai per noi l’immagine ‘consolidata’ di ciascuna fabbrica monumentale. È questo il caso, tra gli altri, anche del famosissimo “Ricetto” o Vestibolo1 – cioè l’ambiente d’ingresso con la
FERRUCCIO CANALI78
grande scala centrale “ovata” – della biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, certo una delle opere più famose di Michelangelo, avviata nel 1519 e giunta, tra alterne vicende, fino alla sua redazione finale nel 1559 e poi al 1571 – quando tutto il complesso venne ufficialmente inaugurato - ma restata poi per secoli incompiuta nel soffitto del grande Salone e nella parte sommitale del Ricetto, oltre che nella facciata esterna di esso. Un ‘incompiuto’ che, tra Otto e Novecento, portò la Cultura fiorentina e nazionale a decidere di procedere al completamento – per restituire unitarietà al complesso michelangiolesco che veniva sentito come ‘monco’ sia fuori che dentro – e la vicenda, avviata nei primi anni Ottanta del XIX secolo, poté dirsi compiuta solo entro il 1910, quando quel Restauro di Completamento risultò definitivamente terminato. Quell’intervento si poneva, in verità, all’interno di un ben più complesso programma che trovava la propria ragion d’essere nell’ingrandimento di tutta la Biblioteca, nel riassetto definitivo dei Chiostri monumentali, bilicati – dal punto di vista proprietario – tra il Demanio e la Parrocchia di San Lorenzo, oltre che nelle iniziative che avrebbero portato alla proposta per una nuova facciata alla Basilica. Riassumeva Pietro Franceschini, pur sotto l’anonimato della Redazione del “Nuovo Osservatore fiorentivo”2:
«la Laurenziana mancava di una collezione di libri a stampa, come corredo allo studio dei codici; di una sala adatta per gli Studiosi; di un locale di esposizione e dello spazio necessario a collocare convenientemente molti dei codici che vi stanno ancora a disagio. Il ministro Guido Baccelli, quattro anni fa [nel 1882], ordinò al prof. Emilio De Fabris lo studio di un a tribuna per porvi i codici danteschi, servendosi di una pianta triangolare, già ideata dal Buonarroti, per edificare un Gabinetto alla estremità della Sala; ed insieme a questo studio ne commetteva allo stesso De Fabris un altro perché fosse provveduto
al modo più conveniente di pervenire al Vestibolo mediante una nuova scala. Morto quell’architetto, e dimessosi il comm.Baccelli dal grado di Ministro, fu ripresa dal suo successore l’idea di quello studio, commettendo all’architetto Cesare Spighi un progetto più completo, ponendo ad un tempo esso Ministro in bilancio le somme necessarie al compimento del Vestibolo, la cui esecuzione veniva affidata all’Architetto medesimo. Il giovane e zelante artista, studiata l’opera del Buonarrori, non poté trarre della medesima altro concetto d’ingrandimento che quello venuto in idea 60 anni prima al Poccianti [Pasquale], di ripetere cioè sull’altro lato del chiostro sul quale sorge la Libreria, altra Libreria uguale, fino all’aggiunta della Rotonda, che tutti ritengono erronea, rilegando le due sale, come faceva il Poccianti, per la loro estremità con un nuovo braccio, o terza sala ... Non ha posto l’architetto Spighi in questo progetto di ingrandimento la Sala di Studio, riserbandola come cosa separata al piano del Vestibolo e con ingresso da questo; proposta alla quale non ha aderito la “Commissione Conservatrice de’ Monumenti” [fiorentina] né aderisce l’”Osservatore” ... Inutile dispendio sarebbe oggi l’erigere di fronte alla Biblioteca presente un sala perfettamente simile ... per cui la sala che l’architetto dovrebbe innalzare di fronte a quella del Buonarroti può essere della massima semplicità, prendere luce dall’alto e restare intera nelle sue pareti per l’uso dei codici ... Felicissimo sarebbe stato l’architetto Cesare Spighi nella scelta dello spazio per pervenire della Libreria; prende esso per quella via, già scelta dal predecessore Emilio De Fabris, cioè del Sala del Capitolo, che si trova nel chiostro in direzione del Vestibolo stesso .. e proseguendo penetra in un resedio che oggi fa parte della cappella contigua alla Sagrestia [Vecchia] della Basilica ... Concorda la “Commissione Consultiva dei Monumenti” [del Ministero] essere quello senz’altro il partito migliore per condurre l’operazione del primo tratto della nuova scala a dovere; ma è ritenuta e non può
protrasse ancora per anni poiché, al momento della partenza di Michelangelo da Firenze (1533), «nessuno dei quattro prospet-ti del vestibolo poteva essere completato (cfr. J.ackerman, The Architecture of Michelangelo, Londra,1961) ... E così anche gli schizzi del “Taccuino di Lille” ... poi copiati da Oreste Vannocci ... mostrano probabilmente lo stato della Biblioteca Lau-renziana attorno al 1535-1540: di particolare interesse il Ricetto, che è mostrato completo con esclusione del piano superiore in muratura grezza»: contardi, Biblioteca Laurenziana [1519-1559] ..., cit., pp.186-197. Nel 1571, al momento dell’apertura al pubblico della Biblioteca, «le alterazioni recenti riguardano il rimaneggiamento della facciata, con l’aggiunta di un ordine superiore di finestre nel Vestibolo; il completamento delle membrature interne all’ultimo piano del Vestibolo» (J.s.ackerman, L’Architettura di Michelangelo, Torino, 1988, p.187), ma restava la muratura grezza al di sopra.2 Pietro Franceschini (1836-1906), libraio, si mostrava molto attento alla situazione artistica di Firenze, intervenendo, sulle pagine del “Nuovo Osservatore Fiorentino” da lui fondato e uscito negli anni 1885 e 1886, sui principali dibattiti riferiti ai Monumenti cittadini, oltre che sulla ricostruzione di vicende storiche di interesse collettivo (che potevano motivare o indirizzare quegli interventi stessi). Di lui si ricordano, oltre agli articoli pubblicati sul “Nuovo Osservatore Fiorentino”, anche: p.franceschini, Appunti di fiorentino argomento: lavori artistici municipali, Firenze, 1875; idem, Doveri di Firenze e dell’Italia verso il tempio di Santa Croce. Lettere due, Firenze, 1881; idem, Le facciate di Santa Maria del Fiore (1296-1883), Firenze, 1883 (pubblicazione uscita presso l’«Autore libraio»); idem Idem, Santa Maria del Fiore da Arnolfo a Brunellesco, notizia storica. Né tricuspidale né basilicale. Dialoghi critici, Firenze, 1887; idem, Il dossale d’argento del tempio di San Giovanni in Firenze: memoria storica, Firenze, 1894; idem, Per l’arte fiorentina: dialoghi critici (1875-1895), Firenze, 1895; idem, La tomba di Lorenzo dei Medici detto il magnifico [in San Lorenzo), Firenze, 1897; idem, Del restauro del tempio di Santa Trinita in Firenze: notizia storica, Firenze, 1898.
il completamento del vestibolo della laurenziana (1880-1905) 79
concedere all’architetto la sua adesione a procedere per codesta via perché approvando il taglio della cappella necessaria a tale operazione teme di ledere l’opera del Brunelleschi. Ciò che ritiene oggi la Commissione avrebbero ritenuto tutti ed a prima giunta ritenne anche l’”Osservatore”; senonché dovendo egli [cioè Spighi] studiare, siccome ha fatto, il tempio di San Lorenzo in ogni sua pare, osservata la cappella che fu già del Sacramento e veduto che ha un’appendice di fianco che nessuna cappella è necessario abbia ... è venuto nella convinzione che quel resede sia da riguardarsi ... più a carico anche che a vantaggio della estetica del tempio; riflessione che se trovata buona anche dai Commissari, spera l’”Osservatore” che si potrà far riprendere lo studio della scala nel senso ideato dall’architetto Cesare Spighi»3.
Parte dunque di un programma tanto vasto, il completamento del Vestibolo e del soffitto del Sa-lone michelangiolesco, ha costituito un ‘nodo sto-riografico’ singolare, tanto che il giudizio sull’in-tervento - originariamente progettato da Cesare Spighi, portato a termine da Giuseppe Castellucci e coordinato dai Direttori dell’”Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Tosca-na”, prima Luigi del Moro (con il quale Castelluc-ci si era formato) poi Agenore Socini sotto la su-pervisione della Direzione delle Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione nella persona dell’ispettore centrale Giacomo Boni - non è stato affatto positivo nei decenni successivi. Così Bruno Contardi ha posto in evidenza come
«il soffitto del vestibolo e la sistemazione dell’ester-no del Ricetto, incompiuta, sono il frutto di un re-stauro di completamento, arbitrario e non brillan-
te, dei primi anni di questo secolo [Novecento]»4; e ciò dopo che Rudolph Wittkower nel 1934 aveva notato che
«riproducendo le vecchie fotografie Brogi precedenti il restauro di completamento (1903) della facciata del Ricetto, ho notato come prima di quella data la sopraelevazione [originale del muro] di circa un metro fosse ancora visibile»5,
sottintendendo, dunque, la cancellazione di una parte dell’opera michelangiolesca.Sugli assunti, i motivi e le modalità di quel «restauro di completamento» otto-novecentesco vale però la pena di tornare, se non altro perché quell’intervento ci ha restituito l’attuale facies della fabbrica michelangiolesca e compiendo una riflessione che può permettere di valutare, ‘laicamente’, il supposto carattere «arbitrario e non brillante» di quell’intervento, soprattutto alla luce del fatto che, allora, quando esso venne eseguito, anche architetti del calibro di Adolfo Avena, Giuseppe Poggi, Luca Beltrami, Giuseppe Calderini ed Ernesto Basile ne giudicarono le modalità perfettamente scientifiche e soprattutto ‘filologiche’ (e dunque non fu certo «arbitrario». Le ‘Filologie’ che cambiano ... O, più semplicemente, le scelte compiute che non conosciamo davvero... .
1. Il progetto di completamento del Vestibolo di Cesare Spighi, «il più anziano degli Architetti che fanno parte dell’”Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana”»: il parere di Giuseppe Poggi e il coordinamento ministeriale di Adolfo Avena (1885-1887)
Era Cesare Spighi6 che, ai primi nel Novecento,
3 Anonimo [ma p.franceschini], San Lorenzo. XXII. La Biblioteca III, «Il nuovo Osservatore Fiorentino», 53, 31 dicembre 1886, pp.423-425. In precedenza anche: idem, San Lorenzo. XX. La Biblioteca I, ivi, 51, 5 dicembre 1886; idem, San Lorenzo. XXI. La Biblioteca II, ivi, 52, 19 dicembre 1886. I tre articoli, perché fossero noti al Ministro, sono in deposito anche in Roma, ACS, AA.BB.AA., II versamento, 2 serie, b.111, fasc. “1302”.4 contardi, Biblioteca Laurenziana (1519-1559) ..., cit., p.196.5 contardi, Biblioteca ..., cit., p.187. Il riferimento è a r.wittkower, Michelangelo’s Biblioteca Laurenziana, «Art Bullettin», XVI, 1934, pp.113 e segg.6 Il fiorentino Cesare Spighi (1854-1929), formatosi prima presso l’Istituto tecnico provinciale, poi presso l’Accademia delle Belle Arti, fu architetto molto prolifico a Firenze, dove avviò la propria carriera iniziando a lavorare con i più famosi Studi di architettura. In rapporti molto stretti con Ferdinando Martini e dunque Assessore ai Lavori pubblici dell’Amministrazione comunale, dopo essere entrato nei ruoli della Tutela dei Monumenti nel 1891 presso l’”Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana” come “Architetto ingegnere”, dal 1892 al 1894 rivestiva anche la carica di “Direttore dell’Ufficio toscano del Catalogo dei monumenti d’Italia”. Nel 1907 poi veniva nominato primo Soprintendente ai Monumenti di Siena. Su Spighi si vedano i miei: f.canali, L’attività di Cesare Spighi, architetto storicista e restauratore in Toscana in Cesare Spighi architetto (1887-1925). Paesaggi di pietra, Catalogo della Mostra a cura di G.Corzani, Cesena, Ordine degli Architetti, Pianificatori ... della Provincia di Forlì-Cesena, 2002, pp.12-16; idem, Cesare Spighi studioso e restauratore ‘ad pristinum’ di Palazzo Vecchio [1892-1910] in Palazzo Vecchio [di Firenze] officina di ingegni, a cura di C.Francini, Cinisello Balsamo, Silvana, 2006, pp. 292-295; idem, «Il culto delle memorie e delle linee dei monumenti»: lavori di «ripristinamento» in Palazzo Vecchio [a Firenze]. Emilio Bardi, Gaetano Bianchi, Oreste Cambi, Guido Carocci, Luigi del Moro e Cesare Spighi, in Palazzo Vecchio e dintorni, a cura di F.Canali e V.C.Galati, «Bollettino della Società di Studi Fiorentini», 12-13, 2003-2004 (ma 2009), pp.109-128; idem, ‘Scoperta’, celebrazione e restauro dei Monumenti quattrocenteschi di Pienza. Corrado Ricci, Cesare Spighi e la Cattedrale di Pienza (1908-1909). Dibattiti storiografici di paternità ... motivi «nazionalistici» e paradigmaticità di un restauro di consolidamento «esemplare», in Brunelleschi, Alberti e oltre, a cura di F.Canali, «Bollettino della Società di Studi Fiorentini», 16-17, 2007-2008 (ma 2010), pp.202-219. E poi i saggi contenuti in: Firenze, Primitivismo e Italianità. Problemi dello “Stile nazionale” tra Italia e Oltremare (1861-1961), da Giuseppe Poggi e Cesare Spighi alla Mostra di F.L.Wright, a cura di F.Canali e V.C.Galati, «Bollettino della Società di Studi Fiorentini», 21, 2012.
FERRUCCIO CANALI80
a causa dell’aspro contenzioso professionale che lo opponeva a Giuseppe Castellucci per la terminazione del Vestibolo della Laurenziana, ripercorreva in due occasioni la serie delle opere da lui svolte, a partire dal 1884 su tutto il complesso laurenziano. E era una questione che ormai si trascinava da vent’anni:
«nel 22 ottobre 1884 fui incaricato dall’onorevole Ministero dell’Istruzione Pubblica di compilare un “Progetto di ampliamento e restauro della Biblioteca Mediceo-Laurenziana”; nonché di compilare lo studio di una grandiosa scala che accedesse al Vestibolo di Michelangiolo. Con Ministeriale comunicatami con Prefettizia del 17 ottobre 1885 si dava approvazione e facoltà di eseguire i lavori di restauro al soffitto del grande salone della Biblioteca, e al “Progetto di completamento della decorazione interna del Vestibolo di Michelangiolo”. Con “Deliberazione” della “Commissione Permanente” [del Ministero] del 23 ottobre 1886 fu approvata la decorazione esterna del vestibolo di Michelangelo. Causa la non lieve somma occorrente per la esecuzione dei lavori previsti con i progetti e “Perizia” da me compilata in data 16 gennaio 1886, 10 giugno 1887 e aprile 1888 fu necessario attendere la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per la esecuzione dei lavori. Intanto nel 1890 fu compiuto il restauro al soffitto del grande salone della Biblioteca e nel gennaio 1891 fu da me proceduto alla consegna del lavori di riduzione di alcuni locali per ampliare la Biblioteca Medicea Laurenziana in conformità della “Perizia” e progetto da me compilato in data 15 marzo 1890. Nel 1893 fu data pure esecuzione ad un’altra sala in aumento di quella già compiuta prima, sotto la mia Direzione e conforme al mio progetto»7.
E in un ulteriore “Promemoria” lo stesso Spighi scendeva nel dettaglio:
«fin dal 21 ottobre 1884 ebbi incarico dal R. Ministero della Pubblica Istruzione di studiare
un progetto di ampliamento e restauro della Biblioteca Mediceo Laurenziana; nonché di compilare lo studio di una grandiosa scala che accedesse al Vestibolo di Michelangelo ... Con Ministeriale comunicatami con Prefettizia del 17 ottobre 1885 si dava approvazione e facoltà di eseguire i lavori di restauro al soffitto del salone della Biblioteca e al progetto della decorazione interna del Vestibolo di Michelangelo. Con deliberazione della “Commissione Permanente” [del Ministero8] del 29 ottobre 1886 fu approvata la decorazione esterna del Vestibolo di Michelangelo. Causa l’elevata cifra occorrente per l’esecuzione dei lavori prescritti con i progetti e “Perizia” da me compilata in data 16 gennaio 1886 e 10 giugno 1887 fu necessario attendere l’iscrizione in Bilancio ... Intanto fu compiuto il restauro al soffitto della gran Sala e nell’anno 1890 fu data esecuzione ai lavori di ampliamento della Biblioteca conforme il progetto e le “Perizie” da me presentate. Tale lavoro di ampliamento si rese necessario per il buon ordinamento del materiale nella stessa Biblioteca esistente. Il progetto fu eseguito sotto la mia direzione e con l’approvazione del mio superiore immediato, il compianto prof. Luigi Del Moro allora Direttore dell’Ufficio Tecnico del “Commissariato per le Antichità e Belle Arti della Toscana”, al quale Ufficio dalla fiducia del Ministero ero stato chiamato a far parte. Nel 1893 fu eseguita l’aggiunta di un’altra sala per uso della Biblioteca e questo pure sotto la mia direzione ... Era naturale che per insufficienza di mezzi iscritti in Bilancio i lavori dovessero rimanere sospesi e ricordo le premure che insieme al Prefetto della Biblioteca furono fatte presso il Ministero per ottenere la facoltà di disporre della somma di lire 10.000, stanziate per il soffitto, per la costruzione invece delle pareti del Vestibolo, considerando che non era possibile pensare alla esecuzione del soffitto stesso se prima non erano ultimate le pareti sulle quali il soffitto doveva posare. Così ed in tale attesa sono passati alcuni anni senza che mi sia stata fatta nessuna comunicazione»9.
7 Cesare Spighi, Lettera pro-memoria sopra i lavori eseguiti alla Biblioteca Mediceo Laurenziana dall’architetto Cesare Spighi di Firenze, a S.E. il comm. Giacomo Cortese, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione Pubblica” del 10 maggio 1901 in Roma, Archivio Centrale dello Stato, Fondo “AA.BB.AA. Direzione Antichità e Belle Arti” del Ministero della Pubblica Istruzione (d’ora in poi: Roma, ACS, AA.BB.AA.), III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, s.p.8 Piuttosto complesse le vicende delle Giunte ministeriali che si susseguirono nei decenni, anche se, in genere, il loro parere vincolante rimase invariato, in quanto fatto proprio dai singoli Ministri: nel 1867 era stata creata presso il Ministero della Pubblica Istruzione la “Giunta di Belle Arti”, trasformata, poi, nel 1881 in “Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti”, suddivisa in “Commissione Permanente di Belle Arti” e “Giunta Consultiva di Archeologia”, con lo scopo di «informare il Ministro sullo stato delle Gallerie, dei Monumenti e di tutto quello che riguarda le Belle Arti»: la Giunta restava un Organo Consultivo superiore, Commissione della quale si avvaleva il Ministro grazie a Professionisti ed Artisti esterni all’Amministrazione. Con Regio Decreto del 16 marzo 1893, n. 156, veniva nuovamente istituita la “Giunta di Belle Arti” (mentre con Regio Decreto 5 gennaio 1893, n. 45, era stato istituito un “Ufficio speciale per la compilazione del Catalogo dei Monumenti”), poi ancora soppressa con Regio Decreto 12 aprile 1894, n. 140, e ricostituita con lo stesso Decreto come “Giunta Superiore di Belle Arti” affiancata da una “Giunta Superiore per la Storia e per l’Archeologia” istituita con Regio Decreto 27 aprile 1894, n. 173; nel 1904 era la volta di una “Commissione Centrale” affiancata alla “Giunta Superiore” del 1894, ma ad esse subentrava nel 1907 il “Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti”.
il completamento del vestibolo della laurenziana (1880-1905) 81
Dunque, un primo progetto di completamento del Vestibolo veniva presentato all’inizio del 1885 da Cesare Spighi alla “Commissione Conservatrice dei Monumenti della Provincia di Firenze”, presieduta dal Prefetto. Si trattava di una proposta di massima che però, veniva «approvata» nella
«adunanza dell’8 agosto 1885 ... con la lettura della “Relazione” della Sottocommissione che ha esaminato il progetto dell’architetto Spighi per la sistemazione della Biblioteca Mediceo Laurenziana»10.
A suo tempo in quel consesso scientifico-operativo, a fare da supporto alle idee di Spighi era stato soprattutto Giuseppe Poggi, come ricordava ancora nel 1888 il Prefetto di Firenze al Ministero:
«la “Commissione Conservatrice dei Monumenti” nella seduta del 15 febbraio 1886 intorno al progetto Spighi pel completamento del Vestibolo michelangiolesco nella Biblioteca Laurenziana ... intesa la “Relazione” verbale fatta dal comm. Poggi deliberò senza motivazione di approvare in massima il progetto, rimettendosi però alla saviezza e competenza dell’Ufficio del Genio
locale per la verificazione dei titoli di lavoro, delle misure, dei prezzi indicati nelle “Perizie” ... dall’architetto Spighi»11.
Trattandosi di una «”Relazione” verbale» di Poggi non ne possediamo oggi copia; ma certo è che sui moduli predisposti dal “Corpo Reale del Genio Civile”, Cesare Spighi, il 17 dicembre 1885, predisponeva un dettagliato “Progetto di completamento della decorazione interna del Vestibolo di Michelangelo della Biblioteca Laurenziana e di restauro del soffitto del Salone di detta Biblioteca”. L’iniziativa avrebbe subito una serie di traversie, fino a venir sottratta allo stesso Spighi negli anni seguenti, ma le sue ‘categorie di lavoro’ sarebbero però rimaste quale orizzonte imprescindibile per tutte le progettazioni successive. Infatti per il Salone si prevedeva:
«1. restauro del soffitto in legno della Sala grande della Biblioteca, rinverzandolo, ripulendolo, dandogli due mani di olio cotto e facendo tutto e quanto altro possa occorrere ... saranno collocati i netti in modo da non guastare l’impiantito frapponendo fra questi e l’impiantito delle assi bene spianate»12.
9 Cesare Spighi, Promemoria sopra i lavori eseguiti alla biblioteca Mediceo Laurenziana dall’architetto Cesare Spighi di Firenze, s.d. in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, s.p. Per Luigi Del Moro si veda: m.bencivenni, Del Moro Luigi in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 1989, vol.38, ad vocem. 10 Prefettura di Firenze, Commissione Conservatrice dei Monumenti della Provincia di Firenze, Adunanza dell’8 agosto 1885, registrata il 31 gennaio 1886 in Roma, ACS, AA.BB.AA., II versamento, 2 serie, b.111, fasc. “1302”, prot.1475. Complessa la storia degli Organi periferici della Direzione Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione tra Otto e Novecento: tra il 1881 e il 1888 fu operativa la “Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti d’Antichità per la Provincia di Firenze”, presieduta dal Prefetto e della quale erano parte Luigi Del Moro e Giuseppe Poggi; nel 1890 venne istituito il “Commissariato per le Antichità e Belle Arti della Toscana” con un “Ufficio Tecnico” che aveva Luigi Del Moro come “Architetto Direttore” e Cesare Spighi come “Architetto” (nel “Consiglio Tecnico” erano Guido Carocci e Giuseppe Poggi che sedeva anche nella “Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti d’Antichità per la Provincia di Firenze”), fino a che nel 1892 diveniva operativo l’”Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana” con Luigi Del Moro come “Architetto Direttore” e Cesare Spighi come “Architetto” (la “Commissione Conservatrice”, ora privata di ogni ruolo decisionale, sarebbe rimasta come organo consultivo fino agli anni Venti del Novecento). Nel 1893 a far parte dell’Ufficio Regionale entravano Giuseppe Castellucci come “Assistente”e Guido Carocci come “Ispettore”, ma dalla documentazione si evince che rimaneva anche Cesare Spighi (presente ancora solo a partire dal 1894 in m.bencivenni, r.dalla negra e p.grifoni, Monumenti e Istituzioni, Parte II: Il decollo e la riforma del servizio di Tutela dei Monumenti in Italia [1880-1915], Firenze, 1992, p.397). Una squadra – con Bernardo Marrai come “Assistente” ed Ezio Cerpi come “Disegnatore” in aggiunta a Angelo Conti come “Ispettore” – che sarebbe rimasta tale (anche se solo nel 1896 il ruolo di Castellucci veniva equiparato a quello di Spighi come “Architetto ingegnere” e non più solo come “Assistente”) fino al 1897. A seguito della morte di Del Moro, nel 1898 Filippo Torrigiani veniva incaricato del ruolo di “Direttore”, mentre nel 1900 Angelo Conti si trasferiva e nel 1902 entrava Icilio Bocci come “Architetto Ingegnere” (in bencivenni, dalla negra e grifoni, Monumenti e Istituzioni ..., cit., p.405). Nel 1901 la Direzione veniva assunta dal senese Agenore Socini, che poi sarebbe stato nominato primo Soprintendente ai Monumenti di Firenze nel 1910. Per la Commissione Conservatrice: s.pesenti, La tutela dei Monumenti a Firenze. Le “Commissioni conservatrici” (1860-1891), Milano, 1996.11 Missiva del Prefetto di Firenze (Presidente della Commissione Conservatrice dei Monumenti della Toscana) alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero P.I. del 25 ottobre 1888 in Roma, ACS, AA.BB.AA., II versamento, 2 serie, b.111, fasc. “1302”, prot.16776. Per Poggi restauratore si veda anche il mio f. canali, Camillo Boito, Firenze e gli amici “fiorentini”: Giuseppe Poggi, Cesare Guasti (e gli epistolari inediti con Telemaco Signorini, Ferdinando Martini, Aristide Nardini). Questioni culturali e artistiche, sensibilità “conservativa” alla luce dei nuovi metodi e delle nuove acquisizioni della “Storia dell’Architettura”, in Firenze, Primitivismo e Italianità. Problemi dello “Stile nazionale” tra Italia e Oltremare (1861-1961), da Giuseppe Poggi e Cesare Spighi alla Mostra di F.L.Wright, a cura di F.Canali e V.C.Galati, «Bollettino della Società di Studi Fiorentini, 20, 2011 (ma 2012), pp.40-88.12 Cesare Spighi, “Progetto di completamento della decorazione interna del Vestibolo di Michelangelo della Biblioteca Laurenziana e di restauro del soffitto del Salone di detta Biblioteca” del 17 dicembre 1885 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”.
FERRUCCIO CANALI82
Per quanto riguarda il Vestibolo, Spighi prevedeva
«smontatura e rimontatura del tetto del Vestibolo per rialzare il muro onde poter fare rincorrere la cornice di coronamento e poter far posto per la collocazione del nuovo soffitto in legno, compreso il rialzamento dei cavalletti e il rinnuovo dei materiali guasti. Collocazione di nuove doccie di bandire per la conduzione delle acque, tinte a tre mani dentro e fuori compresi i ferri necessari per sostenerle a distanza non maggiore di un metro, nonché la collocazione al posto ... Rialzamento del muro in conseguenza del rialzamento del tetto, costruito a piena regola d’arte riprendendo esattamente, tanto nell’interno che all’esterno, la costruzione del muro esistente con filari di mattoni a tutto spessore con pietre spianate e collegate con leghe di pietra arenaria poste ad ogni sessanta centimetri di altezza ... Costruzione di un ponte chiuso per impedire che cadano sulla scala sottoposta oggetti che possino guastarla, mentre si sta sfacendo e rifacendo il tetto, si montano i pietrami e si costruisce il muro ... Per la fasciatura degli scalini e copertura della Balaustra e di tutte le cornici più sporgenti. E ciò per impedire che possino essere guastate cadendo disgraziatamente degli oggetti ... Pietrame necessario per la continuazione della decorazione esistente, tutto eseguito perfettamente e secondo i modini tracciati nelle cornici esistenti. La pietra dovrà essere della medesima qualità e del medesimo colore di quella esistente. Il lavoro sarà tirato a perfetto pulimento simile a quello che già esiste, compreso il trasporto a piè d’opera, rimanendo a rischio dello Scalpellino i pezzi che nel trasporto si guastassero. Si valuta per la cornice m.0.725; fregio m.0.929; basi; basi pilastri; pilastri; mezzi pilastri; capitelli; ricordi sotto le finestre; finestre; ornamenti di sopra le finestre; cornice finale ... Tira e posa per la collocazione al posto di tutto il materiale in pietra lavorata e quant’altro può occorrere ... Muratura di tutto il pietrame decorativo con impiego di calcina, cemento, mattoni, staffe e quant’altro possa occorrere per eseguire una solida ed esatta costruzione ... Vetrate per le finestre del Vestibolo che saranno a vetri colorati con disegni variati a somiglianza di quelli che esistono nel Salone di Michelangelo, armate di ferrami e messe al posto ... Soffitto in legno intagliato messo al posto con armatura tutto completamento ultimato ... Per l’esecuzione di un disegno al nero di detto soffitto e per gli studi e prove che occorreranno ... Impiantito fatto
con pianelle costruite appositamente collocate e messe in opera»13.
Il “Progetto” veniva inviato, dunque, al Ministero che per la prima volta faceva ricorso al “Parere” della “Commissione Permanente di Belle Arti”, coordinata da Adolfo Avena:
«la Commissione propone l’approvazione in massima del progetto presentato e riserva il parere della esecuzione definitiva a quando: 1. Sarà presentato lo studio al vero del soffitto in base a un concetto più semplice di quello presentato; 2. Quando sarà presentato un nuovo progetto per la formazione del pavimento, non essendo idoneo quello presentato e mancando l’indicazione della materia con la quale deve essere formato; 3. Quando sia studiata la decorazione esterna della parte superiore del Vestibolo, essendo utile a conoscersi (come accenna la Commissione consultiva della Toscana) nell’occasione del rialzamento dei muri perimetrali e la formazione delle luci, qualora abbiano luogo. La Commissione propone poi l’esecuzione del restauro del soffitto della Biblioteca ... con l’obbligo di presentare un saggio alla Commissione consultiva. La Commissione Permanente ha quindi bisogno di vedere la lettera prefettizia e la “Relazione del comm. Poggi, le quali accompagnavano il progetto dell’architetto Spighi per la Biblioteca Laurenziana»14.
Ma che la documentazione fosse comunque ritenuta incompleta lo dimostra una nota apposta sugli stessi fogli nella quale si puntualizza che «la “Relazione” del comm.Poggi non era unita a quella lettera né in essa se ne fa parola. Probabilmente la detta “Relazione” rimase nell’archivio della Direzione Generale», senza sapere che quella “Relazione” stessa non pare fosse mai stata trascritta. La “Commissione Permanente di Belle Arti” avrebbe però gradito ‘appoggiarsi’ ad un parere autorevole. Si trattava dunque di un’approvazione fortemente sub condicione; il che, in definitiva, rendeva vana quell’approvazione stessa. Le proposte di Spighi suscitavano ormai nell’ambiente fiorentino un notevole interesse (e qualcosa di più!), specie dopo l’uscita il 31 dicembre 1886, su «Il nuovo Osservatore Fiorentino», di una valutazione possibilista del suo progetto per il riordino e l’allargamento di tutto il complesso della Biblioteca, da parte dell’Anonimo estensore della Storia del complesso
13 Cesare Spighi, Progetto di completamento della decorazione interna del Vestibolo di Michelangelo della Biblioteca Laurenziana e di restauro del soffitto del Salone di detta Biblioteca, del 17 dicembre 1885 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”.14 Parere della “Commissione Permanente di Belle Arti” del Ministero della Pubblica Istruzione del 23 ottobre 1886 in Roma, ACS, AA.BB.AA., II versamento, 2 serie, b.111, fasc. “1302”. Avena era stato appena assunto, nel 1886, nei ruoli del Ministero della Pubblica istruzione: cf. A. gambardella, c.de falco, Adolfo Avena architetto, Napoli, 1991.
il completamento del vestibolo della laurenziana (1880-1905) 83
Laurenziano (ma sappiamo trattarsi di Pietro Franceschini). Era Franceschini che chiudeva la questione con una valutazione generale che forse, in nuce, conteneva il motivo di tutte le resistenze alla proposta spighiana:
«Spighi, animato come sembra a seguire nell’ingrandimento della Libreria le orme del Buonarroti senza presumere di passargli mai innanzi, può essere condotto a far cosa degna dal Governo che gli ha commesso lo studio e soprattutto del monumento, cui per un giovane artista sarà gloria anche semplicemente il poter dire di avervi consociato il nome»»15.
L’opera dell’Architetto, nonostante le perplessità e i ‘rallentamenti’ ministeriali (ufficialmente causati dalla carenza di finanziamenti) continuava con la produzione di nuove “Perizie”, nelle quali veniva previsto:
«1. Decorazione esterna delle nuove finestre, eseguita in pietra simile a quella esistente nelle altre decorazioni esterne secondo il disegno che verrà approntato composto di brachettone, fregio e cornice perfettamente modinate. 2. Cornice posta sotto la gronda simile colla esistente con mensole; Tira e posa per la collocazione al posto di tutto il materiale in pietra lavorata ... 3. Tira e posa per la collocazione al posto di tutto il materiale in pietra lavorata, per il materiale da costruzione, legname, e quanto altro può occorrere, eseguito solidamente e secondo le prescrizioni che verranno date dalla Direzione dei Lavori ... 4. Muratura di tutto il pietrame decorativo con impiego di calcina della migliore qualità, cemento, mattoni, staffe e quanto altro può occorrere per eseguire una solida e esatta costruzione ... 6. Ripresa dei muri esterni eseguita a regola d’arte fatta a cortina con mattoni ben cotti e delle migliori qualità, eseguendo tutte le incassature e gli aggetti che sono nelle parti esistenti, facendo il lavoro a perfetta regola d’arte e come precriverà la Direzione dei Lavori ... 7. Per lo sbalzamento di un tetto che impedisce la piena luce a tre finestre del Vestibolo: smontatura e rimontatura del tetto compreso il rinnuovo dei materiali guasti ... 9. Lavori di rifinimento e di riadattamento dopo la demolizione del muro e lo sbancamento del tetto»16.
L’11 giugno del 1886, una missiva (probabilmente
del Direttore Regionale della Toscana) giungeva al Ministero, facendo il punto della situazione e indicando il nome delle maestranze «artistiche» («scultori del legno», «accollatori») che si intendeva impiegare per la realizzazione del «restauro». Si univa poi alla missiva una tavola rappresentante la proposta della decorazione esterna del Vestibolo.
«nove finestre sarebbero aperte e darebbero luce al vestibolo, le altre tre dalla parte del salone di Michelangelo rimarrebbero chiuse ... oltre alla realizzazione della cornice finale simile alla esistente e per la esecuzione in pietra delle nove finestre suddette»17.
Per la prima volta si avanzava l’idea di un completamento ‘analogico’ anche dell’esterno del Vestibolo, con cornici e modanature « simili alle esistenti». Il 22 maggio 1888, Spighi faceva pervenire al Ministero una nuova “Relazione” relativa a più organiche previsioni per il “Completamento del Vestibolo di Michelangelo”:
«presento gli studi per il completamento del Vestibolo di Michelangelo in seguito all’ordine ricevuto e a seconda dei voti espressi dalla “Commissione Permanente di Belle Arti” nella seduta del 25 ottobre 1886 ... Gli studi fatti sopra il Monumento che contro mio merito ho l’onorevole incarico di studiarne il completamento, mi hanno portato a persuadermi che la sala di accesso alla Biblioteca Mediceo Laurenziana comunemente chiamata Vestibulo dovrebbe essere arricchita di pitture murali [e al Ministero inseriscono un significativo “?!”]. Per tutte le considerazioni e studi fatti mi sono formato il concetto che scopo primo di questo ambiente secondo la mente del suo autore non doveva essere una semplice sala di accesso, un semplice vestibolo, ma bensì una ricca Tribuna, una sala nella quale dovessero essere raccolte le statue, i nomi degli uomini divenuti sommi nello scibile umano. A questo concetto vi si conduce osservando come questa sala sia stata arricchita con decorazioni in pietre maggiori e più sfarzose di quella che non sia stata decorata la sala grande che gli succede; la quantità degli spazi destinati a ricevere tutte le statue, non che poi le tracce evidentissime che i fondi e le parti intermedie alle decorazioni in pietra erano destinate a ricevere
15 Anonimo [ma p.franceschini], San Lorenzo. XXII. La Biblioteca III, «Il nuovo Osservatore Fiorentino», 53, 31 dicembre 1886, pp.423-425 anche in Roma, ACS, AA.BB.AA., II versamento, 2 serie, b.111, fasc. “1302”.16 Cesare Spighi, “Perizia” addizionale alla “Perizia” del 16 gennaio 1886: “Perizia aggiuntiva” del 10 giugno 1887 per la decorazione esterna del vestibolo di Michelangelo e previsione di una parte di indennità dovuta per l’espropriazione necessaria per la costruzione della Sala quadrata d’angolo (giusta la Prefettizia del 17 ottobre 1885) in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900.17 Missiva firmata alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero P.I. dell’11giugno 1887 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.6358.
FERRUCCIO CANALI84
delle pitture murali. Persuaso di questo concetto procedei allo studio del soffitto, il quale riuscisse in armonia con delle pitture murali che con il tempo si sarebbero potute eseguire; e secondo questo intendimento presento i terzetti n.2 e 3, nei quali alcuni spazi sono destinati a ricevere quadri grandiosi che lo pongano in armonia con la decorazione delle pareti ... relativamente allo studio al nero del soffitto richiesto, presentatesi molte difficoltà per poterlo eseguire sia per il luogo nel quale doveva eseguirsi, sia per il modo di esecuzione (se in modello o in disegno) sia per la spesa, dovendolo collocare in luogo atto a giudicarne l’effetto, ritenendo poi fermamente che a nulla avrebbe fruttato questo studio, se non collocato nell’ambiente destinato a riceverlo, completamente decorato, e che per fare ciò era necessario attendere il completamento della decorazione in pietra del Vestibolo non che l’apertura delle nuove finestre, essendo insufficiente la luce attuale per giudicarne l’effetto; per queste ragioni ne ho sospesa e rimandata l’esecuzione a quando sarà il momento opportuno .. Per la razionalità dello spartito generale, per la distribuzione delle parti ornamentali posta in armonia con la ricca decorazione in pietra delle pareti, [comunque] propongo e raccomando per la esecuzione il Bozzetto n.IV ... Però continuando nella linea di maggiori studi e considerazioni, mi sono convinto che se si può assolutamente ritenere che non solo il Vestibolo e Tribuna dovessero essere decorati con pitture murali, ma ancora la gran sala dovesse essere arricchita con simili decorazioni, male si ottempererebbe al mandato ricevuto proponendo la esecuzione di simili decorazioni e a tale concetto si informasse lo studio della decorazione del soffitto. Ultimare la decorazione lasciata interrotta, completarla con il soffitto e l’impiantito, lasciando però in tutto l’ambiente il carattere che attualmente la distingue è veramente la linea di condotta da seguirsi in questo lavoro ... Presento e raccomando per la esecuzione un disegno di impiantito, il quale per lo spazio accidentato nel quale doveva crearsi, ha presentato immense difficoltà. Questo impiantito può eseguirsi a marmo rosso e giallo di Siena oppure in terra cotta rossa e gialla ... Gli allegati alla presente “relazione” sono n.5 Tavole rappresentanti disegni di soffitto; n.2 tavole rappresentanti disegni di impiantito».
Ma sottolineava Spighi che, invece,
«le tavole che dimostrano il grande ampliamento
della Biblioteca non sono state presentate perchè ritenute dal Comm. Prof.Poggi. Le idee di Spighi erano certe ardite (specie per quanto riguardava «le pitture parietali») e dunque il Ministero preferiva liquidare ogni pendenza. Ci pensava il Prefetto, pur rassicurando l’Architetto:
«Il Ministero nell’esaminare il conto delle competenze dovute alla S.V. per i lavori testè eseguiti al soffitto della Biblioteca Medicea Laurenziana ha notato che oltre delle competenze, sono registrate anche quelle relative al progetti e studi pel restauro del Vestibolo di Michelangiolo. Volendo il Ministero fare liquidare tanto le une che le altre ... le richiede per mio mezzo il progetto del Vestibolo che Le fu ritornato con lettera del 15 corrente n.133. Il Ministero poi vuole che ella sappia che con ciò non intende punto di toglierle il mandato affidatole ... ma vuole ripeterle che quando saranno finiti gli studi necessari ... si potrà mettere mano al lavoro, Ella ne sarà il Direttore con una mensile retribuzione»18.
2. Le richieste dei primi anni Novanta: i lavori di Spighi, i giudizi di Luca Beltrami (1892) e di Giacomo Boni, le opere urgenti per il terremoto del 1895
Le cose erano rimaste per un po’ congelate, ma era stato con il nuovo ministro Villari che si era deciso di sbloccare le decisioni. Apprendiamo da una lettera di Spighi ad Adolfo Avena che l’architetto milanese Luca Beltrami si era espresso sui lavori da eseguirsi sulla Biblioteca Laurenziana di Firenze:
«caro amico Avena, sarebbe mio sommo desiderio conoscere, e per questo ti prego farmene ricerca, la “Relazione” del prof. Beltrami di Milano dopo la esecuzione dei miei lavori sulla Biblioteca Laurenziana. Questa “Relazione” venne compilata in conseguenz di un incarico ricevuto da S.E. il senatore Pasquale Villari allora Ministro della P.I. Oltre questa “Relazione” deve esserci quella allo stesso scopo redatta dal compianto prof.Luigi Del Moro»19.
Di questa “Relazione” di Beltrami non ho finora trovata traccia (probabilmente doveva trattarsi di un documento generale sulla condizione dei Monumenti di Firenze o della Toscana) 20; Spighi faceva sottintendere che Beltrami aveva espresso un parere favorevole al suo progetto, ma il prosieguo degli studi speriamo possa gettare
18 Missiva del Prefetto di Firenze a Cesare Spighi del 23 gennaio 1889 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.133.19 Missiva di Cesare Spighi ad Alfonso Avena s.d. in Roma, ACS, III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, s.p.
il completamento del vestibolo della laurenziana (1880-1905) 85
luce su questo importante passaggio. Certo è che l’Architetto fiorentino sottolineava come ciò si fosse verificato
«in seguito ad un carteggio avvenuto fra il libraio fiorentino cav. Pietro Franceschini e l’allora Ministro comm. Pasquale Villari»21.
Certo è che entrava in scena, a coordinare la vicenda come Ispettore Centrale del Ministero, Giacomo Boni che il 29 novembre del 1893 scriveva un “Promemoria per il comm. Bongiovannini” dello stesso Ministero, per cercare di dirimere anche la situazione proprietaria – Demanio/parrocchia di San Lorenzo – che interessava i Chiostri monumentali e dunque l’accesso alla Biblioteca tramite il Vestibolo:
«a me pare che la “Convenzione” [con la Parrocchia] proposta dal [Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana] Del Moro sia accettabile per le seguenti ragioni: 1. Il parroco di San Lorenzo non acconsentirebbe a rescindere il contratto del 1876, se non gli si lasciasse nessuna ingerenza sui fabbricati ora affidati alle sue cure; 2. L’unità amministrativa pura re formalmente non esiste, non potendosi costituire un unico fondo; esiste però nel fatto, giacché il Parroco si fa obbligo nel contratto di presentare i conti preventivi e consuntivi e di non fare alcun lavoro senza il permesso dell’Ufficio Regionale. (Aggiunto a lato: E la sentenza del 1883 dice chiaramente che l’Amministrazione del Fondo per il Culto deve pagare annualmente lire 4560,44 al parroco di San Lorenzo per la manutenzione della Chiesa e della Canonica. Data questa condizione di fatto non vedo la possibilità di condizioni migliori di quelle proposte dall’Ufficio Regionale. B.[oni])»22.
Le questioni, insomma, si affastellavano di continuo, ma secondo una logica precisa che da un
lato tendeva ad ampliare la Biblioteca risolvendo tutte le vertenze di possesso degli annessi (dai Chiostri ai fabbricati); dall’alto puntava al completamento – o perlomeno al riordinamento – della fabbrica a partire dal Vestibolo e poi nel soffitto della Sala michelangiolesca. Anche se, nel dettaglio, ogni questione apriva una nuova vertenza ...Infatti Spighi ricordava che proprio in quei primi anni Novanta, egli aveva compiuto una serie di opere:
«a me furono commessi fino dal 1894 i lavori tutti che si riferivano al riordinamento dei locali ove ha sede la Biblioteca. E così sotto la mia Direzione e sorveglianza furono eseguiti: 1. Il restauro del soffitto del grande salone; 2. l’ampliamento della Biblioteca con la esecuzione di nuove sale per la esposizione dei Codici miniati e per il Bibliotecario; 3. la costruzione di altri locali per la migliore sistemazione dei libri e altri lavori di minore importanza»23.
Restava la questione del Vestibolo e così si aveva uno scambio di missive tra i Dirigenti dei diversi settori operativi del Ministro per sollecitare a formalizzare le concrete intenzioni:
«È intendimento di S.E. il Ministro di incaricare l’ing. Cav. Cesare Spighi di por mano al rialzamento delle pareti del vestibolo della Biblioteca Laurenziana. A tal scopo potrebbe essere erogata la somma di lire 10.000 inscritta in bilancio pel soffitto di detto Vestibolo, non potendosi costruire il soffitto medesimo senza prima rialzare le pareti»24.
Ma la risposta negativa all’avvio delle opere giungeva a stretto giro, puntualizzando la natura degli stanziamenti e i diversi “Capitoli di spesa”:
«Il Prefetto della Biblioteca Laurenziana ha
20 Nella documentazione conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, nei faldoni relativi al “Complesso di San Lorenzo” del Fondo AA.BB.AA., II versamento, 2 serie (in particolare la busta n.112) non vi è traccia della “Relazione”, come neppure in quelli del Fondo AA.BB.AA., III versamento, II parte. Una ricerca più estesa, relativa alla situazione fiorentina dei primi anni Novanta, in particolare nell’ambito del II versamento, 2 serie, potrebbe restituire il documento redatto da Beltrami certamente non solo in merito alla situazione della Biblioteca Mediceo Laurenziana.21 Cesare Spighi, Lettera pro-memoria sopra i lavori eseguiti alla Biblioteca Mediceo Laurenziana dall’architetto Cesare Spighi di Firenze, a S.E. il comm. Giacomo Cortese, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione Pubblica” del 10 maggio 1901 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel Vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, s.p.22 G.Boni, Promemoria per il comm. Bongiovannini del 29 novembre 1893 in Roma, ACS, AA.BB.AA., II versamento, 2 serie, b.111, fasc. “1302”.23 Relazione di Cesare Spighi al Commissario per i Monumenti della Toscana, marchese Filippo Torrigiani, del 16 agosto 1900 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”,24 Missiva del Direttore della Divisione per i Monumenti del Ministero P.I al Direttore Divisione Biblioteche dello stesso Ministero del 16 ottobre 1894 in Roma, ACS, AA.BB.AA., II versamento, 2 serie, b.111, fasc. 1302, s.p.
FERRUCCIO CANALI86
effettivamente pregato questo Ministero di autorizzarlo a principiare i lavori necessari alla decorazione del Vestibolo di quella Biblioteca, giovandosi di un fondo di lire 10.000 iscritto in bilancio ... ma tale proposta non è stata accolta giacché quel fondo non è stato stanziato nel bilancio del presente esercizio ... ed è iscritto con la dicitura “Costruzione del soffitto della gran Sala”. Era impossibile pertanto valersi di detto fondo per i lavori raccomandati ... senza mutare la destinazione del fondo stesso con apposita Legge. Ma il Ministero non ha reputato opportuno per ora di farlo»25.
Inaspettatamente, nel 1895, alcuni lievi scosse di terremoto riaprivano anche la ‘questione Biblioteca’. E da Firenze giungeva al Ministro una “Relazione”:
«Il terremoto del 18 maggio 1895 recò danni sensibili ad una delle Sale della Biblioteca, ove cadde una parte dell’intonaco del soffitto. Da una “Perizia” fatta fare dal mio egregio predecessore, rilevasi che la spesa occorrente per i restauri sarà inferiore a lire 400. Non si mise mano al restauro, che è urgente, temendo che nuove scosse di terremoto dovessero rinnovarsi. Ma ora che il funesto periodo sismico, senza pericolo, sembra chiuso, non si può differire un restauro così necessario. E perché si tratta di un lavoro alla sede della biblioteca e in un edificio monumentale, prego l’E.V. di voler invitare l’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti a provvedere d’urgenza alle riparazioni»26.
L’occasione era ghiotta, ma il Ministero non si profondeva troppo in stanziamenti, limitandosi, oltre alle opere di ‘pronto intervento’, alla sistemazione di una vetrata cinquecentesca:
«in seguito a quanto l’E.V. si degnava di disporre con la sua pregiata lettera del 10 dicembre 1895 e presi gli accordi opportuni col sig. Bibliotecario feci eseguire le due urgenti e indispensabili ripara-zioni ad una Sala della Biblioteca Mediceo Lau-renziana per mettere in buone condizioni la tetto-ia della Biblioteca e il lucernario della Dolciniana e per sostituire ad una vetrata ordinaria un’altra dipinta da Giovanni da Udine e depositata in una cantina, riserbando ad altro tempo e dopo matu-ro esame di svolgere le proposte rispetto alle ripa-razioni del soffitto. Inoltre per il decoro dell’Isti-tuto consentivo che il R.Opificio delle Pietre Dure
eseguisse due iscrizioni indicative incise su marmo nero del Belgio per sostituire due cartelli ridotti in condizioni deplorevoli»27.
3. La ‘variante’ di Giuseppe Castellucci e le mediazioni di Giacomo Boni (1898). I pareri della “Giunta Superiore di Belle Arti” e la nomina della “Commissione Ministeriale per i lavori di completamento del Vestibolo della Laurenziana” di Guglielmo Calderini (1900)
Il Prefetto della Biblioteca Guido Biagi, vista l’empasse ormai decennale (non si era realizzata una nuova Sala di Lettura, né si era risolta la questione del Vestibolo e del soffitto della sala principale), alla fine degli anni Novanta tornava alla carica sia con le Autorità ministeriali, sia, soprattutto, con quelle locali. E si consumava così, con un colpo di mano, l’improvviso esautoramento di Cesare Spighi, come veniva comunicato laconicamente al Ministero:
«In seguito a una sollecitazione del comm.Guido Biagi ... davo incarico all’arch. Giuseppe Castellucci di completare gli studi che aveva già iniziato sotto la direzione del comm. Del Moro per il progetto dei lavori occorrenti al Vestibolo della Biblioteca Mediceo Laurenziana. Nell’inviare all’E.V. i disegni di tale progetto, stimo utile corredarli di una breve delucidazione. I lavori che si propongono per le pareti del Vestibolo non presentano veruna difficoltà né artistica né tecnica perché consistono nel ripetere le parti similari esistenti, fatte dal Vasari su disegno di Michelangelo e rimaste solo incompiute in alcuni tratti delle pareti. L’architetto Castellucci ha delineato anche per il soffitto diversi partiti, valendosi in vario modo delle forme decorative del soffitto della Biblioteca, opera di Michelangelo; ma solo, in via dimostrativa e di massima, per non lasciare incompiuti gli studi che il comm. Del Moro aveva già preordinati. Non essendo ora questione del soffitto, sibbene dei lavori di compimento sulle pareti del Vestibolo, se l’E.V. si degnerà di approvare la proposta, quest’Ufficio si darà premura di far gli studi dei particolari colla valutazione delle singole opere»28.
Rispetto alle aspettative ‘di massima’ di Spighi, si era oprato per un profilo molto ‘basso’ che prevedeva solo la «continuazione pura e semplice delle decorazioni architettoniche esistenti», come sottolineava Giacomo Boni:
25 Missiva del Direttore della Divisione Biblioteche del Ministero P.I al Direttore del Divisione per i Monumenti dello stesso Ministero del 16 ottobre 1894 in Roma, ACS, AA.BB.AA., II versamento, 2 serie, b.111, fasc. 1302, prot.13307.26 Missiva del Direttore della Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Biagi, al Ministro della P.I. del 26 novembre 1895 in Roma, ACS, AA.BB.AA., II versamento, 2 serie, b.111, fasc. 1302, prot.954.27 Missiva del Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana al Ministro della P.I. del 28 giugno 1896 in in Roma, ACS, AA.BB.AA., II versamento, 2 serie, b.111, fasc. 1302, prot.1561.
il completamento del vestibolo della laurenziana (1880-1905) 87
«L’Ufficio Regionale di Firenze faceva gli studi dei particolari e il preventivo dei lavori di compimento sulle pareti del vestibolo. Lavori che consistono nella continuazione pura e semplice delle decorazioni architettoniche esistenti sulle pareti dello stesso vestibolo già compiuto da Vasari. S’intende che non trattandosi di opere di conservazione delle parti monumentali dell’edificio della Biblioteca Mediceo Laurenziana, ma bensì di lavori di moderno completamento a decoro della Biblioteca suddetta, toccherà ad essa provvedere alle spese necessarie. Conferito al proposito col comm.Coppola, Direttore Capo Istruzione di questo Ministero, mi assicurò che esiste un fondo a disposizione per la Biblioteca ... Il comm. Coppola mi disse che il Prefetto della Biblioteca Mediceo Laurenziana desidererebbe vedere il progetto e primache si possa scrivere all’Ufficio di accontentarlo»29.
Compito di Boni era stato quello di coordinare, a livello ministeriale, i vari uffici e di reperire i fondi necessari nel “Capitolo di spesa” opportuno:
«In seguito a sollecitazioni avute dal sig.comm.Guido Biagi, l’Ufficio Regionale di Firenze nel passato febbraio dava incarico all’arch.Castellucci
di completare alcuni studi da esso già iniziati sotto la direzione del compianto prof. Del Moro circa i lavori occorrenti al Vestibolo della Biblioteca Mediceo Laurenziana. Nell’accompagnare ora alcuni disegni relativi al progetto dei suddetti lavori, l’Ufficio Regionale scrive ... Lo scrivente non ha difficoltà a permettere che l’Ufficio Regionale di Firenze faccia lo studio dei particolari architettonici onde trattasi e il preventivo delle opere necessarie per il compimento delle pareti nel Vestibolo della Biblioteca, mettendosi anche d’accordo col comm.Biagi, in tal senso. Prima tuttavia di dare in tal senso una formale autorizzazione all’Ufficio Regionale e al fine di evitare che si compili per avventura, un progetto non traducibile in altro per deficienza di fondi, lo scrivente gradirà che codesta on.Direzione Generale gli faccia conoscere se è disposta ad assumere a proprio carico o a far gravare sulla dotazione della Medieco Laurenziana la spesa che risultasse necessaria per l’esecuzione dei lavori da periziarsi»30.
Infatti
«con nota del 7 novembre 1896 il comm. Biagi [Direttore della Biblioteca Laurenziata] chiede-
28 Missiva del Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana, Torrigiani, alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero P.I. del 21 maggio 1898 in Roma, ACS, III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.6358. Giuseppe Castellucci (1863-1939), allievo di allora famosi architetti fiorentini e in particolare di Luigi Del Moro, vide una svolta nella propria carriera grazie alla collaborazione prestata dal 1891, come disegnatore, all’opera Die Architektur der Renaissance in Toscana, di Karl von Stegmann e Heinrich von Geymüller, uscita a Monaco fra il 1885 e il 1908, proprio in relazione alle opere di Michelangelo. Entratto nei ruoli dell’Amministrazione delle Belle Arti presso l’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana, diretto da Del Moro, nel 1901, divenne Direttore dell’Opera del duomo di Firenze e in questa veste curò la ricostruzione della cantoria di Luca della Robbia, la restituzione sul luogo originario del sepolcro del vescovo A. d’Orso di Tino di Camaino; nel battistero di San Giovanni ricostruì il fonte (poi rimosso). Dopo la morte di Del Moro ereditò buona parte dei suoi cantieri, come quello della basilica di Santa Trinita (vi completò i lavori nel 1897), mentre, contemporaneamente, l’Architetto iniziava una serie di interventi su palazzi fiorentini, tra i quali palazzo Canacci in piazza di Parte Guelfa (il ripristino, terminato nel 1904, fu però accompagnato da aspre polemiche). Nella chiesa di Santa Maria Maggiore Castellucci intervenne sull’altar maggiore nel 1902. A Fiesole l’Architetto ripristinò (1907) la chiesa di San Francesco, eliminando tutte le aggiunte barocche esterne e interne e restaurò radicalmente la villa Pratellino, oggi villa Sparta, oltre al campanile di San Domenico (1899-1900); lavorò quindi al palazzo Pretorio di Prato e tra il 1894 e il 1897 anche nel Duomo di Grosseto. L’ampia attività di Castellucci ad Arezzo ebbe avvio con il restauro della chiesa di Santa Maria delle Grazie nel 1898 (per incarico dell’Ufficio regionale dei monumenti della Toscana) per poi continuare soprattutto negli anni Venti del Novecento. A Lucignano in Val di Chiana intorno al 1902 si occupò della chiesa e del convento di San Francesco, restaurando anche il vicino Palazzo del Podestà; in Casentino, a Stia, ricostruì sulle antiche fondamenta e in forme medievaleggianti il castello di Palagio (compiuto nel 1908). Anche a Cortona la sua attività fu piuttosto ampia: nel 1896, procedeva al ripristino del Palazzo Comunale e di Casa Salvini, restaurava la chiesa di Sant’ Angelo di Metelliano (una fabbrica sulla quale intervenne più volte), e completava la facciata del santuario di Santa Margherita (1896 e poi ancora nel 1917 con la cappella per i Caduti della Grande Guerra). Castelucci curò numerosi restauri anche a Lucca dove realizzò il ripristino dell’oratorio di Santa Giulia (lavori iniziati nel 1899), intervenne in Duomo e nelle chiese di Sant’ Andrea a Gattaiola, di San Frediano, di San Gennaro, di San Leonardo e di San Maria in Corteorlandini. Dopo aver vinto il Concorso del 1893, nel 1895 dava avvio alla costruzione della facciata della cattedrale di Pescia (poi completata nel 1933). A Pisa si occupò di San Francesco (1900) e della Chiesa degli Scalzi, mentre in Umbria procedeva al restauro della pieve romanica di Canoscio presso Città di Castello (dove edificò anche il camposanto, dove erano già stati attivi Emilio De Fabris e Luigi Del Moro). Cfr. g.miano, Castellucci Giuseppe in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 21, 1978, ad vocem.29 Promemoria di Giacomo Boni per il Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero P.I. del 189(?) in Roma, ACS, III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, s.p.30 Missiva di Giacomo Boni per conto del Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione al Direttore Generale per l’Istruzione Superiore e le Biblioteche del Ministero della Pubblica Istruzione, Coppola, dello stesso Ministero del 1 giugno 1898 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900” , prot.6358 .
FERRUCCIO CANALI88
va l’autorizzazione di far cominciare le “Perizie” necessarie per i lavori di costruzione del soffitto della prima sezione della grande Sala della Bi-blioteca Mediceo Laurenziana, per i quali lavori fin dall’esercizio 1887-1888 è stata stanziata in un apposito “Capitolo” del bilancio, la somma di lire 10.000. Il Ministero accordò la chiesta autoriz-zazione, invitando il com. Biagi a far compilare la detta “Perizia” dall’Ufficio competente ... e il Commendatore si è rivolto all’Ufficio Regionale di Firenze come era debito suo. Da parte di que-sto Ufficio non è dunque difficoltà che si rechi a compimento il progetto architettonico nonché il relativo preventivo di spesa»31.
Il Direttore dell’Ufficio Regionale esponeva i criteri che avevano informato il nuovo progetto per il completamento delle «pareti nude» del Vestibolo:
«In ordine alla Ministeriale del 16 giugno 1898 quest’Ufficio, presi gli accordi col comm. Guido Biagi, Bibliotecario della Mediceo Laurenziana, compilava il progetto e la “Perizia” dei lavori da eseguirsi nel vestibolo di quella Biblioteca. Il progetto consta di alcuni disegni che in parte concernono i lavori in pietra sulle pareti e in parte il soffitto del vestibolo. Per il rivestimento in pietra dei tratti nudi delle pareti, quest’Ufficio non ha fatto che ripetere fedelmente le parti similari esistenti ... quali semplici opere di compimento (tav IV° e VI° e V°). Per il soffitto invece (tav.VIII) da eseguirsi per intero ex novo si sono delineati diversi partiti, la cui analisi varrà a porre in chiaro con quali criteri li abbia ideati. Nel partito segnato con lettera A, si è attenuto strettamente al soffitto della sala della biblioteca, opera di Michelangelo, riprendendone le forme decorative su tre ordini di formelle e coordinandone le linee generali colle linee organiche delle decorazioni in pietra del Vestibolo. Per tale coordinamento, imposto dalle ragioni dell’Arte, è avvenuto di necessità che, siccome i pilastri binati del Vestibolo sono più vicini alla linea mediana delle pareti di quel che non sieno i pilastri delle pareti corte della Sala della Biblioteca, le formelle del soffitto del vestibolo sono fra loro in una proporzione diversa di quella del soffitto della Biblioteca. Ma ciò, data la forma quasi quadrata del Vestibolo, anziché nuocere, giova all’effetto estetico del soffitto.Il partito segnato con la lettera B è nelle linee
generali e nelle formelle mediane identico al partito A, ma ne differisce nelle ripartizioni delle decorazioni sulle fasce e nelle formelle laterali, che sono una ripetizione delle formelle mediane. Dei due partiti segnati colle lettere C e D (duplice), il primo è affatto libero nelle sue linee generali, l’altro invece si lega meno le sue fasce ai pilastri binati delle pareti. Questi due partiti offrono il vantaggio di una grande formella centrale e di un ordine di formelle all’intorno, alternativamente similari nelle forme. Dei quattro partiti delineati, quest’Ufficio ha creduto opportuno presentare lo sviluppo di quello segnato con lettera D (tav.IX°), ma solo in via dimostrativa, non in modo definitivo, poiché si riserva, qualora si avesse intenzione di por mano anche all’esecuzione del soffitto, di farne la prova su tela a chiaroscuro per giudicare l’effetto. Nella “Perizia” i lavori sono indicati in modo sommario e valutati partitamente in due titoli distinti. Nel primo sono compresi quelli del rivestimento in pietra delle pareti e il necessario rilevamento e riordinamento del tetto; nel secondo quelli l’esecuzione del soffitto in legno intagliato. La spesa complessiva prevista per i primi lavori in lire 157476.50 e per i secondi in lire 6252.50 »32.
Gli organi ministeriale procedevano a trasmettere alla “Giunta Superiore di Belle Arti”, organo consultivo in seno allo stesso Ministero della Pubblica istruzione, quel progetto di «compimento del Vestibolo della Laurteanziana» poiché
«sin dal giugno 1898 e d’accordo con la Direzione Generale per ‘l’Istruzione Superiore e le Biblioteche, si era autorizzato l’Ufficio Regionale per i Monumenti della Toscana ad allestire il progetto per i lavori di compimento delle pareti nel Vestibolo della Biblioteca ... In adempimento a tale incarico l’Ufficio Regionale ha or inviato una “Perizia” corredata di 11 tavole, con la quale sono proposti, oltre i lavori di rivestimento in pietra dei tratti nudi delle pareti del Vestibolo, anche i lavori per la decorazione ex novo del soffitto. Trattandosi di lavori assai importanti, diretti a completare l’opera condotta dal Vasari su disegni di Michelangelo, si prega la Giunta Superiore di Belle Arti di far conoscere il suo autorevole avviso in ordine al progetto presentato dall’Ufficio Regionale di Firenze»33.
31 Missiva del Direttore Generale per l’Istruzione Superiore e le Biblioteche del Ministero della Pubblica Istruzione, Coppola, al Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti dello stesso Ministero del 10 giugno 1898 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900” , prot.9393.32 Missiva del Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana, Torrigiani, al Ministero del 29 novembre 1899 in Roma, ACS, AA.BB:AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900” prot. 2753 rif. prot.17713.33 lettera di accompagnamento del progetto trasmessa dal Ministero della P.I alla Giunta Superiore di Belle Arti dello stesso Ministero s.d. in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”.
il completamento del vestibolo della laurenziana (1880-1905) 89
Emergeva con evidenza come non si trattasse – rispetto alle proposte di Spighi – semplicemente della «continuazione pura e semplice delle decorazioni architettoniche esistenti sulle pareti dello stesso vestibolo già compiuto da Vasari», ma di « completare l’opera condotta dal Vasari su disegni di Michelangelo ... anche con la decorazione ex novo del soffitto»; e dunque come non ci si allontanasse affatto dai ‘principi’ spighiani. La questione era solo ‘personale’, anche se, rispetto a Spighi, si era eliminata ogni ‘ardita velleità’.Era Giacomo Boni che si occupava di trasmettere all’Ufficio Regionale di Firenze la “Deliberazione” della «Giunta Superiore di Belle Arti per i lavori di compimento del Vestibolo della Biblioteca Mediceo-Laurenziana in Firenze». E le amarezze, questa volta, risultavano equamente distribuite:
«La Giunta, esaminato il progetto Regionale dei Monumenti relativo a lavori di compimento del Vestibolo ... NON può accettare le proposte rife-rentisi al soffitto, prima perché, in via di massima, attenendosi anche ai criteri manifestati riguardo al riordinamento della tomba di Lorenzo il Magni-fico non crede che convenga completare un’opera di tanto Artista, senza averne i dati sicuri; ed in secondo luogo perché negli scomparti non si è te-nuta la necessaria corrispondenza con l’organismo architettonico delle pareti. I lavori poi di comple-tamento delle pareti, appunto perché si tratta di continuare il partito decorativo stabilito, potrebbe-ro essere eseguiti. La Giunta inoltre si riserba ogni ulteriore deliberazione sul modo di copertura del Vestibolo, quando la Sottocommisione che andrà a Firenze ne avrà riferito in proposito»34.
A Boni non restava che far sapere che
«La “Giunta Superiore di Belle Arti”, invitata a pronunciarsi intorno al progetto compilato da codesto Ufficio per i lavori da eseguirsi nel Vestibolo della Biblioteca Mediceo-laurenziana, ha votato il seguente ordine ... che questo Ministero accoglie pienamente come parere e prega quindi la S.V. di tener sospesi i lavori per la decorazione ex novo del Vestibolo, insino a quando la Sottocommissione che deve recarsi a Firenze avrà potuto pronunciarsi sul delicato
argomento. Quanto ai lavori di compimento delle pareti, questo Ministero ne autorizza l’esecuzione, fermo quanto è rimasto stabilito in ordine all’imputazione della spesa»35
Bloccato anche il ‘progetto Castellucci’, l’unico risultato immediato era quello di scatenare la reazione di Spighi che si era visto improvvisamente esautorato:
«Oggi ho saputo con certezza che alla Biblioteca Laurenziana si pone mano per dare esecuzione alle pareti del Vestibolo Michelangiolesco affidando la Direzione ad altri che a me»36.
Si apriva per l’Architetto la sequela delle proteste e delle rimostranze formali a tutte le Autorità competenti, dopo il ‘sorpasso’ che gli era stato fatto da Giuseppe Castellucci, collega dell’Ufficio Regionale. In primis la propria rimostranza al Commissario per i Monumenti della Toscana, marchese Filippo Torrigiani:
«dall’esame di tutti i documenti resta confermato il fatto che la “Commissione Permanente”, i seguito a disegni, “Relazioni” e “Perizie” diverse da me compilate, giudicò essere eseguibile il lavoro di completamento delle tre pareti per Vestibolo Michelangiolesco, perché ne esisteva una parete già compiuta. E siccome la nuova approvazione della “Giunta Superiore di Belle Arti” in nulla modifica la passata deliberazione, ma anzi la conferma, inquantoché non approva che la esecuzione della decorazione nelle pareti del Vestibolo, in quanto esse non sono che una esatta riproduzione delle decorazione esistente nella quarta parete di detto Vestibolo, eseguita dal Vasari sul disegno del grande Michelangelo. Considerando che la esecuzione di questo lavoro non è la effettuazione di un vero e proprio progetto d’iniziativa individuale, per il quale possono avanzarsi pretese di concetti decorativi nuovi speciali e nei quali in nulla è compromesso il merito artistico individuale ... e considerando come io sia il più anziano degli Architetti che fanno parte dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana ... rinnovo calda e speciale domanda ... per la esecuzione del lavoro»37.
34 “Deliberazione” della Giunta Superiore di Belle Arti s.d. ma febbraio 1900 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”.35 Missiva di Giacomo Boni per conto del Ministro P.I. al R.Commissario Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana del 13 marzo 1900 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.17713.36 Cesare Spighi, Promemoria sopra i lavori eseguiti alla Biblioteca Mediceo Laurenziana dall’architetto Cesare Spighi di Firenze, s.d. in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, s.p.37 Relazione di Cesare Spighi al Commissario per i Monumenti della Toscana, marchese Filippo Torrigiani, del 16 agosto 1900 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”.
FERRUCCIO CANALI90
Il Ministero affrettava dunque la visita della “Commissione nominata” e ne avvertiva, il 12 luglio 1900, Guido Carocci, perché accompagnasse i membri («Ricevo questo telegramma Commissione Giunta Superiore la quale visiterà oggi Biblioteca Laurenziana. Per commissario Carocci»38). Un disguido si verificava, però, proprio in merito al sopralluogo della Commissione, che era stata inviata a Firenze per molte questioni e ci si era dimenticati di aggiungere ufficialmente ad esse proprio quella relativa al Vestibolo. E, così, il marchese Torriggiani scriveva al Ministero:
«Commissione Ministeriale non si occupò lavori compimento Vestibolo Laurenziana non avendone avuto mandato; fece però visita Pistoria, conforme ordine ricevuto»39.
Di ritorno da Milano, i Commissari si erano dovuti fermare nuovamente a Firenze e questa volta appositamente per il Vestibolo michelangiolesco. Rientrati a Roma, i tre Commissari effettivi - Giuseppe Calderini (relatore), Ettore Ximenes e Gustavo G[iov]annoni [?] (sul terzo membro resta qualche dubbio ...) – stilavano la “Relazione” tanto attesa, pronta il 1 settembre 1900:
«Con telegramma di codesto Ministero, trasmesso alla Commissione sottoscritta dalla Prefettura di Milano, la Commissione stessa veniva incaricata di rifermarsi di nuovo a Firenze per decidere intorno ai lavori di compimento del Vestibolo della Biblioteca Laurenziana, di cui atta ad occuparsi la “Giunta Superiore delle Belle Arti”. La Commissione, aderendo all’incarico, visitò il predetto vestibolo nel giorno 12 corrente luglio in compagnia del p.Ispettore comm. Carocci e del p. architetto Castellucci dell’Ufficio Regionale di Firenze. L’ispezione fatta sul luogo confermò i criteri generali stabiliti sul proposito dalla Giunta e siccome fu riconosciuto assolutamente necessaria la rimozione del tetto attuale, il quale trovasi troppo basso ed impedisce perciò la costruzione del soffitto, così si opinò che assolutamente il tetto sia da rialzarsi non solo di quanto è strettamente necessario per il prestamento delle corde, ma anche diano quella maggiore altezza necessaria per dare posto alle
rientrane dei cassettoni del soffitto. Esaminata la parte esterna, rispondente nel cortile di San Lorenzo, per vedere se questo piccolo alzamento murario potesse arrecare danno estetico pel cortile stesso, si vide che il presente alzamento non è per produrre alcun disguido e che può per conseguenza liberamente eseguirsi»40.
4. La questione dell’affidamento dell’incarico della Direzione dei Lavori per il completamento del Vestibolo della Laurenziana e il coordinamento ministeriale di Giacomo Boni (1900-1901)
Tentando di salvare il suo vecchio incarico, il 15 settembre 1900, Cesare Spighi aveva scritto anche al Direttore Generale AA.BB.AA. Carlo Fiorilli avvertendolo di
«aver fatto spedizione al suo indirizzo di tutti i disegni e carte relative ai miei studi sulla Biblioteca Laurenziana ... con una cartella contenente i disegni, un inserto di carte contenente “Perizie” e “Relazioni”»41.
La “Commissione Calderini” aveva visitato il Vestibolo; le decisioni erano state prese; restava da dirimere la questione dell’affidamento dei lavoro (Spighi versus Castellucci).Nell’ottobre del 1900 Giacomo Boni riprendeva in mano e coordinava la questione, per cercare una ‘quadratura del cerchio’ tra le Autorità, i pareri ministeriali e i Funzionari, Studiosi e Architetti fiorentini:
«La “Commissione ministeriale” che ha avuto di recente l’incarico di visitare alcuni monumenti della Toscana, ha riferito in ordine alla ispezione da essa fatta, in concorso dell’ispettore [Guido] Carocci e dell’arch. Castellucci di codesto Ufficio, al Vestibolo della Biblioteca Mediceo Laurenziana. Premesso che i risultati assunti dall’ispezione hanno confermato i criteri generali stabiliti dalla “Giunta Superiore di Belle Arti” a proposito dei lavori di compimento da eseguirsi nel suddetto Vestibolo, la Commissione ministeriale così si esprime nel suo “Rapporto”: “Siccome fu riconosciuta assolutamente necessaria la remozione del tetto attuale, il quale trovasi troppo basso ed impedisce perciç la costruzione del soffitto, così si opinò che
38 Telegramma dal Ministero P.I. al Prefetto di Firenze del 12 luglio 1900 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”.39 Telegramma del Commissario Torrigiani al Ministero P.I. del 28 luglio 1900 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”.40 Giuseppe Calderini (relatore), Ettore Ximenes e G.G[iov]annoni [?], Sui lavori di compimento del Vestibolo della Biblioteca Laurenziana in Firenze. Relazione della Commissione Ministeriale all’illustre Ministro della Pubblica Istruzione del 1 settembre 1900 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.12402. Il terzo membro potrebbe essere davvero Gustavo Giovannoni (anche se la sua firma sull’elaborato non si mostra ben leggibile), che era dal 1899 Assistente nella Scuola per Ingegneri di Roma proprio presso la Cattedra di Calderini.41 Missiva di Cesare Spighi a Carlo Fiorilli, Direttore delle AA.BB.AA. del Ministero P.I. del 15 settembre 1900 in Roma, ACS, III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”.
il completamento del vestibolo della laurenziana (1880-1905) 91
assolutamente il detto tetto sia da rialzarsi non solo di quanto è strettamente necessario per il postamento delle corde [che devo reggere i teloni del soffitto], ma anche di quella maggiore altezza necessaria per dare posto alle rientranze dei cassettoni del soffitto. Esaminata poi la parte esterna, rispondente nel cortile di San Lorenzo, per vedere se questo piccolo alzamento murario potesse arrecare danno estetico sul cortile stesso, si vide che il predetto alzamento non è per produrre alcun disguido e che può per conseguenza liberamente eseguirsi”. Dunque questo Ministero accoglie pienamente le proposte della Commisisone e autorizza la S.V. a disporre per l’esecuzione dei lavori nei modi e nei limiti sovraindicati, fermo, per ciò che riguarda il compimento delle pareti del Vestibolo, quant è rimasto stabilito con ministeriale del 13 marzo 1900 n.3213. Lo scrivente coglie poi l’occasione per informare la S.V. che l’arch.cav. Spighi, riferendosi alle precedenti sue istanze, ha rivolto nuove premure perché gli sia affidata la Direzione delle opere dianzi ricordate, richiamando l’attenzione di questo Ministero sul danno morale che gli verrebbe qualora le opere medesime, per le quali esso arch. Spighi ha allestito da vari anni studi e proposte, fossero condotte a termine sotto la guida di un altro funzionario tecnico. Questo Ministero a tal riguardo non dovrebbe che riferirsi alle dichiarazioni già fatte alla S.V. con la nota del 23 luglio; ma per ragioni di convenienza, che certo non isfuggiranno alla saviezza e prudenza della S.V., non può non riconoscere: - che dopo le eccezioni e le riserve della “Giunta Superiore di Belle Arti” e dopo le proposte formulate dalla “Commissione ministeriale”, i lavori da eseguirsi nel Vestibolo della Laurenziana, sono ridotti a proporzioni molto modeste; - che per ciò che riguarda il compimento delle pareti, le proposte di codesto Ufficio [coincidono] con quelle fatte in precedenza dall’arch. Spighi; - che per quanto si riferisce al nuovo soffitto da costruirsi, i criteri adottati dalla “Giunta Superiore di Belle Arti” e confermati dalla “Commissione Ministriale” hanno creato una situazione nuova, che non permette di trarre partito dagli studi fatti in proposito dall’arch. Castellucci. Per queste considerazioni, e avuto riguardo dell’anzianità dell’arch. Spighi e al fatto che i lavori alla Laurenziana furono per il passato eseguiti sotto la Direzione di lui, lo Scrivente crede che anche la Direzione delle nuove opere potrebbe, senza inconvenienti, essergli affidata. Se anche la S.V. concorre in questo parere, voglia
dare le necessarie disposizioni per l’inizio delle opere e sono sicuro che, con la cortesia e il tatto che la distinguono, saprà trovare il modo più acconcio di chiudere questo incidente, senza che ne rimanga lesa la suscettibilità personale dell’uno o dell’altro dei due Funzionari ... e senza che ne rimangano turbate con chichessia la disciplina e le buona armonia tra il personale di codesto Ufficio»42.
Torrigiani, però, evidentemente non ne voleva sapere di Spighi e l’Architetto, qualche mese dopo, nel maggio del 1901, era costretto a ricorrere alle sue ‘aderenze’ ministeriali
«[dopo le opere svolte, nel 1893] restava da eseguire il completamento del Vestibolo che rimaneva difficile portarsi a compimento per la deficienza delle somme occorrenti. Il Barone Podestà, Prefetto della Laurenziana, con lettera del 5 settembre 1894 chiedeva al Ministero di porre mano alla esecuzione dei lavori del Vestibolo, ma fu risposto che, causa la deficienza delle somme inscritte in Bilancio, non poteva prendersi per allora decisioni in proposito. Oggi sembra che le somme necessarie alla esecuzione di questo lavoro siano disponibili, ma so che ad altre persone facenti parte dell’Ufficio al quale appartengo, a me inferiori per nomina e per organico, e che mai hanno preso parte ai lavori fatti alla Laurrenziana, debba essere dato l’incarico della Direzione di questo lavoro, nonostante che nel 1889 codesto onorevole Ministero mi scrivesse per mezzo della R.Prefettura quanto appresso: “Il Ministero Le richiede per mio mezzo il progetto del Vestibolo che le fu ritornato con lettera del 15 corrente n.133. Il Ministero poi vuole che Ella sappia che con ciò intende punto di toglierle il mandato affidatole, che anzi prende questa occasione per confermarglielo e per ripeterle che quando saranno finiti gli studi necessari ad eseguire il detto restauro e si potrà mettere mano al lavoro, Ella ne sarà il Direttore con una mensile retribuzione”. Faccio quindi rispettoso appello alla Eccellenza Vostra perché si compiccia verificare lo stato dei fatti e voglia impedire che io debba sopportare una umiliazione così forte quanto immeritata. Ardisco poi pregare l’E.V. di prendere cognizione delle “Relazioni” del compianto prof. Luigi Del Moro e del comm. Luca Beltrami sopra i lavori da me compiuti nel 1891-1892 alla Biblioteca Laurenziana e ciò in seguito ad un carteggio avvenuto fra il libraio fiorentino cav. Pietro Franceschini e l’allora Ministro comm. Pasquale Villari, non che della
42 Missiva di Giacomo Boni al marchese Filippo Torrigiani, Regio Commissario per i Monumenti della Toscana, del 3 ottobre 1900 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.12402.
FERRUCCIO CANALI92
“Relazione”, per quanto mi riguarda, e della sua conclusione compilata dall’illustre prof. Camillo Boito, Relatore della Commissione incaricata di giudicare il Concorso per il posto di Direttore dell’Ufficio Regionale della Toscana»43.
La ricostruzione di Spighi collimava solo in parte rispetto a come gli Organi ministeriali ‘raccontavano’ la vicenda (ognuno sminuiva i propri dinieghi o quelli ricevuti e riduceva la rilevanza delle opere). Infatti per parte ministeriale la posizione era sostanzialmente di ‘interscambiabilità’ fatte salve le ragioni di ‘opportunità’:
«Per i lavori di compimento del vestibolo della Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, l’arch. Spighi aveva presentato nel 1886 e ripresentato, con qualche variante, nel 1888 un suo progetto corredato di alcuni disegni, sui quali la Commissione Permanente di Belle Arti, nella sua adunanza del 21 dicembre 1888, non credette di poter pronunciarsi perché non davano un’idea completa del lavoro proposto. Il voto sospensivo della “Commissione Permanente” fu comunicato all’arch. Spighi nel gennaio 1889, a mezzo del R. Prefetto di Firenze, ma da allora in poi l’arch.Spighi non ha mai comunicato maggiori elementi di giudizio e i nuovi studi rafici chiesti dalla predetta Commissione Permanente. Istituito [nel 1891] l’”Ufficio Regionale di Firenze”, il compianto prof. Del Moro dava incarico all’arch. Castellucci di allestire un nuovo progetto per i lavori. Quest’ultimo progetto, ultimato dal Castellucci dopo la morte del prof. Del Moro [nel 1897], fu sottoposto all’esame della Giunta Superiore di Belle Arti, la quale espresse avviso contrario alla esecuzione di alcuni lavori proposti per la decorazione ex novo del Vestibolo, ammettendo invece i lavori di completamento
delle pareti, trattandosi con questi ultimi di continuare semplicemente il partito decorativo già stabilito. Una delegazione della “Giunta Superiore”, recatasi sopra luogo, confermò il parere di cui sopra, riconoscendo inoltre la necessità di rialzare il tetto del vestibolo di quanto è necessario per dar posto alle rientranze dei cassettoni del nuovo soffitto. Ridotti i lavori a così semplici proporzioni, tornava indifferente la scelta della persona da preporsi alla Direzione di essi. Ciò nondimeno, poiché il cav. Spighi nei suoi vari reclami aveva creduto di poter invocare un ‘diritto di priorità’, il Ministero, nell’autorizzare l’esecuzione delle opere, fece conoscere al Direttore dell’Ufficio Regionale, marchese Torrigiani, che esso non aveva nessuna difficoltà a che la Ditezione delle opere stesse fosse affidata al cav. Spighi, anziché all’arch. Castellucci. Dal nuovo “Memoriale” presentato dal cav.Spighi e del telegramma da esso diretto al sig. A.Martini, risulta ora che i lavori sono cominciati senza che la Direzione di essi sia stata affidata al cav.Spighi. Il Ministero però non ha elementi per giudicare se e per quali ragioni il marchese Torrigiani, Direttore dell’Ufficio Regionale, abbia creduto opportuno di non valersi dell’autorizzazione data dal Ministero riguardo all’incarico chiesto dall’arch. Spighi»44.
Spighi minacciava però ritorsioni legali («Questa mattina [20 maggio] mia insaputa posto mano vestibolo Laurenziana contrariamente promesse fattemi. Pregoti provvedere subito amici presso Ministero per evitarmi fare contestazioni legali»45) e così, fatta decantare un po’ la furia, toccava solo a Torrigiani pronunciarsi ufficialmente E nell’ottobre era il nuovo Direttore dell’Ufficio Regionale, Agenore Socini46 (che non amava certo Spighi e che gli aveva appena ‘soffiato’ quel posto di Direttore), a scrivere al Ministero per dirimere
43 Cesare Spighi, Lettera pro-memoria sopra i lavori eseguiti alla Biblioteca Mediceo Laurenziana dall’architetto Cesare Spighi di Firenze, a S.E. il comm. Giacomo Cortese, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione Pubblica” del 10 maggio 1901 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel Vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, s.p.44 Promemoria della Direzione AA.BB.AA. del Ministro P.I. al Ministro del 21 maggio 1901 in Roma, ACS, III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, s.p.45 Telegramma di Cesare Spighi ad un funzionario del Ministero della P.I. (forse il sottosegretario Giacomo Cortese) del 20 maggio 1901 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, s.p.46 Il senese Agenore Socini (1859-1926) dopo essersi iscritto nel 1876 all’Istituto d’Arte della città, nel 1880 veniva ammesso alla “Scuola di Architettura dell’Istituto, già nel 1884 iniziava a lavorare con Giuseppe Partini, Maestro della Scuola stessa nonché uno dei massimi rappresentanti del Neogotico senese, come apprendista e come aiuto. Con Partini, Socini collaborava al restauro del Castello di Brolio (dal 1880 al 1894) fino a s che, con la morte del suo Maestro nel 1894, ne ereditava i cantieri in città (a partire dagli interventi nel Duomo, nel battistero di San Giovanni, nella basilica di Santa Maria dei Servi), tanto che, tra il 1895 e il 1902, dirigeva a Siena una trentina di cantieri, fra i quali quelli della chiesa di Sant’Elisabetta della Visitazione, dell’Istituto Santa Caterina e del campanile della chiesa di San Giacomo. Nel 1901 veniva nominato “Direttore incaricato nel ruolo del personale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana” e gli veniva dunque affidata la Direzione dell’Ufficio Regionale a Firenze. Socini continuava, comunque, a lavorare a importanti restauri a Siena, dove veniva anche nominato Professore di Architettura nella Reale Accademia di Belle Arti (di cui divenne Presidente nel 1913), per poi assumere il ruolo nel 1910 di primo Soprintendente ai Monumenti di Firenze. Cfr.www. siusa.archivi.beniculturali.it, “Archivi di personalità. Censimento dei fondi toscani tra ‘800 e ‘900”: Socini Agenore, consultato nel giugno 2014.
il completamento del vestibolo della laurenziana (1880-1905) 93
la nuova questione creata sulla identità del soffitto da eseguire (quello del Vestibolo o quello della Sala michelangiolesca) ignorando le pretese di Spighi e avocando a sé, salomonicamente, la conduzione dell’impresa:
«l’E.V. con la sua pregiata lettera del 13 marzo 1900 n.17713, riferendo il parere emesso dalla Giunta Superiore di Belle Arti sul progetto redatto dall’architetto Castellucci per il completamento del vestibolo d’accesso alla Biblioteca Laurenziana, nettamente determinava l’azione di questo Ufficio. E con la successiva lettera del 3 ottobre 1900 più precisamente stabiliva che del tutto insieme del lavoro si dovesse provvedere, prima di ogni altra cosa, al completamento delle decorazioni di pietra delle pareti, poi al necessario rialzamento della tettoia e infine, dopo che la Giunta Superiore avesse preso nuovamente in esame il progetto delle decorazioni del soffitto, all’applicazione di esse. Ora, è evidente che lo stanziamento fatto in conto ... sotto il titolo generico di “Soffitto” comprendeva tutte le decorazioni che mancano al Vestibolo d’accesso alla biblioteca, nonché le opere indispensabili ad applicarlo quale il rialzamento della tettoia, perché sarebbe impossibile di pensare di applicare un soffitto prima di costruire le pareti che lo debbono sostenere e prima ancora di elevare lo spazio utile di quanto è necessario a contenerlo. Nè può ritenersi che lo stanziamento di quel Capitolo debba essere destinato alla costruzione del soffitto nella grande sala della Biblioteca, della quale il soffitto, opera dello stesso Michelangelo, è completo ... Stimo che questo breve cenno di conferma dello stato di fatto ... valga a chiarire presso la R.Corte dei Conti la proposta di interpretazione della spesa ... interessando nuovamente l’E.V. a sollecitare per quanto è possibile la risoluzione definitiva della cosa»47.
Anche Guido Carocci veniva nuovamente coinvolto nell’iniziativa con il compito di supervisionare la correttezza degli incartamenti. L’Ufficio Regionale ne doveva fare richiesta al Ministero, perché erano giunte a Firenze documentazioni incomplete («prego cortesemente inviarmi ... “Perizia” allegata “Atto di cottimo lavori completamento vestibolo Biblioteca Laurenziana” che non fu inserita Ministeriale
23 novembre 1901 n.ro 18073 per commissario Carocci»48). Le opere potevano così prendere definitivamente il via ... (ed evidentemente Spighi veniva tacitato con altre promesse ...).Ora si trattava di ‘dettagli tecnici, come sottolineava Guido Biagi:
«Col “Capitolo 163” del Bilancio e con la somma di lire 10.000 si è provveduto alla montatura al posto dei pietrami che servono al rivestimento delle pareti del vestibolo di Michelangelo. Ma il lavoro ricominciato, e per il quale sono già stati fatti i ponti, rischia di rimanere interrotto e il monumento michelangiolesco di restaurare incompiuto chi sa per quanti secoli ancora, se non si provvede alla spesa della cornice architettonica di coronamento per le quattro fronti del vestibolo, del suo relativo collocamento e altre necessità ... per la somma di lire 3000. L’Architetto Direttore dell’Ufficio [Socini] opina che se a tali lavori si ponesse mano senza indugio “oltre al beneficio di non lasciare di nuovo incompiuta l’opera michelangiolesca, si otterrebbe una non lieve economia valendosi degli attuali ponti di servizio. E si potrebbe in pari temo fare con tele dipinte la prova per la decorazione del soffitto”. Ho fiducia che la S.V. vorrà prendere in seria considerazione la convenienze d’usufruire dei ponti esistenti ... Non è possibile che lo Stato, dopo aver messo mano ad un lavoro che da secoli attendeva il suo coronamento, e per il quale si è più volte interrogata la Giunta Superiore di Belle Arti, lo lasci ora sospeso per mancanza di mezzi adeguati. La piccola somma di lire 3000, che non sarà oltrepassata, potrà essere tolta dai fondi del “Capitolo 45”, nel quale è uno speciale articolo che concerne le Cappelle Medicee, mentre ve ne dovrebbe essere uno non minore per le altre e più importanti parti del Monumento Laurenziano, le quali hanno maggior pregio delle Cappelle e più urgenti necessità di restauro ... [Si tratterebbe] di un’opera monumentale che anche Ferdinando III, Granduca di Toscana [dal 1790 al 1799 e dal 1814 al 1824] desiderò ma non poté veder compiuta. Anche ai tempi di questo Granduca si fece il palco per completare il Vestibolo, ma il palco cadde in polvere perché le sopravvenute vicende politiche impedirono al Principe di mandar ad effetto il suo disegno»49.
47 Missiva dal Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana, Agenore Socini, alla Direzione AA.BB.AA. del Ministro P.I. del 27 ottobre 1901 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.16311.48 Telegramma del Direttore dell’Ufficio Regionale, Agenore Socini, alla Direzione AA.BB.AA. del Ministro P.I. del 2 gennaio 1902 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”.49 Missiva del Bibliotecario Capo, Biagi, della Regia Biblioteca Mediceo-Laurenziana alla Direzione AA.BB.AA. del Ministro P.I. del 2 gennaio 1902 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.158.
FERRUCCIO CANALI94
Nell’ottobre del 1902 era però Castellucci a redigere una dettagliata “Perizia dei lavori di muratore necessari per la montatura al posto dei pietrami nel Vestibolo della Biblioteca Laurenziana e per il rialzamento del tetto” per la spesa totale di lire 3476. Si prevedeva, per il tetto,
«smontatura e rimontatura, compresi i legnami attuali e quelli nuovi occorrenti e rinnuovo di una parte del materiale laterizio ... [con l’aggiunta di] n.6 puntoni mancanti di mc 3 ... Muro di rialza-mento e di rivestimento di pietrami da eseguirsi con sassi e mattoni mc 65 ... e taglio dei quattro pi-lastri di mattoni per una profondità dai 15 ai 20 cm ... e costruzione della gronda in giro al Vestibolo»50
ma si trattava di un ‘documento d’ufficio’. Infatti nel novembre, Guido Biagi puntualizzava che
«i pietrami necessari al soffitto della grande Sala comunemente chiamata “Vestibolo” son già con-dotti a pie’ d’opera e non resta che metterli a po-sto. La relativa spesa ,a cura dell’Ufficio Regiona-le, fu già sostenuta ... e ora, per mettere a posto codesti pietrami, l’Ufficio Regionale ha compilato una “Perizia” di lire 3480, con le quali si esaurisce lo stanziamento in bilancio. Ma per compiere il lavoro, con ogni sollecitudine e con operai di fidu-cia, l’Ufficio chiede, per mio mezzo, di non essere obbligato alle lungaggini e formalità di un contrat-to, ma che gli sia data la facoltà di provvedere ai pagamenti con la presentazione di tante “Note” dei lavori fatti, sino alla concorrenza della somma prevista»51.
5. I giudizi di Ernesto Basile e della Giunta Superiore di Belle Arti per il completamento del Vestibolo «in armonia con il Salone di Michelangelo, che ne è la continuazione». Una questione di ‘modelli lignei’: l’adozione dell’antico modello ligneo del coronamento e il nuovo «modello in legno di una finestra»
Tutto sembrava procedere per il meglio, ma il Ministero necessitava di ulteriori sicurezze, vista la delicatezza del completamento. Nel gennaio del 1903, il Direttore dell’Ufficio Regionale, Agenore Socini, faceva il punto della situazione che si protraeva almeno da tre anni:
«preparati che furono in perfetta conformità di quelli esistenti, tutti i pietrami per il rivestimento delle pareti, ancora nude, del Vestibolo, vennero colla massima alacrità posti in opera. E perciò, a compimento di tali lavori, per i quali soli era stata da codesto Ministero approvata la spesa, il Bibliotecario, comm.Biagi, faceva subito l’istanza all’E.V. per ottenere l’approvazione anche per la spesa occorrente alla preparazione e collocazione dei pietrami della cornice di coronamento. Nel progetto generale dei lavori per completare l’opera di Michelangiolo, approvato in massima con nota ministeriale del 13 marzo 1900 e in modo definiti-vo del 3 ottobre 1900, la cornice di coronamento era stata delineata anch’essa in conformità di un tratto esistente, creduto di pietra, mentre effettiva-mente è di legno. Ma a giudicare dai caratteri ar-chitettonici, quella cornice fu, senza verun dubbio, ivi apposta fin dai tempi del Vasari come modello per vederne l’effetto. Il quale deve essere parso allora [adeguato], poiché il modello vi fu lasciato nonostante l’avvenuta interruzione di quel lavoro, come parve poi sempre tale che fu da tutti gli Ar-tisti, Storici e Critici d’Arte creduto che fosse stato di pietra. Quest’Ufficio si è quindi, non già perché dubiti dell’autenticità di quel modello che ha le forme caratteristiche delle rimanenti decorazione del vestibolo, come è dato rilevare dallo unito di-segno, creduto in dovere di rendere consapevole del fatto l’E.V. ... per l’esecuzione della cornice in conformità di quel modello»52.
L’Ufficio Regionale aveva inviato la richiesta, ma la “Giunta Superiore di Belle Arti” del Ministero chiedeva ulteriori chiarimenti, che Socini si affrettava ad inoltrare. In particolare, preoccupava la questione della datazione di quel tratto originale della cornice «creduto di pietra, mentre effettivamente è di legno»53. Se le motivazioni di Socini sull’autorialità vasariana potevano essere discusse (cioè gli aspetti ‘artistici’: «i caratteri architettonici»), il carattere ‘storico’ necessitava di appigli più sicuri:
«Corrispondo con la massima sollecitudine ... in-viando la fotografia di quel lato del Vestibolo ove si trova il tratto in legno della cornice di corona-mento, fornendo le seguenti prove della sua auten-ticità: a. La cornice di coronamento della grande
50 G.Castellucci, “Perizia dei lavori di muratore” del 15 ottobre 1902 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”.51 Missiva del Bibliotecario Capo, Biagi, della Regia Biblioteca Mediceo-Laurenziana alla Direzione AA.BB.AA. del Ministro P.I. del 2 gennaio 1902 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.17611.52 Missiva del Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana al Ministro P.I. del 21 gennaio 1903 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.1709.53 Mi sembra che di tutta la questione della cornice lignea, vasariana o meno, non vi sia notizia alcuna nelle Letteratura scientifica attuale riferita al Ricetto.
il completamento del vestibolo della laurenziana (1880-1905) 95
Sala della Biblioteca, opera di Michelangelo, è perfettamente conforme al modello in legno per la cornice del vestibolo ... fatto fare e ivi collocato dal Vasari a giudicare dal suo effetto; b. Abbiamo poi una conferma della sua autenticità nelle seguenti riproduzioni del vestibolo, tutte con quella cornice di coronamento: 1. due disegni d’Ignoto del sec. XVII nella Galleria degli Uffizi; 2. Un’incisione nell’”Architettura civile” del Ruggeri, dell’anno 1722; parecchie incisioni nelle “Fabbriche fiorenti-ne” di Gaetano Guasti. I disegni del Seicento, che riproducono il Vestibolo con la cornice di corona-mento affatto [nel senso di: del tutto] identica al modello ligneo, sono una prova indubitabile che questo modello ivi già esisteva, poiché in quel se-colo, se avessero dovuto fare un modello per la cornice di coronamento che mancava al Vestibolo, non l’avrebbero certo ideato di quella forma, ma nello stile architettonico del tempo. E l’incisione del Settecento riproduce anch’essa il Vestibolo con quella precisa cornice di coronamento. Non consta poi che nel secolo XVII siasi avuto l’intendimen-to di completare il Vestibolo; e certo sarebbe stato necessario di completarlo, prima di pensare alla cornice dei coronamento»54.
Necessitava, ancora una volta, il parere della “Giunta Superiore di Belle Arti” del Ministero. E così da un’apposita riunione derivava, il 23 febbraio 1903, un “Parere”:
«sul progetto generale dei lavori proposti dall’Uffi-cio Regionale pei Monumenti della Toscana, al fine di completare il Vestibolo della biblioteca Mediceo Laurenziana, di cui due pareti erano rimaste prive del rivestimento, la Giunta Superiore di Belle Arti espresse già nel 1900 il proprio parere, respingen-do le proposte riferentesi al soffitto, poiché non reputava conveniente completare l’opera miche-langiolesca senza avere dati sicuri ed approvando solo i lavori di completamento delle pareti perché trattavasi di continuare il partito decorativo già sta-bilito. E il Ministero accolse il voto della Giunta e autorizzò, nei limiti indicati, l’esecuzione dei lavori. Furono preparati, in perfetta conformità di quelli esistenti, tutti i pietrami per il rivestimento delle pareti, ancora nude, del Vestibolo e posti in opera a cura dell’Ufficio Regionale. A compimento poi di siffatti lavori, fu consentita la spesa necessante
alla preparazione e collocazione della cornice di coronamento. Nel progetto generale, la cornice di coronamento era stata delineata anch’essa in conformità di un tratto esistente, creduto di pietra, mentre effettivamente è di legno. Prima di conti-nuare l’opera intrapresa, l’Ufficio Regionale si è rivolto al Ministero per sapere quel che delibera in proposito».
E la Giunta, ancora coordinata da Adolfo Avena come «Segretario», approvava all’unanimità l’autorizzazione ad eseguire il completamento della parte sommitale, la «cornice di coronamento», del Vestibolo:
«tenuto conto delle ragioni esposte dall’Ufficio Regionale pei Monumenti della Toscana nel suo rapporto del 19 gennaio 1903 circa il modello di legno della cornice che corona il second’ordine del Vestibolo della Biblioteca Mediceo-Laurenziana; esaminati i disegni e le fotografie unite agli Atti; considerando che il modello di cui trattasi ha tutti i caratteri dell’autenticità, opina che sia da appro-vare la proposta di ripristinare la cornice ripetendo la sagoma del modello di legno che è sul posto»55.
Si trattava solo di affidare l’opera all’esecutore, cosa alla quale procedeva il Direttore dell’Ufficio Regionale:
«In seguito alle disposizioni concretate da V.E. con il sig. Bibliotecario della Laurenziana que-sto Ufficio avrebbe convenuto con lo scalpellino Antonio Becagli, che ha lodevolmente eseguito il rivestimento in pietra delle pareti del Vestibolo della Biblioteca, la esecuzione del cornicione di coronamento dell’edifizio all’interno e all’esterno nel modo approvato dalla on. Giunta Superiore di Belle Arti»56.
Il progetto era quello di Castellucci, come si sottolineava negli atti ufficiali:
«premesso come “Atto di cottimo” con D.Mle 26 agosto 1901 affidato al sig.Antonio Becagli per la esecuzione dei lavori di scalpellino necessari al completamento delle decorazioni in pietra del ve-stibolo ... E come manifestatasi la convenienza di condurre senza interruzione il completamento di
54 Missiva del Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana al Ministro P.I. del 13 febbraio 1903 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.2778.55 Verbale n.65 e Deliberazione della Giunta Superiore di Belle Arti del 23 febbraio 1903 in Roma, ACS, III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”. Quindi: Missiva del Ministro P.I. al Direttore dell’Ufficio Regionale toscano del 30 marzo 1903 in Roma, ACS, III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.2778.56 Missiva del Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana al Ministro P.I. del 7 aprile 1903 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.1327.
FERRUCCIO CANALI96
quelle decorazioni con l’apposizione del cornicione di coronamento all’interno e di ricorso all’esterno del fabbricato, S.E. il Ministro dell’Istruzione Pub-blica approvò all’uopo il progetto proposto dall’ar-chitetto cav. Giuseppe Castellucci e la “Perizia del-la spesa” in data del 31 marzo 1903 per l’ammonta-re complessiva di lire 2398. In virtù della lettera di S.E. il Ministro della Istruzione Pubblica in data 24 aprile 1903 n.6227, che autorizza l’Ufficio Regio-nale per a Conservazione dei Monumenti della To-scana ad affidare la esecuzione del lavoro comple-mentare proposto, per quanto concerne l’opera di Scalpellino allo stesso Antonio Becagli alle stesse condizioni che furono pattuite con l’”Atto di cot-timo” del 24 luglio 1901 ... per completare col cor-nicione di coronamento all’interno le decorazioni di pietra delle pareti del Vestibolo della Biblioteca Laurenziana e all’esterno la cornice di ricorso e di posa della gronda della tettoia, in conformità alla “Perizia” redatta in data 31 marzo 1903 dall’archi-tetto cav. Castellucci ... alle seguenti condizioni: 1. La pietre da impiegare saranno in tutto conformi al campione presentato dall’aggiudicatario e d ac-cettato dall’Ufficio Regionale; 2. Il lavoro ... sarà condotto ordinatamente e di continuo, senza inter-ruzione da parte dell’aggiudicatario, il quale deve in tutto seguire le ordinazioni giornaliere che gli vengono fatte dall’Architetto Direttore e le norme che agli effetti artistici del lavoro egli, caso per caso, determini; 3. Ogni singolo pezzo, prima di essere posto in opera, sarà collaudato dall’Architetto Di-rettore, al quale è riservata ampissima facoltà di non accettarlo, sia per difetto che vi si riscontri nel-la pietra, come nella lavorazione»57.
Se per la cornice di coronamento si poteva procedere spediti58, la questione delle finestre esterne si presentava con maggiore difficoltà, visto che se ne doveva scegliere l’andamento preciso della mostre. Il 22 giugno 1904, era il Direttore Generale AA.BB.AA. Carlo Fiorilli che, prima dell’avvio delle opere, sollecitava al Direttore dell’Ufficio Regionale toscano l’invio delle tavole, delle “perizie” e delle fotografie dell’esistente per avere un ennesimo giudizio della “Giunta
Superiore di Belle Arti”:
«prima di mettere mano alla decorazione esterna del vestibolo ed armonizzarla con quella, pure esterna, del salone di Michelangelo, che ne è la continuazione, codesto Ufficio Regionale ha avvertito di aver collocato al posto il modello di legno di una finestra per vederne l’effetto ed avere il giudizio della “Giunta Superiore di Belle Arti” sulla decorazione completa di quella fronte del Ricetto ... [si prega di inviare] una particolareggiata relazione sui lavori onde trattasi, corredata di buone fotografie e di quelle altre illustrazioni grafiche che meglio valgano a dare un’idea chiara e compiuta di siffatta questione; a risolvere la quale vedrà la Giunta stessa se non sia necessaria di farla esaminare sopra luogo da una Commissione da eleggere nel proprio seno»59.
Ancora una volta ci si valeva di una maquette lignea per giudicare l’effetto e Castellucci poteva stilare una opportuna “Perizia”, nel 1904:
«1. Costruzione di n.3 finestre in pietra in conformità del modello in legno collocato al posto a lire 400 ciascuna; 2. Collocazione in opera di dette finestre comprese le staffe in ferro e rifacimento degli imbotti; 3. Esecuzione degli intonaci su tutto il prospetto esterno del vestibolo mq 120; 4. Collocazione dei reticolati in ferro delle tre finestre; 5. Costruzione del ponte di servizio e dell’armatura per il tirare dei pietrami; 6. Coloritura della facciata e della gronda»60.
E Socini inviava il progetto completo al Ministero:
«mi pregio di accompagnare a codesto on. Ministero la proposta di completamento della parte esteriore del Vestibolo della Biblioteca Mediceo Laurenziana presentata dall’architetto di questo Ufficio, cav. Giuseppe Castellucci. Il lavoro da eseguirsi, com’è dimostrato nelle due fotografie allegate al disegno, consiste nell’applicazione al piano superiore di tre finestre in Pietra Serena, uguale a quella delle finestre del
57 L”Atto a cottimo” per “Costruzione del cornicione di coronamento all’esterno e all’interno del Vestibolo” del 6 maggio 1903 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, firmato da Socini, Becagli e Castellucci.58 «Per corrispondere al M.scalpellino Antonio Becagli il pagamento della somma di lire 1055,44 dovutagli a saldo del lavoro che egli ha eseguito per la formazione del cornicione di coronamento all’interno e all’esterno del Vestibolo della biblioteca Mediceo Laurenziana, eseguito in conformità dell’”Atto a cottimo” del 6 maggio 1903»: missiva del Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana, Agenore Socini, al Ministro della Istruzione Pubblica del 7 dicembre 1903 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1, “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.4780.59 Missiva del Ministro della P.I. al Direttore dell’Ufficio Regionale per i Monumenti della Toscana del 22 giugno 1904 in Roma, ACS, AA.CC.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.10111.60 “Perizia di massima per la costruzione di tre finestre di Pietra Serena e per la costruzione esterna del vestibolo della Biblioteca Laurenziana” del 28 giugno 1904 del 1 luglio 1904 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”.
il completamento del vestibolo della laurenziana (1880-1905) 97
piano inferire, della forma delineata nel disegno e apparente nella seconda fotografia da un modello in legno applicato a uno dei vani del piano inferiore. La spesa ammonta all’attuazione del progetto, considerata dalla “Perizia” che correda il progetto, è di lire 2200»61.
Relatore del progetto presso la “Giunta Superiore di Belle Arti” del Ministero era, questa volta, Ernesto Basile e così il consesso deliberava che
«terminatosi nella parte interna il Vestibolo ... e la decorazione architettonica, si ritennero necessari alcuni lavori di compimento. Essi consistono nell’apertura di altre 6 finestre, nel proseguimento della scala a chiocciola che serve di accesso al soffitto, nel complemento della facciata esterna del Vestibolo e finalmente nella decorazione del soffitto ad imitazione di quello del Salone di Michelangelo. Per poter iniziare la decorazione esterna del Vestibolo e metterla in armonia con quella pure esterna del Salone di Michelangelo, che ne è la continuazione, l’Ufficio regionale per i Monumenti della Toscana ha collocato a posto di modello in legno di una finestra per vederne l’effetto e il Ministero chiede il giudizio della Giunta Superiore di Belle Arti sulla decorazione completa di quella fronte. L’architetto Basile, dopo aver mostrato a colleghi le fotografie e un lucido e riassunti gli scopi che ha voluto raggiungere l’Ufficio Regionale con i lavori eseguiti all’interno ed all’esterno del Vestibolo della Laurenziana, legge il seguente ordine del giorno concordato coi colleghi della Sottocommissione: “la Giunta Superiore, esaminato il progetto dell’Ufficio Regionale per i Monumenti della Toscana in ordine al completamento della facciata esterna del vestibolo ... vedute le fotografie è di parere che possano essere approvati il disegno complessivo dell’opera e il modello della finestra”. Ordine del giorno approvato all’unanimità nella adunanza pomeridiana del 6 luglio 1904»62.
Ormai si era alle ultime battute e il 13 agosto 1904 arrivava la notizia da Firenze che
«il Direttore dell’Ufficio Regionale per i Monumenti di Firenze mi comunica di avere già disposto che si inizi immediatamente e sia condotto a termine nel modo più sollecito il lavoro già approvato per il completamento della facciata esterna e del Vestibolo della Biblioteca»63.
61 Missiva del direttore dell’Ufficio Regionale per i Monumenti della Toscana Agenore Socini al Ministro della Pubblica Istruzione del 1 luglio 1904 in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.11770.62 Deliberazione della Giunta Superiore di Belle Arti del Ministero della Pubblica istruzione del 6 luglio 1904 in in Roma, ACS, AA.BB.AA., III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”: “Completamento della facciata esterna del vestibolo della Biblioteca Mediceo-Laurenziana in Firenze”.63 Missiva dal Direttore Generale AA.BB.AA. al Direttore Capo della Divisione I del Ministero P.I. del 13 agosto 1904 in Roma, ACS, III versamento, II parte, b.570, fasc. 1 “Compimento delle pareti nel vestibolo della Biblioteca Laurenziana, 1900”, prot.14087.
didascalie
Tutte le immagini sono tratte da: Roma, ACS, III vers, II parte, b.570. (Le immagini vengono tutte pubblicate per concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana, n. 1196/2014)1. Giuseppe Castellucci, Progetto di restauro dell’esterno del volume del Ricetto della Biblioteca Mediceo Laurenziana, anni Novanta del XIX secolo.2. Giuseppe Castellucci, Progetto di ripristino di finestra esterna nel volume del Ricetto della Biblioteca Mediceo Laurenziana, anni Novanta del XIX secolo.3. Fotografia dei ponteggi elevati per l’esecuzione del restauro dell’esterno del volume del Ricetto della Biblioteca Mediceo Laurenziana, anni Novanta del XIX secolo.4. Disegno seicentesco con il prospetto interno, in corrispondenza del vano scale “ovato”, del Ricetto della Biblioteca Mediceo Laurenziana (Uffizi, GDSU 4436A). Il disegno era stato assunto da Cesare Spighi e poi da Giuseppe Castellucci come indicazione per il completamento della parte alta del Ricetto.5. Disegno seicentesco con il prospetto laterale del Ricetto della Biblioteca Mediceo Laurenziana (Uffizi, GDSU 4435A). Anche questo disegno era stato assunto da Cesare Spighi e poi da Giuseppe Castellucci come orientamento per il completamento della parte alta del Ricetto.6. Giuseppe Castellucci, rilievo dell’ordine ‘annicchiato’ michelangiolesco del registro inferiore del Ricetto della Biblioteca Mediceo Laurenziana, anni Novanta del XIX secolo.7. Giuseppe Castellucci, rilievo dell’ordine michelangiolesco del registro superiore del Ricetto della Biblioteca Mediceo Laurenziana, anni Novanta del XIX secolo.8. Fotografia della parte sommitale, incompiuta, del Ricetto della Biblioteca Mediceo Laurenziana, anni Novanta del XIX secolo.9. Fotografia dell’apposizione della maquette lignea, preparata per l’espressione del giudizio di congruità per il completamento della parte sommitale del Ricetto della Biblioteca Mediceo Laurenziana, anni Novanta del XIX secolo.10. Fotografia del registro superiore del Ricetto della Biblioteca Mediceo Laurenziana in vista del completamento della parte sommitale, anni Novanta del XIX secolo.11. Fotografia di una vetrata del Salone Michelangiolesco della Biblioteca Mediceo Laurenziana da sottoporre a restauro, primi del Novecento