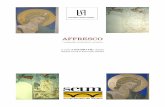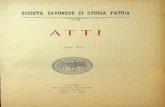Giorda 2012, Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita. Il Risorgimento nei manuali di...
Transcript of Giorda 2012, Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita. Il Risorgimento nei manuali di...
RSCr 9(1/2012) 89-116
MARIA CHIARA GIORDA
RELIGIONE CATTOLICA E INSEGNAMENTONELL’ITALIA UNITA
Il Risorgimento nei manuali di storia per la scuola superiore(dagli anni Venti a oggi)
1. I manuali di storia come strumento per (ri)costruire la storia d’Italia
I manuali di storia hanno avuto e hanno un ruolo importante nella storia dell’educazione dell’Italia unita: i libri su cui si sono formate generazioni di italiani costituiscono un importante strumento di trasmissione del sapere storico in senso più tecnico, ma anche di formazione di un senso comune, storicamente orientato. I manuali sono il tramite attraverso il quale gli stu-denti hanno il loro primo impatto con la storia: nonostante la forza crescente dei mass media, per gran parte dei giovani rimane ancora la sola occasione di contatto con essa. È per questa ragione che, tra i testi scolastici, i manuali di storia sono quelli maggiormente sottoposti a condizionamenti culturali, ide-ologici e politici, in quanto uno degli strumenti di costruzione dell’identità politica e sociale di un paese1; i manuali di storia rifl ettono e trasmettono la storia d’Italia che contengono tra le loro pagine e al contempo contribuiscono a costruirla. Studiare i manuali di storia signifi ca studiare i contenuti dei libri di storia per la scuola, ma anche gli ambienti entro cui sono stati immaginati, elaborati e diffusi ed è utile per numerose altre implicazioni: per porre alcune questioni sul rapporto tra ricerca e didattica, tra storiografi a e storia, tra storia e pedagogia, sul ruolo pubblico della storia2. I manuali sono quindi un pre-zioso strumento attraverso cui è possibile ricostruire un sistema culturale e ideologico, un quadro politico, una storia di rapporti tra diverse forze, tra cui quelle religiose3, che hanno partecipato alla costruzione della storia d’Italia.
1 Giuliano Procacci, Carte d’identità: revisionismi, nazionalismi e fondamentalismi nei manuali di storia, Carocci, Roma 2005.
2 Si veda l’introduzione di Scipione Guarracino, I manuali di storia giudicati, in C’è manuale e manuale. Analisi dei libri di storia per la scuola secondaria, Settecittà, Viterbo 2010, p. 11: «I libri di storia destinati alla scuola sono chiamati manuali quando li consideriamo come una sintesi o un repertorio delle conoscenze accreditate, generalmente riconosciute dagli studiosi; vengono poi chiamati “libri di testo” quando li consideriamo in rapporto alla procedura di adozione; li possiamo defi nire “libri per l’insegnamento” o didattici quando pensiamo ai caratteri specifi ci che possiedono rispetto alle esposizioni che gli studiosi fanno delle loro ricerche originali».
3 Arturo Jemolo, Chiesa e stato in Italia dalla unifi cazione agli anni settanta, Einaudi, Torino 1995; Roberto Pertici, Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo concordato (1914-1984), Il Mulino, Bologna 2009; Maurilio Guasco, Chiesa e Cattolicesimo in Italia (1945-2000), EDB, Bologna 2001, pp. 135-136; Guido Verucci, Cattolicesimo e
08 Giorda.indd 8908 Giorda.indd 89 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
90 Insegnare a credere
Quella storia d’Italia narrata, interpretata e trasmessa nei manuali di storia, è infatti il prodotto di scelte culturali, ideologiche e anche politiche di autori provenienti da ambienti eterogenei ed è, al contempo, l’esito dei programmi didattici e delle riforme della scuola, nonché il rifl esso di strategie italiane politiche, culturali e educative, – cattoliche o laiche4. Per queste ragioni, tra le pagine dei manuali è possibile cogliere anche una storia dell’educazione italiana e delle politiche educative, sia di parte cattolica sia di parte laica, che rappresentano uno sfondo storico importante per questa ricerca5.
All’interno della più generale “storia d’Italia” trasmessa nei manuali, la scelta di concentrarsi sulle sezioni dedicate al Risorgimento si basa sull’ipo-tesi che le letture di tale periodo storico siano una cartina di tornasole pre-ziosa per rilevare la diffusione e la trasformazione delle interpretazioni sto-riografi che sul movimento cattolico, anche perché gli anni che precedettero e seguirono l’Unità sono stati un argomento ampiamente sfruttato per costruire tra gli studenti una precisa immagine della nazione e per creare consenso verso un determinato indirizzo culturale. Si tratta, inoltre, di un tema che, per ovvie ragioni cronologiche, è sviluppato in tutti i manuali che sono qui presi in considerazione e che quindi ben si presta a un’analisi comparativa. Già all’epoca in cui si svolsero gli eventi che portarono all’unifi cazione na-zionale, la loro lettura si intrecciò e spesso si sovrappose al dibattito politico; in particolare, proprio nella narrazione della vicenda risorgimentale una parte rilevante è stata rappresentata dalla questione dei rapporti fra Chiesa e Stato e del ruolo dei cattolici nella costruzione della nazione, un problema che agita ancora molte coscienze e il dibattito pubblico in Italia6. Entro la cornice risor-
laicismo nell’Italia contemporanea, Franco Angeli, Milano 2001; Cesare Mozzarelli (ed.), Identità italiana e cattolicesimo: una prospettiva storica, Carocci, Roma 2003; Stefano Pivato, Clericalismo e laicismo nella cultura popolare italiana, Franco Angeli, Milano 1990.
4 Si vedano i contributi degli storici e in particolare degli storici della pedagogia e delle istituzioni educative: Remo Fornaca, Storia della scuola moderna e contemporanea, Anicia, Roma 1994; Gabriele Turi - Simonetta Soldani, (eds.), Fare gli italiani. Scuola e cultura nell’Italia contemporanea, I, Il Mulino, Bologna 1993; Luciana Bellatalla - Giovanni Genovesi - Elena Marescotti, La scuola in Italia tra pedagogia e politica, 1945-2003, Franco Angeli, Milano 2004; Adolfo Scotto di Luzio, La scuola degli italiani, Il Mulino, Bologna 2007; Nicola D’Amico, Storia e storie della scuola italiana, Zanichelli, Bologna 2010.
5 Cfr. Maurizio Sangalli (ed.), Chiesa e scuola. Percorsi di storia dell’educazione tra XII e XX secolo, Cantagalli, Siena 2000, di stampo cattolico e, in particolare, i seguenti contributi: Giuseppe Tognon, Stato e Chiesa sull’educazione: un confronto decisivo per la storia dell’Italia religiosa contemporanea, pp. 187-243; Giuseppe Ricuperati, Per un nuovo concetto di pubblico nella scuola italiana, pp. 245-262.
6 La bibliografi a sul Risorgimento è sterminata; si farà rimando ad alcuni strumenti bibliografi ci, quali Alberto De Bernardi - Scipione Guarracino, I saperi della storia, Mondadori, Milano 2006; Alberto Maria Banti - Paul Ginsborg, Il Risorgimento. Storia d’Italia, Annali 22, Einaudi, Torino 2007; Lucy Riall, Il Risorgimento. Storia e interpretazioni, Donzelli, Roma 20073; Alberto Maria Banti, Il Risorgimento italiano, Laterza, Roma-Bari 2004 2007; Alberto Maria Banti, La nazione del Risorgimento, Einaudi, Torino 2007. Sul ruolo dei cattolici si veda Francesco Traniello, Religione cattolica e Stato nazionale. Dal Risorgimento al secondo dopoguerra, Il Mulino, Bologna 2007, in particolare pp. 7-220 dove sono trattate diverse idee cattoliche di nazione cattolica, nella formazione e conformazione dello Stato nazionale; il
08 Giorda.indd 9008 Giorda.indd 90 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 91
gimentale, l’oggetto d’indagine è in particolare il ruolo della Chiesa cattolica e dei cattolici, con la precisazione che lo statuto politico della religione, o meglio del cattolicesimo in Italia – per usare un’espressione coniata da Fran-cesco Traniello7 – trascende il suo statuto legale, cioè il quadro e la cornice entro cui il cattolicesimo si è trovato collocato in diversi assetti normativi e istituzionali. Dunque, non si indagherà soltanto il rapporto tra Chiesa e Stato ma le funzioni dei cattolici, il ruolo della Chiesa e dei cattolici in campo poli-tico, sociale, culturale, economico durante il Risorgimento usato come lente di lettura di un periodo più ampio che è la storia dell’Italia unita.
2. Per una breve storia della didattica della storia
Nell’ambito della “didattica della storia”8, in particolare avente come og-getto di analisi i manuali di storia, non sono molto numerosi gli studi condotti direttamente sui testi, sulle particolarità dei singoli manuali, ma piuttosto, sulle cause generatrici di errori storiografi ci e didattici, come faceva notare quasi vent’anni fa A. Brusa con parole che possono essere usate ancora oggi9;
nucleo originario della “cultura guelfa”, da cui ebbe l’avvio l’intransigentismo anti-liberale, ma anche il cattolicesimo liberale.
7 Francesco Traniello, Città dell’uomo. Cattolici, partito e stato nella storia d’Italia, Il Mulino, Bologna 1990, pp. 7-14.
8 Il campo disciplinare specializzato della didattica della storia in Italia ebbe la sua origine nel decennio degli anni Ottanta, punteggiato di ricorrenze della nascita di tale specialismo: il 1983, con la costituzione del Laboratorio nazionale per la didattica della storia, che innova e rilancia il progetto degli Istituti di resistenza in questo ambito e marca l’acquisizione di un settore autonomo; il 1985 è l’anno di inaugurazione di una specifi ca collana editoriale presso la Bruno Mondadori, diretta da De Bernardi e Guarracino; il 1987 vede l’avvio delle pubblicazioni de «I viaggi di Erodoto», periodico pensato per rispondere alle domande degli insegnanti e degli addetti ai lavori. Per una prima bibliografi a sulla didattica della Storia e sui manuali si vedano: Antonio Brusa, Il programma di storia, La Nuova Italia, Firenze 1991; Id., Il manuale di storia, La Nuova Italia, Firenze 1991; Id., Il laboratorio di storia, La Nuova Italia, Firenze 1991; Giuseppe Bosco - Claudia Mantovani (eds.), La storia contemporanea tra scuola e università. Manuali, programmi, docenti, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004; Antonino Criscione, Web e storia contemporanea, Carocci, Roma 2006; Walter Panciera - Andrea Zannini, Didattica della storia: manuale per la formazione degli insegnanti, Le Monnier, Roma 2006. In Europa, l’attenzione per la didattica della storia ha portato alla realizzazione di alcuni progetti recenti, patrocinati dal Consiglio d’Europa, relativi all’immagine dell’altro nell’insegnamento della storia, alla storia d’Europa, alle sfi de dell’insegnamento di una storia comune:http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Results%5CPublications%5CPublicationsIntro_fr.asp. Un recente studio sulle discipline e sui testi è: Paolo Bianchini (ed.), Le origini delle materie. Discipline, programmi e manuali scolastici in Italia, Sei, Torino 2011.
9 A. Brusa, Il manuale di storia, p. 41. Per i manuali si veda: Id., Manuels à lire, manual à travailler: l’évolution du rapport entre lecteur et manuel d’histoire en Italie (1950-1998). Analyse et perspective, in «Internationale Schulbuchforschung» 20 (1998), pp. 237-262; Paolo Pezzino, I manuali di storia contemporanea. Esperienze nazionali a confronto, in «Passato e presente» 55(2002), pp. 20-52; Scipione Guarracino, La realtà del passato, Mondadori, Milano 1987, pp. 57-62; Luigi Cajani, Italia e Germania verso al seconda guerra mondiale, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica» 1(1990), pp. 1-23. Le Riviste «Clio» e «Viaggi di Erodoto» sono dedicate alla didattica della storia. Un esempio virtuoso di analisi e studio
08 Giorda.indd 9108 Giorda.indd 91 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
92 Insegnare a credere
in questo caso, punto di partenza è la “storia della didattica della storia” con un’attenzione particolare alla didattica come terreno di confronto tra laici e cattolici, in altri termini gli sviluppi di una idea di pedagogia religiosa o non religiosa che esiste sullo sfondo della didattica stessa. La storia (religiosa) d’Italia costituisce la cornice dello studio dei manuali di storia ed è, al con-tempo, oggetto dello studio che si concentra su come è trattato, emerge ed è sviluppato il tema del ruolo dei cattolici e della Chiesa cattolica dall’unità d’Italia a oggi.
Per trovare una ricerca entro questi campi disciplinari, che abbia a ogget-to un tema simile a quello che si vuole indagare qui, occorre tornare indietro di alcuni decenni quando, negli anni Settanta, si erano avviati alcuni simposi, seminari e incontri di studio dei manuali di storia attraverso la lente delle religioni e in particolare della religione cristiana. Fu precisamente nel 1969 che il Consiglio d’Europa dava il suo appoggio alla Volkswagen Stiftung af-fi nché nei successivi anni una équipe di esperti esaminasse le epoche della storia europea delle religioni e della chiesa (chiesa antica, medioevo, riforma protestante e cattolica, epoca moderna e contemporanea), in riferimento alla loro presentazione e trattazione nei manuali di storia10. Il primo convegno si ebbe a Braunschweig nel settembre 1971, con riferimento alla chiesa antica; un secondo incontro fu effettuato a Louvain nel 1972, con un impegno diret-to del Consiglio e della Santa Sede, per presentare i risultati delle ricerche dirette da A. D’Haenens; in quell’occasione G. Parrinder tenne una relazione d’inquadramento sul posto della religione nella storia dell’umanità, in riferi-mento alla didattica della storia11. Due successivi convegni nel 1973 e 1975 all’Istituto di Braunschweig furono dedicati allo studio della presentazione della riforma protestante e cattolica nei manuali di storia12; dopo decenni di silenzio e inattività nel campo della manualistica e della storia delle religio-ni/storia religiosa, di recente una ricerca trans-nazionale condotta presso il Georg Eckert Institut di Braunschweig ha prodotto i primi risultati relativi all’analisi delle presentazioni stereotipe dell’islam nei manuali di storia di Germania, Austria, Francia, Spagna e Inghilterra, No Chance of Belonging?
dei manuali, condotto in una prospettiva contemporanea (manuali in uso), è rappresentato dal gruppo di ricerca di Bologna del LANDIS: C’è manuale e manuale. In Europa punto di riferimento è il Georg Eckert Institut, di Braunschweig (biblioteca di oltre 145 mila manuali): http://www.gei.de/. Un volume che contiene ricerche sull’insegnamento della storia e sui manuali entro una prospettiva europea, con la presentazione di differenti casi studio, è Falk Pingel (ed.), Insegnare l’Europa. Concetti e rappresentazioni nei libri di testo europei, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 2003. Si farà riferimento specifi co anche ad altri studi dedicati a programmi e manuali di storia nel paragrafo successivo, dedicato a una storia dell’insegnamento della storia e dei manuali di storia nella scuola italiana.
10 Maurizio Bendiscioli, La religioni nei manuali scolastici di storia dell’Europa Occidentale, in «Pedagogia e Vita» 6(agosto-settembre 1975), pp. 625-642, in particolare p. 626.
11 Cfr. La Religion dans les manuels scolaires d’histoire en Europe. Actes du Symposium organise a Louvain du 18 au 23 septembre 1972 par le Saint-Siege sous les auspices du Conseil de la Cooperation culturelle du Conseil de l’Europe, Conseil de l’Europe, Strasbourg 1974; M. Bendiscioli, La religioni nei manuali scolastici, pp. 637-638.
12 M. Bendiscioli, La religioni nei manuali scolastici, p. 627.
08 Giorda.indd 9208 Giorda.indd 92 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 93
Islam and Modern Europe Remain Segregated in European Textbook; si deve tuttavia notare l’assenza dell’Italia da questa équipe, che spinge a considera-re questo un terreno ancora troppo poco esplorato13.
3. La cornice dell’indagine: appunti metodologici
Un obiettivo concreto che l’analisi dei manuali di storia si è posta è la comprensione di quanto essi rifl ettano il dibattito storiografi co coevo alla loro stesura e in che misura attraverso essi sia ricostruibile tale dibattito, quanto le idee e le pratiche pedagogiche cattoliche e laiche siano espresse nei manuali, quanto la periodizzazione dei programmi e dei manuali, a sua volta dipendente dalla storia della scuola, si rifl etta nella trattazione di un tema come quello scelto.
Dopo una presentazione articolata per periodi dei manuali dell’ultimo secolo, utile a inquadrare i libri scolastici all’interno delle varie fasi della storia della scuola cui corrispondono tipologie più o meno omogenee di testi, si è proceduto con la selezione dei manuali più rappresentativi per numero di adozione e capacità di lunga durata sul mercato14 e il quadro è stato via via arricchito da dati relativi alle case editrici, alla biografi a e bibliografi a degli autori in particolare la loro collocazione ideologica o la loro adesione, affi -liazione a una religione o chiesa15. Queste storie sono indicative del rapporto tra politica, direttive statali sulla scuola e il mondo della scuola stesso, rifl et-tendo i tentativi dall’alto di normare una materia e un campo della pratica educativa scolastica.
L’analisi quantitativa condotta sui manuali mette in luce invece altri aspetti della trattazione del tema nei manuali: come esistono dei criteri di lettura e analisi dei manuali (diffi coltà, leggibilità, multidisciplinarietà, ag-giornamenti, complessità)16, esistono anche dei criteri di analisi degli aspetti materiali del testo (dimensioni, struttura, linguaggi e apparati) e anche dei metodi di analisi tematica, vale a dire delle griglie di lettura per indagare un
13 Cfr. http://www.gei.de/en/news/latest-news/news-details/article/modernes-europa-ver-sus-antiquierter-islam-die-darstellung-von-islam-und-muslimen-in-1.html per la presentazione di un primo rapporto, avvenuta nell’ottobre del 2011. In Italia, sono alcuni lavori coordinati da Luigi Cajani ad aver fornito dati relativi alle religioni nei manuali scolastici, tra cui si può fare riferimento a Luigi Cajani (ed.), Conciedo al otro, el islam y Europa en sus manuales de historia, Santillana, Madrid 2008.
14 I manuali sono 75 + 14 seconde edizioni + 4 seconde/terze edizioni raccolti, si veda l’elenco dei manuali in Appendice.
15 Alcune importanti linee guida per indagare il rapporto tra storici e religione sono tracciate da Giovanni Miccoli, Gli storici italiani del Novecento e la religione, in Daniele Menozzi - Marina Montacutelli, Storici e religione nel Novecento italiano, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 9-22: vi si trovano alcune rifl essioni sulla possibilità di studiare una (parte della) storia religiosa d’Italia a partire dalle biografi e degli autori della stessa storia di Italia.
16 Si veda a proposito C’è manuale e manuale, p. 95 e bibliografi a citata, tra cui Davide Ragazzini, Criteri per l’analisi dei testi di storia: un approccio culturale e didattico, in «Riforma della scuola» 2(1978), pp. 2-16.
08 Giorda.indd 9308 Giorda.indd 93 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
94 Insegnare a credere
unico tema in differenti manuali, utilizzati a seconda dell’obiettivo che si vuole perseguire17.
Nel caso del tema che è stato trattato e degli obiettivi prefi ssati, la griglia di riferimento è la seguente:
Per organizzare la voce relativa al grado di approfondimento, la più inte-ressante ai fi ni dell’analisi che qui è proposta, si sono tenuti in considerazio-ne, oltre alla periodizzazione del dibattito sul Risorgimento, alcune questioni desunte da una ricostruzione della storia del ruolo di cattolici, cattolicesimo e chiesa cattolica18.
17 Si vedano, a titolo di esempio, la griglia tematica e i criteri di osservazione e confronto in C’è manuale e manuale, pp. 48-50; p. 102.
18 È facilmente sintetizzabile un elenco sia cronologico sia tematico di questo genere nella consapevolezza che non tutto si trovi nei manuali: 1. Rapporto Stato/Chiesa, che si colloca a seconda di come e quanto lungo si interpreta il Risorgimento; 2. Il sentimento religioso degli “italiani”: esisteva? Che cosa signifi cava? Le insorgenze di fi ne Settecento sono espressione di questo sentimento religioso? L’identità o il carattere italiano era stato rinforzato o messo alla prova dalla Chiesa e dal Cattolicesimo? 3. Come ha infl uenzato il Risorgimento questo sentimento? la Chiesa era composta da cattolici di differenti posizioni? 4. Stampa cattolica di fi ne Settecento - inizio Ottocento: liberali e reazionari a confronto. Sviluppo del pensiero liberale: quale giudizio? Quale giudizio e quale reazione da parte della Chiesa? 5. Rosmini; Lambruschini; Gioberti. 6. Pio IX e la fi gura di Pellegrino Rossi. 7. 1848: post-reazioni e contro-reazioni in Piemonte; polemiche della stampa del Piemonte liberale nei confronti della Chiesa (legge Siccardi); cattolici liberali moderati e reazionari spaccati. 8. 1857: elezioni (eletti alcuni chierici). 9. Spartiacque del 1859. 10. Leggi degli anni ’60 (1866 e 1867). 11. Figura di Cavour e giudizio sul suo operato; Cavour e Pio IX. 12. 1862 Indirizzo del clero italiano; Conciliatore, Sillabo, la enciclica Quanta Cura, il dogma dell’infallibilità del Papa, il concilio Vaticano I. 13. Senso politico e simbolico di Porta Pia caduta e presa di Roma. 14. Cattolici elettori e eletti dal 1861 fi no al non expedit del 1871. 15. Parlamento diviso tra posizioni differenti (anche i cattolici divisi). 16. Le Guarentigie 17. Cattolici e educazione; cattolici e questione sociale.
Il manuale di riferimento: autore e casa editriceSpazio occupato dal tema rispetto all’indice (analisi quantitativa: pp./pa-ragrafi ; dove è inserito il testo nell’economia del volume; articolazione e scansione dei contenuti)Spazio occupato dal sotto-tema rispetto all’indice (analisi quantitativa: pp./paragrafi ; dove è inserito il testo nell’economia del capitolo; articola-zione e scansione dei contenuti)Titoli capitoli e paragrafi ; parole chiave evidenziateGrado di approfondimento e “problematizzazione” del sotto-tema (anche rispetto alla ricerca storica e al dibattito contemporanei al manuale); svi-luppo di snodi e sotto-sotto-temiApparato iconografi co e cartineDocumenti, antologia, fonti
08 Giorda.indd 9408 Giorda.indd 94 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 95
4. Tra le pagine dei manuali: Chiesa cattolica e cattolici durante il Risorgi-mento
Dopo un’attenta lettura dei manuali selezionati è possibile tracciare un quadro relativo al ruolo di cattolici e Chiesa cattolica, dei rapporti tra Chiesa e Stato, tenendo in considerazione, ovviamente, il quadro più generale del modo in cui il Risorgimento è trattato nei diversi manuali. Questa operazio-ne è utile per analizzare coerenze e incoerenze tra la trattazione del tema, l’approccio storico del manuale nel suo complesso e il profi lo del suo autore, i legami con il dibattito storiografi co contemporaneo ai vari manuali e infi -ne per ricostruire, di rifl esso, la storia d’Italia, o almeno una sua parte, con un’attenzione particolare per il ruolo della Chiesa e dei cattolici.
Tenuto conto che le variazioni dei programmi poco riguardano, da un punto di vista dei contenuti, la trattazione del Risorgimento (lo riguardano soltanto in termini di fi ssazione dei confi ni più ampi o meno, del periodo; di dettaglio degli sviluppi e di denominazione, ad es. “le guerre di indipen-denza”; il 1848; o ancora “la questione romana”, che resta un’espressione invariata in tutti i manuali esaminati, nella versione con la minuscola o con la maiuscola), e non riguardano per nulla il tema specifi co che qui vogliamo indagare (se non in termini di un riferimento, a volte esplicito, alla religione come dato culturale a cui prestare attenzione nell’insegnamento della storia), la periodizzazione dei manuali si ritrova nella trattazione del Risorgimento soprattutto da un punto di vista formale e stilistico: a una narrazione enfatica e retorica, basata sull’esaltazione delle grandi fi gure che furono i protago-nisti, gli eroi del periodo, che caratterizza i manuali pre-fascisti e fascisti, segue una narrazione più piana, meno partecipata e più analitica. Vedremo nel prossimo paragrafo, in cui sono riportati i risultati dell’analisi dei testi, le peculiarità contenutistiche delle diverse generazioni e tipologie di manuali.
4.1. I manuali della fondazione
Nei manuali di fi ne Ottocento e di inizio Novecento, l’impianto nazional-patriottico era costituito da una narrazione problematica e retorica basata sul mito dell’avvenimento e del grande personaggio19. La biografi a della nazione era ridotta a una sorta di “histoire bataille” lineare e teleologica, in cui i fatti erano piuttosto aneddoti e le tavole di valori un elenco consunto: si vedano i manuali di Italo Raulich, professore all’Università di Torino (Manuale di storia contemporanea d’Europa e specialmente d’Italia 1750-1900, Para-via, Torino 1907), quello di Antonio Dall’Oglio, docente al liceo di Modena (Compendio di storia contemporanea, Le Monnier, Firenze 1911) o il no-tissimo Rinaudo, accademico torinese (Corso di storia generale, Barbera, Firenze 1897). L’Italia giolittiana non trovò mai una vera alternativa a tale
19 Alberto De Bernardi, Il canone della Storia Contemporanea nei Manuali scolastici dall’Unità alla Repubblica, in Giuseppe Bosco - Claudia Mantovani (eds.), La storia con-temporanea tra scuola e Università, p. 24.
08 Giorda.indd 9508 Giorda.indd 95 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
96 Insegnare a credere
lezione patriottica e a tale narrazione della storia e i manuali sopravvisse-ro ai cambiamenti politici e culturali dell’epoca quasi intatti, conservando contenuti e forme: infatti questi e altri manuali furono ripubblicati in modo continuativo dagli inizi del Novecento fi no agli anni Trenta20.
La narrazione del Risorgimento era racconto di una gloriosa epopea fi -nita in fulgida storia, i manuali erano tramite di lezioni patriottiche, i cui protagonisti erano i “grandi uomini” dell’epoca, da Pio IX, a Cavour, sui quali pesava il giudizio positivo o negativo degli storici. Si veda, per tutti, il Ri-naudo (1917), in cui vi è un giudizio positivo e entusiastico sulla scelta di Pio IX come pontefi ce: «Si era così poco avvezzi al perdono, che per tutta l’Italia, anzi per tutto il mondo civile, un solo grido s’intese: “Viva Pio IX!”. L’entusiasmo accrebbe, le feste succedevano alle feste e grandiose dimostra-zioni popolari avevano luogo in onore del papa. Le riforme di Pio IX avevano messe la febbre addosso a tutti gli italiani»21.
Il Raulich (1924) è più severo e meno conciliante rispetto all’operato del Papa: il Sillabo di Pio IX è una sfi da alla libertà, una condanna della so-cietà civile, colpevole agli occhi della Chiesa e del progresso: «fu l’anatema contro tutto ciò, di cui col progresso umano e per opera dei pensatori più nobili e grandi delle nazioni più civili s’era arricchito il diritto moderno; di più, anzi, fu una sfi da alla libertà. In fondo Pio IX rimetteva a nuovo la dot-trina teocratica d’Ildebrando, rivendicando alla Chiesa la supremazia sullo Stato, rimetteva i ceppi al pensiero, alla parola, alla stampa, l’impero sulle coscienze»22. Pio IX è intollerante e intransigente23: lasciato solo dal resto d’Europa è sconfi tto, si ritira in Vaticano (la città leonina) e i suoi mercenari ricevono addirittura gli onori di guerra; si sottolinea anche con tono commos-so come vi fossero dei caduti tra gli italiani. Il papa è rinchiuso sdegnoso tra le mura del Vaticano; le Guarentigie gli assicurano l’indipendenza e la liber-tà, dichiarando sacra e inviolabile la sua persona ma la Curia romana non le riconosce e non perdonò all’Italia le vittorie della rivoluzione:
«Eppure quale nuova grandezza venne data anche al papato da quelle vittorie! Una volta esso, indebolito dalla grave soma del poter temporale e confuso tra tutte le me-schine gare dei principi giunse ad apparire persino immemore della croce e a divenire talora anche strumento di tirannia civile. Invece, alleggerito di quella soma, ricondot-te tutte le potenti energie della Chiesa alle sole cose di religione, il papato riprese in questi nostri tempi con l’indipendenza, il vigore da potersi dire a ragione che, sotto l’egida delle nostre leggi di libertà, assurse a nuova grandezza»24.
Il racconto è dominato da interessi militari e politici, mentre solo sullo sfondo restano gli interessi sociali e culturali; come vedremo, lo stesso conti-
20 Anna Ascenzi, La storia nelle scuole secondarie tra le due guerre, in P. Bianchini (ed.), Le origini delle materie, pp. 191-216, spec., pp. 209-210.
21 Costanzo Rinaudo, Storia dei tempi moderni, Barbera, Firenze 1917, pp. 248-249.22 Italo Raulich, Manuale di storia contemporanea, Paravia, Torino 1924, p. 374.23 Ibi, pp. 388-392.24 Ibi, p. 392.
08 Giorda.indd 9608 Giorda.indd 96 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 97
nuerà a accadere per i manuali dell’epoca fascista, anni di costruzione di una storia forte di una nazione forte, costellata dalle vite di alcuni campioni che avevano costruito l’Italia25.
4.2. I manuali del fascismo
Con la riforma promulgata nel 1923 dal fi losofo Giovanni Gentile, mini-stro della Pubblica Istruzione del primo governo Mussolini e defi nita «la più fascista delle riforme»26, si raggiunse l’apice del primato della cultura uma-nistica e, da un punto di vista organizzativo, l’aumento e il consolidamento dei percorsi di studio. La sopravvalutazione delle imprese coloniali italiane, l’esaltazione mitologica del Risorgimento, il culto della persona del duce erano elementi che spianarono la strada alla bonifi ca fascista della scuola, che ebbe luogo alla metà degli anni Trenta: una narrazione basata sulla storia di Roma, sull’esaltazione di un’ideologia destinata a isolare l’Italia, che si autocelebrava in modo esaltante, dall’Europa.
Nello stesso anno della Riforma Gentile fu pubblicato il Sommario sto-rico di Rodolico, direttore dell’Archivio storico italiano, cattolico, militan-te esponente della storiografi a giuridico-economica (Le Monnier, Firenze 1923) la cui ispirazione pedagogica, retaggio di una percezione ancora risor-gimentale dello studio della storia come formazione del cittadino, lo aveva condotto a scrivere compendi e manuali scolastici, nei quali espresse la sua passione per la storia del popolo italiano. I suoi testi mettevano in luce l’esito nazionalistico dell’insegnamento della storia, premessa di una didattica nella quale la patria era divenuta parola simbolo di una concezione populista, au-toritaria e paternalistica. Nel suo manuale si trovava una operazione di ridefi -nizione dell’impianto nazionale patriottico che vedeva il Risorgimento come manifestazione di un destino di potenza della nazione erede delle proprie origini romane, il continuum che rappresentò uno dei più importanti fi li rossi della storia insegnata in chiave fascista e che espungeva l’Italia liberale27.
Nel periodo compreso tra il 1925 e il 1929, man mano che era comple-tata l’edifi cazione delle strutture dello Stato totalitario, il regime operava sul terreno della costruzione del consenso, avvalendosi anche della scuola come strumento di controllo ideologico e come canale per l’indottrinamento di
25 In questa biografi a della nazione emersero fi gure di spicco, grandi personaggi come Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, Cavour, Garibaldi e Mazzini. Alla loro morte, essi vennero eroizzati rapidamente (con l’eccezione di Mazzini, al quale non venne mai perdonato del tutto il suo repubblicanesimo) ed entrarono a far parte di quel pantheon di eroi che l’Italia, come del resto tutte le nazioni europee del tempo, stava erigendo. In questo consesso di eroi tutelari della nazione non mancavano fi gure religiose, come don Tazzoli e tanti altri, martiri della causa nazionale.
26 Si veda Gianni Di Pietro, Da strumento ideologico a disciplina formativa. I programmi di storia nell’Italia contemporanea, Mondadori, Milano 1991, programma n. 41, d, pp. 359-360 e anche pp. 79-86; W. Panciera - A. Zannini, Didattica della storia, pp. 73–76.
27 Scipione Guarracino, I manuali del consenso, in «I viaggi di Erodoto» 8(1989), pp. 170-183.
08 Giorda.indd 9708 Giorda.indd 97 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
98 Insegnare a credere
massa28. Il primato della storia politico-militare-diplomatica propugnato da uno storico come Gioacchino Volpe29 si traduceva nell’elaborazione di una serie di stereotipi quali la sopravvalutazione delle imprese coloniali dell’Ita-lia, l’interpretazione autoctona del Risorgimento nazionale e la mitizzazione di una politica estera improntata all’aggressività e potenza. Nonostante alcu-ni tentativi più criticamente avvertiti tra cui quello di Volpe stesso, prevalse largamente una tendenza nazionalistica e reazionaria che si identifi cò con la preesistente tendenza «sabaudistica» tipica di una parte della storiografi a erudita e che individuava nel fascismo l’esito culminante di tutte le vicende risorgimentali, rendendo quasi del tutto trascurabile nella stesura dei manuali la corrente interpretativa degli storici che si erano mossi in direzione di una complessa opera di valutazione positiva della linea d’intervento del movi-mento liberale e delle forze democratiche. Lo Stato fascista, ultima fase e vero completamento del Risorgimento italiano, diventava anche erede esclu-sivo della potenza imperiale romana.
Dopo le redazioni degli anni 1930 e 193330, emanate nel quadro di quella che il suo artefi ce defi nì la «bonifi ca fascista della scuola», nel 1936 il testo di legge liquidava ogni libertà di insegnamento, attribuendo ai programmi di classe il compito di trasmettere a tutti i giovani una cultura unitaria e viva31; la storia doveva trasmettere agli allievi valori essenziali delle civiltà: in ogni classe di ogni ordine doveva essere dato risalto al processo formativo dello Stato unitario che confl uiva nel Fascismo, alla funzione esercitata dalla di-nastia Sabauda dal suo primo orientamento verso l’Italia, all’azione decisiva che essa svolse durante il Risorgimento e nella vita italiana successiva. Il Risorgimento era presentato come fenomeno schiettamente italiano le cui origini risalivano ai primordi del secolo XVIII.
Negli anni Trenta si generò un rinnovamento dei manuali di storia, con la comparsa di testi e autori nuovi; soltanto pochissimi dei manuali precedenti resistettero e furono ristampati, tutti previa operazione di rimaneggiamen-to32, quali, ad esempio, il Rodolico (Sommario Storico, Le Monnier, Firen-ze 1930; 1931) e il Manaresi (Storia medievale, moderna e contemporanea, Trevisini, Milano 1927; 1940, di forte impianto militare-politico, con vena-
28 A. De Bernardi, Il canone della Storia Contemporanea nei Manuali scolastici dall’Unità alla Repubblica, in G. Bosco - C. Mantovani (eds.), La storia contemporanea tra scuola e Università, pp. 28-30.
29 Per un recente profi lo di Volpe si veda Roberto Pertici, Stato e Chiesa nella storia d’Italia. Le analisi di Gioacchino Volpe, in D. Menozzi - M. Montacutelli, Storici e religione, pp. 263-289.
30 G. Di Pietro, Da strumento ideologico a disciplina formativa, pp. 362-365, R.D. n. 1467 del 5 novembre 1930; Id., Da strumento ideologico a disciplina formativa, pp. 368-371, R.D. n. 491 del 15 maggio 1933; Id., Da strumento ideologico a disciplina formativa, pp. 372-378, R. D. n. 892 del 29 giugno 1933.
31 Id., Da strumento ideologico a disciplina formativa, pp. 378-390, R.D. n. 762 del 7 maggio 1936.
32 Per l’elenco dei manuali che non furono ripubblicati dopo il 1923, si veda A. Ascenzi, La storia nelle scuole secondarie tra le due guerre, pp. 191-216.
08 Giorda.indd 9808 Giorda.indd 98 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 99
ture nazional-patriottiche). I manuali che dominarono la scuola nel ventennio furono il frutto del lavoro di storici che maturarono il loro approdo al fasci-smo che ne infl uenzò e orientò sia l’attività scientifi ca sia quella pratica: il Silva (Corso di storia, Principato, Milano 1936, IV edizione nel 1940, XII nel 1957 e ancora sul mercato successivamente), il Capasso (Le nazioni moderne dall’età napoleonica all’era fascista, Vitagliano, Milano 1930, 1932 e Na-zioni e imperi dell’età moderna, Vitagliano, Milano 1930, 1935), il Cognasso (Storia d’Italia per i licei e gli istituti superiori, Paravia, Torino 1936; 1938), presentavano il fascismo come esito della biografi a della nazione da sem-pre insegnata da generazioni di docenti; senza fratture didattiche né rotture ermeneutiche era suffi ciente l’innesto di alcuni topoi formativi funzionali all’esaltazione del regime e alla demonizzazione della democrazia33. Sono manuali fortemente intrisi di stereotipi interpretativi che emergono in ogni pagina e per i quali sono suffi cienti pochi esempi; tutti i testi erano ideolo-gizzati e in essi si trovano tratti caratteristici di una storia enfatica, retorica, semplifi cante. Un tratto tipico è l’andamento prosopografi co utilizzato, ad esempio, dal Rodolico (1930): nel trattare la fi gura di Ricasoli34, lo presenta come cattolico dai costumi rigidi, un mistico, un grande patriota; egli crede che il nuovo regno debba tenere in considerazione la forza morale e tradizio-nale della Chiesa cattolica, cerca un accordo anche con la soppressione del potere temporale del clero ma il suo programma, che proponeva un’armonia di Regno e Santa Sede, è avversato da partiti d’azione e liberali conservatori avversari del clero.
In tutti i libri di storia di questo periodo si trova una interpretazione fa-scista o fascistizzante della storia; tale posizione è chiaramente rappresentata nel Manaresi del 194135:
«Nell’Europa odierna, travagliata dagli odi politici e dalle contese sociali, l’Italia stretta al suo duce, appare oggi come un’oasi di ordine e di grandezza. Essa è oggi il simbolo dell’avvenire politico del mondo intero, poiché il fascismo ha creato una nuova forma di stato autoritario e corporativo, che si sostituirà allo stato liberale e democratico, portato della rivoluzione francese, ma ormai superato dalle nuove esi-genze della moderna vita politica e sociale».
Secondo l’autore è solo con il fascismo che è possibile la soluzione della questione romana (11 febbraio 1929) e la pace religiosa:
«Il Fascismo, restauratore dei grandi valori morali, non poteva trascurare il proble-ma religioso, importantissimo per una nazione come l’Italia, che ha tutta la sua sto-ria connessa al Cattolicesimo e al Papato. All’antico atteggiamento anticlericale e massonico, il nuovo stato fascista ha sostituito i più cordiali rapporti con le autorità ecclesiastiche; inoltre ha riconosciuto le comunità religiose, ha introdotto l’insegna-mento della religione nelle scuole, ha rinunciato ai placet e ha fi nalmente promosso
33 A. De Bernardi, Il canone della Storia Contemporanea, pp. 19-36.34 Niccolò Rodolico, Sommario storico, Le Monnier, Firenze 1930, pp. 295-297.35 Alfonso Manaresi, L’Italia contemporanea, Poseidonia, Bologna 1941, p. 226.
08 Giorda.indd 9908 Giorda.indd 99 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
100 Insegnare a credere
la Conciliazione tra l’Italia e il Papato (11 febbraio 1929) che era stato il sogno di tanti uomini politici e di tutti i credenti»36.
Il fascismo è la soluzione delle fratture risorgimentali.Tratti comuni permettono dunque un accostamento tra i manuali delle
prime due generazioni, sia post-unitari sia fascisti: oltre all’andamento proso-pografi co che crea dei personaggi d’eccellenza in positivo e in negativo, sono quasi interamente concentrati sulla storia d’Italia e quindi, nell’affrontare il tema del Risorgimento come processo tipicamente italiano (si trascurano, se non solo per grandi cenni, i processi di nation-building europei), raramente sottolineano la dimensione extra-nazionale del movimento cattolico e della Chiesa. Vi si trova anche l’esaltazione del Risorgimento come momento di riscatto e celebrazione del popolo italiano, in grado di abbattere gli ostacoli e sconfi ggere i nemici, che corrisponde a un intento sia culturale sia politico condiviso, anche a forza, di fare l’Italia e gli italiani.
4.3. I manuali del dopoguerra: una pluralità di voci inedita
La defascistizzazione della scuola dell’Italia repubblicana dopo il 1945 procedette in modo contraddittorio; l’impostazione per compartimenti stagni che assegnava al sistema scolastico la funzione di fi ltro sociale fu mantenuta inalterata fi no agli anni Sessanta. Dopo il crollo del fascismo un decreto di Badoglio impose di togliere la storia degli ultimi vent’anni dalla manualisti-ca, per impedire che nella scuola continuasse l’apologia del fascismo37. La defascistizzazione dei libri di storia fu operazione ancora più diffi cile di quel-la dei programmi, anche per le diffi coltà tecniche, quali la stampa di nuovi libri e gli interessi economici delle case editrici38. Tra la fi ne anni Quaranta e l’inizio Cinquanta si cominciano a vedere i primi sintomi di un rinnovamen-to, pur inserito nell’orizzonte di una didattica tradizionale. Tale rinnovamen-to si confi gurava in forme differenti a seconda degli autori che spesso erano storici di valore. Nel Morghen (Civiltà europea, Palumbo, Palermo 1949), presidente dell’Istituto storico italiano per il Medioevo e molto interessato alla storia spirituale, da un punto di vista formale si concretizzava nell’in-troduzione di accorgimenti tecnici, come l’aggiunta di tabelle cronologiche e schemi riassuntivi, o in netto miglioramento nella qualità delle letture; nel
36 Id., L’Italia contemporanea, Poseidonia, Bologna 1941, p. 332.37 A. De Bernardi, Il canone della storia contemporanea, p. 30.38 La Commissione ministeriale per la defascistizzazione che valutò centottantacinque
volumi per un totale di novanta opere proibì la vendita di ventuno volumi, ne autorizzò la vendita e l’uso di cinquantuno se debitamente censurati e ne approvò integralmente centotredici: cfr. Associazione romana editori libri e riviste, Elenco uffi ciale dei volumi esaminati dalla Commissione Ministeriale per la defascistizzazione, Associazione romana editori libri e riviste, Roma 1944. G. Di Pietro, Da strumento ideologico a disciplina formativa, pp. 398-401. Si veda anche Luca Baldissara, L’insegnamento della Storia Contemporanea e le alterne vicende del Manuale, in G. Bosco - C. Mantovani (eds.), La storia contemporaneta tra scuola e Università, pp. 37-45
08 Giorda.indd 10008 Giorda.indd 100 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 101
Pepe e nello Spini consisteva nell’eliminare una parte considerevole dei luo-ghi comuni della manualistica precedente e nel riallacciare l’esposizione con i risultati degli studi più recenti e più accreditati: in particolare nello Spini storico del protestantesimo, dedito alla storia politico-religiosa dell’età mo-derna e contemporanea, signifi cò un’attenzione più viva alle classi sociali, ai confl itti, ai problemi economici, alle grandi ideologie39. Nel Saitta (Il cammi-no umano. Corso di storia, La Nuova Italia, Firenze 1954), storico marxista, di cui era uscito il primo volume, questo rinnovamento si tradusse in un’e-sposizione storica basata su una ricostruzione e una interpretazione critica del passato, in cui alla narrazione dei fatti da parte dell’autore, si alternavano “letture” cui era assegnato un ruolo non soltanto più accessorio. Morghen e Spini trattavano di temi religiosi con grande attenzione40, mentre il Soranzo - Tarantello (Storia, Minerva Italica, Bergamo 1957) si distingueva per il suo taglio confessionale che offriva un punto di vista interessante per quegli anni, sotto molti punti di vista distante e contrario alle posizioni di Saitta.
Occorre leggere questa produzione manualistica nuova e alquanto va-riegata per il posizionamento culturale e politico dei suoi autori, anche in relazione ai dibattiti sul Risorgimento e della posizione che per quegli anni rappresentò il main stream ideologico: dopo la seconda guerra mondiale si era aperto un nuovo dibattito storiografi co soprattutto a partire dalla lettura delle opere di Gramsci, che, dopo la sua morte, erano state riscoperte e pub-blicate a cura di studiosi di orientamento marxista e che portavano ora a con-siderare il Risorgimento come “rivoluzione fallita” o “rivoluzione passiva” se lo si osservava dal punto di vista delle classi sociali meno abbienti, quelle degli operai e dei contadini. Esso rappresentava la vittoria di un gruppo so-cialmente e culturalmente omogeneo, di intellettuali moderati solidali con la grande e media borghesia41. Tuttavia, se questa è la posizione più diffusa sul piano della storiografi a, soltanto in parte, nei manuali, si trova il medesimo approccio: nei libri di testo sembra prevalere la linea politica degli anni della DC al potere, della ricostruzione dell’Italia uscita dalla guerra e in cammino verso il periodo di ripresa e di boom economico. Quale che fosse la posizione politica, culturale e ideologica degli autori, tra le pagine dei manuali è infatti facilmente rintracciabile un comune tentativo di ricostruire la storia d’Italia anche a partire dal Risorgimento.
Entro queste linee si muove, ad esempio, il Morghen (1949), rappre-sentante della storiografi a cattolica, che difende il progetto dello Stato, cui la Chiesa deve sottostare, pur essendo libera, perché – si legge in diversi
39 Giorgio Spini, Disegno storico della civiltà, prima uscita per Macrì di Bari nel 1947; opera destinata a grande fortuna quando uscì a Roma presso l’editore Cremonese nel 1957; Roma 1963 (Edizione riveduta e ampliata [VII] secondo i programmi del 1960).
40 S. Guarracino, La realtà del passato: sui manuali pp. 57-62.41 Accadeva spesso che, se si ricorreva al passato per ritrovare le radici dell’Unità nazionale
e dello Stato contemporaneo, scattavano in simultanea le recriminazioni poiché il binomio “Risorgimento-Nazione” sembrava marchiato a fuoco dall’ipoteca fascista: F. Traniello, La storiografi a italiana del dopoguerra e il concetto di Nazione, in Gian Enrico Rusconi (ed.), Nazione, etnia, cittadinanza in Italia e in Europa, La Scuola, Brescia 1999, pp. 85 e 230.
08 Giorda.indd 10108 Giorda.indd 101 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
102 Insegnare a credere
punti – il potere forte è quello politico42. La trattazione del processo risorgi-mentale fatta dal Morghen è la storia di due correnti, quella moderata rap-presentata da Cavour e quella rivoluzionaria di Garibaldi che si rinvigorisce nel dissidio relativo alla questione romana, durante il quale le due tendenze lacerano il popolo italiano, travagliando con i suoi angosciosi contrasti e le sue dolorose vicende il primo decennio di vita del Regno d’Italia43. Dopo la morte di Cavour, lo iato tra i due approcci continua e in qualche modo è il re Vittorio Emanuele che tenta di farsi garante dell’ordine, della diplomazia, della moderazione anche e, soprattutto, nei confronti del papa e della Chiesa: invia una lettera al Pontefi ce in cui annuncia che invierà un corpo d’esercito per proteggerlo e per garantirgli l’incolumità, invitandolo nel frattempo a la-sciare il potere temporale, assicurandogli il pieno e libero esercizio delle sue altissime funzioni spirituali44. Il giudizio sulle Guarentigie, un documento insigne della sincera volontà dell’Italia di garantire al papato la piena libertà di esercizio della sua altissima funzione45 è indizio di come l’autore propenda per la linea moderata che tuttavia non sempre riuscì a prevalere.
Anche nel Saitta (1963) non si intravede traccia di una eventuale inter-pretazione del Risorgimento come rivoluzione mancata: l’interesse è concen-trato sul processo di unifi cazione della nazione, di conciliazione tra Stato e Chiesa, di superamento degli ostacoli che si presentavano nella storia d’Ita-lia. Il Risorgimento è trattato come un periodo di formazione dello stato ita-liano, ostacolato a più riprese dalla Chiesa cattolica: il Sillabo bollava come eretica la civiltà moderna, dal liberalismo al laicismo; il cattolicesimo libera-le era colpito a morte ma poiché fortunatamente il tempo dello stato braccio secolare della Chiesa era tramontato da un pezzo, il Sillabo restò soltanto un monumento insigne di inintelligente reazionarismo; comunque esso, per contraccolpo, non poté non suscitare una vasta ondata anticlericale in tutta Europa e rafforzare in Italia tutti coloro che volevano porre fi ne al permanere di Roma sotto il potere temporale. La questione romana non era risolta ma piuttosto aveva mutato aspetto: la scomunica e il non expedit del 1874 crea-vano una frattura tra il regno d’Italia e i cattolici – per lo meno quelli attivi e militanti – che ne facevano parte. La proposta del 1871 delle Guarentigie (per Croce – che è citato da Saitta – erano un «monumento di sapienza giuridica») fu un tentativo di colmare il fossato che si era formato, ma non sono accettate e rifi utate dalla Santa Sede. Tuttavia «il leale e scrupoloso mantenimento della legge» fece in modo che pian piano la questione romana si svuotasse da sé e non degenerasse in pericolo per l’unità italiana e che i cattolici si ricon-ciliassero con la vita politica italiana46.
42 Si veda la raccolta: Raffaello Morghen e la storiografi a del Novecento, Casa editrice Università La Sapienza, Roma 2005.
43 Raffaello Morghen, Civiltà europea, Palumbo, Palermo 1949, p. 147.44 Ibi, p. 169.45 Ibi, pp. 169-170.46 Antonio Saitta, Il cammino umano. Corso di storia, La Nuova Italia, Firenze 1963, pp.
284-286.
08 Giorda.indd 10208 Giorda.indd 102 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 103
Un’altra ottica offre infi ne lo Spini (1963), particolarmente sensibile al dato religioso e spirituale. Per Risorgimento Giorgio Spini intende il mo-mento cruciale del processo di unifi cazione politica dell’Italia: un momento di avanzamento e di progresso dell’Italia, grazie al quale l’Italia si inserisce nella più vasta corrente del progresso civile europeo. Gli italiani attinsero, infatti, alle idee che circolavano in Europa, e presero parte alle lotte contro l’imperialismo, il governo militarista e la negazione di libertà dell’impero napoleonico: l’origine del Risorgimento è strettamente connessa con la lotta liberale europea, internazione e interstatale. Colpisce l’assenza di riferimenti ai protestanti e al loro ruolo e atteggiamento in questi anni risorgimentali, mentre sono noti gli studi dello storico sul cristianesimo protestante e in par-ticolare sul ruolo attivo dei protestanti duranti il risorgimento47; si legge però di come Vittorio Emanuele scongiurava il Papa a rinunciare pacifi camente al potere temporale volendo evitare ogni inutile spargimento di sangue; le Gua-rentigie rappresentano massima apertura, ma ciononostante il papa si pro-clama prigioniero della violenza degli italiani e mentre si infrange il sogno di un cattolicesimo liberale, che accettava la separazione tra Chiesa e Stato, si aprì un periodo molto duro per una possibile composizione dei confl itti tra le parti. D’altronde era stato il testo del Sillabo e il seguente Vaticano I a suggellare, inasprendo i termini del confronto, la spaccatura tra confl itto ideologico e politico tra il liberalismo e il cattolicesimo, rappresentato da un papa sempre più intransigente48. Nello Spini è anche interessante il ricorso all’apparato iconografi co: spicca l’icona dell’Italia senza Roma rappresenta-ta in una donna stesa a terra incatenata straziata dalle cornacchie (Napoleone II e la curia romana), tratta da una stampa anti-clericale49.
Nel periodo del dopoguerra dunque, a fronte di una storiografi a risorgi-mentista ancora piuttosto concentrata sull’interpretazione gramsciana, i ma-nuali esprimono posizioni e interessi differenti, trattando in modo complesso e ricco di sfumature le ambiguità di tutte le parti, politiche e ecclesiastiche attive durante il Risorgimento. Senza la pretesa di trovare, forzatamente, un fi lo conduttore unico, è possibile affermare che in questi manuali è vivo un comune desiderio di fondare la storia d’Italia sul Risorgimento, evidenzian-done tuttavia, a differenza dei manuali precedenti, anche i confl itti e i limiti, le contraddizioni; è altresì vero che la lettura dicotomica “buoni/cattivi” resi-ste ancora, benché varino, a seconda dello sguardo, i soggetti.
4.4. Tra conservazione e rinnovamento
Nel clima di riforma e rinnovamento della scuola e della didattica degli anni Sessanta50, per quanto concerne la storia, era pressante l’esigenza di
47 Giorgio Spini, Risorgimento e protestanti, Claudiana Editrice, Torino 1998, pp. 257-265.
48 Id., Disegno storico della civiltà, Edizione Cremonese, Roma 1963, p. 190.49 Ibi, p. 217. 50 G. Di Pietro, Da strumento ideologico a disciplina formativa, pp. 105; 401-406.
08 Giorda.indd 10308 Giorda.indd 103 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
104 Insegnare a credere
includere a pieno titolo nell’insegnamento la storia contemporanea, in par-ticolare quella dell’età repubblicana, prevista nei programmi del 1960 per le superiori e che fi ssò per i licei e magistrali il limite ad quem della trat-tazione storica al 194751. Dopo che la lettura gramsciana era stata messa in discussione dalla storiografi a liberale e revisionista, il periodo risorgimentale era sviluppato secondo interessi scientifi ci di chiavi interpretative di stampo diverso, benché non fosse certo al centro degli interessi del dibattito storio-grafi co; nei manuali di diversa provenienza e appartenenza continuava a in-travedersi un comune approccio teso alla valorizzazione delle idee e dei miti del Risorgimento quale elemento fondativo della cultura sociale e politica italiana. Come nei manuali che avevano popolato il mercato scolastico nei decenni precedenti, la storia del Risorgimento era quasi sempre una storia di confl itto tra Chiesa e Stato, punto di partenza imprescindibile per la storia successiva dell’Italia.
La grande differenza rispetto ai manuali della generazione precedente non risiedeva tanto su un piano ideologico e politico, quanto sul piano didattico: il rinnovamento avveniva soprattutto rispetto alle modalità e agli strumenti con cui era costruito il manuale. Nel corso degli anni Sessanta si assiste in-fatti ad un processo di rinnovamento della manualistica, che almeno in parte registra e fa precipitare nella stesura dei testi i frutti del dibattito svoltosi nel primo ventennio repubblicano52. Al primo posto per il suo successo editoriale il Camera-Fabietti per la Zanichelli (Elementi di storia, Bologna 1967), che sarebbe diventato il più adottato per lungo tempo; il Villari, parlamentare del Pci e sostenitore di una linea democratica e riformista, fu l’autore che pub-blicò per Laterza (Roma-Bari 1969, 1970: Storia, che nei licei affi ancava il Camera-Fabietti), oltre al Quazza per Petrini (Corso di storia 1967, 1969), al Salvo - Rotolo (Le città dell’uomo, Le Monnier, Firenze 1967) al Saitta per gli istituti tecnici della Sansoni (1970), al De Rosa53, storico specialista del movimento cattolico e della Democrazia cristiana (Storia contemporanea, Minerva Italica, Bergamo 1971), opera di impianto tradizionale, scritta da uno studioso cattolico capace di trattare con misura i temi della storia reli-giosa. Un altro manuale destinato al successo fu il Corso di Storia di Giorgio Cracco - Alfonso Prandi - Francesco Traniello (Sei, Torino 1975), particolar-mente interessato e concentrato sulla storia del cristianesimo e della Chiesa, mentre nel 1978 usciva l’opera innovatrice Corso di Storia, di Rinaldo Com-ba - Giuseppe Ricuperati - Massimo Salvadori (Loescher, Torino).
51 L. Baldissara, L’insegnamento della Storia Contemporanea, p. 45, dove è riportata la nota circolare del Ministro della Pubblica Istruzione Bosco (n. 443 del 1960, 19 novembre).
52 Si veda il paragrafo Crise d’un modèle, in A. Brusa, Manuels à lire, pp. 241-245. L. Baldissara, L’insegnamento della Storia Contemporanea, pp. 49-54; Giuseppe Ricuperati, Storiografi a e insegnamento della storia, in «Passato e presente» 2(1982), pp. 183-200.
53 Un profi lo dell’intensa attività di studioso e intellettuale impegnato sul terreno civile e politico-culturale, iniziatore dell’indirizzo di storia sociale e religiosa in Italia è tracciato da Liliana Billanovich, Gabriele De Rosa (1917-2009). Itinerario biografi co e indirizzo di storia socio-religiosa: una ricostruzione, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia» 1(2011), pp. 3-30.
08 Giorda.indd 10408 Giorda.indd 104 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 105
Il Camera-Fabietti è orientato verso una trattazione positiva delle vicen-de risorgimentali, durante le quali il più grave ostacolo in termini politici e culturali era rappresentato dalla Chiesa. Dopo aver descritto come Pio IX si era irrigidito in una opposizione intransigente nei confronti del processo di unifi cazione, ma anche della cultura del tempo che delineava nuove prospet-tive politiche, sociali e scientifi che, il manuale dedica una descrizione e una rifl essione accurata a Quanta Cura e al Sillabo, che «prendeva nettamente posizione contro la libertà di stampa e contro il principio democratico e li-berale della sovranità popolare e rifi utava categoricamente il socialismo, il liberalismo e lo stesso cattolicesimo liberale, respingendo in defi nitiva tut-te quelle manifestazioni del pensiero moderno»54. Rispetto alle Guarentigie si legge che il pontefi ce rifi utò questa offerta creando un grave pregiudizio per il futuro sviluppo democratico e civile del paese55. Nonostante la Chie-sa, il progetto di composizione e di unifi cazione, pur sul lungo periodo (il Novecento)56, sembra funzionare e la pace tra le parti essere un suo pro-dotto; l’eccessiva semplifi cazione è facilmente colta nell’operazione volta a considerare i buoni i protagonisti che volevano l’unità e a disapprovare tutti gli altri; tra questi, lo Stato pontifi cio e il regno borbonico che si erano retti sull’arbitrio e sull’illegalità, su un’agricoltura estremamente arretrata e su redditi individuali molto miseri.
I manuali redatti da storici cattolici prestano maggiore attenzione al ruolo della Chiesa e dei cattolici: dal riscatto o difesa più o meno moderata di Pio IX, al riferimento ai cattolici liberali come parte attiva del processo risorgi-mentale. Si veda il De Rosa, ad esempio, che defi nisce l’atteggiamento di Pio IX nei confronti di Cavour «umanamente comprensibile», che distingue sem-pre tra intransigenti e moderati e che sottolinea il ruolo attivo e responsabile di alcuni cattolici negli anni risorgimentali.
Tra i manuali cattolici, il Traniello-Cracco-Prandi (1984) si segnala per il fatto di non assumere una posizione di difesa dell’operato cattolico durante il Risorgimento, come avevano tentato precedenti manuali, giustifi cando così ogni azione e reazione di Pio IX; scende invece nel dettaglio nella conduzione dell’analisi delle fasi e del ruolo di diverse fi gure che “fecero” il Risorgimen-to, tra cui spiccano i cattolici moderati e i neoguelfi . Del non riconoscimento della legge della Guarentigie, ad esempio, non vengono sottolineate solo le cause, ma soprattutto le conseguenze, ovvero il fatto che insieme al non expe-dit costituì la base su cui venne organizzata l’opposizione cattolica allo stato liberale, che continuava a trovarsi alle prese con gravi problemi sociali e con
54 Un profi lo dell’intensa attività di studioso e intellettuale impegnato sul terreno civile e politico-culturale, iniziatore dell’indirizzo di storia sociale e religiosa in Italia è tracciato da L. Billanovich, Gabriele De Rosa (1917-2009). Itinerario biografi co e indirizzo di storia socio-religiosa: una ricostruzione.
55 A. Camera-R. Fabietti, Elementi di storia, p. 224.56 Si tenga presente che anche nel P. Cataldi - E. Abate - S. Luperini - L. Marchiani -
C. Spingola, Di fronte alla storia, Palumbo, Palermo 2009, p. 487, si legge «I rapporti tra monarchia e Santa Sede rimasero tesi fi no al 1929, anno del concordato tra Chiesa e Italia fascista».
08 Giorda.indd 10508 Giorda.indd 105 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
106 Insegnare a credere
ondate di rivolte contadine presso i quali il clero cattolico aveva conservato intatta la sua autorità. Sempre nel Traniello-Cracco-Prandi, con una modalità inedita, si dedica un capitolo alle trasformazioni sociali e questioni religio-se57, in cui è esposta l’articolazione del cattolicesimo in differente correnti (liberale, democratico e intransigente) e il loro posizionamento in politica, la promulgazione di Quanta Cura e del Sillabo, l’opposizione dei cattolici liberali e l’esigenza di leggere tali documenti con lo spirito di quel tempo, cogliendone il tentativo politico di consolidare una struttura ecclesiastica che faceva capo al pontefi ce. Per la prima volta si leggono anche alcune pagine sul cattolicesimo sociale, sugli scritti papali, sulla pratica religiosa cattolica, sui movimenti e le organizzazione, sugli sforzi in campo sociale e educativo della Chiesa.
Pur attraverso atteggiamenti differenti, i manuali di questo periodo sono interessati in primis alla relazione Stato/Chiesa, ai rapporti di potere, agli in-teressi dei gruppi sociali più che al livello di partecipazione e alla forza degli ideali di rivoluzionari/conservatori/liberali/democratici: i protagonisti della fase risorgimentale sembrano essere, ancora, i laici e i cattolici e le loro auto-rità di riferimento. L’identità religiosa degli autori pare pesare sull’andamen-to narrativo e interpretativo dei manuali, mentre più sfumata è la posizione politica: si assiste all’innescarsi di un processo di stemperamento dell’ideo-logia e della militanza di chi scrive manuali di storia.
4.5. Dagli anni Ottanta a oggi
In questo percorso della didattica della storia e dei manuali, gli anni Ot-tanta rappresentano uno spartiacque o meglio un periodo di svolta decisivo per diverse ragioni, tra cui le tentate riforme della scuola e l’introduzione di nuovi modelli nella stesura dei libri di testo che si sarebbero affermati e diffusi in seguito. Negli anni Ottanta58 giungeva a compimento un percorso
57 Francesco Traniello - Giorgio Cracco - Alfonso Prandi, Corso di storia, SEI, Torino 1984, pp. 237-254: il capitolo è intitolato Cristianesimo e mondo moderno.
58 Per quanto concerne i programmi della scuola secondaria superiore, nonostante i tentativi di riforma, in particolare quello del 1986 del ministro Franca Falcucci, a favore di una storia più moderna e contemporanea e i lavori della Commissione ministeriale presieduta dal sottosegretario della Pubblica Istruzione on. Beniamino Brocca: Maurizio Gusso, Storia nel biennio: è tutto un programma. I nuovi programmi di storia per il biennio: proposte della Commissione ministeriale, in «I viaggi di Erodoto» 8(1989), pp. 156-169; Id., Chi ha paura del Novecento? A proposito dei programmi di storia della secondaria superiore, in «I viaggi di Erodoto» 12(1992), pp. 22-43. G. Di Pietro, Da strumento ideologico a disciplina formativa, pp. 133-151; per una trattazione delle varie fasi del dibattito in particolare si rimanda al numero 2 del 1987 della rivista «I viaggi di Erodoto» e a Francesco Pitocco, Storia antica o contemporanea? Un problema inesistente, in «Riforma della scuola» XXXIII, 1(gennaio 1987), pp. 7-8, fi no alla pronuncia della Commissione per la revisione di programmi di storia, che propose di non toccare i programmi vigenti fi no all’ultimazione dei lavori della Commissione stessa, in «Agenzia stampa Cgil scuola» X, 224-225, 2-3 novembre 1987, p. 9. Per i programmi Brocca: Piani di studio della scuola secondaria superiore e programmi dei primi due anni. Le proposte della Commissione Brocca, in «Studi e documenti degli Annali della Pubblica
08 Giorda.indd 10608 Giorda.indd 106 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 107
di elaborazione e defi nizione di un sapere speciale con proprie regole deon-tologiche e un linguaggio tecnico e che avrebbe portato alla specifi cazione della disciplina della didattica della storia. Riguardo ai manuali non si può non muovere dalla constatazione che a fronte della varietà e quantità dei testi a disposizione, il loro profi lo tendeva e tenderà sempre più a uniformarsi. I manuali iniziavano a connotarsi per la convivenza nel volume di almeno due se non più testi: il racconto manualistico vero e proprio, opera degli autori di copertina, storici come l’Ortoleva - Revelli59; il Giardina - Sabbatucci - Vidotto per Laterza60; il De Luna - Meriggi - Tarpino per Paravia61, il Pro-speri - Viola per Einaudi62; oppure di studiosi esperti di didattica come il De Bernardi - Guarracino per la Mondadori63, spesso eclettici, e cioè divisi tra diverse correnti storiografi che e politiche, non sempre capaci di seguire una linea storiografi ca prevalente.
In alcuni casi, gli apparati iconografi ci e documentari sono frutto del lavoro di redazione, un testo nel testo fatto di fotografi e, immagini, cartine e didascalie, brevi testi e glossari che integrano e supportano il testo narrativo e rendono il manuale più simile a un ipertesto; i percorsi storiografi ci e i do-cumenti sono presenti a volte in volumi separati a volte nello stesso volume del racconto a volte sono curati dagli stessi autori più spesso appaltati a una redazione esterna o a collaboratori; gli apparati didattici sono affi dati a spe-cialisti del settore64.
Istruzione» 56(1991), e Piani di studio della scuola secondaria superiore e programmi dei trienni. Le proposte della Commissione Brocca, tomo I e II, in «Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione» 59/60* e 59/60** (1992); W. Panciera - A. Zannini, Didattica della storia, pp. 224-239. Si veda anche Giuseppe Bosco, Le metamorfosi di un decennio: il curricolo di storia nella scuola superiore, in Id. - C. Mantovani (eds.), La storia contemporanea tra scuola e università, pp. 215- 229.
59 Si tratta di Storia dell’età contemporanea del 1982.60 Ve ne sono state diverse edizioni: Uomini e storia del 1988, Manuale di storia del 1988,
Profi li storici del 1997, Infostoria del 2000, Prospettive di storia del 2004, Il mosaico e gli specchi 2006, Nuovi profi li storici del 2008.
61 Si vedano Codice Storia del 2000, La scena del tempo del 2003, La storia al presente del 2008.
62 Si tratta di Corso di storia del 2000 e di Storia del mondo moderno e contemporaneo del 2004.
63 Da I tempi della storia del 1986, a L’operazione storica del 1987, a Storia del mondo contemporaneo del 1990, a La conoscenza storica del 2000, a I saperi della storia del 2008.
64 Antonio Brusa, Histoire-récit, histoire-image: les deplacements de la réthorique. Les carte set les mythes fondateurs, in «Internationale Schulbuchforschung» 19(1997), pp. 399-412. Questa complessità di redazione rimanda al legame importante – e poco studiato – con il sistema dell’editoria e con il mercato editoriale (i meccanismi di adozione dei libri, le promozioni, il ruolo degli agenti editoriali ed altri criteri commerciali). Massimo Legnani, Ipotesi sul manuale di storia, in «Storia e storia» 1(1979), pp. 45-49. Emilio Zanette, Comunicare con il manuale, in G. Bosco - C. Mantovani (eds.), La storia tra scuola e università, pp. 123-128; Alberto Gialluca, L’Università: una nuova generazione di Manuali, ibi, pp. 129-133; Antonio Brusa - Luigi Cajani, Der Geschichtsunterricht in der italienischen Primar-und Sekundar Schule, in Elisabeth Erdmann - Robert Maier - Susanne Popp (eds.), Geschichtsunterricht international. Worldwide Teaching of History. L’enseignement de l’histoire dans le monde, Verlag Hahnsche Buchhhandlung, Hannover 2006, pp. 35-42. Per fornire un’idea, solo nel 2010 sono stati
08 Giorda.indd 10708 Giorda.indd 107 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
108 Insegnare a credere
Venendo al nostro tema, il panorama storiografi co di riferimento è muta-to: parlare di Risorgimento in questo nuovo contesto signifi cava interrogarsi sulla natura degli italiani e sulle ragioni che ne facevano una nazione e rinno-vare questioni già sviscerate a fondo in un dibattito lungo ormai più di cento-cinquant’anni65. Negli ultimi anni, una nuova corrente di ricerca ha orientato la propria attenzione sulla creazione di un’idea di Italia e si è riversata in parte nella produzione di manuali66. È ormai consolidata la collocazione del Risorgimento, in quanto movimento per l’indipendenza e l’unità nazionale, nel generale movimento europeo per l’emancipazione delle nazionalità, nato dal contraccolpo della Rivoluzione francese, alimentato dal Romanticismo e legato ai movimenti liberali e democratici che furono l’espressione politica delle rivoluzioni borghesi nell’Europa continentale e al processo di sviluppo capitalistico, dapprima agrario-mercantile e poi industriale, che maturò in Italia dopo l’unità.
I manuali procedono analizzando le cause dei processi più che descri-vendole, cercando di mettere in luce limiti, potenzialità, errori delle varie parti protagoniste del Risorgimento, dando anche conto del dibattito stesso, dei suoi sviluppi, delle posizioni e delle interpretazioni degli storici; la nar-razione si fa più complessa, il giudizio più velato e meno palese, la catena di cause e effetti meno semplifi cata; inoltre, si fa riferimento a partiti, correnti, movimenti, associazioni, gruppi più che a singoli individui. Differenze so-stanziali e un andamento soggettivo (mascherato dall’imbarazzante pretesa di oggettività dei manuali della prima generazione) dipendente dalla posi-zione culturale e politica dell’autore non sono aspetti che caratterizzano le nuove generazioni di manuali, che spesso si ripetono, si rimandano, si usano a vicenda come fonte, in un percorso di omogeneizzazione di intenti e stile piuttosto evidente, che appiana le differenze tra autori che pur hanno avuto e conservano formazioni e posizioni culturali e politiche anche molto differen-ti. In tale processo di stemperamento delle peculiarità e degli orientamenti ha infl uito la presenza di una redazione che sta rendendo sempre più de-iden-tifi cati gli autori e sempre più frutto di compromessi redazionali i manuali.
pubblicati 23 nuovi manuali per il biennio, di cui sette novità per Mondadori.65 Gilles Pécout, Il lungo Risorgimento. La nascita dell’Italia contemporanea (1770-1922),
Mondadori, Milano 1999, pp. 17-29. Maurizio Viroli, Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo nella storia, Laterza, Roma-Bari 1995; Ernesto Galli della Loggia, La morte della patria: La crisi dell’idea di nazione tra resistenza, antifascismo e repubblica, Laterza, Roma-Bari 1996.
66 Il tentativo dello storico Banti, anch’egli autore di un manuale di storia in cui un intero capitolo è dedicato alla discussione dell’interpretazione del Risorgimento, è quello di rimettere in discussione l’immagine dell’identità italiana frammentata, indebolita dai confl itti interni: esisteva una sorta di narrazione coerente della nazione italiana, un discorso ricco di rimandi e di coerenze, una specie di pensiero unico della nazione che attingeva ad un comune repertorio di temi, metafore e simboli. Il Risorgimento viene considerato un movimento di massa, attivamente partecipato dai cittadini (nelle sue guerre, nella lotta politica, nelle feste e commemorazioni), che ha creato un movimento culturale più ampio, di portata europea: Alberto Maria Banti, Il senso del tempo. Manuale di storia (1650-1870), Laterza, Roma-Bari 2008: Tema in discussione 6, Risorgimento e Unità d’Italia, pp. 485-499.
08 Giorda.indd 10808 Giorda.indd 108 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 109
Accade così che, anche in presenza di grandi nomi e di storici di rilievo, i contenuti dei manuali siano più simili e sia sempre più diffi cile distinguerli in tipologie diverse per posizione ideologica o politica.
All’inizio di questo ultimo periodo troviamo ancora alcuni manuali più orientati da un punto di vista politico e laico, come Ortoleva - Revelli (1984), variamente ripubblicato, il cui impianto sottende una impostazione di sinistra: l’unità in cui è inserito il Risorgimento italiano è l’unità dell’Età del libero scambio, dove si affrontano i movimenti internazionali, l’ordine europeo, il colonialismo, il movimento operaio e la storia degli Stati Uniti d’America: una parte marginale quindi, sviluppato nell’ottica di una storia mondiale. Nell’unica, breve, pagina dedicata alla “soluzione” della questione romana, la Chiesa ha un atteggiamento di chiusura intransigente che ribadi-sce ogni condanna al liberalismo e a ogni forma di modernizzazione, tanto che Quanta Cura e il Sillabo sono ricordati come strumenti per mantenere un clima di terrore. Il fallimento della “via rivoluzionaria” (tra virgolette nel testo) porta alla storica breccia di Porta Pia e alla conseguenza per cui Roma diventa capitale d’Italia:
«Finiva così l’ultimo brandello di potere temporale della Chiesa e al movimento de-mocratico italiano veniva sottratto un obiettivo e un argomento di agitazione politica che ne aveva qualifi cato l’azione: dopo di allora la “sinistra” muterà la propria identità e assumerà connotati diversi. I cattolici non modifi carono invece la loro posizione di rigida contrapposizione nei confronti del nuovo stato italiano nonostante che il par-lamento avesse garantito per legge (legge delle Guarentigie) alla Chiesa l’assoluta libertà di culto e la sovranità sui palazzi vaticani assegnando allo stato vaticano una congrua dotazione annua: con una bolla papale Pio IX fece esplicito e tassativo divieto ai cattolici italiani di partecipare anche solo con voto alla vita politica (non expedit)»67.
Tendenzialmente però, siamo di fronte al massimo a sfumature e gra-dazioni della narrazione e del giudizio su eventi e personaggi del Risorgi-mento; per rendere più chiara questa affermazione è suffi ciente citare alcuni tra i manuali più adottati e più longevi sul mercato: ne L’operazione storica di De Bernardi e Guarracino (1993), ad esempio, la non accettazione delle Guarentigie – norme che garantivano alla Chiesa la piena sovranità sul Va-ticano e la libertà di svolgere la propria funzione religiosa – e il non expedit sono segnalati come episodi che provocarono una frattura tra Stato e Chie-sa ricomposta dopo alcuni decenni68. Un po’ più cauto il Villari (2002) che commenta le Guarentigie e il non expedit come frattura grave e pericolosa provocata in seno all’elettorato italiano tra la borghesi liberale e democratica e quella cattolica; per fortuna la Chiesa non fece leva sul malcontento delle masse rurali, evitando di mettere a repentaglio l’ordine sociale al quale erano
67 Marco Revelli - Peppino Ortoleva, Storia dell’età contemporanea, Mondadori, Milano 1982, p. 164.
68 Alberto De Bernardi - Scipione Guarracino, L’operazione storica, Mondadori, Milano 1993, p. 307.
08 Giorda.indd 10908 Giorda.indd 109 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
110 Insegnare a credere
interessate tutte le forze dirigenti del paese69. Sempre su questa linea della mancanza di una esposizione storiografi ca, si muove il De Luna - Meriggi - Tarpino (2008), che, dopo avere condensato in poche righe la “questione romana” («Altro problema che la ristretta élite del nuovo Stato si era trovata ad affrontare era stata quello dell’ostilità del Vaticano. Il regno d’Italia era infatti sorto travolgendo lo Stato della Chiesa e nel 1870 ne aveva conquista-to anche il cuore simbolico, Roma, per più di un millennio capitale dei papi e ora capitale dell’Italia unita»), dedica una scheda di mezza pagina al confl itto tra il “nuovo” stato italiano e lo Stato pontifi cio, dove si tratta Quanta cura, il Sillabo, il Vaticano I e il non expedit70.
Conclusioni
I manuali sono stati e sono una risorsa in termini di raccolta di materiale informativo e formativo, sono il tramite attraverso cui sono state educate generazioni di italiani; nodi interpretativi differenti hanno condotto ad ana-lisi e narrazioni storiche differenti, in alcuni momenti della storia d’Italia fortemente ideologizzate, oggi invece piuttosto standardizzate. Cambiamenti sul doppio binario politico e culturale stanno alla base della trasformazione della manualistica di storia più recente, in termini di stemperamento delle contrapposizioni ideologiche: da un lato il mutare della situazione politica dalla fi ne degli anni Ottanta in particolare, con la crisi del comunismo, ma anche dei grandi partiti di massa, tra cui quelli legati alla Chiesa cattolica, e, d’altro lato, il mutare dell’approccio culturale con la crisi delle grandi nar-rative prodotta dalle correnti decostruzioniste post-moderne si sono riversati sugli ambienti formativi, sulla scuola e, di conseguenza, sui manuali. A ciò si aggiunge, nello specifi co per quanto riguarda i manuali, la presenza di un lavoro sempre meno autoriale e sempre più redazionale: anche qualora siano coinvolti storici signifi cativi per le ricerche e per il dibattito storiografi co in corso, le posizioni sono sfumate e rielaborate da equipe di co-autori o cura-tori che hanno approcci diversi al testo. In tal modo le differenze tra manuale e manuale sono più di carattere tecnico e formale che contenutistico: tra i manuali più adottati e diffusi, i toni sono sempre meno militanti sia politica-mente sia confessionalmente. In sintonia con le linee culturali post-moderne, un soggetto collettivo (quasi) anonimo di autori ha quasi completamente so-stituito lo storico come soggetto. La redazione è il sigillo del manuale; il Salvadori, il De Luna, il Banti, storici attori del dibattito pubblico, non sono esattamente gli stessi quando diventano autori di manuali: una delle domande che questa ricerca lascia aperta e su cui si potrà ritornare in altra sede è, in ef-fetti, se questo processo di omogeneizzazione71 sia dovuto a un allentamento
69 Rosario Villari, Storia contemporanea, Editori Laterza, Roma-Bari 2002, p. 291.70 Giovanni De Luna - Marco Meriggi - Antonella Tarpino, La storia al presente, Paravia,
Torino 2008, p. 583.71 Fatta eccezione per alcuni rilievi e sottolineature, non si trova nei manuali traccia delle
08 Giorda.indd 11008 Giorda.indd 110 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 111
dei rapporti tra la ricerca e la didattica, tra il dibattito storiografi co e pubbli-co sul Risorgimento, nonostante quest’ultimo si sia acuito nell’ultimo anno con le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità di Italia o sia invece il frutto di una consapevolezza educativa e didattica che porta a posizioni più moderate quando si scrivono manuali per adolescenti e non saggi di storia o articoli di manuale.
** Ringrazio Paolo Bianchini, Antonio Brusa, Luigi Cajani, Giorgio Chiosso, Paolo Giacotto, Marta Margotti, Francesco Monducci, Francesca Pizzigoni, Giovanni Vian per i preziosi consigli che mi hanno aiutato a mettere a fuoco temi e problemi e a affi nare il metodo di ricerca.
polemiche che hanno alimentato il dibattito contemporaneo, ma neppure il fi lone storiografi co teso a valutare la potenza semantica e simbolica di temi risorgimentali come la famiglia, la patria, l’onore, proposti, altre che da Banti, da studiose come Ilaria Porciani e Silvana Patriarca, con prospettive differenti.
08 Giorda.indd 11108 Giorda.indd 111 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
112 Insegnare a credere
APPENDICE
Lista dei manuali raccolti (75 + 14 seconde edizioni + 4 seconde/terze edizioni)
C. Rinaudo, Corso di storia generale, Barbera, Firenze 1897.C. Rinaudo, Storia dei tempi moderni, Barbera, Firenze 1917.G. Zippel, Manuale di storia moderna d’Europa e specialmente d’Italia, Pa-
ravia, Torino 1904, 1927.I. Raulich, Manuale di storia contemporanea, Paravia, Torino 1907, 1924.A. Savelli, Manuale di storia europea e particolarmente italiana dal 476 ai
giorni nostri, Sansoni, Firenze 1912; 1925.N. Rodolico, L’età contemporanea dal 1748 al 1920, Zanichelli, Bologna
1921.N. Rodolico, Sommario storico, Le Monnier, Firenze 1923, 1930, 1931.A. Manaresi, Storia contemporanea, L. Trevisini, Milano 1927, 1940.P. Silva, Il Mediterraneo dall’unità di Roma, all’Unità d’Italia, Mondadori,
Milano 1927. P. Silva, Il Mediterraneo dall’unità di Roma all’Impero italiano, Mondadori,
Milano 1937. P. Silva, Corso di storia, Principato, Milano 1936, 1940, 1957.C. Capasso, Le nazioni e gli Imperi, Vitagliano, Milano 1930.A. Solmi, Discorsi sulla storia d’Italia, La Nuova Italia, Firenze 1933; 1941F. Calderaro, Vita vissuta. Corso di storia per licei e istituti magistrali, La
Nuova Italia, Firenze 1933.F. Cognasso, Storia d’Italia, Paravia, Torino 1938.N. Cortese, Corso di storia, Sansoni, Firenze 1942; 1943.R. Morghen, Civiltà europea, Palumbo, Palermo 1949.G. Soranzo - G. Tarantello, Storia: per i licei e per gli istituti magistrali,
Minerva italica, Bergamo 1957; 1963. O. Barié, Storia contemporanea, Società editrice Dante Alighieri, Roma
1963.A. Saitta, Il cammino umano. Corso di storia, La Nuova Italia, Firenze 1963.G. Spini, Disegno storico della civiltà, Edizione Cremonese, Roma 1963
(Edizione riveduta e ampliata [VII] secondo i programmi del 1960)G. Spini, Dalla preistoria ad oggi, Edizioni Cremonese, 1967.G. Quazza, Corso di storia, Petrini, Torino 1967.A. Camera - R. Fabietti, Elementi di storia III volume, Zanichelli, Bologna
1967; 1972; 1982.A. Camera - R. Fabietti, Storia. XX secolo, Zanichelli, Bologna 1974; 1999.
08 Giorda.indd 11208 Giorda.indd 112 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 113
R. Villari, Storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1969; 1984; 2002.A. Brancati, L’uomo e il suo tempo, La Nuova Italia, Firenze 1970.A. Brancati - T. Pagliarani, Dialogo con la storia, La Nuova Italia, Firenze
2004.A. Brancati - T. Pagliarani, Il nuovo dialogo con la storia, corso di storia per
il triennio, La Nuova Italia, Firenze 2007.G. De Rosa, Storia, Minerva Italica, Bergamo 1971.F. Gaeta - P. Villani, Corso di storia, Principato, Milano 1974.G. Procacci - B. Farolfi , Passato e presente, La Nuova Italia, Firenze 1974.F. Salvo - F. Rotolo, La città dell’uomo, Le Monnier, Firenze, 1975.F. Traniello - G. Cracco - A. Prandi, Corso di storia, SEI, Torino, 1975; 1984F. Traniello, Lezioni di storia, SEI, Torino 1998.F. Traniello - A. Guasco, Storia di mille anni, Sei, Torino 2004.F. Cardini - G. Cherubini, Storia, Sansoni, Firenze 1977.R. Manselli, L’Europa e il Mondo, Palumbo, Palermo 1978.A. Desideri - A. Gianni, Storia e storiografi a, D’Anna, Firenze-Messina
1978.A. Vegezzi - G. Parenti - M. Legani, Tempo storico, Zanichelli, Bologna
1978.R. Comba - G. Ricuperati - M. Salvadori, Corso di storia, Loescher, Torino
1978.P. Ortoleva - M. Revelli, Storia dell’età contemporanea, Mondadori, Milano
1982; 1984.M. Salvadori, R.Comba, L’età contemporanea, Loescher, Torino 1990.M. Salvadori - R. Comba, Corso di storia. L’età contemporanea, Loescher,
Torino 1995.M. Salvadori - F. Tuccari, L’Europa e il mondo nella storia, Loescher, Torino
2004.F. Gaeta - P. Villani - C. Petraccone, Storia contemporanea, Principato, Mi-
lano 1992.A. De Bernardi - S. Guarracino, L’operazione storica, Mondadori, Milano
1993.A. De Bernardi - S. Guarracino - R. Balzani, Tempi dell’Europa tempi del
mondo 3, Mondadori Milano 2004.A. De Bernardi - S. Guarracino, I saperi della storia, Mondadori, Milano
2006.A. De Bernardi - S. Guarracino, La discussione storica, Mondadori Milano
2009.Storia, Corso diretto da G. Galasso, Bompiani, Milano 1995.A. Desideri - M. Themelly, Storia e storiografi a, G. D’Anna, Messina-Firen-
ze 1996; 1997.T. Detti - N. Gallerano - G. Gozzini - G. Greco - G. Piccinni, La società mo-
derna e contemporanea, Mondadori, Milano 1997.M. Canzoni - F. Occhipinti, I territori della scuola, Einaudi Torino 1998. M. Canzoni - F. Occhipinti, Leggere la storia, Einaudi, Torino 2007.
08 Giorda.indd 11308 Giorda.indd 113 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
114 Insegnare a credere
M. Fossati - G. Luppi - E. Zanette, La città dell’uomo 3, Mondadori, Milano 1998
A. Prosperi - P. Viola, Corso di storia, Einaudi, Torino 2000.A. Prosperi, P. Viola, Storia del mondo moderno e contemporaneo, Einaudi,
2004.A. Giardina - G. Sabbatucci - V. Vidotto, Infostoria, Laterza, Roma - Bari
2000. A. Giardina - G. Sabbatucci - V. Vidotto, Prospettive di storia 3, Laterza,
Bari 2004.A. Giardina - G. Sabbatucci - V. Vidotto, Il mosaico e gli specchi, Laterza,
Bari 2006.A. Giardina - G. Sabbatucci - V. Vidotto, Nuovi profi li storici, Laterza, Bari
2007.A. Bravo - A. Foa - L. Scaraffi a, I fi li della memoria, Laterza, Torino 2000.F.M. Feltri - M.M. Bertazzoni - F. Neri, I giorni e le idee. Categorie per ca-
pire la storia, SEI, Torino 2002.G. De Luna - M. Meriggi - A.Tarpino, La scena del tempo, Paravia, Torino
2003.G. De Luna - M. Meriggi - A.Tarpino, La storia al presente, Paravia, Torino
2008.A. Lepre, La storia, Zanichelli, Bologna 2004.G. Gentile - L. Ronga - A. Rossi, Storia e geostoria 5, Editrice La Scuola,
Brescia 2005; 2006.V. Beonio-Brocchieri, La memoria e il tempo dal basso medioevo all’età
contemporanea, a cura di E. Cantarella e G. Guidorizzi, Einaudi Scuola, Torino 2006.
U. Mancini, Il mondo, i fatti, le idee. Corso di storia, Emmebi, Firenze 2007 F. Bertini, Storia, Mursia, Milano 2007.Z. Ciuffoletti - U. Balocchi - S. Bucciarelli - S. Sodi, Dentro la storia. Eventi,
testimonianze e interpretazioni, D’Anna, Messina - Firenze 2008.A.M. Banti, Il senso del tempo. 1870-oggi, Laterza, Roma-Bari 2008.V. Castronovo, Un mondo al plurale, La Nuova Italia, Firenze 2009.P. Cataldi - E. Abate - S. Luperini - L. Marchiani - C. Spingola, Di fronte alla
storia, Palumbo, Palermo 2009.M. Cattaneo - C. Canonici - M. Vittoria, Manuale di storia, Zanichelli, Bo-
logna 2009.
ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze the role of Catholicism, the Catholic Church and Catholics in the construction of Italian identity (from the second half of the nineteenth century to the present day). This by showing how it is presented in the history books, published from the thirties to present day, and utilized by the upper secondary school. The textbooks are a means through
08 Giorda.indd 11408 Giorda.indd 114 17/04/12 09.2717/04/12 09.27
Giorda - Religione cattolica e insegnamento nell’Italia unita 115
which students have their fi rst impact with history; for most young people, despite the growing strength of the mass media, textbooks remains the only opportunity for a contact with this subject. It is for this reason that among the textbooks, the history books are those who are usually subjected to cul-tural, ideological and political conditioning, as a construction instrument of politics and social identity of a country. Rebuilding through philology the drafting of manuals, means the study of who, how, why and for whom they were written, published and circulated. The report takes into account the pro-fi les of the authors of the manuals, their training and the publishing houses, but also, even if in the background, the programs that were structured and presented in the course of decades, and this, in various waves of renewal and reform of the school and historians during the contemporary debate. Throu-gh a quantitative analysis of the manuals (identify data and structure) and a qualitative analysis of certain junction in the history of Catholicism and the Catholic Church, the report focuses, in particular, on the period of the Risorgimento, the years that prepared and followed the unifi cation of Italy.
Il contributo si propone di analizzare il ruolo del cattolicesimo, della Chiesa cattolica e dei cattolici nella costruzione dell’identità italiana (dalla seconda metà dell’Ottocento ai nostri giorni), per come emerge ed è presen-tato nei manuali di storia, pubblicati dagli anni Trenta a oggi per la scuola secondaria superiore. I manuali scolastici sono il tramite attraverso il quale gli studenti hanno il loro primo impatto con la storia: nonostante la forza crescente dei mass media, per gran parte dei giovani rimane ancora la sola occasione di contatto con essa. È per questa ragione che tra i testi scolastici, i manuali di storia sono quelli maggiormente sottoposti a condizionamenti culturali, ideologici e politici, in quanto uno degli strumenti di costruzione dell’identità politica e sociale di un paese. Ricostruire fi lologicamente l’ope-razione di stesura dei manuali signifi ca studiare da chi, come, perché e per chi sono stati scritti, pubblicati e diffusi. La relazione prende dunque in con-siderazione i profi li degli autori dei manuali e la loro formazione, le case edi-trici, ma anche, seppur sullo sfondo, i programmi che sono stati strutturati e proposti nel corso dei decenni, nelle ondate varie di rinnovamento e riforma della scuola e il dibattito storiografi co contemporaneo alla loro stesura. At-traverso un’analisi quantitativa dei manuali (dati identifi cativi e struttura) e un’analisi qualitativa di alcuni snodi della storia del cattolicesimo e della Chiesa cattolica, la relazione si concentra in particolare sul periodo del Ri-sorgimento, sugli anni che prepararono e seguirono l’Unità d’Italia.
08 Giorda.indd 11508 Giorda.indd 115 17/04/12 09.2717/04/12 09.27