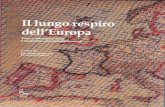Il futuro nel passato. Storia dell’arte e retorica nazionale nell’Italia unita, in Mosaico. Temi...
Transcript of Il futuro nel passato. Storia dell’arte e retorica nazionale nell’Italia unita, in Mosaico. Temi...
Collana diretta da
Rosanna Cio!
Comitato scienti!co
José Maria Morillas Alcázar, Sergej Androsov, Maria Concetta Di Natale, David Ekserdjian, Riccardo Lattuada, Benito Navarrete, Alessandro Rovetta e Philippe Sénechal
Comitato redazionale
Nadia Barrella, Gaia Salvatori, Ornella Scognamiglio
"
MOSAICOTEMI E METODI D’ARTE E CRITICA
PER GIANNI CARLO SCIOLLA
ROSANNA CIOFFI ORNELLA SCOGNAMIGLIO
V#$%&' S'(#)*#
MOSAICOTEMI E METODI D’ARTE E CRITICA
PER GIANNI CARLO SCIOLLA
ROSANNA CIOFFI ORNELLA SCOGNAMIGLIO
V#$%&' S'(#)*#
In copertinaMosaico con alberi da frutta, volatili e vasellame. Roma, Basilica di Santa CostanzaFotogra+e di Domenico Ventura
Il volume è stato pubblicato:grazie ai fondi MIUR-Prin 2008, con un contributo della Banca d’Italia, +liale di Caserta.
Si ringrazia il Dipartimento di Studi Culturali Arti Storia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Palermo
Via P. Francesco Danza, 7Piazza S. Maria la Nova, 44801338 NapoliTel./Fax 081.5525472 - 081.5521597 - 081.5538888http: //www.lucianoeditore.nete-mail: [email protected]
ISBN 978,88,6026,151,9
XIIII)*-(' XIII
L%(3 C-3)(35-$$3Cenni sopra diverse pitture staccate dal muro e trasportate dall’Italia in Gran Bretagna e specialmente di due a;reschi bolognesi di Ludovico Carracci e Guido Reni 385
L-)*3 B#.'3)Le Gallerie dell’Accademia di Venezia e i quadri della collezione Manfrin. Il ruolo di Pietro Selvatico 397
A$&'.-)*3 D- B')'*'//#La Storia dipinta: Domenico Morelli e il Sacco di Capua 407
C.-6/-)3 G3$366-La formazione delle pinacoteche comunali nell’Umbria postunitaria tra dispersioni e connoisseurship 417
L3%.3 G3$$#Un dipinto di Giuseppe Isola nel castello di Racconigi 425
A)/#)'$$3 T.#//3Il futuro nel passato. Storia dell’arte e retorica nazionale nell’Italia unita 433
F.3)(# B'.)35'-Riegl e i +loso+ 439
J#:3))3 V3<<3.-J.J. Tikkanen’s +ling cards on art history of expressions, gestures and movement 455
S-&#)' F'..3.-Fra Bramante, Leonardo e Jacopo de’ Barbari: il punto di vista di Alfredo Melani 465
G-%6'77-)3 P'.%6-)-Simon Horsin-Déon e la vendita della collezione Turinetti di Cambiano (Torino 1857) 471
XIV M#63-(#. T'&- ' &'/#*- *’3./' ' (.-/-(3 7'. G-3))- C3.$# S(-#$$3M#63-(#. T'&- ' &'/#*- *’3./' ' (.-/-(3 7'. G-3))- C3.$# S(-#$$3XIV
N3*-3 B3..'$$3Spunti dalla stampa periodica: aspetti del museo ottocentesco ne «L’Illustrazione Italiana» 483
M3.-3 C#)('//3 D- N3/3$'Metodologia per lo studio delle opere d’arte decorativa: alcuni esempi siciliani 497
E)0# B#.6'$$-)#Mercato dell’arte e tutela dopo l’Unità: il caso degli a;reschi del Maestro dell’Incoronazione di Urbino 513
G-#3((:-)# B3.5'.3Una scheda sul sipario di Paolo Vetri per il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza 525
M. G-%$-3 A%.-9'&&31911: il Congresso Artistico Internazionale di Roma 531
M3.-3 R#63.-3 D' R#63Max Dvo=ák lettore del Manierismo (e dell’Espressionismo tra le righe nascoste) 543
A))3&3.-3 D%((-“Grand Canyon”. Ancora su Focillon e la storia (a partire da alcuni appunti inediti) 551
G-%$-3)3 T#&36'$$3La funzione dei musei civici nella vita municipale italiana: ri>essioni d’inizio secolo di uno storico dell’arte 561
R#63))3 C-#88-Angelo Conti e la valorizzazione dei musei napoletani. Dalle pagine del «Marzocco» e da alcuni documenti inediti 569
G3-3 S3$43/#.-Gli scritti sull’arte +gurativa di Alfredo Gargiulo: da «La Critica» a «Vita Artistica» 583
A)9'$# T.-&3.(#La modernità, il “rimodernamento” 593
S-&#)'//3 L3 B3.5'.3Lineamenti e motivi di storia dell’arte siciliana: le ri>essioni di Enzo Maganuco su alcuni temi di arte siciliana 601
M3.-3 P3663.#“To open eyes”. L’insegnamento artistico di Josef Albers 611
XVI)*-(' XV
M3./3 N'00#La cappella degli Scrovegni durante la seconda guerra mondiale 619
V-)(')0# T.-#)'Il grande colorista. Michelangelo Antonioni tra cinema e pittura 629
S/'83)-3 Z%$-3)-Collezione di idee. Uno sguardo sulla “nuova museologia” 639
S-$4-3 B#.*-)-Su alcune parole della critica d’arte contemporanea 647
B-5$-#9.38-3 657
I)*-(' *'- )#&- 745
T34#$' 783
1. La memoria degli eroi
All’indomani dell’Unità, il discorso sul patrimonio storico e artistico, sulla sua consistenza fi sica e determinazione geografi ca, ma anche sul suo valore di luogo di appropriazione simbolica ed emotiva, è
centrale nella defi nizione dell’identità del nuovo stato italiano. Se l’immagine stessa della nazione si dichiara fi n dapprincipio come comunità di coscienza e di memoria territorialmente defi nita, il patrimonio appare come il terreno di aff ermazione, o di immediata negoziazione, di valori condivisi su cui fondare l’identità della nazione e dei suoi cittadini. Esso off riva l’occasione di comporre le tensioni tra conservazione e cambia-mento, tradizione e modernità, pubblico e privato, centro e periferia, in un modello di intesa che, radicato nella comune eredità del passato, poteva superare le divisioni del presente e garantire la trasmissione al futuro di signifi cati unifi canti. Come dimostra la storia complessa della legge di tutela, si trattava di un percorso non sempre lineare, ma avvertito con maggiore urgenza quanto più rapide si facevano le trasformazioni sociali ed economiche e più inquietanti le incertezze da esse suscitate. Ingaggiato in un confronto serrato con l’orgo-glio civico, le rivendicazioni politiche e le ambizioni sociali di singoli gruppi, le spinte centrifughe di intere comunità locali, l’impegno dello stato unitario a costituire gli strumenti amministrativi per studiare e con-servare le testimonianze del passato in nome della nazione, poteva fare leva su temi che avevano il potere di attivare una comunione di interessi, intenzioni e sentimenti altrimenti inimmaginabile. L’Italia, aveva detto Cavour in uno dei discorsi fondativi del nuovo stato, è «una nobile nazione», istruita nella corrispondenza tra la forma del governo, gli istituti dell’amministrazione e i caratteri della stirpe, della lingua, della religione, ma sostenuta da una trama di aff etti e memorie. Da questo punto di vista, la nazione è una comunità biopolitica, che, in nome delle «memorie degli strazi sopportati e le speranze dell’intiero riscatto»1, si cementa intorno al valore dell’esempio, si tratti del sacrifi cio dei martiri del Risorgimento, le cui effi gi, a partire dagli anni ottanta e novanta dell’Ottocento, popolavano le piazze, le strade e i giardini delle città2, o del talento di Mi-chelangelo e Raff aello, gli eroi del Rinascimento, di cui, a partire dall’Unità, si celebravano con la medesima adesione destinata ai funerali o alle incoronazioni dei sovrani, i centenari di nascita e di morte. Così, le fi gure e le istituzioni della storia dell’arte partecipavano a pieno titolo della retorica dell’Italia unita.
Nel 1883, i festeggiamenti per il quarto centenario della nascita di Raff aello furono una vera e propria
Antonella Trotta
Il futuro nel passato. Storia dell’arte e retorica nazionale nell’Italia unita
434 Mosaico. Temi e metodi d’arte e critica per Gianni Carlo Sciolla
liturgia nazionalizzante: inaugurati a Urbino, in Palazzo Ducale – il cui restauro appena ultimato si presenta-va come un esperimento riuscito di conciliazione, sia pure tardiva, tra interessi municipali e nazionali3 – essi coinvolsero tutte le città italiane e straniere legate alla memoria del “divino pittore”, da Roma a Firenze, a Perugia, a Dresda, a Vienna, a Boston, in una enunciazione, culturale e politica, del “primato italiano” come armonica corrispondenza dei valori della piccola patria locale con l’onore nazionale. «Di fronte a Dante, a Petrarca, ad Ariosto, al Tasso, la Germania vanta il suo Goethe, l’Inghilterra il suo Shakespeare, la Francia il suo Corneille, la Spagna il suo Cervantes. Ma quale nazione può contrapporre degnamente il suo nome a quello di Raff aello?»: «divina scintilla» che ha preservato lo spirito nazionale durante i secoli bui della conquista straniera, per Raff aello, aveva sottolineato Giuseppe Fiocchi Nicolai, presidente dell’Accademia intitolata all’Urbinate e gran cerimoniere dell’evento, Urbino e l’Italia erano ora il centro naturale di tutto «il mondo civile»4.
Al tema del “primato italiano” come fuoco di valori locali, nazionali e universali, inoltre, erano ispirati tanto l’allestimento della Sala degli Alabardieri, sede, in Palazzo Ducale, dei lavori della «tornata accademi-ca», quanto gli interventi degli oratori, che, tra velluti cremisi e luminarie al soffi tto, erano chiamati a sfi lare su un palco alle cui estremità campeggiavano, simmetricamente disposte, le effi gi di Raff aello e del re Um-berto I, raccordate da una serie di ritratti di urbinati celebri5.
La prolusione inaugurale era stata affi data a Marco Minghetti: a lui, già ministro dell’Interno del primo governo Cavour, ministro dell’Agricoltura del governo Menabrea e delle Finanze sotto la presidenza Peruzzi prima e Lanza poi, due volte presidente del Consiglio, negoziatore della Convenzione di settembre e ancora uno dei deputati più autorevoli della destra parlamentare, oltre che collezionista, conoscitore e discepolo devoto di Giovanni Morelli, toccava tenere insieme le ragioni della politica e quelle della storia dell’arte. Raff aello, aveva detto Minghetti, fa parte di quei «rarissimi» che, «alzati smisuratamente sopra la natura mortale», non appartengono solo alla memoria locale né a quella nazionale, ma, poiché «formano vanto perpetuo della umanità», partecipano di una memoria universale. Poiché il vero attiene al bello e il bello al buono, il talento straordinario di Raff aello per la verità naturale e le forme più alte della bellezza sollecitano nello spettatore «i sentimenti più nobili e più soavi» e rispondono a «tutte quelle parti dell’umano spirito che tengono del divino». Questi eff etti sono ottenuti con una maniera che riunisce «in sommo grado e nelle debite proporzioni, tutti i pregi: la composizione, il disegno, il colorito, l’espressione degli aff etti, il decoro, la cura alle cose grandi come alle minime». «Spontaneo e proprio», «unico», lo stile dell’Urbinate rispecchia nell’accordo di tutte le sue parti la felice corrispondenza tra la forma di governo e le forme dell’arte dell’Urbi-no dei Montefeltro: pacifi cata, colta e virtuosa, la città di Raff aello era già nel Rinascimento quando la vicina Perugia, divisa dagli scontri tra fazioni, era ancora nel Medioevo6.
Urbino, come la Roma di Giulio II – il cui progetto politico era stato più volte invocato dal Risorgimen-to7 – sono per Minghetti i poli essenziali di quell’ “età di Raff aello” che, secondo una lettura forse troppo rapidamente cristallizzata, ma tipicamente italiana, di Burckhardt, è l’epoca di composizione dei contrasti in nome dell’educazione al vero e al bello8. E ora, di fronte alle rappresentanze di Comuni e Province, dei Mi-nisteri della Pubblica Istruzione e degli Aff ari Esteri, della Camera e del Senato, delle Accademie, dei Musei e delle Gallerie del regno, ma anche delle Associazioni di reduci delle patrie battaglie, a Urbino si richiamava
435Antonella Trotta - Il futuro nel passato. Storia dell’arte e retorica nazionale nell’Italia unita
questa memoria culturale, in base alla quale l’Italia postrisorgimentale poteva superare le tensioni del presen-te, ritrovare il suo “primato” e, fi nalmente, istruirsi come patria.
2. Raff aello tedescoTratto «dal sereno campo delle lettere e delle arti» dall’impegno politico «pieno di agitazioni e di cura»,
e dall’impegno politico restituito ora «a quei primi studi»9, Minghetti aveva riassunto per le celebrazioni urbinati le conclusioni esposte in una serie di articoli su Raff aello che, alla fi ne del 1883, avrebbero trovato una sistemazione monografi ca. Lo scopo di questi lavori era ambizioso: rimediare alla mancanza di studi sul tema in lingua italiana dai tempi di Vasari10.
In eff etti, nel XIX secolo Raff aello era dominio della critica d’arte francese, dell’abilità tecnica nelle riproduzioni di opere d’arte inglese e, soprattutto, dell’erudizione tedesca. La prima monografi a moderna sull’artista, l’Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël di Quatremère de Quincy, era apparso in Francia nel 1824 e, malgrado incertezze attributive e lacune documentarie, aveva avuto una larga fortuna, anche in Ita-lia. Dalla fi ne degli anni cinquanta, erano tornati sull’argomento, con strumenti e interessi diversi, François Anatole Gruyer, Charles Clément e Ludovic Vitet. Nel 1881, Eugène Müntz aveva pubblicato Raphäel 11, immediatamente apprezzato in Inghilterra12.
Centrale nell’elaborazione della teoria estetica tra XVIII e XIX secolo, da Daniel Webb a Joshua Reynolds, su Raff aello in Inghilterra aveva scritto, nel 1816, Richard Duppa. Nel 1853, il principe consorte Alberto aveva avviato la campagna fotografi ca per il primo catalogue raisonné dell’Urbinate, pubblicato, nel 1876, nei prestigiosi Works of Raphael Santi da Urbino.
Ma, come avrebbe ricordato Hermann Grimm a margine dell’ultima edizione della sua Das Leben Raphaels, gli studi raff aelleschi erano innanzitutto un privilegio dell’erudizione tedesca. Ai tedeschi formati intorno all’Istituto prussiano di Roma, da Niebuhr a Bunsen, si doveva certo il merito di aver inserito la fi gura e l’opera di Raff aello in una prospettiva storica; a Carl Friedrich von Rumohr quello di aver aff rontato il tema col rigore dello storiografo e l’acutezza del conoscitore in una visione complessiva dello sviluppo della pittura italiana e a Johann David Passavant quello di essere diventato sull’argomento un’autorità indiscussa, seconda solo a Vasari13. Da Passavant, inoltre, discendevano le ricerche dei francesi e il progetto inglese del principe consorte, curato e completato dal tedesco Carl Ruland, allora bibliotecario di Windsor Castle ma poi diret-tore del museo di Weimar14.
Ancora nel 1886, facendo il punto sulla bibliografi a raff aellesca, l’inglese Martin Conway non elencava alcuno studio di rilievo in lingua italiana: l’attualità di Raff aello era affi data sostanzialmente al lavoro dei tedeschi Grimm, Springer, Schmarsow e Kahl, del francese Müntz, dell’italiano, ma tedesco di lingua e di formazione, Giovanni Morelli, e alla monografi a appena pubblicata, in inglese, da Crowe e Cavalcaselle15.
E se Minghetti aveva sottolineato il valore simbolico e nazionalizzante di Raff aello per l’Italia unita, sia pure nel riconoscimento di una comune appartenenza a un patrimonio universale, è utile rilevare che in que-gli anni il dibattito specialistico europeo e le imprese editoriali si erano decisamente colorate di sentimento nazionale, se non di nazionalismo. In Inghilterra, il progetto del principe consorte doveva essere in primo luogo uno strumento di educazione del gusto di artigiani e manifatturieri che potevano trarre vantaggio
436 Mosaico. Temi e metodi d’arte e critica per Gianni Carlo Sciolla
dalla ricostruzione, attraverso la riproduzione di disegni e dipinti, del processo creativo del “divino pittore”, e accorciare la distanza con la produzione più apprezzata dei cugini francesi16. Inoltre, la reiterata espunsione dal regesto raff aellesco dell’Apollo e Marsia di Morris Moore, la cui autografi a era stata sostenuta, oltre che dall’ostinato proprietario, da Delaborde e Gruyer, contro le conclusioni di Eastlake, si tingeva evidentemente di polemica antifrancese17.
In Germania, l’anno fondativo dell’Impero era stato festeggiato con la grande mostra di Dresda su Hans Holbein, il “Raff aello tedesco”, dove la Madonna del Borgomastro Meyer, intorno alla quale si era consolidata la ricerca storico-artistica nazionale, era esposta come «l’espressione compiuta della femminilità tedesca, fi ssata in ogni cuore tedesco» accanto alla Madonna Sistina 18. Due anni prima, Grimm aveva riaperto, in chiave nazionalistica, il dibattito attributivo sul presunto autoritratto di Raff aello di Monaco: le opinioni contrastanti sull’autografi a del dipinto e sul soggetto rappresentato nascondevano più che una querelle me-todologica un confl itto tra nazioni, tra un’alleanza culturale franco-italiana – cui purtroppo aveva aderito anche Passavant, cattolico e debole di carattere – e un partito fi lotedesco. Per i Romani, concludeva Grimm, screditare un’opera d’arte italiana portata da un tedesco in Germania era una questione nazionale19.
D’altra parte, Grimm avrebbe aggiunto altrove, qual era il contributo eff ettivo degli italiani agli studi raf-faelleschi? Privati dalle vicende politiche di una letteratura storica nazionale, e di una storia dell’arte, divisi e incostanti per ragioni di campanile o di vanità collezionistica, ma anche per orientare in maniera fraudolenta il mercato dell’arte, si erano esercitati in questioni attributive camuff ate da dibattiti eruditi, con il risultato di aver aumentato il catalogo di Raff aello e, loro malgrado, aver aperto un nuovo campo di studi20. Per i tedeschi.
3. Il “Cuore” e la testaSebbene non aff rontasse nessuno dei nodi cruciali della critica raff aellesca contemporanea21, né – come pure
i suoi studi – presentasse alcuna originalità interpretativa, nelle intenzioni il discorso di Minghetti intendeva rispondere a queste tensioni e rivendicare, se non le ragioni, gli auspici per una storia dell’arte della nuova Ita-lia, unifi cata nel sentimento e nelle istituzioni della politica e della cultura, e inserita in un contesto europeo.
Allo stesso modo, gli organizzatori delle celebrazioni urbinati si erano impegnati a conferire all’evento un respiro internazionale, inviando corrispondenti nelle città europee coinvolte nei festeggiamenti e ricevendo rappresentanze straniere: tra gli ospiti, si contavano Karl von Lützow, Victor Wimpff en, Hans Canon, per l’Accademia di Belle Arti, la Società per la riproduzione delle opere di belle arti e per la Società degli Artisti di Vienna, Jules Comte per l’Académie des Beaux-Arts di Parigi, e Julian Moore, per il padre, che aveva par-tecipato con una cospicua donazione all’acquisto della casa natale di Raff aello22. Internazionali erano state le sottoscrizioni che, fi n dal 1869, erano state raccolte per la realizzazione della statua di Raff aello, che si attendeva di collocare davanti Palazzo Ducale, ed europei erano gli artisti che avevano risposto all’appello23: così, la visita alla mostra dei bozzetti selezionati dalla giuria in vista della premiazione alla fi ne dei festeggia-menti, si presentava come prosecuzione della prima Mostra internazionale di belle arti di Roma, inaugurata nel gennaio dello stesso anno24.
Soprattutto, le delegazioni straniere, i rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali e il pubblico erano chiamati a intervenire a una liturgia nazionalizzante. Per questo, la città aveva progettato un’impressionante
437Antonella Trotta - Il futuro nel passato. Storia dell’arte e retorica nazionale nell’Italia unita
scenografi a: le vie principali, da Palazzo Ducale al Municipio, dall’Università a piazza Vittorio Emanuele, che gli ospiti dovevano percorrere in corteo per deporre corone di fi ori alla casa di Raff aello, erano state trasformate in un eccezionale percorso luminoso, di prospettive effi mere e ventagli con i ritratti degli italiani illustri. Si trattava di «un incanto» di luci e colori che, sottolineato dalla marcia reale suonata dalla banda militare25, ricordava ai presenti, se non nel tono almeno nell’intensità della partecipazione emotiva, quel prototipo di pellegrinaggio laico che erano stati, cinque anni prima, i funerali di Vittorio Emanuele II: la cerimonia, che si era svolta a Roma «sotto una pioggia di fi ori», davanti a «una legione di generali», «una folla di ministri e di principi», i reduci e gli inviati delle città, era stata uno dei fuochi patriottici di Cuore, il testo più coerente ed effi cace della contemporanea retorica della nazione, se non già nazionalistica26.
Ma, se le spoglie reali erano solo evocate, quelle di Raff aello che con il primo re d’Italia divideva la se-poltura al Pantheon, a Urbino erano fi sicamente presenti: grazie a una temporanea deroga al regolamento, la Congregazione dei Virtuosi di Roma aveva concesso alla pubblica devozione il calco del cranio del pittore che era stato tratto al momento della scoperta del suo sepolcro sotto l’altare della Madonna del sasso, nel 1833. Allora, quando le truppe austriache chiamate a reprimere nel sangue i moti di Modena, Bologna e nelle Legazioni erano ancora di stanza nello stato della Chiesa, il ritrovamento aveva suscitato un’onda di commozione: per sei giorni, i resti di Raff aello erano stati esposti a un pubblico così numeroso da costringere il Papa a impegnare le guardie svizzere e i soldati comuni, e i Virtuosi ad aprire una nuova porta. Il principe Odescalchi, uno dei cronisti dell’accaduto, aveva osservato che, in quei giorni in cui gli assembramenti non avevano nulla di rassicurante, quella confusione festosa era stata «un gran bel riposo sul tanto vaneggiare e trar profezie intorno ai politici rivolgimenti». «A tutti – aveva concluso – quasi pareva di essere retroceduti insino ai tempi di Raff aello»27. Ora che l’Unità era fatta, dalla reliquia laica della testa del “divino pittore”, novello Orfeo o Caput Oli, si attendevano vaticini per il futuro del nuovo stato.
438 Mosaico. Temi e metodi d’arte e critica per Gianni Carlo Sciolla
Note
1 Così, l’11 marzo 1861, Cavour presentava il disegno di legge sul conferimento del titolo di re d’Italia a Vittorio Emanuele II. Cfr. E. Gentile, La grande Italia. Ascesa e declino della nazione del XX secolo, Milano 1997, p. 10.
2 A.M. Banti, Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Roma-Bari 2011, pp. 51-77. 3 S. Troilo, La patria e la memoria. Tutela e patrimonio culturale nell’Italia unita, Milano 2005, pp. 189-191. 4 Parole del prof. Cav. G. Fiocchi Nicolai, in Atti del IV Centenario della nascita di Raff aello. 28 marzo 1883, Urbino 1887, pp. 3-4.5 Atti del IV Centenario…, cit., p. XII.6 Discorso di S.E. il cav. Marco Minghetti, in ivi, pp. 9-21. 7 Ibidem e M. Minghetti, Raff aello, Bologna 1885, pp. 103-104. Cfr., anche, R. Gherardi, Dall’arte di Raff aello alla politica moder-
na: rifl essioni di Marco Minghetti, in «Scienza & Politica», 40, 2009, p. 73. 8 M. Ghelardi, La scoperta del Rinascimento. L’ “età di Raff aello” di Jacob Burckhardt, Torino 1991, pp. 211-224. 9 Discorso…, cit., p. 12. Gli studi di Minghetti su Raff aello – Raff aello a Roma sotto Giulio II; Raff aello a Roma sotto Leone X (1523-
1520) e Ultimo periodo di Raff aello (1517-1520) – apparvero, su «Nuova Antologia», nel 1883. Su Minghetti e la storia dell’arte italiana, cfr. S. Lodovici, Storici, teorici e critici delle arti fi gurative (1800-1940), Roma 1942, p. 349 e R. Gherardi, P. Schiera, Un commento a due mani a M. Minghetti, “La Maddalena nell’arte”, in «Scienza & Politica», 36, 2007, p. 18. È utile ricordare che le opere politiche più interessanti dello statista, assai più originali degli studi storico-artistici, sono degli stessi anni, cfr. M. Minghetti, Scritti politici, a cura di R. Gherardi, Roma 1986.
10 M. Minghetti, Raff aello…, cit., pp. I-II. 11 E. Müntz, Raphaël, sa vie, son œuvre et son temps, Paris 1881. Sul nazionalismo della storia dell’arte francese nel XIX secolo, cfr. Histoire
de l’histoire de l’art en France au XIX e siècle, a cura di R. Recht, P. Sénéchal, C. Barbillon, F.-R. Martin, Paris 2008 e, su Müntz, M. Pas-sini, L’Italia come problema. La storia dell’arte francese e la questione del Rinascimento, in «Annali di critica d’arte», 4, 2008, pp. 213-220.
12 Lo studio di Müntz fu subito tradotto in inglese, cfr. Id., Raphael: His Life, Works and Time, London 1882. 13 H. Grimm, Th e Life of Raphael, traslated by S. Holland Adams, Boston 1888, pp. 300-304. 14 J. Montagu, Th e Ruland/Raphael Collection, in «Visual Resources», III, 3, 1986, pp. 167-183. Lo stesso Grimm aveva studiato
Raff aello a partire dal catalogo di Ruland. 15 M. Conway, in «Th e Academy», 748, 4 settembre 1886, pp. 157-158 e D. Levi, Cavalcaselle. Il pioniere della conservazione dell’arte
italiana, Torino 1988, p. 389. 16 A. Hamber, Photography in Nineteenth-Century Art Publications, in Th e Rise of the Image. Essays on the History of the Illustrated Art
Book, a cura di R. Palmer, T. Frangenberg, Aldershot 2003, pp. 218-220.17 F. Haskell, Le metamorfosi del gusto. Studi su arte e pubblico nel XVIII e XIX secolo, Torino 1989, pp. 224-258. 18 A. Woltmann, Holbein und seine Zeit, vol. I, Leipzig 1866-1868, p. 319 e D.A. Brown, J. van Nimmen, Raphael and the Beautiful
Banker. Th e Story of the Bindo Altoviti Portrait, New Haven-London 2005, p. 123. 19 H. Grimm, Raphael’s eigene Bildnisse: Beitrag zur Geschicte der modernen Kunstforshung, in «Preussische Jahrbücher», XXIV, 1869,
p. 581 e D.A. Brown, J. van Nimmen, Raphael…, cit., pp. 120-121. 20 H. Grimm, Th e Life of Raphael…, cit., pp. 308-309. 21 Numerosi, come in E. Müntz, Les historiens et les critiques del Raphael, 1483-1883, Paris 1883. Cfr. D. Levi, Cavalcaselle…, cit., p. 389. 22 Atti del IV Centenario…, cit., p. XVIII. A Moore senior, che in quei giorni era a Roma per concludere la vendita dell’Apollo e
Marsia al Louvre, veniva dedicato un busto ritratto nella casa di Raff aello. 23 Ivi, pp. XXIII-XXV e S. Troilo, La patria…, cit., pp. 191-192.24 M. C. Buscioni, Esposizioni e “stile nazionale” (1861-1925), Firenze 1990, pp. 85-89.25 Atti del IV Centenario…, cit., p. XXXII.26 E. De Amicis, Cuore [1886], Milano 1993, pp. 65-66. 27 Istoria del ritrovamento delle spoglie mortali di Raff aello Sanzio da Urbino, scritta da P. Odescalchi e con le aggiunte di P. E. Visconti,
Roma 1833, p. 40. La vicenda è ricostruita in A. Muñoz, La tomba di Raff aello nel Pantheon e la sua nuova sistemazione, in «Vita d’arte», IX, 1912, pp. 164-192.