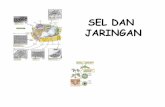Temi Sel., intonaci
Transcript of Temi Sel., intonaci
1 Per uno studio dei materiali e tecniche della pittura murale greca in generale, si veda MORA et alii1984, 85-87; su quella funeraria magnogreca, BREKOULAKI 2001, 11-70, con i contributi di COLOMBINI etalii 2001, 72-75, e di LAZZARINI 2001, 76-98, sui materiali e le tecniche.
2 Le pietre porose, proprio per la loro porosità sono più soggette delle compatte a un forte degrado, ades. per cicli di cristallizzazione salina in aree marine, con la generazione di gravi forme di deterioramentocome l’alveolizzazione.
INDAGINI ARCHEOMETRICHE SUGLI INTONACI DEI TEMPLI DI SELINUNTE
Lorenzo Lazzarini
Introduzione
Da una prima ricerca bibliografica, sono risultate pressoché assenti indagini archeo-metriche non solo sistematiche, ma anche occasionali di intonaci o finiture a stucco diarchitetture della Grecia antica, includendo in questa vasta area geografica le colonie siaorientali che occidentali. Molto rare sono quelle riguardanti dipinti murali di edificipubblici e funerari prodotti dalla medesima civiltà figurativa, e stesi su supporti lapidei1.Questa lacuna appare del tutto sorprendente se si pensa alla incredibile diffusione che haavuto nel mondo ellenico l’uso dei porolithoi, pietre tenere locali solitamente costituiteda calcari porosi, calcareniti, e arenarie (spesso impropriamente denominati tufi) che,quando usate in edifici pubblici importanti (templi e loro altari, ekklesiasteria, teatri,tombe, ecc.) venivano di norma rivestite con intonaci e/o stucchi a base di calce, dei verie propri marmorini, frequentemente policromati. L’uso di tale rivestimento era dettatosia da un intento nobilitante del materiale povero, che veniva reso simile al marmo, e co-sì con superfici eventualmente adatte a ricevere una policromia, sia e soprattutto, dallanecessità di proteggere il substrato lapideo che per le sue intrinseche proprietà era gene-ralmente poco durevole2.
Esempi di intonacature e stuccature di edifici pubblici greci si trovano dall’età arcai-ca al tardo ellenismo, nella madrepatria come nelle colonie: per citarne solo alcuni bennoti, lontani tra loro geograficamente e cronologicamente, nell’Hekatompedondell’A-cropoli di Atene, studiato dal Brückner e poi dal Wiegand, nei templi di Heraa Olimpiae di Crotone a Capo Colonna, nei capitelli eolici di Neandria e Larissa sull’Ermo, neitempli poseidoniati, specie nella c.d. Basilica, in quelli agrigentini (ben conservate letracce in quello dei Dioscuri) e selinuntini, ecc.
La pratica della intonacatura dal mondo greco passò anche a quello romano, dove aRoma si ritrova soprattutto in fabbriche repubblicane, come sul tempio della Fortuna Vi-rile, le cui colonne sono in tufo vulcanico locale ricoperto di uno spesso rivestimentoche termina in un bel marmorino.
Lorenzo Lazzarini
138
3 Per una breve storia degli studi sulla policromia nell’architettura e arti plastiche di età classica si ve-da MELUCCOVACCARO 1985 e EAD. 1987, 4-23.
4 Al proposito, lo studio più completo, che comprende l’esegesi delle fonti, una schedatura delle scul-ture policrome più famose sia greche, sia romane, e una ampia bibliografia, è quello della MANZELLI 1994,che va integrato per l’architettura con il contributo di CAMPISI 1987, 25-43 e, più in generale, col catalogodella mostra di cui alla nota 8 (infra), in particolare con i contributi di BANKEL 2004, 91-106 e BRINKMANN
2004, 133-140.5 Tra quest’ultime va segnalato lo studio di MARAVELAKI et alii 2003, che conferma, come detto in
MORA et alii 1984, 83-87, che Minoici, Micenei e i loro successori Greci usarono tecniche pittoriche e dirivestimento architettonico basate sulla calce.
6 L’inquadramento generale sulle tecniche costruttive dell’architettura greca di Sicilia è in GULLINI
1985, 415-491; un aggiornamento sui monumenti selinuntini in MARTENS1996, 315-346. Lo scrivente unaquindicina di anni orsono ebbe proprio dal prof. Giorgio Gullini, con l’autorizzazione dell’allora Soprin-tendente Rosalia Camerata Scovazzo, l’incarico di studiare con colleghi dell’Università di Modena la cal-carenite delle fabbriche e i marmi delle metope dei templi selinuntini (sui risultati delle indagini, si vedaGORGONIet alii 1992, 531-539 e ID. 1993, 33-59). Nell’occasione vennero prelevati abbastanza sistemati-camente anche campioni di intonaci relativi al tempio di Hera (tempio E), oggetto principale dell’indaginesollecitata dal Gullini, e solo in via preliminare e indicativa da altri edifici templari selinuntini.
7 Il suo celebre studio non ha purtroppo portato a una adeguata conservazione dei pur abbondanti restidi pietre policrome ancora conservati in situ, né subito dopo la pubblicazione, né successivamente.
8 Testimonianza ne è, da ultimo, la mostra intitolata I Colori del Bianco, policromia nella scultura an-tica che si è tenuta ai Musei Vaticani nel 2004: su di essa si veda il catalogo di autori vari dallo stesso titolo,Roma 2004.
9 Sulla biocalcarenite di Selinunte, e il calcare di Misilbesi usato per le metope dei suoi templi si veda-no CARAPEZZA et alii 1983; HEIN 1990; GORGONIet alii 1993; GORGONI-PALLANTE 2000.
Gli studi degli intonaci di elementi architettonici lapidei e della policromia in architet-tura e scultura risalgono a A. Quatremère de Quincy, un seguace del grande storico del-l’arte classica A. Winckelmann (1717-1768), che seppe meglio del maestro scoprire letracce di colore sopravvissute nelle fabbriche e statuaria antiche, nate colorate, comemolti studi successivi hanno ampiamente dimostrato3. Tali studi hanno avuto molti culto-ri, specie tra archeologi e storici dell’arte tedeschi, mentre solo recentemente si è prestataattenzione agli aspetti dei materiali e delle tecniche impiegati nei rivestimenti e tratta-menti superficiali dell’architettura e della plastica di età classica4. Come detto sopra, an-cora più rare sono le ricerche comprendenti indagini di laboratorio finalizzate allo studiodi tali materiali e tecniche della classicità, rarissime quelle riguardanti il mondo greco5.
Per colmare, anche se solo in minima parte, questa lacuna di conoscenza, si è pensatodi esporre di seguito i risultati di alcune indagini eseguite in questo campo dallo scriven-te nel corso degli ultimi anni e, vista la natura monografica del presente volume dedicatoa temi selinuntini, di restringere l’esposizione dei risultati ad alcuni edifici templari diquella città6.
Fu proprio a Selinunte che J.J. Hittorff verso la metà del XIX secolo condusse le sueprime osservazioni sulle finiture superficiali del tempietto B dell’acropoli, da lui dettodi Empedocle, che lo portarono a pubblicare nel 1851 il primo saggio sull’argomento7,saggio che segna l’inizio degli studi sistematici sulla policromia nell’architettura grecapoi proseguiti per oltre un secolo con alterna fortuna, ma che tanto successo hanno ri-scosso di recente8. Contrariamente a quanto può pensare il visitatore comune, infatti,l’architettura selinuntina non era del tutto caratterizzata dal giallo della pietra locale,una biocalcarenite porosa del Pleistocene9 cavata nei dintorni della città (Latomie
Indagini archeometriche sugli intonaci dei templi di Selinunte
139
10 Sulle cave antiche di Selinunte si veda PESCHLOWBINDOKAT 1990, 9-44.11 L’azione protettiva degli intonaci si esercita anche nei confronti della colonizzazione lichenica: è
una conclusione che appare evidentissima dall’osservazione che chiunque può fare, e cioè che i licheni neri(Verrucaria nigrescens), bianchi (Dirina massiliensis, Lecanora pruinosa) e gialli (Caloplaca aurantia) aSelinunte attaccano quasi esclusivamente la biocalcarenite (GORGONIet alii 1992), perché essa offre loroun substrato poroso trattenente a lungo l’acqua, risparmiando gli intonaci residui che assicurano ancora unrivestimento bastantemente efficace.
12 Sugli aspetti archeologici e storico-artistici delle metope dei templi selinuntini, si vedano tra i nume-rosi contributi, TUSA 1983; MARCONI 1994; CONTI 1996.
13 Per un inquadramento geologico generale della Sicilia occidentale, MASCLE 1970. Sui calcari di Mi-silbesi, CARAPEZZA et alii 1983; GORGONIet alii 1993; sui marmi, GORGONIet alii 1993; GORGONI-PALLANTE
2000.14 Lo stato di abbandono dei templi di Selinunte è a dir poco vergognoso: i ferri fuoriusciti e arrugginiti
delle integrazioni in cemento armato del tempio E, e la pluriennale, pericolante, impalcatura sulla peristasisettentrionale del tempio C sono solo le due più evidenti manifestazioni di un abbandono ingiustificabilenonché di una mancanza totale della seppur minima manutenzione su edifici di tale importanza, e fannopersino passare in secondo piano la grave e progressiva perdita degli intonaci superstiti presenti in questi emolti altri monumenti.
Landàro, Latomie del Barone), o poco più lontano (Cave di Cusa vicino a Campobellodi Mazara, e cavette come quelle di Cusa, ma probabilmente inedite, in località S. Nico-la di Mazara)10, ma anche dal bianco degli intonaci di molti edifici pubblici, prevalente-mente templi. Questi intonaci erano degli stucchi compatti come i marmorini, policromiin quelle loro parti sottolineanti elementi architettonici, che facevano risaltare anche dalontano le fabbriche più importanti della polis, oltrettutto proteggendone la pietra11. Po-licrome erano anche le metope, sia di VI che di V sec. a.C.12, ricavate nel calcare tenerodi Misilbesi, sempre fossilifero ma più compatto della biocalcarenite, forse anch’essesottilmente intonacate prima di essere dipinte, e talora con acroliti di marmo bianco pa-rio per lo più dalle cave a cielo aperto di Lakkoi13.
L’aspetto essenzialmente bianco dei templi nel panorama selinuntino, complessiva-mente giallo per la pietra locale, e verde per la vegetazione, era quindi di grande impattovisivo, ora difficile da immaginare; ma bisogna anche ricordare la determinante funzio-ne conservatrice che gli intonaci svolgevano nei confronti della pietra tagliata e messa inopera, pietra di proprietà fisico-meccaniche scadenti e facilmente soggetta a gravi feno-meni di deterioramento nell’ambiente costiero di Selinunte, ricco di aerosolsmarini.Nonostante ciò, questi intonaci, come quelli dei monumenti di altre città siceliote qualiAcragante, Gela, Morgantina, ecc., tutti costruiti con la pietra tenera locale e bisognosidi intonacature, sono stati quasi del tutto ignorati dalle scienze archeologiche.
Si ritiene quindi, anche in considerazione del precario stato di conservazione degliintonaci selinuntini, già una quindicina di anni fa ridotti nella maggioranza dei templiesaminati a vere e proprie ‘larve’, che questo studio serva come testimonianza di una ri-levante storia materiale a fortissimo rischio di perdita totale14. Vale pertanto la pena dicitare la presenza di intonaci negli edifici esaminati, e descriverne brevemente la consi-stenza con una documentazione fotografica di minima.
Nel complesso degli edifici del santuario della Malophorosalla Gàggera, sono anco-ra presenti (2006) tracce di intonaci bianchi sul muro settentrionale all’interno del me-garon (fig. 1) e, più estese, sull’altare in sua corrispondenza (fig. 2). Lo stesso si può ri-
Lorenzo Lazzarini
140
15 PARISI PRESICCE1984, 29-38 (con molto generiche indicazioni sui materiali, incluso un intonaco, diBellotti), e PARISI PRESICCE1986, 23-53.
16 Un frammento abbastanza grande di tale intonaco, già staccato da uno spigolo, è stato utilizzato me-diante semplice sezionatura per levigazione, sia per osservazioni mesoscopiche (fig. 4 bis) sia, successiva-mente, per la preparazione di una sezione sottile (infra). In generale tali osservazioni, facili da effettuarecon una lente contafili, sono di notevole interesse per determinare il numero degli strati, il loro spessore ecomposizione di massima.
petere per le medesime strutture del piccolo edificio solitamente identificato come Trio-lo Nord (figg. 3, 4), probabilmente un piccolo Heraion15, nel cui altare è in opera un in-tonaco di ottima qualità, come si è potuto notare anche da osservazioni macroscopichein situe in laboratorio (fig. 4 bis)16.
Sui templi dell’acropoli, sono presenti ancora vaste tracce di intonaco rosso sul muro(della cella ?) del tempio B (figg. 5, 11), e intonaci bianchi molto consunti in qualcherocchio di colonna nel tempio D (fig. 6), mentre nel tempio C si notano solo piccole areebianche solo sotto il capitello della colonna più occidentale della peristasi.
Dei templi della collina orientale, l’E (Heraion) mostra estese superfici intonacate incorrispondenza delle scanalature delle colonne oggetto dell’anastilosi dell’inizio degli an-ni sessanta (anche di quelle sopravvissute delle fasi più antiche E 1, E 2, reimpiegate inquella E 3), specie della peristasi settentrionale (figg. 7, 8), di alcuni blocchi delle architra-vi dei due fronti, di cui uno a terra, di fronte al lato Est, conserva tracce di un intonaco ros-so (fig. 9) del tutto identico a quello del tempio B. Osservando da vicino le colonne, qui sinota chiaramente una preparazione (arriccio) per l’intonaco bianco di colore giallino espessore molto variabile, da qualche mm fino a 2-3 cm, che aveva anche la funzione di re-golarizzare (e probabilmente portare a dimensione standard) il profilo delle colonne. Neltempio F sono numerosi i rocchi di colonne della peristasi Sud e dei due fronti con ancorain posto intonaci bianchi (fig. 10), che nel complesso sembrano di spessore molto inferiorea quelli del tempio E. Come è noto, nel tempio G, non finito, non sono presenti intonaci.
Campioni analizzati e metodi di studio
Sono stati campionati intonaci dalle seguenti parti architettoniche di edifici templariselinuntini:– muro interno e altare del megarondel santuario della Malophoros;– idemdall’edificio detto Triolo Nord;– colonna della peristasi meridionale del tempio D;– frammento dell’architrave (?) nel lapidario di fronte all’antiquariumdell’Acropoli, e
cornice del fregio dipinta di blue, ora conservata nel Museo Archeologico RegionaleA.Salinas di Palermo (fig. 11), ambedue del tempio B;
– blocchi dell’architrave, del fregio e del geison, colonne della fase E 1, E 2 ed E 3 deltempio E (Heraion);
– colonna della peristasi meridionale del tempio F.Con l’eccezione del tempio E, da cui sono stati prelevati 8 campioni (come detto,
parte dal tempio E 1, ed E 2, e parte dall’attuale fase, convenzionalmente indicata con E3), da tutte le altre strutture si è rimosso un solo frammento di intonaco, per lo più di co-
Indagini archeometriche sugli intonaci dei templi di Selinunte
141
17 Alcune analisi diffrattometriche sono state eseguite dalla dott.ssa M.L. Amadori, ora all’Universitàdi Urbino, che si desidera qui ringraziare.
lore bianco. I campioni di tale colore sono stati prelevati da parti in via di distacco, o na-scoste, mediante scalpellino, avendo cura di interessare anche gli eventuali arricci, e didanneggiare il meno possibile gli intonaci stessi, nonché di limitarne le dimensioni a cir-ca 1-2 cm quadrati. Quelli di colore invece sono stati staccati utilizzando la punta acu-minata di un bisturi e sono stati ridotti a qualche mm quadrato. I primi sono stati suddi-visi in due porzioni: il frammento più grosso è stato inglobato in una resina poliesterepolimerizzabile a freddo e da esso è stata ricavata una sezione sottile successivamenteesaminata in luce trasmessa al microscopio polarizzatore seguendo le raccomandazioniNORMAL 12/83, mentre una seconda porzione, più piccola, si è disgregata per macinatu-ra in mortaio di agata sino a ottenere una polvere impalpabile, poi analizzata mediantediffrazione dei raggi-X (Radiazione Cu Ka/Ni a 40KV, 20 mA)17, avendo prima cura diseparare meccanicamente sotto uno stereomicroscopio gli eventuali arricci dagli intona-ci. I campioni di colore sono stati anch’essi inglobati come sopra, ma se ne è preparatauna sezione lucida trasversale poi studiata in luce riflessa in microscopia ottica ed elet-tronica a scansione; quest’ultima tecnica è stata usata anche con l’interfaccia di una mi-crosonda elettronica a dispersione di energia (SEM+EDS) che ha consentito un control-lo mediante analisi microchimica dell’identificazione microscopica dei pigmenti utiliz-zati nelle coloriture attraverso la determinazione dei loro elementi cromofori, nonché dialcuni componenti gli intonaci.
I risultati ottenuti
L’analisi diffrattometrica di tutti gli strati preparatori (arricci) degli intonaci esamina-ti è risultata poco utile, avendo dato esiti pressoché identici a quelli delle biocalcarenitidi Selinunte, e cioè calcite abbondante, presenza di quantità variabili, da abbondante atracce, di quarzo e, talora, tracce di K-feldspato.
La stessa analisi effettuata su alcuni strati di intonaco e intonachino bianchi, ha evi-denziato sempre la presenza di sola calcite, salvo in un campione dal tempio E 3 che hamostrato tracce di weddellite (ossalato di calcio biidrato). Lo studio di alcuni campioni,sempre di intonaco bianco, al SEM+EDS non ha fornito la benché minima traccia di sili-cio e alluminio, indicativi di un eventuale utilizzo di calcari argillosi per la preparazionedella calce, o di magnesio, riferibile a calcari magnesiaci di partenza.
Le informazioni più importanti sono state ricavate dallo studio al microscopio petro-grafico delle sezioni sottili trasversali dei rivestimenti campionati. I risultati ottenuti so-no di seguito sintetizzati per area archeologica e monumento.
Ar ea della Gàggera
Santuario della Malophoros, rivestimento bianco dell’altare, muro orientale:– L’arriccio è di colore giallo come quello della pietra e ha uno spessore medio di circa
1 cm; presenta un’ottima compattezza e pori piccoli e di forma globulare per lo piùgeneratisi per evaporazione dell’acqua. È composto da una matrice di aspetto da col-
Lorenzo Lazzarini
142
loforme a micritico, e un aggregato abbondante (ca. 30%) e granulometricamenteomogeneo (arenaceo), costituito da una sabbia formata da singoli bioclasti (di alghecalcaree, echinidi, rotalidi ed altri microforaminiferi, ecc.) della biocalcarenite locale,e componenti detritici della medesima biocalcarenite (quarzo, anche policristallino,feldspato, rari individui di glauconite, biotite, clinopirosseno). I clasti carbonatici ditale sabbia sono ben arrotondati e con alto indice di sfericità, mentre quelli detritici,principalmente il quarzo, sono da angolosi ad arrotondati, con sfericità medio-alta.
– L’intonaco è formato da uno strato unico di colore bianco, molto compatto, con raripori globulari da bollosità e allungati (perpendicolari alla superficie esterna) da fes-surazione (fig. 12); ha uno spessore medio di 0,8 mm. È costituito da calcite pura diaspetto colloforme, con qualche raro clasto, sicuramente occasionale, di quarzo.L’adesione arriccio-intonaco è perfetta; due microfessure con andamento perpendi-
colare alla superficie (fig. 12) interessano sia la parte sommitale dell’arriccio che tuttol’intonaco, indicando che quest’ultimo è stato steso quando l’arriccio non era ancora deltutto essiccato.
Santuario della Malophoros, megaron, rivestimento bianco della parete interna del mu-ro settentrionale:– L’arriccio è del tutto simile a quello descritto sopra, salvo che per l’aspetto della matri-
ce che è più decisamente micritico (fig. 13). Lo spessore massimo misurato è di 8 mm.– L’intonaco è costituito da un solo strato di calce molto pura e compatta con poche
fessure perpendicolari alla superficie esterna, e una contenuta porosità di forma glo-bulare (da bollosità). L’aspetto microscopico generale è da colloforme a micritico,con molti individui singoli di microsparite (fig. 13) dispersi nella massa: questi deri-vano senz’altro dalla disgregazione di un calcare con grana da microsparitica a spari-tica, che si nota presente in pochi clasti di dimensioni massime attorno ai 0,4-0,5mm. Tali clasti presentano contorni da subangolosi (prevalenti) a subarrotondati esfericità media.L’adesione arriccio-intonaco è straordinariamente buona, anche qui indizio di una
stesura dell’intonaco quando l’arriccio era ancora parzialmente fresco.
Edificio Triolo Nord, rivestimento bianco della parete interna del muro settentrionale:Si è riscontrata la presenza di due strati di arriccio come segue
– Un primo strato di arriccio grossolano a contatto della pietra, spesso 6-7 mm, e for-mato da una matrice piuttosto porosa (con pori sia globulari che allungati) e di aspet-to colloforme, in cui è inglobato un aggregato composto da un sabbione costituito daclasti di granulometria da arenacea a microconglomeratica di biocalcarenite, biocla-sti algali e di rare altre rocce quali selce e calcare micritico.
– Un secondo strato di arriccio del tutto simile ai precedenti della Malophoros. Lospessore medio misurato è di 2 mm.
– Un intonaco dello spessore medio di 0,8 mm con discreta porosità formata da poriglobulari e raramente allungati. La calcite è da micrite a microsparite, come nell’in-tonaco precedente, con pochi clasti di identico calcare microsparitico (fig. 14) che ar-rivano a quasi 1 mm di dimensione massima; sono presenti pochi calcinaroli di pic-cole dimensioni.
Indagini archeometriche sugli intonaci dei templi di Selinunte
143
Altare dell’Edificio Triolo Nord, spesso rivestimento bianco d’angolo, già staccato, incorrispondenza del muro occidentale:
Questo rivestimento è risultato il più complesso, e il meglio conservato di tutti quelliesaminati. Avendo il campione interessato anche un frammento del substrato lapideo, èstato possibile risalire alla sua stratigrafia completa. Esso è composto da:– Un primo spesso strato (7 mm) di arriccio grossolano costituito da una malta abba-
stanza compatta con matrice di aspetto colloforme e un aggregato con addensamentodel 20-30% formato da un sabbione arenaceo di clasti biocalcarenitici e degli usualicomponenti detritici (con quarzo arrotondato che arriva sino a 1,8 mm di diametro),tutti ben arrotondati e con indice di sfericità medio-alto.
– Un secondo strato di arriccio del medesimo spessore, ma più raffinato e omogeneogranulometricamente (fig. 15), del tutto simile a quelli analoghi descritti sopra (nel-l’aggregato si sono notati, oltre ai soliti componenti, anche granuli di chert e di clino-pirosseno). L’adesione allo strato sottostante è buona.
– Uno strato di intonaco formato da calcite con aspetto da colloforme a microspariticocome sopra, ma con più radi clasti di calcare microsparitico (0,7 mm di dimensionemassima misurata) (figg. 15 e 16). Lo spessore medio sul lato dello spigolo dove l’in-tonaco è più spesso, è di 1,2 mm.
– Una rasatura (scialbatura di finitura) di calcite come sopra, ma con sole particelleisolate di microsparite, e uno spessore medio di 0,2 mm.
Ar ea archeologica dell’Acropoli
Tempio B, cella, muro orientale, frammento di solo arriccio:Lo spessore massimo conservato è di 3, 6 mm, la compattezza è buona, i pori sono
per lo più globulari. La matrice presenta aspetto da colloforme a micritico; l’aggregato ègranulometricamente omogeneo e della stessa quantità (addensamento) e composizionedegli arricci “raffinati” visti sopra.
Tempio B, intonaco bianco da un blocco del coronamento della cella (?) conservato nellapidario a Nord dell’antiquarium:– Arriccio con spessore massimo osservato di 2,8 mm, e caratteristiche del tutto simili
a quelle del muro della cella esaminato sopra.– Intonaco con spessore medio di 1,8 mm formato da calcite da colloforme a micritica
e microsparitica e da calcare disgregato, presente anche con qualche clasto.– Strato di intonachino dello spessore medio di 0,25 mm costituito da calcite pura, tan-
to fine da essere semiopaca.
Tempio B, frammentino di intonaco di colore azzurro del fregio (fig. 11) conservato nelMuseo Archeologico Regionale A. Salinas:
Una sezione stratigrafica del colore ha consentito di misurare lo spessore della pelli-cola pittorica, risultato di 0,6 mm, e di verificare che il pigmento è costituito da blueegi-ziano di ottima qualità (di notevole intensità cromatica) (fig. 17), ed è stato probabil-mente steso con la calce (pittura alla calce).
Lorenzo Lazzarini
144
Tempio D, intonaco bianco di un rocchio di colonna della peristasi meridionale:– Arriccio ‘raffinato’ come per i campioni precedenti. Lo spessore massimo misurato è
di 4 mm.– Tracce di intonaco composto da calcite micritico-microsparitica (la microsparite solo
in singoli cristallini, come nel campione precedente), con quarzo occasionale.
Ar ea archeologica della Collina Orientale
Tempio E 1, intonaco bianco prelevato da una colonna di E1 reimpiegata in E 2, muro 621:L’arriccio è stato solo in piccola parte interessato dal prelievo, e appare simile ai ‘raf-
finati’ precedenti.L’intonaco è costituito da uno strato unico dello spessore di 0,8 mm di sola calcite da
colloforme a micritica, passante localmente a microsparitica, quest’ultima associata agliusuali piccoli clasti calcarei (addensamento attorno al 5-10%). È piuttosto poroso per mi-crofessure isoparallele e perpendicolari alla superficie esterna, e mostra alcuni piccoli cal-cinaroli e clasti occasionali di quarzo e dei soliti microfossili della biocalcarenite locale.
Tempio E 1, intonaco bianco prelevato da un blocco di reimpiego nella fase E 3:L’arriccio è in un unico strato di spessore massimo (conservato nel campione) di 3, 6
mm: è identico ai ‘raffinati’ precedenti.L’intonaco è del tutto identico al precedente sulla colonna, salvo lo spessore medio,
che è superiore, e pari a 1,4 mm, e una quantità maggiore di clasti di calcare microspariti-co (10-20%), che in qualche individuo arriva a superare 1,5 mm di dimensione massima.
Tempio E 1, blocco del fregio del muro meridionale:Il prelievo ha interessato unicamente l’arriccio conservato, risultato dello spessore
massimo di 4 mm, e del tipo ‘raffinato’.
Tempio E 1, blocco del medesimo fregio dipinto di rosso (fig.), frammento di intonacocolorato di rosso:
L’arriccio è come quelli ‘raffinati’ visti sopra, con matrice costituita da calcite preva-lentemente micritica, ma anche a plaghe di tipo colloforme. Lo spessore massimo misu-rato è di 2,8 mm.
L’intonaco rosso è formato da un unico strato dello spessore medio attorno a 0,5 mm,composto da una matrice di calcite micritica in cui sono disperse abbondanti particelledi ocra rossa ematitica (fig. 18) impura per quarzo, plagioclasio e minerali argillosi(quest’ultimi sono stati verificati al SEM+EDS). Visto lo spessore dello strato e le carat-teristiche strutturali, l’intonaco è evidentemente costituito da una stesura (probabilmen-te a spatola) del colore mescolato con calce (pittura alla calce).
Tempio E 3, rocchio della VIII colonna (centrale) della peristasi meridionale, frammen-to di intonaco bianco:
L’arriccio è identico a quelli ‘raffinati’ visti sopra, lo spessore massimo prelevato èattorno ai 3,5 mm.
L’intonaco è molto spesso, mediamente attorno ai 3,6 mm, ed è composto da una ma-trice di micrite con abbondanti clasti di calcare (addensamento medio del 30% o supe-
Indagini archeometriche sugli intonaci dei templi di Selinunte
145
riore) come quello visto sopra, che qui appare anche biosparitico (fig. 19), mostrandobioclasti di rudiste (fig. 20), fossili tipicamente di età cretacica. Sopra questo strato èpresente una rasatura dello spessore medio di 0,6 mm di sola calcite micritica con pochiindividui microsparitici.
Tempio E 3, rocchio della I colonna da Est della peristasi settentrionale, frammento diintonaco bianco:
L’arriccio è identico ai ‘raffinati’ visti sopra, ma con meno aggregato, valutabile al20% circa. L’intonaco si è in buona parte consumato nella preparazione della sezionesottile; le tracce rimaste lo indicano come identico a quello del campione descritto im-mediatamente qui sopra.
Tempio E 3, due campioni da blocchi del geison (orientale ?) a terra di fronte alla casa deiguardiani, frammenti di intonaci, di cui uno azzurrino ricoperto da patina biancastra:
Il prelievo ha interessato solo una sottile porzione dell’arriccio, in ambedue i casi ri-sultato del tutto simile ai precedenti. L’intonaco è anch’esso del tipo con clasti di calcaree abbondanti individui microsparitici, quello azzurro con poco blueegiziano: il colore èstato dilavato e parzialmente sostituito da deposizione di calcite secondaria.
Tempio F, intonaco bianco su rocchio di colonna della peristasi meridionale:L’arriccio non è presente.
– Intonaco con spessore massimo osservato di 4,8 mm, mal conservato.
Conclusioni
Da quanto esposto nel paragrafo precedente, si possono fare delle considerazioni ge-nerali sulla intonacatura della pietra monumentale di Selinunte. Risulta innanzitutto unapersistenza per tempi lunghi, almeno dall’inizio del VI alla seconda metà del V sec. a.C.,nell’uso degli stessi materiali e di un’analoga tecnica nell’esecuzione dei rivestimentiparietali dell’architettura sacra, segno indubbio di lunghe ricerche e collaudate esperien-ze che portarono a veri e propri canoni operativi.
Nella maggior parte dei casi, infatti, i rivestimenti della pietra dei monumenti arcaiciselinuntini esaminati erano costituiti da uno strato di preparazione (arriccio) e uno di in-tonaco. Solo nell’edificio Triolo Norde relativo altare, si sono riscontrati due strati diarriccio, nell’altare anche due pertinenti a un intonaco e un intonachino/rasatura, que-st’ultimi presenti anche nel tempio B (e forse anche in altri edifici, ma scomparsi col de-terioramento totale delle rasature per il loro esiguo spessore originale).
È evidente che l’arriccio aveva lo scopo di regolarizzare la superficie della pietra la-vorata, e quindi di creare il supporto ideale per l’intonaco. Esso è risultato ottenuto conuna calce impura (con ogni probabilità ottenuta per calcinazione di calcareniti a granafine e più pure delle ordinarie, che ha formato una matrice giallina) mescolata a una sab-bia sicuramente di origine fluviale o di duna, nel primo caso, forse anche setacciata. Chetale sabbia abbia una simile origine è provato dalla totale assenza di clasti di conchigliemarine attuali (quali sono ancora presenti nella sabbia del litorale del lido di Marinella)e, che se fluviale sia stata setacciata è intuibile dalla notevole omogeneità granulometri-
Lorenzo Lazzarini
146
18 Secondo la MANZELLI 1994, 101-107, un’operazione sempre attuata nei confronti della policromia diopere plastiche.
19 Per le caratteristiche generali delle calci aeree si veda SHIELE-BERENS1976.20 L’abbondante frazione detritica delle biocalcareniti selinuntine fa sì che per la loro eventuale calci-
nazione si debba impiegare più tempo (e quindi più fuoco, e perciò costi maggiori), col risultato poi di otte-nere una calce notevolmente impura, oltretutto di colore beige, data la presenza non trascurabile in esse dicomposti del ferro.
21 COPPI-RIGO DE RIGHI 1955.
ca dei suoi clasti. Paleo-dune sono presenti proprio in corrispondenza della Gàggera, edesse possono ben aver fornito la sabbia per le malte degli arricci, come sembrerebbe in-dicare la presenza abbondante in esse di quarzo arrotondato di origine eolica. Ma anchele sabbie dell’Hypsas(fiume Cottone), o del Sèlino (Modione) possono essere statesfruttate per la preparazione di malte.
In un solo caso, nell’altare dell’edificio Triolo Nord, si è rilevata la presenza di unprimo strato di arriccio grezzo preparato mescolando alla calce di cui sopra un sabbionegrossolano, certamente non setacciato perché disomogeneo e contenente anche clastiplurimillimetrici di biocalcarenite.
Un dato importante risultato dalle indagini di laboratorio condotte sui rivestimenti se-linuntini, è la notevolissima compattezza degli strati di finitura (intonaco p.d. e rasatura),che si pensa si sia potuta ottenere solo grazie a ottime calci di partenza, e con la lavora-zione prolungata delle superfici con appositi ‘ferri’, e forse anche con la gànosis18 (dalverbo greco ganoo, lucidare), un trattamento superficiale con sostanze organiche (ad es.cera d’api mescolata a caldo con olio d’oliva) che serviva sì a lucidare, ma soprattutto aproteggere il colore delle superfici dipinte di statue e altri manufatti litici e litoidi.
Circa la qualità, essa va messa in relazione con una sofisticata tecnologia raggiuntanella fabbricazione della calce, in particolare con la purezza dei calcari di partenza e unlungo spegnimento della calce viva, fattori principali per l’ottenimento di ottime malte19.Poiché la calcarenite locale non è certo adatta alla produzione di buona calce20, tantome-no di calce bianca per la produzione di intonaci raffinati del tipo dei marmorini, penso sipossa senz’altro concludere che gli artigiani selinuntini si siano serviti dei calcari com-patti bianco-avorio e grigi del Lias-Oligocene di Contrada Magaggiari ma affioranti an-che in altre località della Val del Belice e sopra Menfi21. In particolare, la presenza di bio-clasti di rudiste accertata in un campione di intonaco del tempio E 3, indica con ragione-vole certezza l’uso di calcari cretacici per la fabbricazione della calce. Si pensa che questistessi calcari siano anche all’origine dell’aggregato bianco addizionato alla calce nellastesura degli intonaci per renderli del tutto simili a dei marmorini. Al proposito, si ritieneche si siano utilizzati i blocchetti non del tutto calcinati dalla cottura del calcare stesso;questi, ulteriormente sbiancati e parzialmente disgregati dalla calcinazione, erano ancoracarbonato di calcio (e pertanto non reattivi all’acqua), e si potevano facilmente disgregaremediante macinatura; la polvere grossolana che così si otteneva costituiva un ottimo ag-gregato per gli intonaci, e un sostituto a buon mercato del ben più costoso marmo maci-nato (il marmo, come è noto in Sicilia esiste solo in piccoli lembi dei Peloritani, che co-munque sembra non siano stati sfruttati in antico). Prova diretta di questo uso è l’abbon-dante presenza di particelle di microsparite nella maggioranza degli intonaci selinuntini.
Circa la lavorazione, è evidente che in più casi gli strati di finitura di calce sono stati
Indagini archeometriche sugli intonaci dei templi di Selinunte
147
22 MORA et alii 1984, 63 sgg.23 PATINE 2005, Convegno di Firenze.24 La weddellite è un ossalato di calcio biidrato componente abituale delle patine dei monumenti anti-
chi che si può formare sia per l’azione di licheni che per mineralizzazione di sostanze organiche usate co-me legante di policromie o come protettivi: sulla loro genesi LAZZARINI -SALVADORI 1989, 20-25; sul signi-ficato per i vari materiali artistici, PATINE 2005.
25 Presenza di pittura alla calce è stata verificata anche in stele della Tessaglia, e da Alessandria d’Egit-to e Sidone ora nel Museo Archeologico di Istanbul (MORA et alii 1984, 87).
stesi su arricci ancora non del tutto essiccati, e ciò per favorire l’impregnazione dei duestrati da parte del latte di calce (idrossido di calcio in soluzione) dell’intonaco che cosìne migliorava l’adesione reciproca. Tale adesione, e la compattezza degli intonaci/into-nachini, si pensa siano anche il risultato di loro trattamenti superficiali, ad es. di premi-tura e lisciatura con appositi strumenti. È stato infatti provato da saggi sperimentali ten-denti a confermare la tecnica a buon fresco (e non a encausto) dei dipinti murali roma-ni22, che premendo attrezzi metallici o lapidei (del tipo dei ‘brunitoi’in pietre dure usatiancora adesso nella doratura a foglia) su una malta di calce ‘in tiro’, si richiama latte dicalce verso la superficie che, trasformandosi in carbonato di calcio dopo carbonatazio-ne, va a occludere i pori e a produrre una migliore compattazione della malta stessa (euna fissazione di più pennellate di colore nel caso dei dipinti). Una certa isorientazione eparallelismo con la superficie esterna osservata nei clasti di calcare di forma più allun-gata indicherebbe che tale lavorazione può essere stata adottata anche a Selinunte.
Per quanto riguarda la gànosis, la sua effettiva applicazione si ritiene impossibile daprovare, anche con le più sofisticate analisi strumentali ora disponibili, per la scarsa per-sistenza nel tempo delle sostanze organiche e delle loro proprietà23. Essendo però essa,come ci dicono le fonti antiche, pratica corrente, si può pensare fosse messa in opera an-che sulle estese superfici degli edifici. La presenza di weddellite in un intonaco del tem-pio E 3 potrebbe essere proprio dovuta a una mineralizzazione di sostanze organichedella gànosis24.
Da sottolineare ancora, l’uso di una tecnica di ‘pittura alla calce’per gli intonaci co-lorati (dei templi E e B): questa ha assicurato una buona durevolezza al colore, ed è pro-babile sia stata la tecnica usata per dipingere anche le metope dei vari templi selinunti-ni25, alcune delle quali ancora conservano tracce della policromia originale. La persi-stenza dopo oltre due millenni di tracce, talora estese, di intonaci, anche in un ambienteaggressivo come quello marino di Selinunte, evidenzia l’alto livello tecnologico rag-giunto dalle maestranze selinuntine cui si può senz’altro attribuire, anche per questo ba-gaglio di conoscenze materiali, una straordinaria cultura architettonica.
Bibliografia
BREKOULAKI 2001: H. BREKOULAKI , L’esperienza del colore nella pittura funeraria dell’Italiapreromana, V-III secolo a.C., Napoli 2001, 11-70.
CAMPISI 1987: M. CAMPISI, L’evidenza archeologica: l’architettura, in I colori perduti, la poli-cromia nell’architettura e nella scultura classica, a cura di A. MELUCCOVACCARO, Dossier diArcheo, 29, 1987, 25-43.
Lorenzo Lazzarini
148
CARAPEZZA et alii 1983: M. CARAPEZZA, R. ALAIMO , S.CALDERONE, M. LEONE, I materiali el’ambiente delle sculture di Selinunte, in V. TUSA, La scultura in pietra di Selinunte, Palermo1983, 32-41.
COLOMBINI et alii 2001: M.P. COLOMBINI, F. MODUGNO, S. FRANCESCONI, Caratterizzazione di le-ganti proteici e lipidici in campioni di policromie antiche, in H. BREKOULAKI, L’esperienza delcolore nella pittura funeraria dell’Italia preromana, V-III secolo a.C., Napoli 2001, 72-75.
Colori del bianco: I colori del bianco. Policromia nella scultura antica, Roma 2004.
CONTI 1996: M.C. CONTI, Componenti strutturali e caratteristiche tecniche delle “piccole meto-pe”selinuntine, in M.C. CONTI, S. PIRO, L. VERSINO, C. ZOPPI, Selinunte. 3, Roma 1996, 7-58.
COPPI-RIGO DE RIGHI 1955: L. COPPI, M.M. RIGO DE RIGHI, Carta Geologica d’Italia 1:100.000,Foglio 265, Mazara del Vallo, Roma 1955.
GORGONIet alii 1992: C. GORGONI, L. LAZZARINI , O. SALVADORI, Minero-geochemical transfor-mations induced by lichens in the biocalcarenite of the Selinuntine monuments, in The dete-rioration and conservation of stone. Proc. of the 7th Int. Congr., I, ed. by J. DELGADO RODRI-GUES, F. HENRIQUES, F. TELMO JEREMIAS, Lisbon 1992, 531-539.
GORGONIet alii 1993: C. GORGONI, M.L. AMADORI, L. LAZZARINI , P. PALLANTE , Risultati dell’in-dagine micropaleontologica, minero-petrografica e geochimica preliminare sui materiali la-pidei (calcari e marmi) dell’insediamento greco di Selinunte, in C. GORGONI, M.L. AMADORI,L. LAZZARINI , P. PALLANTE , S. PIRO, L. VERSINO, C. ZOPPI, Selinunte. 1, Roma 1993, 33-59.
GORGONI-PALLANTE 2000: C. GORGONI, P. PALLANTE , Cycladic marbles used in the Greek andPhoenician colonies of Sicily, in Paria Lithos, ed. byD. SCHILARDI , D. KATSONOUPOULOU,Athens 2000, 497-506.
GULLINI 1985: G. GULLINI , L’architettura, in Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia greca, Milano1985.
HEIN 1990: U.F. HEIN, Geologische und petrographische Merkmalsmuster antiker Baustoffe Se-linunts und seiner Steinbrüche, in A. PESCHLOWBINDOKAT, Die Steinbrüche von Selinunt. DieCave di Cusa und die Cave di Barone, Mainz am Rhein 1990, 45-66.
HITTORF1851: J.J. HITTORF, La restitution du temple d’Empédocle à Sélinonte ou l’architecturepolychrome chez les Grecs, Paris 1851.
LAZZARINI 2001: L. LAZZARINI , Uno studio del colore e di altri materiali componenti, inH.BREKOULAKI, L’esperienza del colore nella pittura funeraria dell’Italia preromana, V-IIIsecolo a.C., Napoli 2001, 76-98.
LAZZARINI -SALVADORI 1989: L. LAZZARINI , O. SALVADORI, A reassessment of the formation of thepatina called scialbatura, Studies in Conservation, 34, 1989, 20-25.
MANZELLI 1994: V. MANZELLI , La policromia nella statuaria greca arcaica, Roma 1994.
MARAVELAKI et alii 2003: P. MARAVELAKI KALAIZAKI , A. BAKOLAS, A. MOROPOULOU, Physico-chemical study of Cretan ancient mortars, Cement and Concrete, 35, 2003, 651-661.
MARCONI 1994: C. MARCONI, Selinunte. Le metope dell’Heraion, Modena 1994.
MARTENS1996: D. MARTENS, L’architettura del mondo greco d’Occidente, in I Greci in Occi-dentea cura di G. PUGLIESECARATELLI, Monza 1996, 315-346.
Indagini archeometriche sugli intonaci dei templi di Selinunte
149
MASCLE 1970: G. H. MASCLE, Geological sketch of Western Sicily, in Geology and history of Si-cily, ed. by W. ALVAREZ, K.H.A. GOHRBANDT, Tripoli 1970, 231-243.
MELUCCOVACCARO 1985: A. MELUCCOVACCARO, La policromia nell’architettura e nella plasti-ca antica: stato della questione, Ricerche di Storia dell’Arte, 24, 1985.
MELUCCOVACCARO 1987: A. MELUCCOVACCARO, L’antichità a colori o in bianco e nero?, in Icolori perduti, la policromia nell’architettura e nella scultura classica, a cura di A. MELUCCO
VACCARO, Dossier di Archeo, 29, 1987, 25-43.
MORAet alii 1984: P. MORA, L. MORA, P. PHILIPPOT, Conservation of wall paintings, London 1984.
NORMAL 1983: NORMAL-12/83, Aggregati artificiali di clasti e matrice legante non argillosa:schema di descrizione, Roma 1983.
PARISI PRESICCE1984: C. PARISI PRESICCE, Edificio “Triolo Nord” , Sicilia Archeologica, XVII,54-55, 1984, 29-38.
PARISI PRESICCE1986: C. PARISI PRESICCE, Edificio “Triolo Nord” , Sicilia Archeologica, XIX,60-61, 1986, 23-53.
PATINE 2005: Le Patine. Genesi, significato, conservazione. Atti del Workshop,a cura di P. TIA-NO, C. PARDINI, Firenze 2005.
PESCHLOWBINDOKAT 1990: A. PESCHLOWBINDOKAT, Die Steinbrüche von Selinunt. Die Cave diCusa und die Cave di Barone, Mainz am Rhein, 1990, 9-44.
SCHIELE-BERENS1976: E. SCHIELE, L.W. BERENS, La calce - calcare, calce viva, idrato di calcio- fabbricazione, caratteristiche, impiego, Milano 1976.
TUSA 1983:V. TUSA, La scultura in pietra di Selinunte, Palermo 1983.
Fig. 1. Le superstiti tracce di intonaci bianchi sulla parete interna del muro settentrionale del megarondella Malophoros.
Lorenzo Lazzarini
150
Fig. 2. L’intonaco bianco dell’altare di fronte al megarondella Malophoros.
Fig. 3. Come in fig. 1, ma dell’edificio Triolo Nord.
Indagini archeometriche sugli intonaci dei templi di Selinunte
151
Fig. 4. Come in fig. 2, ma dell’edificio Triolo Nord.
Fig. 4bis. Macrografia di una sezione tra-sversale dell’intonaco di cui alla fig. 4.
Lorenzo Lazzarini
152
Fig. 5. Gli estesi resti di intonaco rosso del muro orientale (della cella ?) del tempio B.
Fig. 6. Tracce dell’intonaco bianco originale su un rocchio di colonna della peristasi Sud del tempio D.
Indagini archeometriche sugli intonaci dei templi di Selinunte
153
Fig. 7. Alcune delle colonne della peristasi Norddel tempio E con abbondanti tracce di intonaca-tura bianca.
Fig. 8. Particolare di una delle colonne di cui allafig. 7.
Fig. 9. L’intonaco rosso di un blocco dell’archi-trave del frontone Est del tempio E.
Fig. 10. I resti dell’intonaco bianco originale suun rocchio di colonna del tempio F.
Lorenzo Lazzarini
154
Fig. 11. Frammenti del fregio del tempio B nel Mu-seo Archeologico Regionale A. Salinas di Palermo.
Fig. 12. Riv. altare Malophoros, micrografia in lu-ce trasmessa della sez. sott. mostrante a sx partedell’arriccio, e a dx l’intonaco, ambedue interes-sati da microfessure da essiccamento. N //, 60 X.
Indagini archeometriche sugli intonaci dei templi di Selinunte
155
Fig. 13. Riv. muro del megaron Malophoros, comein fig. 12, ma a N + e a 30 X, mostra meglio la mi-crosparite dispersa nella micrite dell’intonaco.
Fig. 14. Riv. muro ed. Triolo Nord, come in fig.12, ma N + con clasti di calcare microsparitico inmatrice micritica con microsparite diffusa.
Lorenzo Lazzarini
156
Fig. 15. Riv. muro altare Triolo Nord, come in fig.13, arriccio (a sx) con abbondante quarzo, e into-naco (a dx) con microsparite diffusa e pochi clastidi calcare.
Fig. 16. Particolare di fig. 15 a 60 X, mostrante iclasti di calcare microsparitico.
Indagini archeometriche sugli intonaci dei templi di Selinunte
157
Fig. 17. Riv. azzurro del tempio B, micrografia inluce riflessa polarizzata a 160 X della sez. lucidaevidenziante le particelle di bleuegiziano in unamatrice calcitica.
Fig. 18. Riv. rosso del tempio E, come in fig. 17,ma a 120 X; mostra lo strato di stucco rosso colo-rato da ocra ematitica.
Lorenzo Lazzarini
158
Fig. 19. Riv. bianco del tempio E 3, come in fig.13, mostra lo spesso intonaco con abbondante ag-gregato di clasti bio-micritici/sparitici e, in alto, lasottile rasatura di sola calce.
Fig. 20. Particolare della fig. 19 a 120 X, eviden-ziante bioclasti di rudista con guscio ‘seghettato’.