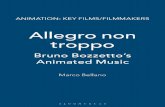"L'ornamento de marmi" della cappella Franzone- M. BRUNO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of "L'ornamento de marmi" della cappella Franzone- M. BRUNO
71
“L’ornamento de marmi” della cappella FranzoneMariangela Bruno
Gli occhi dei genovesi hanno sempre individuato nella cappella del Cro-cifisso della chiesa intitolata ai Santi Vittore e Carlo un elemento estraneo alla propria cultura, riferendo il suo aspetto all’ambito romano: così gli scrittori locali del XVIII e XIX secolo, Carlo Giuseppe Ratti e Federigo Ali-zeri, mettevano in evidenza la matrice forestiera di questo spazio sacro. Il primo sottolineava come la “cappella de i Signori Franzoni magnificamen-te architettata di marmo bardiglio con disegno dell’Algardi, ha un Croci-fisso, e dodici busti di santi, il tutto gittato, e lavorato in bronzo dall’istesso celebre autore, di cui son anche i depositi con busti in marmo del Cardinale Giacomo Franzoni, che la fece fabbricare, e di Agostino fratello di lui”1; an-che l’erudito ottocentesco ricordava il “disegno, la distribuzione, e quanto v’ha di bronzi e di scultura in marmo” come opera di Alessandro Algardi2. Si deve inoltre riferire quanto riportato da Giuseppe Odoardo Corazzini nel 1873, il quale ebbe modo di consultare la documentazione conservata nell’archivio della famiglia Franzone: “È costruita di bardiglio, decorata di sculture in bronzo ed in marmo bianco; giudizioso accozzamento del bian-co e del nero, funerei colori, che meravigliosamente conviene al fine cui fu destinata, di servire cioè di sepolcro gentilizio. Al bolognese Alessandro Algardi, celebre alunno di Lodovico Caracci, devesi il disegno, la distribu-zione e le sculture di questa magnifica cappella”3.Questi eruditi erano concordi nel riferire l’ideazione dell’insieme e dei singoli manufatti scultorei ad Algardi e nel ritenere nota caratterizzante della cappella l’utilizzo del marmo bardiglio: scelta cromatica, questa, assai rara nella produzione altaristica coeva locale, che andava intenzio-nalmente a definire, come osservato da Corazzini, la cappella Franzone in tono funereo4.In continuità con tale tradizione letteraria, anche gli studiosi moderni han-no indicato il sacello Franzone come un esempio di barocco romano in cit-tà: Rudolph Wittkower infatti nel 1958 notava come “l’influsso del barocco romano giunse per la prima volta a Genova attraverso il lavoro dell’Algardi per la Cappella Franzoni in San Carlo”5. Effettivamente la serie dei busti di santi (tavv. VIIa-XII) e il Crocifisso (tavv. IV-VI), collocati in due momenti distinti presso l’altare Franzone6, rappresentano un raffinato esempio della cultura romana, e più precisamente de l’altra faccia del barocco, che faceva capo ad Algardi e alla sua bottega.Se il tono romano deriva, come condivisibilmente precisava Wittkower, dal “lavoro dell’Algardi”, ovvero i bronzi inseriti nel sacello – riconosciuti da Lauro Magnani come una coerente affermazione del gusto collezionistico
7372
“L’ornamento de marmi” della cappella FranzoneMariangela Bruno
1. Scultore della metà del XVI secolo, Ritratto di Giacomo Franzone, Genova, chiesa di Santa Maria di Castello, in deposito presso la Biblioteca Franzoniana.
a proprie spese, in solido con i fratelli e lo zio paterno Agostino, acquistò da Anna Lomellini per £. 6500 un bosco situato sulle alture di Genova, che donò successivamente agli eremiti camaldolesi a condizione di farvi co-struire un romitorio e una chiesa. I Franzone per parte loro si impegnavano a erigere il coro e l’altare maggiore dell’edificio religioso, di cui ottennero anche il giuspatronato18: in questo luogo Gaspare volle essere seppellito, come disposto nelle sue ultime volontà, redatte durante la terribile epi-demia di peste che flagellò Genova tra il 1656 e il 165719. L’impegno dei membri del casato nel finanziare tale operazione era stato probabilmente indirizzato dal desiderio di riservarsi l’area presbiteriale come luogo di se-poltura. Con la morte di Gaspare Franzone e di suo figlio Anfrano Mattia veniva meno l’interesse della famiglia per questo sito, forse determinato da qualche contrasto con i religiosi per la stretta osservanza delle indicazio-ni borromaiche, che scoraggiavano l’inserimento delle insegne gentilizie negli edifici sacri, in particolare in prossimità della zona dell’altare mag-giore. Ciò troverebbe conferma nel testamento di Gaspare in cui il nobile stabiliva un lascito ai camaldolesi affinché fosse recitata una messa perpe-tua “all’altare maggiore del choro di detta chiesa fondata per essi signori, quando però essi padri mostrino verso mia casa maggiore gratitudine”20.Un’altra ipotesi percorribile vedrebbe affievolirsi l’attenzione di alcune personalità del casato per questa iniziativa, per via della collocazione peri-ferica del sito. Infatti già Agostino, fratello di Anfrano, nel suo testamento manifestava la volontà di edificare una nuova cappella in una chiesa ge-novese; nel contempo disponeva che il suo cadavere fosse seppellito in un monumento fatto innalzare nella chiesa di San Teodoro a Fassolo, dove fu effettivamente deposto nel 165821. Con la morte dello zio Agostino, dei fratelli maggiori, Gaspare (1657) e Tommaso (1656), e con Giacomo im-pegnato nella carriera ecclesiastica a Roma, Agostino Franzone fece suo il progetto dinastico di creare una tomba per il proprio casato. Si deve pro-prio a tale figura la decisione di inserire il sepolcreto di famiglia all’inter-
della famiglia Franzone7 –, la dimensione della cappella, “magnificamente architettata”8 in maniera monumentale e grandiosa, deve essere riferita alla sua partitura architettonica: nella visione frontale l’altare ricalca i prototipi diffusi dalla trattatistica cinquecentesca, già adottati nella produzione alta-ristica locale nel XVI secolo9. Quindi più che di un elemento architettoni-co originale, progettato ad hoc per lo spazio di questa chiesa, tale struttura deve essere interpretata pertanto come la traduzione tridimensionale di una pagina di trattato, adattata alle proporzioni del sito10. Questa artico-lazione spaziale era stata probabilmente pensata e predisposta per il solo Crocifisso bronzeo e soltanto in un secondo momento furono inseriti i dodi-ci busti, alterando così l’originario rapporto tra l’impaginato architettonico e l’elemento scultoreo.L’individuazione dello spazio entro la chiesa carmelitana in Strada Balbi non fu però così immediata. Sembra utile fare una digressione su come si giunse alla scelta di questo sito per comprendere quanto fosse sentita da parte dei Franzone la ricerca di un luogo dove far sorgere il sacello del ca-sato. La questione se la pose già il capofamiglia Anfrano Franzone († 1621), quando nelle sue ultime volontà espresse il desiderio di essere sepolto in una cappella, da far erigere, insieme al fratello Agostino (1573-1658) o in un altare che avrebbero fondato i suoi figli in qualche chiesa cittadina. Nel caso fosse stato impossibile attuare tali ipotesi, egli stabiliva che il suo cor-po dovesse essere tumulato nella tomba posta nella chiesa dell’ordine do-menicano intitolata a Santa Maria di Castello, dove erano custodite le spo-glie degli antenati11. I vari membri della famiglia agirono quindi per trovare uno spazio appropriato a tale funzione e Gaspare († 1657), primogenito di Anfrano, cercò un luogo dove far sorgere una nuova cappella che potes-se affiancare o sostituire quella nel complesso domenicano. Quest’ultimo ambiente, una camera sepolcrale posta sotto la sacrestia della chiesa, rima-se in realtà un punto di riferimento costante per i membri di casa Franzone, tanto che alcuni di loro vi si fecero seppellire ancora nel corso del XVII e XVIII secolo12. Inoltre nel 1671 l’affetto verso le memorie degli avi portò a un ‘restauro’ di questo spazio, come sembrerebbero attestare due lapidi così datate13 che riportano i nomi dei fratelli Agostino (1614-1705), Giaco-mo (1612-1697), Paolo Girolamo († 1704) e dei nipoti di questi, Anfrano Mattia (1646-1679), Stefano (1648-1719) e Tommaso († 1710)14. Di questo sacello gentilizio si hanno poche notizie. Così lo descrive Rai-mondo Amedeo Vigna nel 1864: “vi rinvenni parecchie casse di cadaveri, una intatta, altre scoperte e poste alla rinfusa”15. Rimane un busto in mar-mo bianco ricordato dallo stesso Vigna entro una nicchia posta sulla porta che dava accesso al coro della chiesa, che l’erudito riteneva un ritratto del cardinale Giacomo, mentre Corazzini metteva in discussione tale identifi-cazione rilevando la mancata somiglianza con le effigi del prelato16. Il busto (fig. 1), che a parere di chi scrive è opera di uno scultore attivo alla metà del XVI secolo, raffigurerebbe più verosimilmente l’antenato omonimo dell’il-lustre cardinale che nel 1523 aveva fondato proprio il sepolcro all’interno degli spazi di Santa Maria di Castello17.Nel 1637 Gaspare Franzone, in osservanza dei desideri del padre Anfrano,
7574
“L’ornamento de marmi” della cappella FranzoneMariangela Bruno
pegnò come si è visto a mantenere l’intitolazione dell’altare al Crocifisso, e statuì che al di sopra della mensa eucaristica avrebbe fatto disporre il Cristo bronzeo di Algardi. Il fatto che in questa occasione non si faccia riferimento agli altri busti o al disegno del sacello, sembrerebbe indicare che le dodici opere bronzee non fossero ancora in possesso del patrizio genovese e che l’elaborato grafico non fosse il frutto di una progettazio-ne algardiana, come altrimenti sarebbe stato opportunamente precisato nell’atto33; ciò sembrerebbe plausibile, nonostante quanto riferito dal ben informato Corazzini e sostenuto in un primo momento da Mario Labò, che pure quando scriveva i suoi fondamentali contributi aveva ancora a disposizione l’archivio parrocchiale della chiesa34.Un mese dopo i patti stretti con i religiosi si formalizzò, presso la casa di Agostino Franzone posta in salita San Francesco, il contratto con Gio-vanni Battista Casella (1627-1678)35 “per fare l’ornamento de marmi alla capella”36. Il capitolato dei lavori, suddiviso in dodici punti, indirizzava scrupolosamente l’azione dello scultore che doveva tradurre entro la zona del transetto destro dell’allora chiesa di San Carlo il “disegno e Profilo” della cappella, presentati alla stipula del contratto e firmati da entrambe le parti. In tali elaborati erano riportate le misure di ogni singolo elemento dell’architettura prevista: i piedistalli, caratterizzati dall’arma di casa Fran-zone, le colonne, i capitelli, gli architravi e la “bardella”, ossia balaustra, che doveva essere sollevata e circondata da due scalini, “nella conformittà del disegno ossia Proffilo, detti gradi e Bardella se convenisse farsi scon-tonarla nelli canti in forma d’Ottangulara sia in elettione dell’Illustrissimo signor Agostino Franzone”. Tra i lavori affidati a Casella era previsto anche il rivestimento delle pareti laterali del vano della cappella. Il tutto doveva essere realizzato entro diciotto mesi con marmo bardiglio di Carrara dal colore uniforme.L’attenta regia del committente emerge anche nel riservarsi il diritto di poter scegliere la forma della balaustra e apportare dei cambiamenti al progetto in corso d’opera, sotto però la supervisione del responsabile del cantiere l’architetto Matteo Lagomaggiore, che avrebbe dovuto valutare la fattibilità e i costi aggiuntivi.I documenti chiariscono pertanto come a Giovanni Battista Casella spet-tasse un ruolo di mero esecutore: in effetti tradusse semplicemente nel marmo bardiglio le componenti architettoniche tracciate negli elaborati grafici quotati, che illustravano la visione frontale e il profilo della cappella; inoltre nell’accurata capitolatione predisposta nell’accordo siglato nel mag-gio 1677, era specificato che il progetto era fornito dallo stesso committen-te che gelosamente lo custodiva presso di sé37.Rispetto alla produzione locale coeva, Agostino Franzone decideva di ca-ratterizzare il sacello della propria famiglia con una struttura architettonica semplice e sobria, priva della qualità dinamica e decorativa che andava per la maggiore nel contesto genovese e che prevedeva, oltre all’impiego di marmo bianco, l’uso di un vasto campionario di pietre policrome adope-rate a simulare quegli apparati tessili, che durante le ricorrenze religiose fasciavano le colonne e le altre partiture degli altari. La scelta del commit-
no della chiesa di San Carlo, nella cappella posta nel transetto destro del tempio carmelitano22. Questa scelta manifestava la chiara volontà di pre-disporre un ambiente che avrebbe dovuto essere un unicum nel contesto locale; inoltre il favore verso tale sito era stato incoraggiato dallo stesso ordine religioso, che aveva dimostrato una piena disponibilità a concedere il giuspatronato al nobile sin dal dicembre 167623. Erano trascorsi più di una ventina di anni da quando Agostino, come rife-rito dalle fonti pressoché coeve, Filippo Baldinucci e Giovanni Pietro Bel-lori24, aveva acquistato durante la sua permanenza a Roma, entro il 1654, anno della morte di Algardi, il bellissimo Crocifisso algardiano25. Le sue di-mensioni indicavano una destinazione più consona a un altare entro una chiesa, piuttosto di una collocazione entro una cappella domestica dalla spazialità più contenuta.Sono questi gli anni in cui i Franzone stavano perfezionando l’acquisizione del giuspatronato dell’area presbiteriale della chiesa camaldolese intitolata a Santa Tecla26. Poiché Gaspare Franzone, fratello maggiore di Agostino, in punto di morte chiedeva di essere “sepelito nel coro che di presente si fabrica nel eremo de padri Camaldoli dalla sua casa fondato”27, si potrebbe postulare che il Crocifisso fosse in un primo momento destinato a quella sede. Purtroppo la documentazione a nostra disposizione per ora non con-sente di andare oltre l’ipotesi qui preliminarmente proposta; si può però annotare che la famiglia negli anni dell’acquisizione del capolavoro algar-diano non aveva ancora individuato uno spazio altro, rispetto a quello di Santa Maria di Castello, da eleggere come nuovo sepolcro.In effetti la cappella entro la chiesa di San Carlo fu eretta idealmente intor-no al Cristo bronzeo di Alessandro Algardi, un soggetto che corrispondeva peraltro all’intitolazione dell’altare, dedicato al Crocifisso, concesso dai pa-dri carmelitani al nobile genovese28. Sta di fatto che dopo una serie di deli-bere del capitolo dei religiosi, nell’aprile 1677 venne formalizzato davanti a un notaio un accordo attraverso il quale Agostino acquisì il giuspatronato della cappella nel transetto destro della chiesa29. Il patrizio fece inoltre pre-cisare nell’atto che avrebbe fatto esporre sull’altare alla pubblica adorazio-ne il simulacro del Crocifisso, “staturae supranaturalis, insigne opus equitis Alexandri Algardi Bononiensis”. Pur essendo uno spazio che nasceva per l’iniziativa di una precisa personalità, la cappella fu pensata – come dichiara anche la lastra terragna datata 1680 – come sacello di Agostino e dei suoi eredi e in effetti il nipote Anfrano Mattia nel suo testamento del 5 aprile 1679 espresse il desiderio che il suo corpo fosse tumulato nella sepoltura di Santa Maria di Castello oppure “se così parrà al signore Agostino mio signor zio deposto nella capella fatta accomodare, e fabricare ultimamente”30.Occorre a questo punto ripercorrere la scansione cronologica degli in-terventi che hanno condotto la cappella Franzone alla sua definizione nonché al suo compimento, partendo da quanto chiarito da Mario Labò nei suoi scritti, attraverso i quali è infatti possibile definire e ordinare temporalmente le fasi iniziali della costruzione del sacello in San Car-lo31. Quando nell’accordo dell’aprile 167732 Agostino Franzone ottenne il giuspatronato della cappella dai padri carmelitani di San Carlo, si im-
7776
“L’ornamento de marmi” della cappella FranzoneMariangela Bruno
verde Polcevera, rimasti in San Carlo e acquisiti anche questi dallo stesso Garvo. Nella somma pagata da quest’ultimo ad Agostino era inoltre “com-preso il porto di esso [marmo] dalla bottega a S. Carlo et la tavola e’ fattura del modello per la balaustrata et come sia concha”. Quindi al Garvo si deve la messa in opera dei marmi già lavorati da Casella e la realizzazione della balaustra. Molto probabilmente in occasione della conclusione di questa tranche di lavori Agostino Franzone fece issare il Cristo bronzeo algardiano e quindi porre davanti alla cappella la lastra terragna, ancora in loco, che reca la seguente scritta: AUGUSTINUS FRANSONUS QUONDAM IL-LUSTRISSIMI ANFRANI SIBI SUISQUE HAEREDIBUS POSUIT ANNO SALUTIS MDCLXXX.Nel 1680 l’altare era quindi composto nel suo alzato, doveva però anco-ra essere perfezionato il prospetto frontale dell’intera cappella. Così per la decorazione delle porzioni poste ai lati delle monumentali colonne in marmo bardiglio Agostino convocò presso la sua dimora un artista pro-venzale di nascita, ma genovese per scelta di vita: Honoré Pellé (1641-1718). Nell’atto notarile del 22 novembre 168243 si dichiaravano le inten-zioni del committente desideroso di “aggiongere qualche lavori di Marmo Bardiglio alla sua Capella del Crocifiso”; tale intervento, da eseguirsi entro cinque mesi, era pensato come un cortinaggio che si apriva per rivelare e mostrare gli elementi della Passio Christi, proporzionati nelle loro misure alla scala monumentale proposta nell’ordine architettonico dell’altare; le dimensioni dei due pezzi di bardiglio da cui ricavare tali soggetti erano in effetti imponenti: alti 21 (520 cm) e larghi 5 palmi genovesi (123,9 cm). Come tutti i contratti, questo documento riporta quanto avevano già sta-bilito i contraenti a voce e fissa per iscritto le puntigliose richieste di Ago-stino. Questi si mostrava particolarmente scrupoloso nel definire modi e forme della realizzazione richiesta: come già in precedenza con Giovanni Battista Casella, cercò infatti di indirizzare l’azione dell’artista attraverso una serie di clausole inerenti gli aspetti tecnici, le tempistiche e la suddi-visione delle spese.Lo scultore avrebbe quindi dovuto intagliare per l’esigente Franzone due “modiglioni”, ovvero le mensole da posizionare nella parte inferiore dell’altare sopra i basamenti ai lati delle colonne, e i rilievi raffiguranti i misteri della Passione di Cristo con i due “festoni per il finimento di sopra”. Tutti questi elementi dovevano essere scolpiti nel marmo bardiglio, che il committente avrebbe fornito all’artista, così come precisato nella stipula contrattuale. Sempre Franzone avrebbe messo a disposizione i modelli in cera44 da cui poter cavare tutti i soggetti; malauguratamente non è preci-sato l’autore di questi manufatti: lo stesso Pellé? Ma forse in questo caso sarebbe stato precisato. Oppure Agostino li aveva richiesti a un altro artista di sua fiducia?Sicuramente, in virtù della predilezione del nobile per gli elementi scultorei e in particolare per quei manufatti che ne attestavano l’iter creativo, tali opere entrarono a far parte della sua collezione, come sembra certificare il fatto che tali modelli fossero “improntati col sigillo di detto illustrissimo signor Agostino”. Ricevute le cere, Pellé si impegnava a tenerle presso di sé
tente andava quindi a emendare ogni orpello decorativo, dagli elementi di ornato alle figure abitualmente inserite a coronamento del timpano, che invece si riscontrano in altre strutture altaristiche realizzate ad esempio dallo stesso Casella. Quest’ultimo operava solitamente in società con altri maestri per armonizzare i diversi aspetti del manufatto: la quadratura, l’or-nato e l’elemento figurato, come ben esemplifica l’altare maggiore condot-to per la chiesa di Santa Teresa a Savona – oggi collocato nel transetto della cattedrale savonese –, che l’artista realizzò in società con Gio. Giacomo della Porta entro il 166438.La decisione di Agostino nel qualificare tale sito come luogo di sepoltura lo spinse quindi a privilegiare l’impiego di marmo bardiglio per il rivestimen-to di tutta la cappella. Questo materiale, perlopiù in uso nell’edilizia per realizzare singoli elementi architettonici o per il rivestimento di pavimenti e adoperato limitatamente per ambiti artistici, evidenzia la volontà di far apparire tale altare, sull’esempio degli apparati effimeri approntati per le esequie funebri, come un baldacchino da catafalco39.Alcuni elementi emersi nel corso di recenti ricerche consentono di aggior-nare le scansioni temporali fino ad ora note per i lavori nella cappella del Crocifisso e di maturare nuove considerazioni. Anfrano Mattia Franzone nel suo testamento attestava come la cappella fosse stata da poco ultimata: il cantiere in realtà dopo la morte di Giovanni Battista Casella, avvenuta il 12 novembre 1678, aveva subito una battuta d’arresto e nel corso dell’anno seguente i lavori erano stati riavviati, ma non terminati40.Da una testimonianza del marmoraro Giacomo Garvo (1625-1697)41, resa nel 168542 su istanza di Daniele Casella, si traggono alcune informazio-ni: “Havendo l’anni passati l’Illustrissimo signor Agostino Franzone fatto fabricare una capella nella Chiesa di S. Carlo dei Padri Carmelitani scalzi di questa città fatta adornare di marmi e datane l’incombenza a maestro Gio. Batta Cazella il quale prima di terminare detta fabrica se ne morse”. Nello stesso documento anche Lazzaro Vivaldi, servitore di Agostino Fran-zone, rende una dichiarazione su quella circostanza, precisando come alla scomparsa di Giovanni Battista “restorno per conto di sua eredità, et eredi quantità di marmi bardigli che haveva prontato per ornamento di detta cappella, e perché il detto illustrissimo signor Agostino restava creditore di detto quondam Gio. Batta di maggior somma so’, che ritenne appresso di se detti marmi”. Dalle affermazioni dei testimoni della vicenda si desume pertanto che Casella era morto prima di condurre a termine il lavoro, il materiale lapideo già scolpito era in attesa di essere assemblato e messo in opera e che il committente, avendo versato una somma di denaro superio-re al lavoro svolto, tratteneva presso di sé quei marmi a titolo di garanzia di quanto sborsato. Giacomo Garvo, che il 29 novembre 1679 aveva già compilato una lista di tali pezzi di bardiglio indicando una loro stima, versò ad Agostino Franzone tale cifra, impegnandosi a proseguire e condurre a termine il lavoro. In due aggiunte al documento, datate 11 e 12 gennaio 1685, il notaio Gio. Francesco Cavagnaro raccoglieva altre dichiarazioni dei due uomini già interpellati, che concordemente affermavano come Casel-la avesse lasciato, oltre a del marmo bardiglio, anche tre pezzi di marmo
7978
“L’ornamento de marmi” della cappella FranzoneMariangela Bruno
2. Honoré Pellé, Rilievo con i simboli della Passione, parete destra, Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo.
3. Honoré Pellé, Rilievo con i simboli della Passione, particolare, parete destra, Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo.
4. Honoré Pellé, Rilievo con i simboli della Passione, parete sinistra, Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo.
5. Honoré Pellé, Rilievo con i simboli della Passione, particolare, parete sinistra, Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo.
e della lustratura dei marmi45. Nel rispetto delle particolari caratteristiche fisiche del materiale impiegato in questo cantiere è estremamente inte-ressante la richiesta avanzata da Agostino Franzone all’artista di prestare attenzione a non danneggiare il marmo bardiglio; tale pietra infatti, pur presentando le medesime caratteristiche della lavorazione del marmo bianco, mostra un inconveniente: in caso la superficie finale fosse stata urtata da un elemento metallico, come ad esempio uno scalpello, avrebbe
il tempo necessario a condurre a termine la sua opera, quando le avrebbe poi riconsegnate al committente.Rispetto al progetto architettonico dell’altare, questi modelli raffiguravano delle soluzioni pensate appositamente per questo spazio: l’elemento del drappo ha infatti origine dal cornicione inferiore del timpano dell’altare e attraverso un festone si appunta sull’imposta della parete laterale della cappella. La sequenza verticale dei simboli della Passione di Cristo è poi proposta in una concitata successione, quasi a contrasto con la severa stati-ca architettonica della struttura altaristica. Come puntigliosamente indica-to nel documento di committenza, a ridosso dei due festoni sono “li flagelli della Passione che vanno dalle due parti, ”conformi, secondo un’annota-zione che restituisce la dinamica e l’organizzazione interna del cantiere, alle “carte attacate alla capella”. Scendendo con lo sguardo, a cominciare dal versante destro, si ritrovano la lancia di Longino incrociata all’asta con la spugna su cui è addossata la veste di Cristo e subito sotto sono disposti la colonna e la fune che rimandano al momento della flagellazione (figg. 2-3); a sinistra i restanti emblemi: la scala, le tenaglie, il martello, il gallo e la Veronica, in cui il volto di Gesù è delineato attraverso delle filettature in metallo dorato (figg. 4-5). La raffigurazione di questi elementi, conce-pita come una vera e propria ostensione di sacre reliquie, rassomiglia a quei manufatti effimeri – realizzati con carta, cartone, cartapesta e legno – che venivano allestiti annualmente in occasione delle ricorrenze religiose, come ad esempio nel corso del periodo pasquale, o approntati per eventi occasionali, tra cui proprio la sistemazione di catafalchi funebri; l’appara-to predisposto da Agostino induce a un momento di raccoglimento, a cui sono chiamati a partecipare i due fratelli Franzone, ammessi alla contem-plazione del corpo di Cristo in croce e dei misteri della Passione.Il documento non si dilunga molto sulla descrizione di questi sogget-ti, demanda ovviamente ogni riferimento iconografico ai modelli di cera menzionati e ribadisce più volte la rispondenza a degli standard di qualità esecutiva richiesti dal committente. Il nobile, interessato ad avere un ma-nufatto eseguito a regola d’arte, fa infatti precisare al notaio che i pezzi di bardiglio da cui sarebbero stati ricavati i rilievi della Passione avrebbero dovuto essere giunti tra loro senza che si notasse alcuna cesura; inoltre tutti i lavori eseguiti da Pellé dovevano essere “bene intagliati e spicati da suo piano [...] farli con ogni diligentia acciò non vi restino le botte del scalpello acciocche si possino fare lostrare”. In effetti in un insieme decorativo pres-socché monocromatico dare il corretto risalto alle forme per mezzo degli scalpelli, distinguendole dal fondo, consentiva di modulare la dinamica chiaroscurale e di conseguenza far comprendere meglio quanto effigiato; la cappella era illuminata oltre che dalle tre aperture poste a ridosso dell’al-tare anche da una finestra posta in alto a destra, al di sopra del cornicione del transetto, la cui presenza – ancorché tamponata – è attestata da una foto scattata dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale (fig. 6).Come emerge dalla documentazione archivistica giunta sino ai nostri gior-ni, solitamente gli scultori si avvalevano di collaboratori specializzati, tal-volta interni alla bottega o “liberi professionisti”, per la fase della segatura
8180
“L’ornamento de marmi” della cappella FranzoneMariangela Bruno
6. Foto storica della chiesa dei Santi Vittore e Carlo dopo i danni bellici della seconda guerra mondiale, Genova, Archivio parrocchiale della chiesa dei Santi Vittore e Carlo.
una figura specializzata nell’ornato: fu quindi coinvolto Francesco Macet-ti (1619-1687)51, un marmoraro appartenente a una famiglia di nazione lombarda originaria di Rovio (Canton Ticino), che aveva collaborato in più occasioni anche con Pierre Puget durante il suo soggiorno genovese; l’ultima per la messa in opera della cappella per il palazzo di Stefano Lo-mellini, predisposta per ospitare l’Immacolata Concezione realizzata dallo scultore francese52.L’impegno richiesto a Garvo consisteva oltre che nel fasciare con del bar-diglio le pareti poste ai lati dell’altare, anche nel definire e rivestire con il medesimo materiale le nicchie e lo spazio compreso tra la parte superiore delle porte sino all’altezza della base dei capitelli delle lesene. Secondo il progetto tale allestimento richiedeva la perizia di un capace marmoraro quadraturista, che sapesse tradurre “l’architettura che resta designata sopra della muraglia [...] nel Claustro della chiesa”, e al contempo l’abilità di un maestro in grado di trasporre nel marmo bianco le cornucopie, i festoni e l’arma araldica franzoniana (tavv. II-III). All’interno di ogni nicchia doveva poi essere disposto un deposito di marmo di Portovenere (comunemente chiamato portoro) “con le foglie bene intagliate come si vede nel medemo disegno”. Nella suddivisione del lavoro Garvo si occupò di definire i partiti architettonici e quindi la pavimentazione, disegnata attraverso delle liste in marmo bianco e verde di Polcevera, mentre, come ulteriormente puntua-lizzato nel documento, “tutti l’intagli doveranno essere fatti con diligenza da Maestro Francesco Masetti”.Ogni lavoro menzionato doveva essere condotto a termine secondo il modello disegnato sul muro della chiesa: un tracciato grafico che, confor-memente alla prassi lavorativa dei cantieri, non solo delineava la visione d’insieme e la sistemazione del pavimento, ma circostanziava anche alcuni dettagli decorativi da intagliare, fornendone le misure e i profili. In questi disegni erano certamente inclusi i busti di Agostino e Giacomo Franzo-ne: in effetti in una delle frasi conclusive dell’accordo si precisava che tutti “i lavori cioè delli due depositi, Porta, urna, Intagli ornamenti che sono designati nel Claustro della detta Chiesa di San Carlo, fuori che li busti, detto Maestro Giacomo Garvo si obbliga di farli”. Queste parole sembrano assumere il tono di una ‘raccomandazione’, circoscrivendo quanto era di competenza del marmoraro titolare dell’opera: egli avrebbe dovuto infatti predisporre il tutto per accogliere sui piedistalli situati sopra l’urna i ritratti del committente e del fratello. Quanto registrato dal notaio non lascia dub-bi: le effigi marmoree a questa data, aprile 1684, erano già state scolpite e in mano ad Agostino, che probabilmente le conservava all’interno della propria dimora posta in salita San Francesco. I due busti di Agostino e Giacomo Franzone (figg. 7-8) fino ad ora non sono mai stati esaminati con la dovuta attenzione; essi erano infatti ricompresi, un po’ come tutti i manufatti scultorei della cappella, entro la tradizionale attribuzione ad Alessandro Algardi. Fu Minna Heimbürger Ravalli a rileva-re l’erroneo riferimento algardiano, spostando la loro data di realizzazione nella seconda metà del Seicento53. Tale cronologia fu condivisa da Jennifer Montagu che, nel fondamentale studio monografico dedicato allo scultore
potuto segnarsi e creare così una macchia bianca, detta “pistatura”, che se fosse penetrata in profondità avrebbe reso difficile la sua rimozione. Una grande accortezza doveva inoltre essere prestata durante le fasi della levi-gatura e lucidatura, poiché se surriscaldata eccessivamente la superficie del bardiglio sbiadisce assumendo una colorazione biancastra46, come sembra di poter scorgere in alcune porzioni del lato destro superiore del fregio scolpito da Honoré Pellé (fig. 3).La buona riuscita del lavoro sarebbe stata valutata non solo dallo stesso Agostino, ma anche dal giudizio di un professionista. Il pittore Giovanni Andrea Carlone (1639-1697)47 fu infatti chiamato a rivestire il ruolo di giu-dice e quindi a valutare l’operato dello scultore: in caso di giudizio positivo Pellé avrebbe ricevuto altre 50 lire, oltre il compenso pattuito di 250. Il coin-volgimento di altri artisti – in particolare dei pittori ai quali era riconosciuto un ruolo di “guida” nel campo artistico – nella stima della qualità di un manufatto scultoreo ultimato era una pratica assai frequente; ovviamen-te tale ruolo era destinato a quelle personalità che si erano distinte per il loro valore. Carlone fu probabilmente scelto in virtù della sua esperien-za pluriennale a Roma, dove forse aveva conosciuto il cardinale Giacomo Franzone, visto la frequentazione da parte di entrambi della bottega del mercante d’arte genovese Pellegrino Peri48; l’artista, tra le personalità più aggiornate del suo tempo, fu più volte coinvolto nella valutazione di opere pittoriche e scultoree dall’aristocrazia genovese49.Dopo gli interventi di Pellé rimanevano soltanto le pareti laterali della cappella da perfezionare e Agostino Franzone il 5 aprile 168450 affidò tale incarico a un maestro che già conosceva, Giacomo Garvo. Egli aveva in-fatti operato nella stessa fabbrica qualche anno prima per ultimare l’alzato dell’altare. In questa fase del cantiere occorreva però, accanto al Garvo,
8382
“L’ornamento de marmi” della cappella FranzoneMariangela Bruno
9. Honoré Pellé, Ritratto di Filippo Ferretto, Genova, Albergo dei Poveri.
10. Honoré Pellé, Ritratto di Carlo II, Londra, Victoria and Albert Museum.
7. Honoré Pellé (qui attribuito), Ritratto di Agostino Franzone, Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo.
8. Honoré Pellé (qui attribuito), Ritratto del cardinale Giacomo Franzone, Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo.
un’attenta ricognizione sull’opera dello scultore, consentendo di ampliare il corpus del suo catalogo61 e di rileggerne il percorso artistico svincolato dalla figura di Pierre Puget, a cui Pellé è stato sempre associato, e inseren-dolo piuttosto entro un più ampio discorso di interscambio di merci e di maestranze tra Genova e la Provenza62.Honoré Pellé si inserì nel contesto locale adattandosi all’organizzazio-ne del lavoro del marmo in vigore nella seconda metà del Seicento a Genova, si iscrisse difatti all’Arte degli scultori, scalpellini e marmarari, ri-spettandone le regole e le deliberazioni. Prova ne è non solo la stipula nel 1674 di un contratto con cui lo scultore si impegnava a formare un giovane, Luciano Firpo, nel mestiere di scultore63, ma anche la parteci-pazione alle riunioni della corporazione, in seno alla quale rivestì pure la carica di consigliere64. Artista poliedrico, Pellé intagliava opere nel le-gno, poppe di navi e casse processionali65, scolpiva il marmo e lavorava al contempo il metallo. Nel corso della sua carriera artistica si distinse inoltre nel genere del ritratto: si cimentò nella realizzazione di alcune immagini di benefattori genovesi, come le effigi a figura intera di Fi-lippo Ferretto (fig. 9)66 e di Giuseppe Saluzzo67. Nel 1682 doveva avere raggiunto una significativa notorietà se gli venne affidato il prestigioso incarico di realizzare il busto in pietra del sovrano inglese Carlo II Stuart che si conserva presso la Burghley House, replicato dallo stesso artista due anni più tardi nel marmo ora al Victoria and Albert Museum (fig. 10)68. Questo importante incarico e la fama che ne scaturì non doveva essere passata inosservata ad Agostino, sensibile collezionista di manu-fatti scultorei69 e attento pigmalione alla scoperta di talenti operanti nel contesto locale: si ricordi infatti che fu proprio il nobile a commissionare
bolognese, articolava la sua posizione ponendo in evidenza l’assenza dei caratteri della ritrattistica algardiana nei due marmi, circoscrivendo la loro esecuzione al settimo decennio del Seicento sulla base dell’abbigliamento degli effigiati: Giacomo è in abito cardinalizio (titolo raggiunto nel 1660)54 e Agostino indossa il robone da senatore genovese (la prima nomina risale al 1661)55. La studiosa inglese proponeva inoltre di avvicinare i due busti alla maniera di Domenico Guidi, stretto collaboratore di Algardi, suppor-tando tale proposta con la familiarità dei rapporti tra l’artista e il cardinale di casa Franzone56: da allora la critica ha accettato tale attribuzione, indi-cando la coppia di ritratti marmorei come opera di Guidi57. Tale riferimen-to è stato messo in discussione solo recentemente da Cristiano Giometti, che nella puntuale monografia sullo scultore ha espunto dal suo catalogo i busti franzoniani, riferendoli piuttosto a un artista ignoto attivo a Genova dopo il 166058. Lo studioso fonda la sua ipotesi su un’analisi stilistica, rile-vando come i due marmi non siano partecipi del modo di ritrarre di Guidi. A suffragare questo suo parere è inoltre l’indicazione riportata nel testa-mento del cardinale Franzone, redatto a Roma il 21 settembre 1696, dove si attestava che nella cappella fabbricata nella chiesa di San Carlo il fratello Agostino “ha fatto porre una statua rappresentante la persona di esso si-gnor cardinale”59. L’acuta osservazione di Giometti ha consentito di porre una nuova attenzione su questi manufatti e di ricondurne l’esecuzione più propriamente al prolifico contesto genovese. A seguito delle ricerche condotte in occasione della giornata di studio e approfondite per la stesura di questi atti viene proposto da chi scrive di avvicinare i due ritratti alla produzione dello scultore provenzale Honoré Pellé: diversi aspetti contingenti, cronologici e stilistici sembrerebbero in-fatti confermare tale riferimento. La personalità di Pellé, scultore attivo sulla scena genovese dalla seconda metà del Seicento, è stata indagata nei pioneristici contributi di Venanzio Belloni e Piero Boccardo, facendo emergere la figura di un artista di cui poco si conosceva sino a quel momento, escluso quanto riferito dal biogra-fo Carlo Giuseppe Ratti60. Negli ultimi anni Francesca Fabbri ha condotto
8584
“L’ornamento de marmi” della cappella FranzoneMariangela Bruno
11. Honoré Pellé, Cristo alla colonna, particolare, Genova, convento della Congregazione di Nostra Signora del Rifugio.
12. Honoré Pellé (qui attribuito), Ritratto di Agostino Franzone, particolare, Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo.
13-14. Honoré Pellé (qui attribuito),Ritratto del cardinale Giacomo Franzone, particolari, Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo.
un leggero moto con il braccio destro che increspa il robone senatoriale in tessuto operato, creando un crepitio di pieghe.I busti di Agostino e Giacomo presentano inoltre l’iride appena accennata sul globo oculare (fig. 14). La mancata caratterizzazione dello sguardo, che incide anche sulla debole connotazione psicologica dei ritratti, è forse da porre in relazione con la collocazione dei due marmi: erano in effetti in-seriti sopra ai depositi di portoro, a una considerevole altezza, in solitaria contemplazione del Cristo crocifisso posto sull’altare. A quel tempo infatti non era ancora stata sistemata la serie dei busti bronzei dei santi.Un nuovo contratto dell’aprile 1693 definiva gli ultimi lavori da affrontare nella cappella Franzone. Bernardo Garvo, figlio di Giacomo, si accordava con il perseverante Agostino a rivestire con marmo bardiglio, entro i suc-cessivi cinque mesi, i quattro pilastri e le lesene che delimitavano le pareti laterali del sacello, ricavando su ciascun elemento due “modiglioni” dello stesso materiale che avrebbero dovuto accogliere i busti bronzei dei santi, identificati dai nomi intarsiati in marmo giallo74.La disomogeneità tra questi busti, rilevata anche nel contratto, indusse
nel 1673 la Madonna con il Bambino, prima opera in marmo nota sino ad oggi di Filippo Parodi (cfr. fig. 21 del saggio di D. Sanguineti)70. Sembra plausibile che il patrizio, dopo aver fatto eseguire i rilievi della Passione, abbia vagliato attentamente, insieme al pittore Giovanni Andrea Carlo-ne, l’operato di Pellé e, rimastone soddisfatto, gli abbia affidato la realiz-zazione dei due busti.Per quanto riguarda l’aspetto cronologico, si è visto come nel documento riferito alle decorazioni delle pareti della cappella realizzate da Garvo (da-tato aprile 1684) i busti fossero menzionati, a conferma della già avvenuta loro esecuzione; questo dato trova una ulteriore conferma nell’iscrizione che era posta sotto la nicchia contenente il deposito in marmo portoro con il ritratto del cardinale Franzone, oggi non più leggibile: IACOBUS TITULI SANCTAE MARIAE IN ARA COELI / SANCTAE ROMANAE ECCLE-SIAE PRESBITER CARDINALIS / FRANZONUS EPISCOPUS CAME-RINENSIS71. Queste parole ricordano Giacomo Franzone quale cardinale titolare di Santa Maria in Aracoeli, carica che mantenne dal 27 febbraio 1673 sino al 30 aprile 168572, un intervallo temporale che corrisponde alla possibile datazione dei busti, da collocare, secondo il parere della scrivente e in assenza di altri riferimenti, tra il 1682 e il 1684.Occorre rilevare che i due ritratti presentano esiti differenti. L’effigie di Agostino Franzone è maggiormente caratterizzata, Pellé ebbe infatti modo di studiare direttamente le fattezze dell’uomo, mentre il busto del cardi-nale Giacomo sembra raffigurare un’immagine derivata da un’incisione o da un ritratto pittorico. La mancata osservazione diretta del modello si evidenzia nella riproposizione per sommi capi dei tratti del viso e quindi nella messa a punto del prototipo del buon religioso: viene di fatto stem-perata l’immediatezza e l’attenzione per i dettagli che invece si riscontra nel volto del fratello, dove l’artista restituisce la pelle dell’uomo, ormai non più giovane.Un confronto tra questi due marmi e le opere realizzate in quel torno d’an-ni da Honoré Pellé pone in evidenza alcune assonanze nella concezione dei manufatti e nella loro lavorazione. L’attenta osservazione del volto di Agostino fa emergere un modo di elaborare i volumi, individuati attraverso delicati trapassi nel modellato, che si riscontra anche nel viso del Cristo alla colonna, conservato presso il convento della Congregazione di Nostra Si-gnora del Rifugio73. Altro dettaglio che accomuna le due sculture è il modo di delineare l’andamento delle ciocche dei lunghi capelli mossi: i ricci sono modellati attraverso l’azione di uno scalpello che, nel segnare il marmo, accompagna il movimento delle forme; nel contempo il trapano crea dei rialzi nella capigliatura, alleggerendo la materia attraverso una serie di fori (figg. 11-13). In entrambe le opere le chiome prossime alla fronte sono disciplinate con poca enfasi, privilegiando l’impiego di uno scalpello.Il gusto per una componente dinamica composta appare come ulteriore termine di paragone che si può instaurare tra i busti franzoniani e le opere ‘certe’ dello scultore provenzale, come il ritratto del re inglese Carlo II. Qui il movimento della figura si traduce con una peculiare tensione, la stessa caratterizzante i panneggi delle vesti di Agostino: questi accenna infatti a
8786
“L’ornamento de marmi” della cappella FranzoneMariangela Bruno
17. Alessandro Algardi, Santa Maria di Cleofa, Genova, chiesa dei Santi Vittore e Carlo.
18. Daniele Solaro, Ritratto di Angela Veronica Colombino, Genova, collezione privata.
15. Domenico Parodi, Battesimo di Cristo, Genova, chiesa di Santa Maria delle Vigne.
16. Pietro Galleano, Battesimo di Cristo, collezione privata.
la spalla, l’orlo della veste che si increspa sul petto e il mantello che avvolge il busto, bensì mira a rievocare, certo in maniera più abbreviata, quell’ideale di pacata grazia espressa attraverso un armonioso modellato consono pe-raltro alla personalità artistica dello stesso Solaro78.Alla luce di queste ultime considerazioni si deve riconoscere ad Agostino Franzone un ruolo trainante nel rinnovo dei modelli artistici in città negli ultimi decenni del Seicento. Attraverso la propria collezione e l’edificazio-ne della cappella di famiglia in San Carlo – eretta, come si è visto, tra il 1677 e il 1693 – egli ebbe modo di introdurre una tendenza estetica, che faceva capo ad Algardi e alla sua scuola, che trovò una ricezione e una penetra-zione differenti in città, sia da parte degli appassionati sia dagli artisti locali, ma sicuramente non passò inosservata e lasciò tracce durature.Certo è che questa raffinata koiné algardiana, amplificata dall’opera del suo allievo più intraprendente Domenico Guidi, presente con diverse realizza-zioni entro il contesto genovese, segnò il volgere di un secolo e di un nuo-vo orizzonte culturale dove l’accesa sperimentazione del Seicento cedeva il passo a un linguaggio temperato: esemplari in tal senso le due figure allegoriche, la Mansuetudine e l’Innocenza, poste sull’altare di San France-sco di Sales, scolpite da Francesco Biggi e Domenico Parodi, che trovavano proprio nell’opera di Guidi e nella produzione pittorica di Carlo Maratti un punto di riferimento79.
il committente a richiedere a Bernardo la realizzazione di un modello in terracotta delle mensole, che sarebbe stato esaminato ed approvato dal-lo stesso Agostino, che si dimostra ancora una volta un attento regista di tutta la decorazione della cappella. Tale termine temporale è in special modo significativo, poiché consente di stabilire che a quella data il nobile possedeva la serie completa dei bronzi, probabilmente conservati in quel momento nel suo palazzo cittadino sito in salita San Francesco. Una volta che Garvo ultimò il suo lavoro, la cappella fu visibile nella sua interez-za decorativa, vuoi nella componente marmorea vuoi in quella bronzea. L’esposizione di questi ultimi manufatti dovette avere una notevole eco nella società del tempo, suscitando ammirazione nei pari di Agostino e al contempo si rivelò come una nuova occasione di studio per gli artisti, in particolare per l’immaginario degli scultori del tempo più sensibili alle novità introdotte nel contesto locale. Si può in effetti riscontrare nella pro-duzione scultorea lignea e lapidea coeva una serie di rimandi a queste e altre opere algardiane che erano presenti in città. A titolo esemplificativo di questo revival algardiano75, che scaturì dal sacello franzoniano, sono em-blematiche la letterale trascrizione iconografica del Battesimo di Cristo, oggi al Museum of Art di Cleveland (cfr. fig. 8 del saggio di J. Montagu) – già evidenziata da Jennifer Montagu76 –, realizzata dallo scultore Domenico Parodi (1644/1653-post 1712) per la chiesa genovese di Santa Maria delle Vigne (fig. 15) e il piccolo gruppo ligneo riferito da Daniele Sanguineti a Pietro Galleano (1687-1761), allievo di Anton Maria Maragliano (fig. 16)77. Differente è la scelta dello scultore Daniele Solaro (1649-post 1726) che, nel riproporre i caratteri della muliebre bellezza del busto di Santa Maria di Cleofa (tav. VIIb; fig. 17) nel Ritratto di Angela Veronica Colombino (fig. 18), non si limita a citarne alcuni dettagli, come la ciocca di capelli adagiata sul-
8988
“L’ornamento de marmi” della cappella FranzoneMariangela Bruno
44 Gli scultori per la realizzazione di mo-delli in scala ridotta, oltre alla creta, im-piegavano anche la cera, come attestato dalla trattatistica del tempo. Baldinucci 1681b, pp. 31-32.45 Bruno 2004-2010, p. 100 nota 27; Bru-no 2012b.46 De Tomassi 2002, p. 40.47 F. Lamera in Gavazza, Lamera, Ma-gnani 1990, pp. 407-408.48 Pellegrino Peri intratteneva stretti rap-porti sia con il pittori Giovanni Andrea Carlone sia con il cardinale Giacomo Franzone. Lorizzo 2010, pp. 26, 48-49, 92.49 Bruno 2012b.50 ASGe, Notai antichi, Pietro Gerolamo Turicelli, 8636, 5 aprile 1684. Il docu-mento è stato reso noto e trascritto in Bruno 2004-2010.51 Per quest’artista si veda Belloni 1988, pp. 117-121; Franchini Guelfi 2006.52 La scultura, come attesta una lapide, fu posta nel 1762 sull’altare dell’oratorio di San Filippo Neri.53 Heimbürger Ravalli 1973, p. 178.54 Bertoni 1998.55 Corazzini 1873, p. 71.56 Montagu 1985, II, schede R.38-39, pp. 473-474. Per i rapporti tra il cardinale Giacomo Franzone e Domenico Guidi si veda in questi atti il saggio di Cristia-no Giometti.57 Boccardo 1988, pp. 99-100; Bozzo 1998, p. 29; P. Cannata in Algardi 1999, scheda 53, p. 212.58 Giometti 2010, scheda 7.OA.R, pp. 314-315.59 ASR, Notai R.C.A., F. Antamoro, vol. 73, 21 settembre 1696, f. 309v; Montagu 1985, II, schede R.38-R.39, p. 473; Gio-metti 2010, p. 314.60 Ratti 1762, pp. 230-231; Ratti 1769, p. 326; Belloni 1988, pp. 145-151; P. Boc-cardo in La scultura a Genova 1988, pp. 207-208.61 Fabbri 2003; Fabbri 2004a; Fabbri 2004b; Fabbri 2008.62 Fabbri 2003, p. 184.63 ASGe, Notai antichi, Gio. Battista Ugo, 9056, 19 settembre 1674; Fabbri 2004b, p. 195, nota 28.64 ASGe, Notai antichi, Giuseppe Ce-lesia, 8410, 10 dicembre 1696 (Belloni
1988, p. 270); ASGe, Notai antichi, Ales-sandro Alfonso, 9180, 3 dicembre 1698. Per la corporazione degli scultori lom-bardi si veda Santamaria 2000-2003; Bruno 2012b.65 Per l’attività di Pellé intagliatore San-guineti 2013b, pp. 181-185 (con biblio-grafia precedente).66 La statua, secondo i documenti noti, è stata realizzata tra il 1679 e il 1681 per la chiesa dell’Albergo dei Poveri, dove ancora si conserva. Parma Armani 1990, p. 175.67 L’effigie di Giuseppe Saluzzo, scolpita dall’artista francese nel 1680, era desti-nata all’Ospedale dei Cronici; oggi si trova nello scalone del Palazzo di Giu-stizia di Genova. Alizeri 1875, p. 293; Belloni 1988, p. 147.68 Bruno 2011, p. 163 (con bibliografia precedente).69 Per la collezione di Agostino Franzo-ne si veda in questi atti il saggio di Piero Boccardo.70 I pagamenti di quest’ultima opera, rintracciati da Fausta Franchini Guelfi, vennero effettuati da Agostino Franzo-ne tra il 1673 e il 1674. Franchini Guelfi 1987, pp. 22-24, 37-40; Magnani 1992b, p. 299; Bruno 2012b.71 Corazzini 1873, p. 182.72 Casimiro da Roma 1736, p. 358.73 L’opera, eseguita per Giuseppe Maria Durazzo nel 1680, in passato era attri-buita a Filippo Parodi. Grazie a Dino Puncuh è stata ricondotta entro il cata-logo dello scultore provenzale. Puncuh 1984, p. 206.74 Il documento, reso noto da Luigi Al-fonso, non è stato rintracciato alla se-gnatura archivistica indicata. Alfonso 1985, pp. 186-187.75 Tale aspetto è stato affrontato nel cor-so della tesi di dottorato discussa dalla scrivente nell’aprile 2012 presso l’Uni-versità degli Studi di Genova e di pros-sima pubblicazione. Bruno 2012b.76 Montagu 1985, I, p. 82, 85; Bruno 2011, pp. 164-166.77 Sanguineti 2010, pp. 32-33; Bruno 2012b.78 Bruno 2011, pp. 164-166.79 Bruno 2012b.
1 Ratti 1766, p. 178.2 Alizeri 1847, I, p. 159.3 Corazzini 1873, p. 72.4 Labò 1930-1931, pp. 1392, 1397.5 Wittkower 1993a, p. 391.6 Per la collocazione dei busti entro la cappella Franzone si vedano i saggi di Andrea Bacchi, Cristiano Giometti e Jennifer Montagu in questi atti.7 Magnani 1992b, p. 293; Bruno 2012b. Sulla presenza di opere algardiane nel-la raccolta Franzone si vedano i contri-buti di Piero Boccardo e Jennifer Mon-tagu in questi atti.8 Ratti 1766, p. 178.9 Labò 1930-1931, p. 1403; Labò 1931, p. 34; Lamera 1988, pp. 102-103; Bruno 2004-2010, p. 96; Franchini Guelfi 2005, p. 43. 10 Ibidem. Si veda inoltre il saggio di Sara Rulli in questi atti.11 ASGe, Notai antichi, Battista Pane-si, 5455, 9 dicembre 1620; Corazzini 1873, p. 45.12 È questo il caso di Anfrano, capostipi-te di questo ramo della famiglia (1621), di suo padre Tommaso (1627), del figlio Tommaso (1656) e del nipote Anfrano Mattia (1679). Vigna 1864, p. 430; Co-razzini 1873, pp. 34, 60.13 Vigna 1864, pp. 334-335; Corazzini 1873, pp. 182-183.14 Anfrano Mattia era il figlio di Maddale-na Sauli e Gaspare Franzone; quest’ulti-mo era il fratello maggiore di Giacomo e Agostino. Stefano e Tommaso erano figli di Tommaso Franzone. Vigna 1864, pp. 334-335; Corazzini 1873, pp. 45, 59-60.15 Vigna 1864, p. 335.16 Vigna 1864, p. 448; Corazzini 1873, pp. 70-71.17 Ivi, p. 146.18 ASGe, Notai antichi, Giovanni Tom-maso Poggio, 6545, 18 aprile 1637; Co-razzini 1873, p. 59.19 ASGe, Notai antichi, Giovan Carlo Mercante, 7130, 6 agosto 1657; Coraz-zini 1873, p. 58.20 ASGe, Notai antichi, Anton Maria As-sereto, 8926, 11 maggio 1680.21 Corazzini 1873, p. 52.22 Sul ruolo di Agostino Franzone nell’edificazione della cappella di fa-miglia entro la chiesa dei Santi Vittore e Carlo si veda Labò 1931, pp. 33-34; Bruno 2004-2010.
23 Labò 1931, p. 33.24 Bellori 1672, p. 404; Baldinucci 1681a, V, p. 58.25 Montagu 1985, II, scheda 15.D.I., p. 327. Si vedano inoltre in questi atti i contributi di Andrea Bacchi, Piero Boc-cardo, Cristiano Giometti e Jennifer Montagu.26 La chiesa non esiste più e il suo arre-do, compreso un crocifisso bronzeo di Algardi lasciato in eredità ai camaldo-lesi dal cardinale Giacomo Franzone, è andato disperso. Corazzini 1873, p. 58; Montagu 1985, II, scheda L.21., p 340. 27 ASGe, Notai antichi, Giovan Carlo Mercante, 7130, 6 agosto 1657.28 Labò 1931, p. 33; Bruno 2012b.29 ASGe, Notai antichi, Gio. Batta Garelli, 8760, 11 aprile 1677; Labò 1931, p. 33.30 ASGe, Notai antichi, Anton Maria As-sereto, 8926, 5 aprile 1679; Corazzini 1873, p. 60.31 Labò 1930-1931; Labò 1931.32 ASGe, Notai antichi, Gio. Batta Garelli, 8760, 11 aprile 1677; Labò 1931, p. 33.33 Gallo Colonni 1965, p. 161.34 Corazzini 1873, p. 72; Labò 1930-1931; Labò 1931. L’archivio della chiesa è andato distrutto durante la seconda guerra mondiale. 35 Sull’artista si veda Belloni 1988, pp. 112-114; F. Lamera in La scultura a Ge-nova 1988, p. 202.36 ASGe, Notai antichi, Gio. Batta Garelli, 8760, 6 maggio 1677; Labò 1931, p. 33.37 ASGe, Notai antichi, Gio. Batta Garelli, 8760, 6 maggio 1677; Labò 1930-1931, p. 1396.38 ASGe, Notai antichi, Giovanni Battista Bargone, 7917, 29 gennaio 1662; Alfon-so 1985, p. 346, nota 38.39 Labò 1930-1931, p. 1392.40 Belloni 1988, p. 114.41 Giacomo Garvo nel 1671 risultava in società con Tomaso Orsolino e Giovan-ni Battista Casella per l’acquisto di una fornitura di marmi. Alfonso 1985, p. 125. Per Garvo si veda Belloni 1988, pp. 193-194; Molteni 1999, p. 403.42 ASGe, Notai antichi, Gio. Francesco Cavagnaro, 8222bis, 3 gennaio 1685; Bruno 2004-2010, p. 97.43 ASGe, Notai antichi, Pietro Gerolamo Turicelli, 8636, 22 novembre 1682. Il do-cumento è stato reso noto e trascritto in Bruno 2004-2010, pp. 96-97, 101.