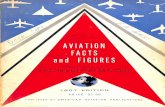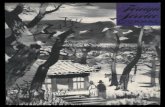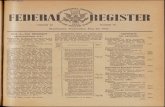Il braccio mancante. I restauri del Laocoonte (1506-1957)
Transcript of Il braccio mancante. I restauri del Laocoonte (1506-1957)
Ludovico Rebaudo
IL BRACCIO MANCANTEI restauri del Laooconte
(1506-1957)Nuova edizione aggiornata
EdItREg sRLtRIEstE 2007
«VaRIE daL passato» - 2
© Editreg srlsede legale: via san Lazzaro 17, I-34122 triestesede operativa: via Ugo Foscolo 26, I-34139 triestetel./fax +39/040/362879
e-mail: [email protected]
IsBN 978-88-88018-60-7
Finito di stampare nel mese di aprile 2007 presso Lithostampa srl - via Colloredo 126, 33037 pasian di prato (Ud)
Il presente volume è stato stampato con il contributo di:
U n i v e r s i t à d e g l i s t U d i d i U d i n e
dipartimento di storia e tUtela dei Beni CUltUrali
premessa alla ristampa riveduta e corretta della seconda edizione
Lo studio che costituisce la parte principale di questo volume è stato pubblicato nel 2000 con il titolo Il braccio mancante. Il Laocoonte, la fortuna, i restauri (1506-1957) da una piccola casa editrice, a capo di una vicenda che ne ha ritardato l’apparizione di un paio d’anni. Le stesse circostanze hanno fatto sì che il libro vedesse la luce a pisa invece che a Napoli, come avrebbe dovuto, e fosse stampato in fretta e con poca cura, di modo che nella prima edizione ha avuto scarsa circolazione.
Nel frattempo una versione condensata del lavoro è uscita in appendice ad un libro, al contrario, assai fortunato (I restauri del Laocoonte, in s. settis, Laooconte. fama e stile, Roma, donzelli, 1999, pp. 231-258), di modo che le idee qui contenute sono comunque note e hanno trovato, mi pare, riscontro da parte degli studiosi.
a distanza di qualche anno la ricorrenza del cinquecentesimo dalla scoperta del Laocoonte è buona occasione per riproporre il lavoro nella versione integrale. Il testo è quello della prima edizione, con alcuni ritocchi e miglioramenti. È stata invece aggiornata la bibliografia e arricchito il corredo iconografico.
I restauri
Lo stato di conservazione
Quando fu scoperto il Laocoonte (fig. 1) era quasi integro1. L’anonimo corrispondente di sabadino degli arienti, che nel gennaio del 1506 partecipa al letterato bolognese la notizia del rinvenimento, cita quali uniche lacune le braccia di Laocoonte e del figlio più pic-colo2:
Queste figure sono fragmentate, che al padre mancha uno braço in quo habebat telum, ad uno deli figl‹i›uoli mancha uno braço similiter, del resto sono assai integre et sane.
sostanzialmente identica la testimonianza del mercante fiorentino giovanni di Lorenzo Cavalcanti, che scrive il 14 febbraio3:
Manchono ad queste figure queste due braccia, et per quello si vede dalla spiccatura luno et laltro braccio era elevato et credono ch’el padre dovessi avere in mano una hasta, o qualche altra arme.
1 Non è questo il luogo per ricordare, anche solo parzialmente, la sterminata bibliografia sul L. La si veda raccolta in B. andreae, Pretorivm spelvncae. L’antro di Tiberio a Sperlonga, Cosenza, Rubbettino, 1995; N. Himmelmann, Sperlonga. Die homerische Gruppen und ihre Bildquellen, opladen, Westdt. Verl., 1996 («Vortr. Nordrhein-Westfälischen akad. der Wiss. düsseldorf. geisteswiss.», g 340); g. saUron, Un conflit qui s’éternise: la ‘Guerre de Sperlonga’, «Ra», 1997, 2, pp. 261-296; s. settis, Laocoonte. Fama e stile, Roma, donzelli, 1999, pp. 3-81; From Pergamon to Sperlonga. Sculpture and context, ed. by t. de grummond and B. sismondo Ridgway, Berkeley, U.C.p., 2000.
2 per il testo (as Mantova, arch. gonzaga, busta 1146, cc. 171-172v): s. maffei, La fama di Laocoonte nei testi del Cinquecento, in settis, Laocoonte, cit., pp. 85-230: ii.3, p. 104 s.; C. James, The Letters of Giovanni Sabadino degli Arienti (1481-1510), Firenze, olschky; perth, Univ. of W. australia, dep. of Italian, 2002, pp. 66 e 236 s., nr. 172. In prec., meno fedelmente: r. renier, rec. a Joanne sabadino de li arienti, Gyne- vera de le clare donne, a c. di C. Ricci, a. Bacchi della seta (disp. 223a della scelta di Curiosità Letterarie), Bologna, Romagnoli dell’acqua, 1888, in «giornale storico della Letteratura Italiana», XI, 1888, pp. 205-218, spec. 209 s., da cui numerose ristampe.
3 as Firenze, carteggio d’artisti, 1, ins. 3, da cui trascrive maffei, La fama di Laocoonte, cit., ii.4, p. 106 s. prima ed., parziale e scorretta: E. Müntz, Les antiquités de la ville de Rome aux XIVe, XVe et XVIe siècle, paris, Leroux, 1886, p. 45 s. L’autore della lettera non è il giovanni Cavalcanti (ca 1444-1509) amico di Marsilio e membro dell’accademia platonica, come si legge in maffei, l. cit., bensì il più giovane e meno noto giovanni di Lorenzo di Filippo Cavalcanti (1480-1542): C.M. siCCa, Pawns of international finance and politics: Florentine sculptors at the court of Henry VIII, «Renstud», XX, 2006, pp. 1-34: 6-10; sulla lettera: ibid., pp. 8-10 (con ripr. fotograf. dell’originale).
I documenti grafici prossimi alla scoperta concordano con i resoconti epistolari e consentono di individuare con precisione le parti mancanti. si tratta, è bene ricordarlo, di un manipolo di disegni e incisioni sor-prendentemente esiguo a paragone della massa di immagini di ogni tipo prodotte dopo il 1520: quasi che, a dispetto della fama istantanea, il Laocoonte entrasse nel novero delle opere antiche che un artista aggior-nato non poteva non conoscere solo dopo un certo tempo.
Il primo testimone è un disegno anonimo del Kunstmuseum di düsseldorf reso noto da Mathias Winner oltre trent’anni fa (ds 1, fig. 2)4. Riconducibile ad un disegnatore dell’Italia settentrionale – non però giovanni antonio da Brescia, al quale è stato recentemente attri-buito (infra, p. 11) – il foglio è parzialmente obliterato da una tarda spennellatura ad acquerello blu che non ne facilita la lettura. Una data tracciata a penna sul verso da una mano antica, 1508, costituisce un plausibile termine ante quem. due nomi accanto alla data, Domenico Pisano e Michele di Credi di Aristotele, scritti con inchiostro di iden-tico colore, potrebbero essere quelli dei proprietari nel momento in cui l’iscrizione è stata apposta, ma non dicono nulla di più.
Il gruppo è rappresentato prima della collocazione sulla grande base marmorea che lo ospita tuttora. L’altare e il piede sinistro di Lao- coonte sono puntellati da frammenti di marmo; il figlio maggiore, sepa-rato dalle altre figure, è tenuto in equilibrio da piccoli blocchi incastrati sotto la caduta del manto. Nelle figure sono visibili poche lacune: il braccio destro, il membro virile e l’alluce sinistro del padre; il braccio destro e la parte inferiore della gamba destra del figlio minore (non le dita del piede, conservate assieme all’altra gamba); le dita della mano destra, l’alluce sinistro e probabilmente alcuni brandelli del manto del figlio maggiore5. È probabile che il Laocoonte si trovasse in questo stato poco dopo il trasporto in Vaticano. se però il disegno preceda o segua la collocazione nella nicchia costruita di fronte alla porta d’ingresso del Cortile, avvenuta il 1 giugno 1506, è impossibile dire6.
4 per la bibl.: app., ds 1. per quanto segue: M. Winner, Zum Nachleben des Laokoon in der Renaissance, «JahrBerlMus», XVI, 1974, pp. 82-121: 99-102.
5 La più accurata recensione delle lacune e dei restauri (seppure in parte supe-rata dal ripristino di Filippo Magi del 1957-1959): W. amelUng, Die Skulpturen des Vatikanischen Museums, II, Berlin, in Komm. bei georg Reimer, 1908, nrr. 74, 74a, 74b, pp. 181-205: 181-184.
6 per la storia dell’esposizione delle sculture antiche, e in particolare del Lao- coonte, nel Cortile ottagono: a. miCHaelis, Geschichte des Statuenhofes im Vaticanischen Belvedere, «JdI», V, 1890, pp. 5-72: 16 s.; J.s. aCkermann, The Belve-dere as a classical villa, «JWCI», XIV, 1951, pp. 78-90; g. daltrop, Zur Aufstellung antiker Statuen in der Villetta di Belvedere des Vatikans, «Boreas», VI, 1983, pp. 217-232: 220 s.; U. geese, Antike als Programm. Der Statuenhof des Belvedere im Vatikan,
Il braccio mancante8
Vale la pena di osservare che, come il disegno mostra inequivo-cabilmente, la testa del serpente che addenta Laocoonte al fianco era integra. poiché essa manca nelle riproduzioni a partire dalla metà circa del Cinquecento e ricompare solo verso il 1720, dopo essere stata restituita da agostino Cornacchini nel secondo decennio del XVIII secolo (infra, pp. 53 ss.), molti studiosi la ritengono un’invenzione del restauratore settecentesco, dubitando dell’esattezza del suo posizio-namento. Il particolare è invece genuino: a parte uno spostamento di pochi millimetri rispetto al punto di frattura (infra, p. 56), Cornacchini ha ricollocato la testa al suo posto, ricostruendola con notevole fedeltà, a quanto è dato di vedere dai disegni. I numerosi tentativi di restituire il gruppo altrimenti che nella forma canonica, con un andamento delle spire del serpente più complesso, la testa del mostro culminante vici-no alla testa di Laocoonte, nascono da un equivoco e sono del tutto immotivati7.
Il disegno deve essere messo a confronto in primo luogo con la stampa di giovanni antonio da Brescia (ds 7, fig. 3), incisore man-
in Natur und Antike in der Renaissance, Liebighaus, Museum alter plastik, Frankfurt a. M., 5 dez. 1985 - 2 Mär. 1986, hrsg. v. H. Beck, p.C. Bol, Frankfurt a. M., Hassmüller, 1985, pp. 24-50; g. daltrop, Antike Götterstatuen im Vatikan. Die vatikanische-römische Tradition der klassischen Archäologie, Basel und Frankfurt a. M., Lang, 1987; a. nesselratH, Il Cortile delle Statue. Luogo e storia, in Il Cortile delle statue. Der Statuenhof des Belvedere im Vatikan, akten d. intern. Kongr. zu Ehren v. Richard Krautheimer, Roma, Bibl. Hertziana, d.a.I., Musei Vaticani, 21 - 23 ott. 1992, a c. di M. Winner, B. andreae, C. pietrangeli (†), Mainz, von Zabern, 1998, pp. 1-16.
7 Una discussione delle proposte più antiche in E. vergara Caffarelli, Studio per la restituzione del Laocoonte, «RIa», n.s., III, 1954, pp. 29-70: 36 s. Inoltre, a mia conoscenza: s. ferri, Aspetti ipotetici di un ulteriore restauro del gruppo del Laocoonte, «archCl», II, 1950, pp. 66-69; s. HoWard, On the Reconstruction of the Vatican Laocoon Group, «aJa», LXIII, 1959, pp. 365-369; H. siCHtermann, Der wiederhergestellte Laokoon, «gymnasium», LXX, 1963, pp. 193-211; p. Åström, Suggerimento per una nuova ricostruzione del Laocoonte, «Collsod», s. ii, II, 1968-1970, pp. 11-20; s. HoWard, Laocoon rerestored, «aJa», LXXXXIII, 1989, pp. 417-422; B. Blomë, p. Åström, The Laocoon-group: a tentative reconstruction, stockolm, svenska Institutet i Rom, 1994. Un tentativo è stato compiuto anche da e. simon, Laokoon und die Geschichte der antiken Kunst, «aa», IC, 1984, pp. 643-672. Ma il gioco di competere con gli scultori antichi nell’invenzione di un Laocoonte diverso e, possibilmente, più bello dell’antico è ben precedente alla nascita dell’archeologia moderna: v. ad es. i gruppi di Vincenzo de’ Rossi, 1560-1565 (d. Heikamp, Die Lao- koongruppe des Vincenzo de’ Rossi, «MKIF», XXXIV, 1990, pp. 343-378) e adrien de Vries, 1623 (F. sCHolten, Adrien de Vries (1556-1626) Imperial Sculptor, with con-trib. by R. Mulcahy et al., amsterdam, Rijksmuseum; stockholm, Nationalmuseum; Los angeles, J.p. getty Museum, 1998, pp. 237-239, nr. 41; v. anche L.o. larsson, Imitatio and aemulatio. Adrien de Vries and the classical sculpture, ibid., pp. 52-58: 53). In generale: L. reBaUdo, Per la fama di Laocoonte, «pdp», LIX, 2004, pp. 55-72: 67-72, con ulter. indicazioni e bibl.
I restauri 9
tegnesco dalla biografia oscura ma dalla produzione relativamente abbondante8. Nonostante due fogli sicuramente più antichi di ambito fiorentino o senese, già attribuiti a Jacopo sansovino, ora oscillanti fra il sodoma e Fra Bartolomeo (ds 3, 4, fig. 9), la stampa di giovanni antonio (fig. 3) è il solo documento che, come il disegno di düsseldorf (fig. 2), riproduce il gruppo prima del consolidamento. La somiglianza fra le due immagini è notevole: si conferma l’assenza delle braccia delle figure principali e delle quattro dita lunghe della mano del figlio maggiore, di cui peraltro la stampa documenta la posizione mal leggibile nel disegno, cosicché il gesto della mano ruotata verso lo spettatore si può considerare sicuro. Confermata è anche la peculiare rottura della caviglia del figlio minore e l’esistenza delle altre lacune, in particolare dell’alluce sinistro e del membro virile di Laocoonte.
Nonostante la situazione conservativa del gruppo simile se non identica, la stampa sembrerebbe più tarda del disegno di circa un decennio. Ragioni tecniche e stilistiche impongono di assegnare il Laocoonte alla maturità di giovanni antonio. Il tratteggio incrociato, che non compare prima del 1515 circa, e l’esecuzione estremamente lineare, difficile da riscontrare nelle incisioni più antiche, indicano il quinquennio 1515-1520 come la più verosimile delle collocazioni cronologiche9. del resto l’artista sembrerebbe essersi trasferito a Roma solo fra il 1510 e il 1513, gli anni del passaggio dalla maniera giovanile a quella della maturità: passaggio che potrebbe essere stato innescato appunto dalle nuove esperienze romane e dal contatto con agostino Veneziano. se la fondamentale Flagellazione di Cristo (Hind V, 40, nr. 13), datata 1509, mostra ancora inequivocabili i segni dello stile del periodo mantovano, le prime stampe a soggetto archeologico, la Venere ispirata al gruppo della Venus Felix (Hind V, 41, nr. 14) e il
8 per gli scarni dati biografici: Giovanni Antonio da Brescia, in Early Italian Engravings from the National Gallery of Art, ed. by J.a. Levenson, K. oberhuber, J.L. sheerman, Washigton dC, National gallery of art, 1973, pp. 235-237; Giovanni Antonio da Brescia, in The ill. B. 25 (1984), p. 335 s. (M. zUCker); Giovanni Antonio da Brescia, in DA, XII (1996), p. 698 (red.).
9 Così M. zUCker, sch. nr. 029, in The ill. B. 25, p. 352; J.a. levenson, sch. nr. 97, in Early Italian Engravings, cit., p. 252; Giovanni Antonio da Brescia, in DA, cit., p. 698 (red.); F. QUeyrel, Une nouvelle image du Laocoon, «REa», VC, 1993, 1-2, pp. 301-315: 304 s. di contro, H.H. BrUmmer, The Statue-Court in the Vatican Belvedere, stockholm, almquist & Wiksell & p.a. Norstedt & söner, 1970, p. 82: «perhaps the earliest acconunt of the group after its exhumation»; così anche H.-W. krUft, Metamorphosen des Laokoon. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschmacks, «pantheon», LXII, 1984, pp. 3-11: 3 s. (1506 ca); m. kosHikaWa, sch. nr. 48, in High Renaissance in the Vatican. The Age of Julius II and Leo X, tokio, National Museum of Western art, 21 sept. - 28 Nov. 1993, a c. di M. Koshikawa, M.J. McCormack (Engl. text suppl.), tokio, the National Museum of Western art & NtN Corp., 1993 (testi in lingua inglese, senza apparato iconografico), p. 65 s.
Il braccio mancante10
Torso del Belvedere (B. XXIV, 100, nr. 5), che si suppongono eseguite a Roma, segnano una transizione verso il nuovo stile. E al nuovo stile il Laocoonte, come si è detto, già pienamente appartiene.
tuttavia la cronologia avanzata della stampa non implica neces-sariamente che l’immagine rifletta lo stato del gruppo alla fine del secondo decennio. Le abitudini di giovanni antonio, incline per tem-peramento a riprodurre invenzioni altrui più che a elaborare soggetti originali, rendono probabile la dipendenza da un modello, che potrebbe anche precedere la stampa di diversi anni10. Nikolaus Himmelmann e arnold Nesselrath hanno creduto di individuare questo modello nel disegno di düsseldorf (ds 1, fig. 2), che Nesselrath assegna allo stesso giovanni antonio11. Ma dallo scorcio della base vicino al piede di Laocoonte si capisce che il disegnatore ha ritratto il gruppo da una posizione ruotata verso destra e lievemente ribassata rispetto all’inci-sore12. Neppure l’anatomia dei figli (specie del minore), la posizione della testa del fanciullo più grande, la capigliatura del padre e il chiaro-scuro delle pieghe del manto coincidono. se pensiamo alla meccanica fedeltà con cui giovanni antonio copiava i suoi modelli, al punto che nelle sue tavole non solo i particolari minimi ma anche lo stile del dise-gno di partenza si leggono limpidamente, possiamo escludere che egli abbia riprodotto il foglio di düsseldorf13. al contrario, l’uno e l’altra testimoniano lo stato del monumento dopo la scoperta e si sostengono a vicenda. purtroppo, se il disegno (fig. 2) è abbastanza precisamente datato (1506-1508), la stampa (fig. 3) lo è solo in maniera piuttosto ‘larga’ (1515-1520), e il disegno da cui essa dovrebbe dipendere non
10 In proposito: zUCker, l. cit. e pp. 335-338; levenson, l. cit.11 N. Himmelmann, Laokoon, «antK», XXXIV, 1991, pp. 97-115: 97 s.; a.
nesselratH, sch. nr. 234, in Hoch Renaissance im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste I. 1503-1534, Bonn, Kunst- und ausstellungshalle d. Bundesrep. deutschland, 11 dez. 1998 - 11 apr. 1999, Katalogkoord. p. Krause, Bonn, Kunst- und ausstellungshalle d. Bundesrep. deutschland, 1998, p. 515.
12 Così già Winner, Zum Nachleben, cit., p. 102; g. daltrop, Die Laokoon-gruppe im Vatikan. Ein Kapitel aus der römischen Museumsgeschichte und der Antiken-Erkundung, Konstanz, Universitätsverlag Konstanz, 1982 (Xenia, Konstanzer althist. Vortr. u. Forsch., 5), p. 15.
13 Esemplare il caso delle copie da Mantegna, perfettamente fedeli: i Trionfi (B. XIII, 321, nr. 7; 322, nrr. 8-9) derivati dalla traduzione grafica del maestro medesimo (B. XIII, 235-237, nrr. 12-14), o il Cristo con i santi Andrea e Longino (B. XIII, 318, nr. 3), ricavato dalla stampa omonima (B. XIII, 231, nr. 6). altrettanto significativa l’evidenza con cui si legge lo stile di amico aspertini nei Fanciulli danzanti (B. XIII, 328, nr. 19) come nella Caccia al leone tratta dal noto sarcofago di palazzo Rospigliosi (B. XXVII, 313, nr. 416, attr. ad agostino Veneziano; The ill. B. 25, nr. 032, p. 355 s.): per quest’ultimo cf. p. BoBer, Drawings after the Antique by Amico Aspertini, London and Leiden, Brill, 1957, p. 38, n. 1.
I restauri 11
lo è affatto. Non possiamo dunque ‘usare’ giovanni antonio per affer-mare che il Laocoonte restasse frammentario fino al 1515, o addirittura fino al 1520. Non possiamo, però, neppure escluderlo. Limitiamoci a prendere atto che in un’immagine del secondo decennio, pur sospetta dal punto di vista documentario, il Laocoonte non mostra ancora inter-venti conservativi di rilievo.
Lo stadio successivo nella storia del gruppo è documentato dalla nota incisione di Marco dente, uno dei capolavori della grafica rina-scimentale (ds 8, fig. 4). Il Laocoonte vi appare sullo sfondo di un muro in rovina attraversato da una cornice ionica, quasi che si trovasse ancora nell’edificio antico in cui fu scoperto. Un’ambientazione di fan-tasia, incompatibile col fatto che le figure sono già installate sulla base modanata moderna, di cui si intravede nella tavola la parte superiore. La situazione del gruppo è migliorata: le figure sono state consolidate nella posizione quasi perfettamente assiale che da allora ne caratterizza l’immagine e che è certamente quella originale. Le lacune maggiori, le braccia del padre e del figlio minore, sono presenti; sembrano invece scomparse quelle di minor conto, ma è probabile che si tratti di un’inte-grazione dell’incisore piuttosto che di un restauro vero e proprio.
difficile ancora una volta fornire un dato cronologico sicuro per questa situazione. La datazione della stampa del ravennate, l’unica firmata, è assai più disputata di quella di giovanni antonio (ds 7, fig. 3). secondo taluni si tratterebbe della prima prova romana dell’artista, eseguita subito dopo l’arrivo in città nel 1515 (anche lo Spinario, la sola altra sua tavola dedicata ad una statua antica, pare essere fra i lavori più precoci)14. altri vi riconoscono modi stilistici relativamen-te avanzati, collocandola in vario modo fra il 1520 e il 152515. altri ancora la considerano opera matura, da porsi verso la fine della vita dell’artista, che notoriamente scomparve nel maggio del 1527 durante il sacco di Roma16.
Il braccio mancante12
14 argomentazioni e bibliografia: s. massari, Marco Dente, in Giulio Romano pinxit et delineavit. Opere grafiche autografe, di collaborazione e bottega (cat. d. mostra s.d. e indic. di luogo), a c. di s. Massari, Roma, palombi, 1993, p. 25 s. per una sintesi delle problematiche critiche su M. dente: e. Borea, Dente, Marco, in DBI, XXXVIII (1990), pp. 790-795.
15 ad es. J.t. spike, sch. nr. 34, in Rome and Venice. Prints of the High Renais-sance, Cambridge (ma), Fogg art Museum, ed. by K. oberhuber, Cambridge, Cambridge U.p., 1974, p. 53 s. (1520 ca); m. kosHikaWa, sch. nr. 49, in High Renais-sance (Engl. text suppl.), cit., p. 66 (1520-1525); a. gnamm, sch. nr. 176, in Roma e lo stile classico di Raffaello. 1515-1527, Mantova, gall. Civica di palazzo te, 20 mar. - 30 mag. 1999; Wien, graphische samml. albertina, 23 giu. - 5 set. 1999, a c. di K. oberhuber, a. gnann, Milano, Electa, 1999, p. 368 (1522-1525).
16 W. steadman sHeard, sch. nr. 60, in Antiquity in the Renaissance, Northamp-ton (ma), smith Coll. Museum of art, 6 apr. - 6 Jun. 1978, ed. by W. steadman
In realtà la tavola è anteriore alla primavera del 1523. Il Laocoonte era in quel momento parzialmente restaurato, essendo già state integra-te le braccia dei fanciulli ma non quello del padre (infra, pp. 17 ss.). siccome le integrazioni non compaiono nell’incisione, nonostante il ravennate completi la figura ove possibile, almeno il disegno prepara-torio deve precedere il restauro. Ma la forbice cronologica, compresa fra l’arrivo a Roma dell’artista (1515) e il restauro del gruppo (1523), mal si combina con la datazione della stampa di giovanni antonio (ds 7, fig. 3), che si colloca aprossimativamente negli stessi anni. La difficoltà, non volendo riconsiderare verso l’alto la cronologia di quest’ultima, suggerisce che gli eventi della prima fase della storia del Laocoonte, ovvero il consolidamento, l’installazione sulla base moderna e il restauro delle figure minori (di cui vedremo più avanti le circostanze), solitamente distribuiti nell’arco di almeno un decennio, possano essersi verificati a breve distanza l’uno dall’altro, o addirittura in unico momento, intorno al 1520 (infra, pp. 17 ss.).
La sequenza tradizionale dei restauri
due secoli di ricerche e di esplorazione delle fonti hanno portato ad una ricostruzione della storia dei restauri che, delineata per la prima volta da Christian gottlob Heyne alla fine del XVIII secolo e ripropo-sta in seguito da quasi tutti coloro che si sono occupati della fortuna del Laocoonte, è divenuta di fatto canonica17. Questa sequenza costituisce il nostro punto di partenza.
I restauri 13
sheard, Northampton (ma), smith Coll. Museum of art, 1978, p. 86. Le circostanze della morte di M. dente sono ricostruite da a. petrUCCi, Una vittima del Sacco di Roma, «Il Messaggero», 17 marzo 1959, p. 3. per le conseguenze del sacco sulla comunità degli artisti: a. CHastel, The Sack of Rome. 1527, Washington dC, princeton U.p., 1983, trad. ital. Il sacco di Roma. 1527, torino, Einaudi, 1983, pp. 154-161; a. gnamm, I giovani artisti a Roma dalla morte di Raffaello al Sacco di Roma, in Roma e lo stile classico, cit., pp. 31-57: 47 (M. dente).
17 [Chr.g. Heyne], Prüfung einiger Nachrichtungen und Behauptungen vom Laokoon im Belvedere, in Sammlung antiquarischer Aufsätze von Chr.g.H., zweites stück, Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich, 1779, pp. 1-52: 9-20. per la fortuna della sequenza ricostruttiva tradizionale: K. sittl, Empirische Studien über die Laokoon-gruppe, Würzburg, Kommissionverl. des städ. KB. Hof- und Universitäts-Buch- und Kunstverhandlung, 1895, p. 19 s.; BrUmmer, The Statue-Court, cit., pp. 87-101 (in parte diversa); F. Haskell, N. penny, Taste and the antique. The lure of classical sculpture 1500-1900, New Haven and London, Yale U.p., 1981, trad. ital. L’antico nella storia del gusto. La seduzione della scultura classica 1500-1900, torino, Einaudi, 1984, pp. 340-342; o. rossi pinelli, Chirurgia della memoria. Scultura antica e restauri storici, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, III, Dalla tradizione all’archeologia, a c. di s. settis, torino, Einaudi, 1986, pp. 181-250: 183 ss.; p. BoBer p[ray], r. olitsky
i. Ricostruzione del braccio di Laocoonte in cera da parte di Baccio Bandinelli. Il cardinale giulio de’ Medici affida a Baccio Bandinelli l’esecuzione di una copia in marmo del gruppo destinata a Francesco i di Valois, re di Francia. Nel corso dei lavori, fra il 1523 e il 1525, lo scultore fiorentino ricostruisce sull’originale il braccio del padre con la cera per sperimentare la soluzione da usare nella copia (vasari, Le vite, vi, pp. 146 e 632 s.).
ii. Restauro di Giovanni Angelo Montorsoli. su consiglio di Michelangelo Clemente VII affida a giovanni angelo Montorsoli, frate dell’ordine dei servi di Maria nel convento della ss. annunziata di Firenze e allievo prediletto del Buonarroti, il restauro delle prin-cipali statue del Belvedere. Montorsoli restaura di sua mano il Laocoonte e l’Apollo, e sovrintende al completamento dell’Ercole-Commodo (vasari, Le vite, vi, p. 632 s.). Le circostanze della vita di Michelangelo suggeriscono che l’intervento sia stato compiuto fra il 1532 e il 1533.
iii. Esecuzione del braccio marmoreo non finito ‘di Michelangelo’. Un braccio di marmo incompiuto destinato al Laocoonte compare in Belvedere verso il 1720. piegato e strettamente avvolto dalle spire, viene giudicato ‘antico’ dai visitatori settecenteschi. Non se ne cono-sce l’autore, ma una fortunata tradizione di museo lo attribuisce a Michelangelo. In un momento imprecisato una porzione consistente della spalla destra di Laocoonte viene tagliata appositamente per con-sentire l’installazione di questo braccio. Ma poiché i documenti grafici non rappresentano mai il gruppo con il braccio in opera se ne deduce che, nonostante la predisposizione, esso non fu mai collocato.
iv. Restauro di Agostino Cornacchini. secondo numerosi viag-giatori ed eruditi lo scultore pistoiese agostino Cornacchini, attivo a Roma dal 1712 al 1756, esegue delle nuove braccia per Laocoonte e i suoi figli. La notizia, sebbene non abbia trovato riscontri archivistici, è ritenuta attendibile dalla critica moderna. Il restauro è stato datato congetturalmente fra il 1725 e il 1727, in concomitanza con il Carlo Magno colossale del nartece di s. pietro, la più importante delle com-missioni vaticane di Cornacchini.
Il braccio mancante14
rUBinstein, Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Handbook of Sources, London, Miller, 1986, nr. 122, pp. 153-155; B. preiss, Die wissenschaftliche Beschäf-tigung mit der Laokoongruppe. Die Bedeutung Christians Gottlob Heynes für die Archäologie des 18. Jahrhunderts, Inaugural-diss. Rhein. Friedrichs-Wilhelms-Univ. zu Bonn, 1992, Bonn, Verlag u. datenbank f. geisteswiss., 1992. Cf. reBaUdo, I restauri del Laocoonte, in settis, Laocoonte, cit., pp. 231-258: 232 s.; m.r. Hofter, Laokoons Arm, in Wiedererstandene Antike. Ergänzung antiker Kunstwerke seit der Renaissance, München, Biering & Brinkmann, 2003, pp. 261-265.
v. Ripristino di Filippo Magi. Fra il 1957 e il 1959 Filippo Magi pro-cede ad un ripristino ‘filologico’ del gruppo. Vengono rimosse tutte le integrazioni moderne e viene collocato al suo posto il braccio antico che Ludwig pollak aveva scoperto nel 1905 nella bottega di uno scalpellino romano e di cui Ernesto Vergara Caffarelli nel 1954 aveva provato la pertinenza al gruppo. È questa la situazione attuale del gruppo.
a dispetto della fama consolidata, questa storia dei restauri del Laocoonte non è attendibile. gli interventi sono più numerosi dei cinque ufficialmente individuati, e alcuni di quelli noti devono essere meglio collocati nel tempo. Lo studio incrociato delle fonti e della documentazione iconografica consente di ricostruire in modo suffi- cientemente preciso lo svolgimento dei fatti.
Ipotesi virgiliane
Le fonti mostrano che fin dai primi giorni l’osservazione dei corpi dei serpenti aveva fatto intuire una ricostruzione sostanzialmente esat-ta del gruppo. testimone giovanni Cavalcanti18:
Il primo ha morso nel fianco diricto il più giovane fanciullo, et indi girandoseli al dritto braccio li riesce drieto ad le reni, et scendendo in sulla choscia diricta, deinde ritorna fra·lle ghanbe del padre el sinistro piede, et con la choda cingne la sinistra ghanba dell’altro fanciullo ad presso il tallone. Vedesi il faciullo dicto alzare alquanto la ghanba, et porre la mano sopra el nodo del serpente, per dilegarsi, simulque, chome dissi, riguarda el viso al padre quasi temendo et chiedendoli aiuto. L’altro serpente ha preso il vechio nel fiancho sinistro dove etiam lui porge la mano et fa forza di sciacciarlo [sic]; indi girandosi pigl‹i›a il magior figl‹i›uolo al braccio dextro, annodandolo nel medesimo modo che l’al-tro, dipoi rivoltasi drieto alle mani del padre, si crede che·lli avolgeva il braccio destro et con la choda la mano destra al primo fanciullo.
si era compreso che il braccio destro di Laocoonte non poteva essere libero dalle spire del serpente («si crede che·lli avolgeva il braccio destro») e che la mano, di conseguenza, doveva trovarsi vicino al capo. Ma l’aspetto della frattura e la suggestione dei versi più volte citati nei resoconti (Aen. II, 216 s.: ipsum subeuntem auxilium ac tela ferentem | corripiunt spirisque ligant ingentibus) suggeriscono subito un’altra ipotesi: che Laocoonte fosse armato di lancia e tenesse l’arma brandita sul capo per tentare di salvare i figli.
In verità Virgilio dice che Laocoonte fu a sua volta coinvolto nel mortale groviglio: un padre spiris ingentibus ligatus dovrebbe dunque
I restauri 15
18 V. supra, n. 3.
aver già perso il telum che il poeta gli aveva posto in mano. Il minia-tore trecentesco che ha illustrato il codice Vat. Lat. 2761 (fig. 5), il quale non disponeva di alcun supporto iconografico ma si sforzava di tradurre in figure il racconto dell’Eneide, ha immaginato Laocoonte pronto a colpire mentre i mostri divorano i fanciulli; ha posto invece bene in vista la lancia caduta a terra quando anche il padre diviene vittima dei serpenti19.
pure, la ricostruzione degli scopritori è in un certo modo profe-tica. tentando la combinazione del luogo poetico con l’immagine scultorea essi anticipano un problema che avrebbe acceso vani dibattiti e ispirato migliaia di pagine nei tre secoli seguenti. Ma la percezione ‘virgiliana’ non poteva reggere l’impatto con l’evidenza archeologica. E altrettanto repentinamente com’era comparsa, la lan-cia scompare dalla mano di Laocoonte, lasciando libero il campo alle congetture degli artisti20.
Un’espunzione: Jacopo Sansovino
Nel 1895 il controverso saggio di Karl sittl sul Laocoonte attirava l’attenzione su un documento da tempo pubblicato ma rimasto fino ad allora sconosciuto agli archeologi e agli storici dell’arte: la descrizione del Belvedere che gli ambasciatori della Repubblica di Venezia in- viati a dichiarare l’obbedienza al pontefice adriano VI avevano inclu-so nella relazione letta al senato veneto al ritorno dalla missione21.
In occasione dell’udienza di congedo del 28 aprile 1523 i legati avevano avuto il permesso, certo ambito, di visitare il Belvedere: nel resoconto lo descrivono dunque meticolosamente, soffermandosi soprattutto sul cortile delle statue, che era apparso loro come un magni-fico giardino pensile all’italiana, con fonti d’acqua e aiuole di aranci
Il braccio mancante16
19 Vat. Lat. 2761, c. 15. La miniatura è stata segnalata da r. förster, Laokoon im Mittelalter und in der Renaissance, «JhbpreusKs», XXVII, 1906, pp. 146-178: 154 s. e 157. V. ora settis, Laocoonte, cit., p. 67, fig. 34.
20 tenta di individuare influenze virgiliane nella tradizione iconografica moder-na, e specialmente in Michelangelo, g. maUraCH, Der vergilische und der vatikani-sche Laokoon. Mit einem anhang zu Michelangelos Laokoon-Zeichnung und tafeln i-viii, «gymnasium», XCIX, 1992, pp. 227-247.
21 sittl, Empirische Studien, cit., p. 9 s. Il testo della relazione è in Sommario del Viaggio degli oratori Veneti che andarono a Roma a dar l’obbedienza a Papa Adriano VI, in Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato, a c. di E. albéri, s. iii, III, Firenze, La Nuova Italia, 1946, pp. 77-120. La descrizione del Belvedere è ristampata in: BrUmmer, The Statue-Court, cit., p. 266; maffei, La fama di Laocoonte, cit. p. 174.
ritagliate nella pavimentazione marmorea22. Con scrupolo fanno rivi-vere ai senatori la visita, descrivendo ad una ad una le sculture antiche nell’ordine esatto in cui le hanno viste. giunti al Laocoonte, si attarda-no in una puntigliosa, esattissima e ammiratissima descrizione23.
alquanto più in là [i.e. dell’apollo], ma pure in quella faccia la quale va a volta, e in simile loco e sopra una simil base, alta da terra quanto un altare, dirimpetto a un perfettissimo pozzo, vi è il Laocoonte, per tutto il mondo celebrato, figura di grandissima eccellenza, di grandez-za d’un comune uomo, con una barba irsuta, tutto ignudo; si veggono li nodi, le vene e i proprii nervi da ogni parte, che più in un corpo vivo non si potria vedere; né gli manca che lo spirito. sta seduto con li due puttini, uno per banda; ambidui, insieme con lui, cinti dai serpenti, che dice Virgilio (ut in eo). E in questo si vede tanta eccellenza dell’arte-fice, che non si potria dir meglio; e si vede manifestamente languire e morire e si vede uno dei puttini dal lato destro, cinto strettissimamente a traverso dal biscione, ben due volte intorno, una delle quali gli tra-versa le tettine e stringegli sì il cuore, che vien morto, l’altro puttino a mano sinistra, cinto ancor lui da un altro biscione, volendosi tirare dalla gamba col suo braccietto il rabido serpente, né potendosi per modo alcuno aiutare, sta con la faccia lagrimosa, gridando verso il padre, e tenendolo con l’altra mano pel braccio sinistro. E veggendo il misero padre più acerbamente percosso che lui, si scorge in questo puttino il doppio dolore: l’uno è per vedersi la morte propinqua, l’altro perché il padre non lo può aiutare; e sì languisce, che poco gli manca a mandar fuora lo spirito. È impossibile che arte umana arrivi a fare tanta opera e così naturale. ogni cosa è integra, salvo che al Laocoonte manca il braccio destro.
Le sorprendenti ultime parole, «ogni cosa è integra, salvo che al Laocoonte manca il braccio destro», contraddicono le fonti e i disegni più antichi (ds 1, 7, 8, figg. 2-4), dai quali risulta che al gruppo manca-vano, oltre al braccio del padre, quello del fanciullo più giovane e parte della mano del maggiore. Quasi tutti gli studiosi hanno ritenuto l’affermazione poco significativa, interpretandola come una svista o una sorta di reticenza, quasi che i legati avessero voluto ricordare solo la lacuna principale, l’unica significativa. È invece chiaro che la
I restauri 17
22 per la storia dell’evoluzione architettonica del Cortile in relazione all’espo- sizione delle sculture: a. nesselratH, Il Cortile della Statue. Luogo e storia, in Il Cortile delle Statue, cit., pp. 1-16; C.l. frommel, I tre progetti bramanteschi per il Cortile del Belvedere, ibid., pp. 17-66; p. liverani, Geschichte des Cortile Ottagono im Belvedere, in B. andreae, k. anger, m.g. granino et al., Museo Pio Clementino. Cortile Ottagono, a c. di J. Köhler, ed. B. andreae, Berlin und New York, de gruyter, 1998, pp. v-xv. In prec. è classico miCHaelis, Geschichte, cit., pp. 5-72.
23 Sommario, cit., p. 116; BrUmmer, The Statue Court, cit., p. 266; maffei, La fama di Laocoonte, cit., p. 176.
pignoleria con cui quei funzionari notano ogni particolare esclude che abbiano taciuto per eccesso di brevitas mancanze come il braccio e la mano dei fanciulli. Il braccio ricadente del figlio minore è fondamen-tale per l’interpretazione della figura come morente in contrappunto a quella del fratello dolente sulla quale essi tanto insistono, anticipando in parte una lettura che l’aretino avrebbe reso popolare24. La mano destra del figlio minore è ricordata come appoggiata al braccio del padre: particolare piuttosto strano ma sufficiente ad assicurarci che i legati videro qualcosa di diverso dal moncone disegnato dagli artisti dopo la scoperta (figg. 2-4). Risulta ovvio, insomma, che l’estensore del testo se scrive «ogni cosa è integra» vuole essere preso alla lettera e intende, appunto, ogni cosa, salvo il braccio di Laocoonte.
Come spiegare l’incongruenza? Karl sittl ipotizzava che nel perio-do fra la tavola di Marco dente (ds 8, fig. 4) e la visita dei veneziani il Laocoonte fosse stato completato parzialmente con la reintegrazione delle braccia dei figli. Ipotesi apparentemente fragile, come tutti gli argomenti ex silentio, ma non facilmente eludibile, dal momento che l’affermazione degli ambasciatori deve pur trovare una spiegazione. sittl purtroppo screditava la sua intuizione tentando di associare il restauro, su basi questa volta sì davvero fragili, ad un noto episodio de Le vite vasariane. secondo Vasari (Le vite, vi, p. 146) l’allora giova-nissimo Jacopo sansovino avrebbe primeggiato in una gara voluta da Bramante per l’esecuzione di una copia in cera del Laocoonte (Cr 1):
Bramante, architetto anch’egli di papa Iulio, ch’allora teneva il primo luogo e abitava in Belvedere, visto de’ disegni di questo giovane [i.e. Jacopo sansovino] [...] gli ordinò che dovesse ritrar di cera grande il Laocoonte, il quale faceva ritrarre anco da altri per gettarne poi uno di bronzo; cioè da Zaccheria Zacchi da Volterra, da alonso Berugetta spagnuolo, e dal Vecchio da Bologna; i quali, quando tutti furon finiti, Bramante fece vederli a Raffaello sanzio da Urbino, per sapere chi si fusse di quattro portato meglio. Là dove fu giudicato da Raffaello che il sansovino così giovane avesse passato tutti gli altri di gran lunga; onde poi per consiglio di domenico cardinal grimani fu a Bramante ordinato che si dovesse gittar di bronzo quel di Iacopo: e così, fatta la forma, e gettatolo di metallo, venne benissimo.
Entrato Jacopo tanto autorevolmente in contatto con il Laocoonte, argomentava sittl, è molto probabile che sia stato autorizzato da giulio II e Bramante a completare il gruppo originale, tanto più che secondo Vasari fu anche restauratore di statue antiche. Ma il completamento sarebbe stato solo parziale, avrebbe cioè riguardato le braccia dei figli
Il braccio mancante18
24 maffei, La fama di Laocoonte, cit., iv.C.17, p. 203 s. (p. a., in Venezia, a sebastiano Fausto da Longiano, 17 dic. 1537); reBaUdo, Per la fama, cit., p. 65 s.
ma non quello del padre, troppo impegnativo per uno scultore così giovane e non ancora abbastanza esperto25.
Un’ipotesi siffatta, che dalla modellatura di un bronzetto deduce un restauro, e nel restauro immagina una gerarchia delle riparazioni in rapporto all’età del restauratore, suona quanto meno capziosa e arbi-traria. Non sorprende che i recensori si siano concessi commenti sar-castici e abbiano bollato il libro come un esempio del modo in cui uno studioso serio non dovrebbe procedere. Richard Förster, il più autore-vole (e severo) fra costoro, al vituperio ha fatto seguire anche alcune precise obiezioni: se Vasari fosse stato al corrente di un intervento tanto importante non avrebbe attribuito genericamente al sansovino il restauro di alcune statue antiche ma avrebbe esplicitamente men-zionato il Laocoonte; inoltre avrebbe ricordato questo precedente al momento di riferire del successivo restauro del Montorsoli26.
Questi argomenti, come l’ipotesi cui reagiscono, sono tutto somma-to poco significativi. se valgono a negare l’inutile chiamata in causa del sansovino, non bastano a dimostrare che il rifacimento delle brac-cia dei figli sia un’invenzione. È evidente che Vasari nulla sapeva di un restauro di Jacopo al Laocoonte, né il suo racconto fornisce alcun appiglio per ipotizzarlo, ma è parimenti evidente che altri videro e descrissero quelle braccia prima che Montorsoli restaurasse il gruppo (infra, pp. 42 ss.). Inevitabile dunque che, dopo un lungo accantona-mento cui il discredito del libro di sittl ha contribuito, l’ipotesi del restauro parziale tornasse prima o poi ad affacciarsi. La troviamo for-mulata con diversi argomenti e con maggior respiro, ma ancora sulla base del passo vasariano, in un fortunato articolo di adriano prandi dell’inizio degli anni Cinquanta27.
Convinto che il ‘concorso’ bramantesco non potesse essere stata «una pura esercitazione di copia» perché la modellatura di un Laocoonte in miniatura non avrebbe giustificato un racconto tanto circostanziato, prandi ipotizzò che gli artisti avessero integrato nei loro modelli le lacune dell’originale, producendo le prime immagini complete del Laocoonte. da questa premessa, indimostrabile ma non assurda, prandi giunge a concludere che «il sansovino reintegrò, forse
I restauri 19
25 sittl, Empirische Studien, cit., p. 3. sulle vicende della copia bronzea rica-vata dal modello del sansovino, prima in proprietà di domenico grimani, poi nelle collezioni del card. Jean de guise, infine dispersa, v. infra, parte II, Cr 1 con bibl. per un riassunto puntuale delle vicende collezionistiche: B. BoUCHer, The sculpture of Jacopo Sansovino, London and New Haven, Yale U.p., 1991, II, p. 361, nr. 83.
26 r. förster, Laokoon, «JdI», XXI, 1906, pp. 1-32: 3, con bibl.27 a. prandi, La fortuna del Laocoonte dalla sua scoperta nelle terme di Tito,
«RIa», n.s., III, 1954, pp. 78-107.
in gesso, le braccia dei figli e il braccio del padre», e che tali braccia costituiscono «il restauro più fedele alla verità archeologica, come attestano le incisioni anteriori al 1533 confrontate con il restauro odierno»28. Il dipanarsi del ragionamento che nel saggio conduce a queste conclusioni, e ancor più il fatto che esso abbia persuaso tanti lettori accorti nel corso dei decenni, continua a stupire chi scrive.
dopo aver prudentemente affermato che «sarebbe forse eccessivo [...] far discendere dalla narrazione vasariana l’attribuzione al sanso- vino di un vero e proprio restauro nel senso moderno della parola»29, prandi si chiede se siano esistiti disegni e stampe perduti che possano aver diffuso la conoscenza del Laocoonte fra gli artisti della penisola prima del restauro di Montorsoli (infra, pp. 42 ss.). per quanto ne sap-piamo le stampe anteriori al 1533 sono due: le tavole in rame di gio- vanni antonio da Brescia (ds 7, fig. 3) e di Marco dente (ds 8, fig. 4), entrambe con il gruppo mutilo. dopo il ravennate nessun incisore ha mandato Laocoonte sotto il torchio prima del 1539, quando Eurialo d’ascoli ne fece intagliare uno piuttosto fantasioso per le Stanze sopra la statua del Laocoonte (ds 39)30, e la prima stampa fededegna è addirittura la silografia della Urbis Romae Topographia di Bartolomeo Marliani del 1544 (ds 40, fig. 23). Ma appena qualche pagina più avanti, con un salto argomentativo che ha della petitio principii, prandi trasforma la sua ipotesi delle stampe perdute con il gruppo restaurato in arbitrario dato di fatto, proseguendo il discorso come se la loro esistenza fosse un fatto pacifico e acclarato31. tali stampe divengono allora i testimoni che «ripetono, con innegabile coerenza, il braccio quale fu modellato dal sansovino» e, dunque, le prove documentali dell’esistenza del restauro32. Non conosco altri casi in cui un’ipotesi dimostri se stessa con tale spudorata e forse inconsapevole naturalezza, e senza che nessuno per lungo tempo si accorgesse dell’incongruenza. Ma è pur vero che per individuare la frattura del ragionamento occorre leggere e rileggere il testo, tanto essa si nasconde nelle discontinuità di uno stile ambiziosamente variato, che tende alla prosa d’arte.
ovviamente l’aspetto del braccio sansovinesco è rintracciato non nelle stampe, che né esistono né mai sono esistite, ma in alcune precoci (e presunte) deduzioni iconografiche dal Laocoonte, che dalle stampe
Il braccio mancante20
28 prandi, La fortuna, cit., p. 102.29 prandi, La fortuna, cit., p. 82.30 Un estratto (ott. 1-8) in maffei, La fama di Laocoonte, cit., pp. 138-140. Com-
menta brevemente la xilogr. del frontespizio s. desWarte-rosa, Francisco de Hollan-da et le Cortile del Belvedere, in Il Cortile delle Statue, cit., pp. 389-410: 394-398.
31 Ibid., p. 83.32 Ibid., p. 88.
sarebbero derivate e ne tramanderebbero il particolare connotante: il braccio destro ripiegato sul capo. prandi menziona lo Zeus della Fucina di Vulcano di antonio Lombardo per lo ‘studio di marmi’ di Ferrara (fig. 6); il Cattivo ladrone della Deposizione dalla Croce di Baccio Bandinelli33; il Giuseppe della formella con Giuseppe che interpreta i sogni del fornaio e del coppiere del faraone di Niccolò tribolo sulla facciata di s. petronio34; la notissima xilografia con Laocoonte e i figli trasformati in scimmie attribuita a Niccolò Boldrini su disegno di tiziano35. Con le loro braccia variamente atteggiate ma comunque mai tese, queste citazioni dimostrerebbero che a partire dal 1508 circa un ‘Laocoonte a braccio piegato’ era noto agli artisti italia-ni: il Laocoonte appunto restaurato dal sansovino.
Fin qui prandi. può, certo, sembrare inutile discutere tanto in det-taglio un’ipotesi dai presupposti così paradossali, ma la fortuna del saggio è stata, l’abbiamo detto, lunga e tenace, e ha generato equivoci periodicamente riproposti dai quali è indispensabile sgombrare il cam-po. Mettiamo allora in chiaro alcuni punti. L’esistenza di un braccio di Jacopo sansovino è una mera ipotesi e necessita di due presupposti altrettanto ipotetici: a) che il Laocoonte della gara bramantesca (Cr 1) fosse completato delle braccia mancanti; b) che il gruppo antico sia stato restaurato sulla base delle soluzioni sperimentate nella copia.
I restauri 21
33 M.g. Ciardi dUpré, Il modello originale della ‘Deposizione’ del Bandinelli per Carlo V, in Festschrift Ulrich Middeldorf, hrsg. v. a. Kosegarten, p. tiegler, Berlin, de gruyter, 1968, pp. 269-275; J.-r. gaBorit, Un relief du musée des Beaux-Arts d’Orleans: la Flagellation par Baccio Bandinelli, «Bsocantiq», 1994, pp. 146-152: 147, con bibl.
34 L. sigHinolfi, Nicolò Tribolo e le sculture delle porte minori di S. Petronio, Modena, Ferraguti, 1910, pp. 48-51. per una messa a punto recente: M. ferritti, Niccolò Tribolo, in Scultori del Cinquecento, a c. di stefano Valeri, Roma, Lithos, 1998, pp. 69-90.
35 L’invenzione è attribuita a tiziano da Carlo Ridolfi (1648); l’intaglio è per comune opinione del vicentino Niccolò Boldrini (1500 ca - post 1566), supposto inci-sore di disegni tizianeschi, uno solo dei quali documentato; interpretazione e datazione sono controverse: v. Tiziano e la silografia veneziana del Cinquecento, a c. di M. Muraro e d. Rosand [Venezia, Fondazione giorgio Cini, s.d.], Vicenza, Neri pozza, 1976, sch. nrr. 49, pp. 110-114 e 78, p. 137. In materia di cronologia prevale oggi l’opi-nione che colloca disegno e intaglio nel quinto decennio del Cinquecento: Y. mina- gaWa, sch. nr. 68, in High Renaissance (Engl. text suppl.), cit., p. 68. si noti però che all’altezza cronologica proposta non era più possibile osservare il gruppo dal punto di vista scelto dal disegnatore, con le figure al livello del suolo, in quanto esso era da tempo installato sull’imponente base documentata per la prima volta nell’incisione di Marco dente (ds 8, fig. 4), la cui cronologia oscilla fra il 1515-1516 e il 1523 (supra, p. 12 s.). Le immagini che riproducono il Laocoonte senza basamento sono in gene-rale anteriori al 1520 (ds 1-7, figg. 1-2). Eccezione significativa, lo schizzo di amico aspertini nel taccuino detto London I (ds 26, fig. 20), dell’inizio degli anni trenta.
ora, che il bronzetto del sansovino avesse o meno le braccia è que-stione accademica: entrambe le circostanze sono possibili. Esistono piccole repliche integrate e altre con le lacune: il Laocoonte inv. 427B del Museo del Bargello (Cr 6, fig. 7), uno dei più precoci e qualitati-vamente migliori, già attribuito ad antonio Elia e per molti accreditato pretendente al ruolo di ‘Laocoonte del sansovino’, è privo di brac-cia36. Quanto al restauro, non ne esiste la più piccola traccia nella tradizione grafica. prandi aggira il problema puntando sulle deduzioni che presupporrebbero un Laocoonte ‘a braccio piegato’. Ma, a parte la xilografia di Boldrini, solo il rilievo di antonio Lombardo (fig. 6) ha diritto di figurare nel catalogo delle riprese del Laocoonte37. Il Ladrone di Baccio e il Giuseppe del tribolo dipendono da altri model-li: il Marsia scorticato e i numerosi morenti delle scene di battaglia o di miti cruenti come la Strage dei Niobidi, se non semplicemente san sebastiano38. E il Giove di antonio Lombardo fa parte, con il Cristo della Flagellazione in argento attribuita al Moderno (fig. 8), di un piccolo gruppo di rielaborazioni del Laocoonte in cui la soluzione del braccio piegato è individuata autonomamente dai diversi artisti39.
Il braccio mancante22
36 L’identificazione, già assai fortunata (g. mariaCHer, in Alvise Cornaro e il suo tempo, padova, Loggia e odeo Cornaro, sala del palazzo della Ragione, 7 set. - 9 nov. 1980, padova, Comune di padova, 1980, p. 250, con bibl.), è ora generalmente, e a ragione, respinta: g. agosti, sch. nr. 16, in Michelangelo e l’arte classica, Firenze, Casa Buonarroti, 15 apr. - 15 ott. 1987, a c. di g. agosti, V. Farinella, Firenze, Cantini, 1987, p. 57; BoUCHer, The sculpture, cit., II, nr. 83. Lo stesso bronzetto è stato in anni più lontani identificato con la copia del milanese antonio Elia menzionata in una lettera di giovanni Caradosso al duca alfonso I d’Este (Cr 4): a. VentUri, Il gruppo del Laocoonte e Raffaello, «archstarte», II, 1889, pp. 97-112: 107 ss.
37 W. steadman sHeard, Antonio Lombardo’s reliefs for Alfonso d’Este’s Studio di Marmi: their significance and impact on Titian, in Titian 500, a c. di J. Manca, «stHistart», XLV, 1993, pp. 314-357; M. isHii, Antonio Lombardo e l’antico: qualche riflessione, «artVen», LI, 1997, pp. 6-19: 13; a. sarCHi, Per Antonio Lombardo: fortuna e collezionismo. I rilievi per Alfonso d’Este, «artLomb», n.s., CXXXII, 2001, pp. 48-58; Il Camerino d’alabastro. Antonio Lombardo e la scultura all’antica, a c. di M. Ceriana, Cinisello Balsamo e Milano, silvana Editoriale, 2004 (Gli Este a Ferrara, coord. a. Rossetti, R. Cerri et al., 3).
38 per la fortuna (abbastanza significativa) del tipo del Marsia scorticato nella scultura e nella pittura dei decenni a cavallo fra Quattro e Cinquecento: F. Caglioti, Due ‘restauratori’ per le antichità dei primi Medici: Mino da Fiesole, Andrea del Ver- rocchio e il ‘Marsia rosso’ degli Uffizi. I, «prospettiva», 72, nov. - dic. 1993, pp. 17-42; id., Due ‘restauratori’ etc. II, «prospettiva» , 73-74, gen. - apr. 1994, pp. 74-96.
39 sulla Flagellazione: m. leitHe-Jasper, sch. nr. 25, in Renaissance Master Bronzes from the collection of the the Kunsthistorisches Museum Wien, smithsonian Institution traveling Exhibition serv. (Washington d.C., National gallery of art et alias), ed. by M. Leithe-Jasper, London, scala Books (in ass. with the smithsonian Inst. trav. Exhib. serv., Washington d.C.), 1986, pp. 125-127.
Queste braccia, molto diverse l’una dall’altra, derivano da una corretta percezione dello schema della figura e forse, in qualche caso, dall’autopsia. poiché se si esamina il Laocoonte da vicino, come ave-vano fatto i primi testimoni e come era ancora agevole fare prima della collocazione sul basamento moderno, si scorge fra i capelli del padre, accanto all’orecchio, «una mancanza di marmo cagionata da rottura che in linguaggio artistico si direbbe strappo»40. dalla frattura, che anche Canova avrebbe notato, si poteva dedurre che il braccio origina-le convergeva verso il capo e che il braccio stesso, la mano o una spira del serpente toccavano in quel punto. E forse lo ‘strappo’ spiega una delle soluzioni più inusuali ed estreme per il braccio di Laocoonte: la mano appoggiata al capo in segno di disperazione di amico aspertini (ds 26, fig. 20).
si deve aggiungere, se ve ne fosse bisogno, che un disegno degli Uffizi da lunga data attribuito al sansovino, stilisticamente collocabile in ambito toscano non oltre l’inizio del secondo decennio (ds 3, fig. 9), mostra una soluzione del tutto opposta: un braccio levato, ener-gicamente disteso verso l’alto, in linea con la futura interpretazione montorsoliana di Laocoonte che lotta contro il proprio destino41. In verità per sapere quanto esso sia significativo ai fini del nostro discorso bisognerebbe risolvere la complessa questione attributiva, che lo vede oscillare fra sansovino, il sodoma e la cerchia di Fra’ Bartolomeo42. Ma se il disegno fosse di Jacopo come molti credono, e come credeva prandi, dimostrerebbe che il giovane scultore aveva optato per una soluzione ben diversa da quella che gli viene attribuita e che ha ali-mentato tanta confusione. La pietra tombale sull’assurda ipotesi del ‘braccio piegato’ di sansovino.
I restauri 23
40 g. de rossi, Lettera sopra il restauro di un’antica statua di Antinoo, e sopra il restauro degli antichi marmi nei tre secoli precedenti al nostro, «Nuovo giornale de’ Letterati», XIII, 1826, pp. 23-38: 26.
41 per la bibl.: parte II, ds 3.42 Convince soprattutto il confronto con un Sacrificio d’Isacco (gall. d. Uffizi,
gab. disegni e stampe, inv. 1455F) disputato fra Jacopo (m.d. garrard, The Early Sculpture of Jacopo Sansovino. Florence and Rome, phd diss., Baltimore, the John Hopkins Univ., 1969, ann arbor (mi), UMI, 1970, p. 110 s.;) e il sodoma (E. petrioli tofani, cit. da a. de marCHi, sch. nr. 179, in Domenico Beccafumi e il suo tempo, siena, pinacoteca Naz., 16 giu. - 16 set. 1990, Milano, Electa, 1990, p. 511). L’anatomia delle figure, il contorno, le ombre a linee parallele e certi particolari come le dita dei piedi e le ginocchia consentono di riferire i fogli alla medesima mano. C. Cordellier, sch. nr. 73, in D’aprés l’antique, paris, Musée du Louvre, 16 oct. 2000 - 15 jan. 2001, comm. de l’exp. J.-p. Cuzin, J.-R. gaborit, a. pasquier, paris, Réunion d. Mus. Nationaux, 2000, pp. 235-237: 236 ripropone il nome di Jacopo. altrimenti M. Winner, La collocazione degli dei fluviali nel Cortile delle Statue e il restauro del Laocoonte del Montorsoli, in Il Cortile delle Statue, cit., pp. 117-128: 127: Fra’ Bartolomeo.
Baccio Bandinelli?
Le divagazioni attorno al presunto restauro sansovinesco non devono farci dimenticare il problema principale: l’affermazione degli ambasciatori veneti che «ogni cosa è integra salvo che al Laocoonte manca il braccio destro» (supra, p. 17 s.). Che cosa hanno visto quegli osservatori meticolosi? Nulla di diverso da ciò che dicono: il gruppo restaurato in parte, il braccio e la mano dei figli ricostruiti, il braccio del padre mancante.
diversi documenti grafici mostrano che per un certo periodo il gruppo si presentò in questo modo. Una veduta del Belvedere sco-perta da Mathias Winner (ds 31, fig. 10), l’unica che si conosca nel Cinquecento, mostra il cortile dall’angolo nord-est, pressapoco dalla nicchia-fontana in cui era allora collocata la Cleopatra-Arianna dormiente acquistata da giulio II43. dietro il Tevere e il Nilo, che campeggiano maestosi al centro sulle loro basi con le armi medicee, il Laocoonte è nella sua «cappella», che dalla pianta del Belvedere con-servata alla King’s Library di Londra (fig. 11) sappiamo trovarsi leg-germente spostata verso est rispetto all’asse centrale. Il particolare, per quanto minuto, è nitidissimo: il padre privo del braccio, i fanciulli, per la prima volta completi. Che si tratti delle braccia autentiche, non di integrazioni di fantasia, si comprende dal fatto che sono identiche alle braccia attribuite a Montorsoli, presenti in tutte le immagini del gruppo fino all’avanzato settecento. sembra addirittura di scorgere nella mano del figlio più giovane il dito indice sollevato rispetto alle altre dita: un particolare ben visibile in molti disegni e stampe cinquecenteschi (ad es. ds 40, 43, 44, 45, 54, 55).
La veduta londinese (ds 31, fig. 10) sarebbe da sola prova suffi-ciente dell’esistenza del restauro, ma possiamo contare anche su altri importanti testimoni, sia pure indiretti. In primo luogo gli affreschi che rappresentano il Laocoonte nel Palazzone del cardinale silvio passerini a Cortona, costruito fra il 1521 e il 1527 dal ‘vitruviano’ giovan Battista Caporali (da 1, 2)44. Il primo (da 1, fig. 12) orna la parete principale del salone al pianterreno: un Laocoonte policromo su un’imponente base marmorea davanti ad una triplice arcata ispirata all’arco trionfale romano, aperta su un paesaggio appenninico dai toni quasi nordici. Il gruppo è inquadrato da due colonne di marmo violetto screziato che sorreggono un architrave decorato da un improbabile fregio dorico. Il secondo (da 2), nella ‘camera del cardinale’ al piano superiore, è dipin-
Il braccio mancante24
43 per la bibl.: parte II, ds 31, spec. p. liverani, a. nesselratH, sch. nr. 36, in High Renaissance (Engl. text suppl.), cit., p. 57 s.; Winner, La collocazione, cit., p. 118.
44 f. magi, Laocoonte a Cortona, «Rendpontacc», XL, 1967-1968, pp. 275-294.
to a monocromo verde pallido davanti ad una quinta di fantasia, intesa presumibilmente come riferimento al palazzo di tito.
In entrambi i casi il frescante, che almeno per il salone è stato individuato nel modesto tommaso Bernabei, il Papacello, si è servito della stampa di Marco dente (ds 8, fig. 4), che all’altezza cronologica della decorazione cortonese, dopo la metà degli anni Venti, era proba-bilmente l’unica immagine a stampa di ampia circolazione45. Nel-l’incisione il gruppo è privo di restauri, ma negli affreschi le braccia dei fanciulli sono aggiunte con precisa consapevolezza delle braccia autentiche, di cui riproducono molti particolari, specie l’indice solleva-to nella mano del fanciullo morente. al contrario, il braccio del padre vi è di fantasia, sebbene la soluzione adottata sia diversa da un affresco all’altro: di tipo quasi montorsoliano, con il braccio moderatamente steso e una gran spira attorno alla mano nella stanza del cardinale (da 2); più estemporanea, con un gesto aperto e una banale voluta a spirale attorno al braccio nel salone (da 1, fig. 12).
È evidente che il papacello e gli altri frescanti, se più d’uno, dispo-nevano di informazioni sullo stato del monumento, cioè di disegni recenti sui quali aggiornare il modello, magari inviati da Roma dal committente medesimo46. L’improvvisazione nelle braccia paterne prova il perdurare della lacuna sull’originale. Le diverse soluzioni riflettono le difficoltà che il restauro poneva in termini di gusto e di immagine, e gli esperimenti in diverse direzioni condotti da queste maestranze cortonesi non saranno stati troppo dissimili da quelli che, negli stessi anni, si potevano forse vedere a Roma.
sono di grande interesse anche i disegni di un foglio transitato sul mercato antiquario nel 1987 sotto il nome di giovannangelo Montorsoli, ora in collezione privata francese (ds 24, 25, figg. 13, 14)47. sul recto (fig. 13) il gruppo è visto di fronte, ma solo la parte superiore della figura del padre e il braccio del figlio minore sono compiutamente modellati con un chiaroscuro a tratteggio. Il resto è più o meno rapidamente abbozzato e intorno si vede qualche cenno di una sistemazione architet-tonica in cui due colonne o finti pilastri inquadrano il gruppo. Il braccio
I restauri 25
45 magi, Laocoonte a Cortona, cit., pp. 277 ss. attribuisce il Laocoonte della stanza del cardinale al papacello (da 1), quello del salone (da 2) più cautamente ad un anonimo su probabile cartone di Caporali. Un inquadramento del papacello: m. salmi, Tommaso Bernabei detto il Papacello, «Bda», s. ii, III, 1923-1924, pp. 162-175: 169.
46 J. Corsi, La cultura romana negli affreschi del Palazzone di Cortona, «Boll. d’Informazione. Brigata aretina d. amici d. Monumenti», XXXIII, 1999, pp. 58-64.
47 Bibl.: infra, parte II, ds 24, 25. descr. in Sotheby’s. Dessins Italiens du XIVe au XVIIe siècle. Collection Michel Gand, München, 20 giugno 1987, lotto nr. 80, p. 27 e n. 3; a. nesselratH, Montorsolis Vorzeichnung für seine Ergänzung des Laokoon, in Il Cortile delle Statue, cit., pp. 165-174.
di Laocoonte, piegato verso il capo e leggermente arretrato, è stretto al braccio del figlio più giovane da un’ampia spira che termina con la coda del serpente svolazzante oltre il gomito del fanciullo: chiaramente un’invenzione del disegnatore. si leggono sul foglio due annotazioni a penna. La prima è riferita alla spira che avvolge la gamba sinistra di Laocoonte: «questa serpe fala no(n) rotta». La seconda riguarda la coda del serpente: «e questa fala cosi».
sul verso (fig. 14) la stessa mano ha disegnato in scala leggermen-te più grande il figlio morente e il padre. Quest’ultimo è tuttavia solo abbozzato, salvo il particolare del ginocchio destro con cui il figlio è a contatto per la stretta del serpente. Vi è in compenso delineata con cura l’ambientazione architettonica, costituita da uno zoccolo modanato sovrastato da una cornice sulla quale sono impostate due lesene che definiscono un campo piano a far da sfondo al gruppo. anche qui c’è un’annotazione riferita al lembo del mantello del fanciullo che si scorge appena dietro la spira avvolta al braccio sinistro: «questo e panno».
arnold Nesselrath insiste sull’attribuzione del foglio a Montorsoli su base stilistica e paleografica. La mano scrivente sarebbe identica a quella di due fogli con gli abbozzi del sigillo dell’accademia del disegno di Firenze, di invenzione notoriamente montorsoliana48. I disegni sarebbero gli schizzi preparatorî per un restauro del gruppo pianificato da Montorsoli durante il pontificato di Clemente VII, insie-me a una nuova sistemazione dalla nicchia bramantesca, con il gruppo collocato a terra e non sopra l’alto plinto sul quale tuttora si trova.
si tratta di una lettura a mio parere sbagliata. La questione attributi-va non è fondamentale: chiunque sia il disegnatore (una grafia cinque-centesca canonica difficilmente consente in 49 caratteri di individuare una mano personale), il riferimento a un artista michelangiolesco del terzo o quarto decennio del Cinquecento è convincente49. Ma i dise-gni non sono destinati ad un restauratore che lavorerà a contatto con l’originale bensì, ed è evidente, a un pittore che sulla base di questo modello eseguirà un Laocoonte d’aprés l’antique. Un appunto come «questo e panno» è inutile a chi ha sotto gli occhi il marmo antico, mentre è essenziale per chi, copiando dal disegno, deve sapere che in
Il braccio mancante26
48 nesselratH, Montorsolis Vorzeichnung, cit., pp. 171-173. per il sigillo: B. lasCHke, Montorsolis Entwürfe für das Siegel der Accademia del Disegno in Florenz, «MKIF», XXXI, 1987, pp. 392-402.
49 di diversa opinione, credo a torto, B. lasCHke, Fra Giovan Angelo da Montorsoli. Ein florentiner Bildhauer des XVI. Jahrhunderts, Berlin, Mann, 1993, p. 143, n. 16; ead., Die Arme des Laokoon, in Il Cortile delle Statue, cit., pp. 175-186: 183, n. 44. si v. in generale a.M. petrioli tofani, Appunti per un corpus grafico di Giovanni Angelo Montorsoli, «artista», 2003, pp. 150-163. anche in questo caso ringrazio Francesco Caglioti per avere discusso con me il problema.
quel punto poco visibile c’è la continuazione del panneggio che spunta sotto la spira del braccio destro. La prescrizione «questa serpe fala non rotta» paradossale per un restauratore, serve al pittore che non dovrà riprodurre in quel punto una frattura del marmo. Frattura che c’era, come mostra ad es. il disegno del taccuino di Cambridge (ds 45, fig. 29), e che si vede ancor oggi, nonostante la riparazione in gesso di Filippo Magi. aggiungiamo che la soluzione pensata per il braccio di Laocoonte, legato in modo vistoso a quello del figlio, con la coda del serpente a mezz’aria, è irrealizzabile in marmo. Nessuno sculto-re esperto avrebbe seriamente proposto una tale integrazione, anche senza contare che sulla scapola di Laocoonte si conserva l’ultimo tratto della coda del serpente, che sarebbe stato necessario cancellare.
siamo di fronte ad uno schizzo in cui il disegnatore riflette sulla soluzione da adottare per il braccio del padre, la cui perdurante man-canza è evidenziata dal suo imbarazzo. al contrario, il braccio del fi- glio minore, piegato e con il particolare ben noto del dito indice solle-vato, è autentico. Come van Heemskerck (ds 31, fig. 10) e il papacello (da 1, fig. 12) questo artista vicino a Michelangelo aveva di fronte un Laocoonte con le braccia dei figli ma senza quello del padre: il Laocoonte descritto dagli ambasciatori veneziani. Il disegno documen-ta lo sforzo di coordinare, in un medium che consentiva di lasciare da parte i problemi statici, l’esistente e l’inventato, il gesto reale del figlio e quello di fantasia del padre.
Un Laocoonte semirestaurato propone con chiarezza anche un dise-gno del Museo Boijmans van Beuningen di Rotterdam (ds 20), per il quale esiste un riferimento estemporaneo a Marco dente. si tratta di una mediocre copia della stampa del ravennate (il che forse spiega l’attribuzione) eseguita da un artista italiano che disegna con cura ma senza talento. partendo dal modello in cui tutte le braccia mancano, egli ha aggiunto un po’ alla buona le braccia ai figli, lasciando invece frammentario quello del padre, evidentemente perché anche per lui, come per gli artisti di Cortona, l’immagine che copiava non era più attuale rispetto allo stato del monumento ed esigeva dunque di essere modificata. L’aggiornamento è impreciso, forse eseguito a memoria, ma per questo ancora più significativo. È la riprova che il gruppo rima-se nella situazione ‘provvisoria’ abbastanza a lungo da fissare nella memoria degli spettatori l’immagine di un monumento in cui «ogni cosa è integra, salvo che al Laocoonte manca il braccio destro».
se i figli sono stati completati prima del 1523, come i testimo-ni diretti e indiretti dimostrano, quando e da chi è stato eseguito il restauro? Le attribuzioni puramente indiziarie sono un terreno assai scivoloso ma azzardo comunque un nome: Baccio Bandinelli. Vediamo perché.
I restauri 27
È noto che il cardinale giulio de’ Medici commissionò a Baccio, per conto di papa Leone X, una copia in marmo scala al vero del Laocoonte destinata al re di Francia Francesco I (Co 1, fig. 15), il quale aveva tentato invano di ottenere l’originale50. La commissione, allogata nel gennaio del 1520 per ben 900 ducati d’oro, prevedeva che la copia fosse scolpita «di pezzi», ovvero da più blocchi separati, come avevano fatto gli scultori del Laocoonte secondo la constatazio-ne di Michelangelo51. I lavori cominciarono in febbraio, dopo che Bandinelli aveva prodotto un cartone del gruppo in grandezza natu-rale (ds 12) e un modello in cera (Cr 5). Nel cortile venne approntato un gabbiotto («una turata con tetto per lavorare») che permetteva allo scultore di essere quotidianamente a contatto con l’originale. L’esecu-zione in un primo momento avanzò spedita. Nel mese di settembre, quando venne firmato il contratto, uno dei figli era finito e lo scultore si impegnava a consegnare l’opera entro un anno52. poi la morte di Leone X (1 dicembre 1521) e l’elezione di adriano VI (9 gennaio 1522), l’austero ‘alemanno’ che aveva educato Carlo V, poco pro-penso alla promozione delle arti e ancora meno al culto degli idola antiquorum, interruppero i lavori, che sarebbero ripresi solo con l’ele-zione di Clemente VII (18 novembre 1523). prima dell’interruzione tuttavia Baccio aveva portato a termine il secondo figlio, che fu visto dalla legazione veneziana in primavera: «già son fatti li putti, che sono lì in una camera; ma il maestro, se anche vivesse cinquecento anni, e ne avesse fatti cento, non potria mai far cosa uguale»53. Il gruppo fu portato a termine nel 1525 ma non prese la via della Francia, come
Il braccio mancante28
50 H. reUmont, Urkundliches zur italienischen Kunstgeschichte. 4. Die Lao- koongruppe del Bandinelli, «Kunstblatt», 1849, Heft 7, p. 26 s.; g. agosti, sch. nrr. 17 e 18, in Michelangelo e l’arte classica, cit., pp. 58-60; sh.e. reiss, Cardinal Giulio de’ Medici as a patron of art, 1513-1523, phd diss., princeton, princeton Univ. (ma), 1992, I-III, ann arbor (mi), UMI, 1993, I, pp. 427-432; W. lieBenWein, Clemens VII und der Laokoon, in Opere e Giorni. Studi su mille anni di arte europea dedicati a Max Seidel. Werke und Tage: tausend Jahre europäischer Kunstgeschichte. Studien zu Ehren von Max Seidel, a c. di K. Bergdolt, g. Barsanti, Venezia, Marsilio, 2001, pp. 525-532. per un breve inquadramento dell’opera di Baccio: l. Canova, Baccio Bandi- nelli, in Scultori del Cinquecento, cit., pp. 21-40.
51 Il carteggio di Michelangelo. Edizione postuma di giovanni poggi, a c. di p. Barocchi, R. Ristori, II, Firenze, s.p.E.s., 1967, nr. Cdliv, p. 214.
52 Il testo è parzialmente pubblicato in g. vasari, Le vite de più eccellenti pit-tori, scultori ed architettori, scritte da G.V., pittore aretino. Con nuove annotazioni e commenti di g. Milanesi. Ultima inpressione, I-IX, Firenze, sansoni, 1906 (rist. anast., ibid., sansoni, 1981), VI, p. 145, n. 2; cf. reiss, Cardinal Giulio de’ Medici, cit. pp. 430 ss.; d. Cordellier, sub sch. nr. 75, in D’aprés l’antique, cit., p. 238.
53 Sommario, cit., p. 116; cf. BrUmmer, The Statue-Court, cit., p. 266; maffei, La fama di Laocoonte, cit., iv.B.3, p.176 s.
avrebbe dovuto54. alcuni anni dopo, nel 1531, fu inviato invece a Firenze, dove Clemente lo aveva destinato al secondo cortile del palazzo di via Larga, che aveva l’ambizione di trasformare in una sorta di Belvedere privato della famiglia Medici55.
ora, una singolare coincidenza temporale fra i tempi di esecuzione della copia e il restauro delle braccia dei figli sull’originale invita a supporre un rapporto fra le due commissioni. Nel 1523, quando da un anno il cortile delle statue era chiuso e non vi si lavorava (dice Vasari che adriano VI conservava presso di sé le chiavi dell’unica porta di accesso), i fanciulli erano finiti e sull’originale erano installate le nuove braccia (fig. 10). al contrario, il braccio del padre, la cui figura era da fare, mancava. pura casualità? Forse no, visto che le braccia di restauro e quelle della copia sono identiche, come immediatamente mostra anche il più frettoloso dei confronti. La somiglianza dei gesti è così stretta che si può spiegare solo in termini di derivazione della copia dai restauri o dei restauri dalla copia. In altre parole, se Baccio non ha trovato il gruppo parzialmente integrato e copiato le parti anti-che e moderne insieme, ha eseguito egli stesso le integrazioni man mano che procedeva con la sua opera.
I restauri 29
54 I dati a supporto della datazione tradizionale (1520-1525) sono in vasari, Le vite, vi, p. 146. Cf. agosti, sch. nrr. 17 e 18, in Michelangelo e l’arte classica, cit., pp. 58-60. di contro lasCHke, Die Arme des Laokoon, cit., p. 177, n. 15 nega che il grup-po potesse essere già concluso nel 1525 poiché l’iscrizione sul basamento (Baccius Bandinellus Florentinus Eques Sancti Iacobi faciebat) presuppone il conferimento dell’ordine di s. giacomo, ottenuto nel 1530. Ma è più verosimile che l’iscrizione sia stata apposta dopo il trasferimento a Firenze, assieme ad un’altra sulla faccia superiore della base, recante la data della collocazione in palazzo Medici (scoperta al momento del trasporto agli Uffizi nel 1659): Auspice Clemente VII Pontifice-| Maximo Bac- cius Bandinellus | Florentinus Eques S. Iacobi faciebat |-et Laochoontem posuit in atrio | illustrissimae Medices Domus Anno | MDXXXI. X. Octobris. Cf. K. Weil gar- ris, On Pedestals: Michelangelo’s David, Bandinelli’s Hercules and Cacus and the Sculpture of the Piazza della Signoria, «RömJhbKg», XX, 1983, pp. 376-415: 404.
55 W. BUlst, Uso e trasformazione del palazzo Mediceo fino ai Riccardi, in Il palazzo Medici Riccardi di Firenze, a c. di g. Cherubini, g. Fanelli, Firenze, giunti, 1990, pp. 98-129; g. satzinger, Der “Statuenhof” Clemens’ VII. im Garten des Palazzo Medici in Florenz. Zur Laokoon-Zeichnungen der Albertina, inv. 48v, und zu Folio 28v im Codex Geymüller der Uffizien, A 7818v, in ‘Ars naturam adiuvans’. Fest-schrift für Matthias Winner zum 11 März 1996, a c. di V.V. Fleming, s. schütze, Mainz a. R., von Zabern, 1996, pp. 208-227 dimostra che un noto foglio dell’ albertina (ds 23), un tempo attribuito a giuliano da sangallo, da ackermann assegnato ad antonio il Vecchio (J.s. aCkermann, The Cortile del Belvedere, Città del Vaticano, tipografia poliglotta Vaticana, 1954, p. 36), già creduto un progetto per la sistemazione del Laocoonte in Belvedere [bibl. in M. kosHikaWa, sch. nr. 50, in High Renaissance (Engl. text suppl.), cit., p. 66 s.], si riferisce in realtà alla progettata installazione della copia bandinelliana nel cortile di palazzo Medici, dove le sculture antiche e donatelle-sche erano ospitate entro nicchie perimetrali.
In termini meramente probabilistici questa seconda ipotesi sembra preferibile. abbiamo un artista documentato in Belvedere negli anni in cui il restauro è stato eseguito; un movente plausibile (si ricordi la promessa di giulio de’ Medici agli ambasciatori di Francesco I: «a sua Maestà si manderà o questo [il gruppo originale] o un simile, che non ci sarà differenza»); la coincidenza temporale fra il progredire della copia e la comparsa delle braccia. In caso contrario dobbiamo postulare la presenza in Belvedere di un artista non documentato e, naturalmente, trovare un’altra spiegazione per la parzialità del com-pletamento. È chiaro che un ragionamento su base probabilistica non può portare alla certezza, e che in questo caso manca la possibilità di una verifica stilistica (le mani sono scomparse all’inizio del XVIII secolo: infra, pp. 53 ss.). tuttavia scartare il nome del Bandinelli pone più problemi che accettarlo. se Baccio è l’autore delle braccia ci tro-viamo di fronte ad una circostanza singolare: un particolare inventato ex novo per l’opera moderna è stato riportato sull’archetipo antico. Un rovesciamento significativo della sequenza canonica per cui l’inven-zione procede dalla copia all’originale e non, secondo natura e logica, dall’originale alla copia.
Il braccio non finito ‘di Michelangelo’
secondo Vasari Baccio restaurò il braccio di Laocoonte solo nella forma provvisoria di un modello in cera: il «braccio di cera grande che corrispondeva co’ muscoli e la finezza all’antico e con lui si univa di sorta, che mostrò quanto Baccio intendeva l’arte: e questo modello gli servì a fare l’intero braccio del suo» (Le vite, vi, p. 143).
Questo braccio non ha lasciato tracce nella tradizione grafica ma servì come modello per la copia: uno sguardo al marmo degli Uffizi dovrebbe dunque dàrcene un’idea attendibile. E se il braccio in cera assomigliava a quello della copia (Co 1, fig. 15), la sua vicenda non può non intrecciarsi con quella del braccio marmoreo incompiuto, tradizionalmente attribuito a Michelangelo (fig. 16), che appunto a quest’ultimo moltissimo somiglia.
Il braccio ‘di Michelangelo’ è l’oggetto misterioso della storia moderna del Laocoonte. scolpito in un blocco di marmo bianco-grigio apparentemente privo di venature, è piegato e strettamente avvolto dalle spire di uno dei serpenti che Laocoonte tenta di allontanare da sé. Il viluppo formato dal corpo del rettile parte da dietro la spalla, nel punto in cui s’interrompe il frammento superstite del serpente antico, gira tre volte intorno al bicipite, sale fino alla mano che ne risulta rove-sciata all’indietro, ridiscende avvolgendosi su se stesso e termina al-
Il braccio mancante30
l’altezza della spalla in una breve coda sinuosa56. dalla superficie di giunzione, regolare e piana, spunta un tenone a forma di ‘L’ rovesciata ricavato nel blocco medesimo e lavorato sommariamente a subbia e scalpello.
Nel 1957 Filippo Magi, rimuovendo il braccio ottocentesco in gesso allora in opera (infra, p. 77 s.), scoprì una mortasa di forma analoga scavata nella spalla destra della statua (fig. 17) e constatò che una porzione della stessa era stata tagliata per regolarizzare il piano di frattura e adattarlo al corrispondente piano di giunzione del braccio, consentendone in tal modo una collocazione relativamente agevole e stabile (fig. 18)57. oggi questa superficie è occultata dal braccio ori-ginale scoperto nel 1905 e definitivamente ricollocato nel 1959 (infra, p. 77), di modo che la sola documentazione esistente degli interventi sulla spalla sono le fotografie prese all’epoca. È però evidente che in un dato momento della storia del Laocoonte la messa in opera del ‘braccio di Michelangelo’ fu pianificata e portata quasi a compimento, con una manomissione piuttosto pesante del marmo antico.
Il braccio è menzionato per la prima volta dal pittore inglese Joh-nathan Richardson e da suo figlio Johnathan Jr., che visitarono l’Italia nel 1720. Il loro diario di viaggio è una delle fonti più preziose per la storia del collezionismo italiano del XVIII secolo. Nel lungo brano dedicato al Belvedere, dopo aver descritto il Laocoonte riferiscono che «si vede dietro il piedistallo un braccio che Michelangelo aveva co- minciato per Laocoonte, ma che lasciò imperfetto per modestia»58.
Il cimelio è dunque accompagnato fin dall’inizio dalla nobilitan- te attribuzione al Buonarroti e classificato fra i testimoni di uno dei luoghi più celebri della mitologia michelangiolesca, quello del- la modestia nei confronti degli antichi, con i quali il maestro non avrebbe mai ardito apertamente confrontarsi59. per tutto il settecen-
I restauri 31
56 Ho potuto esaminare il braccio nel 1998 grazie alla cortesia del prof. pao- lo Liverani, al quale sono grato anche per il prezioso scambio di opinioni durante la visita nel Cortile delle statue. Essendo attualmente impossibile eseguire un’effica- ce misurazione, data la disagevole collocazione del pezzo, riporto i dati forniti da F. magi, Il ripristino del Laocoonte, «Mempontacc», s. iii, IX, nr. 1, Città del Vati- cano, tipografia poliglotta Vaticana, 1960, p. 46: lungh. del braccio 0,175 m; lungh. dell’avambraccio 0,135; largh. media 0,085; prof. alla spalla 0,097; prof. alla mano 0,073.
57 magi, Il ripristino, cit., pp. 46-50.58 [J. riCHardson sr., J. riCHardson Jr.], An Account of the Statues, Bas-relie-
fs, Drawings and Pictures in Italy, etc. with Remarks. By Mr. Richardson sen. and Jun., London, printed for J. Knapton at the Crown in st. paul’s Churchyard, 1722, p. 277.
59 Un’ampia raccolta di testimonianze in a. von salis, Antike und Renaissance. Über Nachleben und Weiterwirken der Alten in der Neuen Kunst,
to questa attribuzione ha avuto la forza di una «comune opinio-ne» (Carlo Fea)60, trovando autorevole sanzione nelle pagine di Winckelmann61.
La fama del braccio si riflette nella memorialistica e nella lette-ratura di viaggio, ove se ne incontrano continue menzioni. secondo Charles de Brosses Michelangelo si sarebbe servito dell’immagine sul rovescio di una medaglia per ritrovare il «profilo originale» del gruppo62:
Mancava al Laocoonte un braccio che Michelangelo ha tentato di rifare in marmo, e per questo aveva la felice opportunità di ritrovare il profilo originale perché abbiamo la figura intera del gruppo sul rovescio di una medaglia. pure ha rinunciato dopo averlo sbozzato; la pietra è ancor adesso sotto il piedestallo.
La ‘medaglia’ non sembra poter essere altro che uno dei tre tipi di contorniati con la Morte di Laocoonte e dei suoi figli al verso, la cui
Il braccio mancante32
Erlenbach und Zürich, Rentsch, 1947, pp. 47-53, 143-151, 175-184; g. vasari, La Vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, a c. di p. Baroc- chi, Milano e Napoli, Ricciardi, 1968, IV, p. 2109 s. Nella sterminata bibl. sul ‘pa- ragone’ fra Michelangelo e gli antichi: agosti, Il paragone, cit., p. 107 s.; Il Tor- so del Belvedere: da Aiace a Rodin, München, staatl. antikensammlungen und glyptothek, 21 gen. - 29 mar. 1998; Città del Vaticano, Musei Vaticani, 19 nov. 1998 - 31 gen. 1999, a c. di R. Wünsche, Città del Vaticano, tipogra- fia Vaticana, 1998. Il topos del paragone fra artisti antichi e moderni si contestua- lizza in una più generale idea ‘umanistica’ di imitazione competitiva dei model- li antichi: su questo sopr. i.d. roWland, The Culture of the High Renaissance: Ancients and Moderns in sixteenth-century Rome, Cambridge and New York, Cambridge U.p., 1998; v. anche l. Barkan, Unearthing the past: archaeology and aesthetics in the making of Renaissance culture, New Haven, Yale U.p., 1999.
60 [J. J. WinCkelmann], Storia delle arti del disegno presso gli antichi di gio- vanni Winckelmann, tradotta dal tedesco e in questa edizione corretta e aumentata dall’abate Carlo Fea, In Roma, dalla stamperia pagliarini, 1783-1784 [ma 1783-1786], II, p. 244, nota s.nr.
61 J. J. WinCkelmann, Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Altertums &c. Erster theil, dresden, 1767, rist. anast. Baden-Baden und strasbourg, Heitz, 1966, p. 101.
62 Ch. de Brosses, Lettres familières, text éd. par g. Cafasso; intr., notes et bibl. par L. Norci, II, Naples, Centre Jean Bérard, 1992: Lettre XLIII à Mon- sieur de Quentin, s.d., pp. 793-825: 813: «Il y manquoit [i.e. au Laocoon] un bras que Michel-ange a tenté de refaire en marble, et pour ceci il avoit l’heureuse facilité de retrouver le modèle du contour original, car nous avons la figure en- tière du groupe sur le revers d’une medaille. Cependant il y a renoncé apres l’avoir degrossi; la pierre est encore en bas du piedestal». La lett. è parte di una serie che costituisce un’organica descrizione di Roma moderna (XXXI, pp. 665- 703; XLI, pp. 729-772; XLVI, pp. 859-887; XLVIII, pp. 919-933; L, pp. 961- 977).
iconografia è peraltro diversa da quella del gruppo vaticano, con le braccia del padre levate in segno di disperazione63.
Il nobiluomo tedesco Johann george Keyssler (1751) ha sentito dire, come tanti altri visitatori prima e dopo di lui, che Michelangelo avrebbe lasciato incompiuto il braccio per la ben nota ‘modestia’ di fronte agli antichi: «Michelangelo, a quel che si dice, non ha portato a termine per modestia il braccio che avrebbe dovuto nuovamente com-pletare il Laocoonte e che è esposto qui»64.
L’astronomo francese Joseph-Jérôme de Lalande, autore del più voluminoso e popolare fra i resoconti del Grand Tour (1769), un best-seller in rapporto agli standard dell’epoca, conferma la notizia che il braccio era esposto assieme al gruppo: «Michelangelo aveva anche cominciato a fare un braccio di marmo, che si vede ancora in un angolo della stessa nicchia, ma abbandonò l’impresa»65.
Il tedesco Johann Jacob Volkmann, le cui Historisch-Kritische Nachrichten von Italien furono, al contrario del Voyage, criticate anche aspramente, e nelle quali osservazioni originali si alternano a brani copiati da altri autori (fra i quali principalmente Lalande), mette in relazione il braccio con un restauro abbandonato e, assurdamente, anche con una copia che Michelangelo avrebbe lasciata a mezzo: «Michelangelo doveva restaurare il gruppo e ha fatto un braccio. Cominciò una copia ma la abbandonò subito. se ne vede qui comun-que l’inizio»66. a rastrellare notizie qua e là si prendono, come si vede, grossi abbagli. Il viaggiatore, che goethe disprezzava crede di aver visto in Belvedere quello che non c’è mai stato (una copia incom-
I restauri 33
63 a. alföldi, E. alföldi, Die Kontorniat-Medaillons. Teil 1. Katalog. In neuer Bearb. von a.a. und E.a.; unter Mitwirk. von Curtis L. Clay, Berlin, de gruyter, 1976, p. 201, nrr. 87-89.
64 [J.g. keyssler], J.G.K. [...] neueste Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen &c., I, Hannover, im Verlage sel. N. Försters und sohns Erben, 1751, p. 585: «Es hat Michel angelo Buonaroti den arm, der den Laokoon wieder hätte ergänzen sollen, und allhier gezeigt wird, aus Beschedenheit, wie man sagt, nicht gar vollendet».
65 [J.-J. le français de la lande], Voyage d’un Français en Italie, fait dans les années 1765 & 1766 contenant l’histoire & les anecdotes plus singulières de l’Italie &c., À Venise, et se trouve à paris, chez desaint, 1769, III, p. 235: «Il [i.e. Michel-ange] avoit même commancé a en faire un [i.e. bras] de marbre, que l’on voit encore ebauché dans un coin de la même niche, me il abbandonna l’entreprise».
66 [J.J. volkmann], Historisch-Kritische Nachrichten von Italien [...] aus des neuesten französischen und englischen Reisebeschreibungen und aus eigenen anmerkungen zusammengetragen von J.J.V., Leipzig, Verlegts Kaspar Fritsch, 1770[-1771], II, p. 133: «Michel angelo sollte die gruppe restaurieren, und hat auch einen arm gemacht. Er fieng eine Copie an, liess aber nachgehend liegend. Man sieht den anfang davon hier ebenfalls».
piuta del Laocoonte), ma se pensiamo al michelangiolismo imperver-sante nella cultura settecentesca, in omaggio al quale tutte le principali raccolte d’Italia avevano la loro quota di sculture antiche restaurate dal Buonarroti, la fortuna del topos della modestia non stupisce, né le sue molte varianti, e tantomeno le sciocchezze dei testimoni meno attenti, come appunto Volkmann67.
Ma se il nome del massimo artista del Rinascimento non suscitava perplessità nei ben disposti protagonisti del Grand Tour, molte ne ha ispirate invece alla critica otto e novecentesca. La prestigiosa attribu-zione stride con il lungo oblio che per due secoli ha sottratto il braccio all’attenzione di coloro che, biografi, artisti o viaggiatori, hanno scritto dell’artista. Lo stile poi è sì poderoso ed energico, come astrattamente si potrebbe pensare di un’invenzione michelangiolesca, ma lo stadio di lavorazione è tale che nessuno può seriamente pretendere di indi-viduare nel braccio uno stile personale. d’altra parte è indubbio che se il marmo non fosse stato percepito come un cimelio venerando la tradizione non sarebbe nata, né tantomeno avrebbe goduto di così larga fortuna. di conseguenza fra i sostenitori e gli avversari dell’autogra-fia michelangiolesca si è acceso un dibattito a bassa intensità che dai tempi di Winckelmann non si è mai spento. Le posizioni si sono però via via definite e coagulate, se così si può dire, intorno a tre punti di vista:a) Il braccio è di Michelangelo perché la tradizione è troppo compatta
per poter essere ignorata (Winckelmann) e perché un intervento audace come il taglio della spalla di Laocoonte può essere stato compiuto solo da un artista dotato di immenso carisma (Michaelis, amelung, Weizsächer, von salis, Magi, Bieber, Favaretto, Brummer, al.)68.
b) Il braccio è cinquecentesco ma non di Michelangelo perché in tal caso non sarebbe stato dimenticato per tanto tempo (Heyne, Fea,
Il braccio mancante34
67 Un elenco parziale di presunti restauri di Michelangelo è in H. tHode, Michelangelo. Kritische Untersuchungen über seine Werke, Berlin, de gruyter, 1908, II, p. 301 s. Vd. anche s. HoWard, Pulling Herkles’ Leg. Della Porta, Algardi and Others, in Festschrift Ulrich Middeldorf, hrsg. v. a. Kosegarten und p. tiegler, Berlin, de gruyter, 1968, pp. 402-407: 406, n. 6, nonché le sensate considerazioni di M. Collareta, Michelangelo e le statue antiche, un probabile intervento di restauro, «prospettiva», 43, 1985, pp. 51-55 che inducono ad una posizione di cautela nei con-fronti della tradizione.
68 miCHaelis, Geschichte des Statuenhofes, cit., p. 30 s.; amelUng, Die Skulpturen, cit., nr. 74b, p. 201 s.; von salis, Antike und Renaisssance, cit., p. 145; magi, Il ripristino, p. 46 s.; M. BieBer, Laocoon. The influence of the group since its rediscovery. Revised and enlarged edition, detroit, Wayne state U.p., 1967, p. 24; I. favaretto, La tradizione del Laocoonte nell’arte veneta, «atIstVen», CXLI, 1982-1983, pp. 75-92: 87; BrUmmer, The Statue-Court, cit., p. 89.
Visconti)69, e più ancora perché non vi è alcun supporto concreto all’attribuzione (Howard, Winner, agosti, Collareta, Laschke, al.). L’autore è con ogni probabilità uno scultore della prima metà del Cinquecento: Montorsoli (Howard), Bandinelli (Laschke, Rebaudo), un artista non identificato (Winner, agosti, Collareta)70.
c) Il braccio è settecentesco perché le fonti lo ricordano a partire dal 1720, circostanza spiegabile solo con il fatto che era stato eseguito poco tempo prima. L’autore può essere agostino Cornacchini, che in quegli anni eseguiva un nuovo restauro del gruppo (daltrop, preiss, Liverani)71.delle tre ipotesi l’unica sostenibile è, a mio parere, la seconda.
depongono a favore della cronologia cinquecentesca la tecnica esecu-tiva, poco ortodossa dal punto di vista dell’insegnamento accademico, e l’artificio utilizzato per ancorare il blocco alla spalla di Laocoonte, tanto inusuale da non trovare confronti. Vediamo in dettaglio.
pur con la prudenza d’obbligo in simili materie, l’impiego degli strumenti sulla superficie del braccio pare senz’altro più rinascimentale che settecentesco. L’uso istintivo che l’artista ha fatto degli strumenti non è consono ad un periodo in cui la formazione nelle accademie insegnava agli artisti la pianificazione del lavoro e diffondeva una pras-si rigorosa e relativamente uniforme72. Lo scultore del braccio non ha
I restauri 35
69 [Heyne], Prüfung einiger Nachrichtungen, cit., p. 15 s. (che contesta anche il topos della ‘modestia’, messo in relazione con un aneddoto riferito in [J.-J. Boissard], II Pars Antiquitatum Romanarum seu Topographia Romanae Urbis [...] a I.I. B. pri-mum ad theodorum de Bry missa &c., Francfordii, artifice theodoro de Bry Leod., 1597, p. 7: «hanc [statuam, i.e. il Torso del Belvedere] Michael angelus dicit esse mira-culum artis singulare: in quo divinum artificum debeamus suspicere ingenium potius quam ad imitationem nos accingere»); [e.Q. visConti], Il Museo Pio-Clementino descritto da E.Q.V.-tomo secondo &c., Roma, da Ludovico Mini, 1784, p. 76, n. (a); [WinCkelmann], Storia delle arti del disegno (ed. Fea), cit., II, p. 244, nota s.n.
70 HoWard, On the Reconstruction, cit., p. 365; Winner, Zum Nachleben, cit., p. 118; g. agosti, sch. nr. 39, in Michelangelo e l’arte classica, cit., p. 90 s.; Collareta, Michelangelo e le statue antiche, cit., p. 55; lasCHke, Die Arme des Laokoon, cit., p. 178 s.
71 daltrop, Die Laokoongruppe, cit., p. 19; preiss, Die wissenschaftliche Beschäftigung, cit., p. 56 s.; liverani, Geschichte des Cortile, cit., p. vii.
72 sulla tecnica scultorea fra Rinascimento e Barocco: R. WittkoWer, Sculpture. Processes and Principles, London, penguin Books, 1977 (trad. ital. La scultura rac-contata da Rudolf Wittkower. Dall’antichità al Novecento, torino, Einaudi, 1985), pp. 117-256; p. roCkWell, Lavorare la pietra. Manuale per l’archeologo, lo storico dell’arte e il restauratore, Roma, NIs, 1989, pas.; inoltre l’utile raccolta di fonti: s. rinaldi, La tecnica della scultura nei trattati del Rinascimento. antologia di testi 1400- 1584, [Roma], Lithos, 1994; id., Tecnica e restauro della scultura lapidea nelle fonti dal Barocco al Neoclassicismo, antologia di testi 1650-1802, Roma, Lithos,
proceduto dal ferro più grossolano al più fine, ma ha lavorato con stru-menti diversi contemporaneamente, di modo che la maggior parte della superficie presenta tracce di due gradine a tre denti, una più grossa sul braccio, l’avambraccio e la spalla, una più fine sul corpo del serpente. Nella parte superiore, presso la piega del gomito, vi è un’area lavorata a scalpello, dove lo strumento è andato in profondità. più in basso, in corrispondenza del tòrcine del serpente, si individuano dei punti model-lati a subbia, e indietro, presso la prima spira, dei segni di scalpello. La parte posteriore è ad uno stadio di lavorazione meno avanzato: si nota un dislivello nella pietra lungo la linea del profilo superiore del brac-cio, nel punto in cui le tracce di gradina si interrompono. particolare la situazione della mano, che nella parte anteriore è modellata abbastanza finemente (si notano, ad un esame ravvicinato, interventi con la gradina più fine presso l’unghia del pollice), ma dietro, in corrispondenza delle falangi, è appiattita e squadrata, quasi priva di modellato, come se lo scultore avesse scavato troppo il marmo e tentato poi di correggere il difetto con un’energica lisciatura.
Questa profusione di strumenti impiegati in modo non pianificato è in contrasto con i risultati delle analisi condotte da peter Rockwell sugli angeli di ponte s. angelo e su alcune sculture giovanili della galleria Borghese, le quali dimostrano che già Bernini si serviva degli strumenti (subbia, due tipi di gradina, scalpello, ferrotondo, raspa, unghietto, trapano e abrasivi) secondo una precisa sequenza. Il proce-dimento bernininano prevedeva la sgrossatura e la prima definizione delle forme a subbia, seguita dalla chiarificazione dei dettagli del drap-peggio con la gradina e dalla levigatura con lo scalpello e la raspa73. Una linearità di procedimento lontana dalla lavorazione del braccio, che ricorda negli effetti di superficie piuttosto la Centauromachia di Casa Buonarroti o il Tondo Pitti, in cui le tracce degli strumenti rivela-no un procedimento che tende a definire le forme ‘simpateticamente’, ovvero secondo l’istinto dello scultore, e non per passaggi successivi, come è stato messo in evidenza da Wittkower74.
Il braccio mancante36
1996, spec. pp. 9-36; M.g. Helms, The Materials and Techniques of Italian Renais-sance Sculpture, in Looking at Italian Renaissance Sculpture, ed. by s. Blake McHam, Cambridge (ma), Cambridge U.p., 1998, pp. 18-39.
73 p. roCkWell, Gli angeli di Ponte S. Angelo. La tecnica dello scultore, in La via degli Angeli. Il restauro della decorazione scultorea di ponte S. Angelo, a c. di L. Cardilli aloisi, M.g. tolomeo speranza, Roma, de Luca, 1988, pp. 91-127.
74 WittkoWer, La scultura, cit., pp. 134-137. sulla tecnica di Michelangelo si veda ora anche a.m. farinato, È di Michelangelo: si vede dalla subbia e dallo scalpello, «Il giornale dell’arte», XVII, 1999, fasc. 177, p. 10. sull’istintività del processo creativo di Michelangelo scultore si sofferma anche s. CoHen, Some Aspects of Michelangelo’s creative Process, «art&Hist», XXXVII, 1998, pp. 43-63.
anche il grande tenone a forma di ‘L’ rovesciata intagliato nel marmo del braccio è anacronistico in rapporto alla prassi del restauro settecentesco. Un tale sistema di giunzione, suggerito dalla preoc-cupazione di fissare il pesante blocco al corpo della statua senza perni metallici, è un unicum e ha certamente posto allo scultore dei problemi complessi. Lo scavo della mortasa (fig. 17) è delicato, e in caso di errore la solidità del giunto sarebbe compromessa. Inoltre la superficie di contatto deve essere regolare e rettilinea, il che, come abbiamo visto, ha imposto il taglio della spalla di Laocoonte quando la collocazione del braccio è stata tentata (infra, p. 63). Una soluzione di questo tipo è assai più plausibile verso il 1525, quando la prassi del restauro appena cominciava ad acquisire qualche diffusione, che non al principio del XVIII secolo, in epoca di metodologie codificate. al tempo di Cornacchini i restauratori operavano serialmente e avevano a disposizione una manualistica basata sull’esperienza di diverse gene-razioni. Uno sguardo ai trattati secenteschi, a partire dalle Osserva- zioni sulla scoltura antica di orfeo Boselli (1657), ne fornisce la prova75. Il capitolo dedicato all’imperniatura fornisce un prontuario di misure per ciascun tipo di giunto: «come chiodo, o fil di ferro ordina-rio» per i nasi; «quanto è largo un quatrino» per polsi, braccia e ginoc-chia; «quanto è largo un mezo Baiocho» per torsi e cosce. Nello stesso capitolo si trova illustrato il procedimento per applicare i contrassegni dei fori di alloggiamento in modo da evitare sfasature76:
Facendo i busci nel pezzo antico, in lochi più forti e comodi li contras-segno con lapis in figura di lettera X o numero dieci maiuscolo il mezzo della quale sia il fatto buco, posandovi sopra li pezzi comessi, e contras-segnando li estremi di detta lettera di sopra come è sotto, nel mezzo della intersezione fo li busci corrispondenti, ne’ quali pongo i perni di ferro bene agiustati, et con la solita mistura li attacho insieme.
dietro queste prescrizioni c’è la consuetudine di botteghe e cantieri in cui si restauravano centinaia di statue, sarcofagi e bassorilievi per
I restauri 37
75 o. Boselli, Osservazioni sulla Scoltura Antica. I Manoscritti di Firenze e Ferrara, a c. di a.p. torresi, Ferrara, Liberty House, 1994, c. 174v; p. dent Weil, Contributions toward a history of Sculpture. I. Orfeo Boselli on the Restoration of antique Scultpure, «studCons», XII, 3, agosto 1967, pp. 81-101; d. sparti, Tecnica e teoria del restauro scultoreo a Roma nel Seicento, con una verifica sulla collezione di Flavio Chigi, «storia dell’arte», XCII, 1998, pp. 60-131. Le soluzioni adottate per la commessura delle parti moderne in restauri secenteschi, spec. di braccia in posizione levata, possono essere verificate in a.a. amadio, sch. nrr. 9, 22, 24, in La collezione Boncompagni Ludovisi. Algardi, Bernini e la fortuna dell’antico, Roma, Fondazione Memmo, palazzo Ruspoli, 5 dic. 1992 - 30 apr. 1993, a c. di a. giuliano, Venezia, Marsilio, 1992, pp. 116-121; 182-187; 194-199.
76 Boselli, Osservazioni, cit., c. 174v.
l’arredo dei grandi palazzi romani. Il Laocoonte era, certo, un pezzo eccezionale; ma appunto per questo è improbabile che un restauratore del 1720 rinunciasse ai metodi sperimentati per tentare una soluzione tanto ardua e inusitata. Inoltre nel braccio non troviamo applicato uno dei ‘segreti del mestiere’ che Bartolomeo Cavaceppi, principe e deca-no dei restauratori romani, avrebbe raccomandato qualche decennio dopo77:
Le commessure delle restaurazioni, anziché farsi piane e diritte, dovranno definirsi in maniera che appariscano casuali e irregolari, come appunto casuali e irregolari sono le rotture dell’antico.
Il contrario esatto di ciò che ha fatto lo scultore del Belvedere. Insomma, per tecnica esecutiva e sistema di imperniatura il braccio ‘di Michelangelo’ appartiene ad una fase più arcaica di quella descritta da Boselli e dai trattatisti settecenteschi. Vi si riconosce il procedere del-l’artista che inventa una soluzione ad hoc in un momento in cui nessu-na prassi è ancora norma e l’opera moderna ambisce a porsi in rapporto paritetico con l’antico invece che a nascondersi nello spirito mimetico del restauro neoclassico. Non a caso questa è l’interpretazione corrente nel settecento dei presunti restauri michelangioleschi.
Il braccio è, dunque, cinquecentesco: su questo punto si può ragio-nevolmente convenire. Ma per lungo tempo i visitatori del cortile, che pure tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo furono numerosi e tutt’altro che distratti, ne restarono all’oscuro78. Molte sono le riprove di questo oblio.
Il braccio mancante38
77 Raccolta d’Antiche Statue, Busti, Bassirilievi et altre Sculture restaurate da Bartolomeo Cavaceppi Scultore Romano, I, Roma, salomoni, 1768, s. n. di pagina (il passo è cit. in rinaldi, Tecnica e restauro, cit., p. 77). L’attività di restauratore del Cavaceppi e le sue opinioni sul restauro sono state oggetto di frequenti studi. Fra i contributi più recenti: o. rossi pinelli, Scultori e restauratori a Villa Borghese, in Collezionismo e ideologia. Mecenati, artisti e teorici dal classico al Neoclassico, a c. di E. debenedetti, Roma, Multigrafica, 1991, pp. 259-272; s. HoWard, Albani, Winckelmann and Cavaceppi. The Transition from Amateur to professional Antiqua- rianism, «JHistColl», IV, 1992, pp. 27-38; Bartolomeo Cavaceppi (1717-1799) scul-tore romano, Roma, Museo di palazzo Venezia, 25 gen. - 15 mar. 1994, a c. di M.g. Barberini, C. gasparri, Roma, palombi, 1994; da ultimo Von der Schönheit weissen Marmors: zum 200. Todestag Bartolomeo Cavaceppis, schloss Wörlitz, galerie am grauen Haus, 19 Jun. - 5 sept. 1999), hrsg. v. th. Weiss, Mainz a. R., von Zabern, 1999, in particolare d. kreikenBom, Cavaceppis Maximen zur Antikenrestaurierung, pp. 85-92; U. müller-kaspar, Cavaceppi zwischen Theorie und Praxis, pp. 93-102; n. ramage HirsCHland, The Pacetti-Papers and the Restoration of Ancient Sculpture in the 18th Century, pp. 79-84.
78 sull’attitudine dei viaggiatori nei confronti delle statue antiche (e sugli stru-menti linguistici con cui esprimono il loro interesse): J.-p. Haldi, Die Rezeption
Nel 1688 l’architetto svedese Nicodemus tessin il giovane, osser-vatore così meticoloso da elencare una per una tutte le dita rotte delle statue del cortile, attribuisce erroneamente il braccio montorsoliano in terracotta a Michelangelo: prova inoppugnabile che non conosceva il braccio che di lì a poco sarebbe stato per tutti del Buonarroti79.
Il 28 ottobre 1707 Jean de Wargnier de Blainville, ex-segreta-rio dell’ambasciata olandese a Madrid, a tutti noto semplicemente come Monsieur de Blainville, si sofferma lungamente sul fatto che Michelangelo chiamava il Belvedere «il suo luogo di studio» e che il Laocoonte era per lui «un prodigio della scultura», ma ignora il pezzo che sarebbe stata la migliore prova del rapporto fra il maestro e il monumento tanto ammirato80.
Nel 1719, solo poche settimane prima della visita dei pittori inglesi Richardson padre e figlio, Jean-Baptiste du Bos dedica una pagina delle sue fondamentali Refléxions critiques sur la Poesie e sur la peinture a dimostrare la superiorità del Laocoonte sul Mosè di Miche- langelo. ancora una volta il braccio, che nel serratissimo confronto fra il maestro e il capolavoro antico sarebbe stato un prezioso testimone a supporto della posizione antimoderna, latita81.
per una ragione o per l’altra, prima del 1720 il braccio non era accessibile ai visitatori del cortile. Ma contrariamene a quel che pen-
I restauri 39
römischer Antikensammlungen durch “Grand Touristen” in 18. Jahrhundert, in Von der Schönheit weissen Marmors, cit., pp. 17-22.
79 [n. tessin], N.T. d. Y:s Studieresor i Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike och Italien; anteckningar, bref och ritningar, a c. di o. sirén, stockholm, Norsted, [1914], p. 160. sull’opera e la personalità del tessin, uno dei maggiori architetti del primo settecento in svezia: R. JosepHson, Nicodemus Tessin D.Y. Tiden, mannen, verket, stockholm, Norstedt, [1930-1931].
80 Il resoconto del viaggio è pubblicato per la prima volta in inglese dopo la morte dell’autore: [J. de Wargnier, le sieur de Blainville], Travels trough Holland, Germany, Switzerland, but especially Italy in three volumes by the late Monsieur de B., London, printed for John Noon, 1757, a me non accessibile. Cito dalla traduzione tedesca: [id.], Reisebeschreibung durch Holland, Oberdeutschland und die Schweiz besonders aber durch Italien &c., III, Reisebeschreibung besonders durch Italien enthaltend die Fortsetzung der Beschreibung von Rom &c., Lemgo, in der Meyerschen Buchhandlung, 1766, p. 136.
81 [J.-B. dU Bos], Refléxions critiques sur la Poesie e sur la peinture par l’abbé d.B. &c., À paris, chez Jean Mariette, 1719, I, p. 385. Esiste un’edizione moderna del trattato: id., Réflexions critique sur la poésie et la peinture, pref. de d. désirat, paris, Éc. Nat. sup. d. Beaux-arts, 1993; ora anche una trad. integrale in ital.: id., Rifles- sioni critiche sulla poesia e sulla pittura, a c. di M. Mazzocut-Mis e p. Vincenzi, trad. ital. di M. Bellini e p. Vincenzi, palermo, Centro Intern di st. di Estetica, 2005. per l’importanza delle Réflexions nella cultura settecentesca: Jean-Baptiste du Bos e l’estetica dello spettatore, a c. di L. Russo, palermo, Centro Intern. di st. di Estetica, 2005.
sano i sostenitori della cronologia settecentesca, ciò non significa che non esistesse: la possibilità che sia stato scolpito all’inizio del XVIII secolo è, anzi, assai remota. oltre alle ragioni tecniche già ricordate, è veramente poco plausibile che i visitatori che lo videro dopo la ricomparsa, molti dei quali artisti o comunque familiari con la scultura antica e moderna, scambiassero un marmo appena uscito dalle mani dello scultore e neppure terminato, con i segni della lavorazione fre-schi, per un cimelio vecchio di due secoli. se al suo apparire il braccio evoca la paternità di Michelangelo è perché, comunque, porta su di sé i segni del tempo; perché a tutti coloro che lo vedono sembra antico e venerando.
Il fatto poi che torni in luce verso il 1720 può spiegarsi in relazione alle vicende architettoniche e amministrative dei Musei Vaticani. In quegli anni, gli ultimi del pontificato di Clemente XI (1700-1721), erano in corso importanti lavori di riordino delle collezioni e di rias-setto degli spazi espositivi. sovrintendeva all’impresa, che avrebbe portato alla nascita del museo Clementino, il ‘presidente delle anti-chità’ monsignor Francesco Bianchini, il quale andava trasformando il Cortile delle statue con lo spostamento del Torso nella Loggetta occi-dentale (da allora detta ‘sala del Torso’) e la progettata sistemazione al centro dell’ottagono della vasca di porfido proveniente dalle terme di Caracalla, che con otto colonne prelevate dalla pergola paleocristiana del Pantheon doveva costituire una fontana monumentale82. Il pro-getto non andò a buon fine e i lavori si arrestano dopo la sistemazione della vasca e la costruzione di una tettoia provvisoria che era ancora in opera quando giovanni pietro Chattard pubblicò il terzo volume della Nuova descrizione del Vaticano (1767)83. Ma in questo programma trovano posto la riparazione del Laocoonte e dell’Apollo (infra, pp. 60 ss.) e, probabilmente, la valorizzazione del ‘prezioso’ braccio, che si può supporre riemerso nel corso dei lavori. al convinto assertore di una museografia centrata sulla storia, quale Bianchini fu per tutta la vita, quel marmo immediatamente ricondotto a Michelangelo dal non-finito appariva certo degno di essere ammirato accanto al capolavoro antico cui era destinato. Non solo opera di mano insigne, ma documento di un’idea che le circostanze non avevano consentito di portare a termine: esattamente come i modelli lignei della mai realizzata sacrestia di s.
Il braccio mancante40
82 C. pietrangeli, Il Museo Pio-Clementino Vaticano, «Rendpontacc», XXVII, 1951-1954, pp. 87-107; g.p. Consoli, Il Museo Pio-Clementino. La scena dell’antico in Vaticano, Modena, panini, 1996, pp. 34-58; liverani, Geschichte des Cortile, cit., p. ix s.
83 M. loret, I lavori artistici nel Vaticano durante il pontificato di Clemente XI (1700-1721), «archivi d’Italia», s. ii, III, 1936, pp. 54-59.
pietro in s. Maria della febbre appena esposti nella rinnovata villetta di Innocenzo VIII84.
Il braccio è dunque con ogni probabilità cinquecentesco e con altrettanta probabilità mai uscito dal Belvedere in cui fu scolpito e dimenticato. Cinquecentesco però non significa di Michelangelo: su questo punto la posizione degli studiosi ‘scettici’ è perfettamente giustificata. dato che nessun elemento, al di là delle dicerie dei turisti Ancien Regîme, ne supporta l’attribuzione, il nome del Buonarroti andrà lasciato da parte.
Chi fu allora quello scultore «dotato di immenso carisma» che fu autorizzato a mettere le mani sul Laocoonte? se riflettiamo, il solo ele-mento di una qualche consistenza per collocare il braccio in un ambito culturale definito è la somiglianza della soluzione adottata con quella del Laocoonte di Baccio Bandinelli. Il braccio piegato, la spira del ser-pente avvolta su se stessa, la mano rovesciata all’indietro a significare l’inanità della lotta rimandano al gruppo degli Uffizi: nei bronzetti che presentano la stessa soluzione, come quello di Ludovico Lombardi (Cr 10, fig. 26) la mano resta dritta. se Baccio ha eseguito le braccia dei fanciulli, come ho cercato di provare, è possibile che abbia progettato l’esecuzione di quello del padre, che poi non fu concluso, forse perché non riuscito troppo bene oppure perché, come è stato suggerito, sono intervenute opposizioni esterne85.
appare così meglio comprensibile la notizia vasariana del restauro provvisorio in cera. La testimonianza stabilisce una relazione fra il Laocoonte degli Uffizi (Co 1, fig. 15) e il braccio incompiuto, confe-rendo alla somiglianza un certo peso nella questione della paternità. se d’altra parte l’autore fosse un artista che non conosciamo, costui avrebbe davvero fatto un braccio identico a quello dell’irascibile fiorentino? guardando bene, il marmo incompiuto del Belvedere differisce dal braccio della copia solo per la mancanza del triplice
I restauri 41
84 liverani, Geschichte des Cortile, cit., p. ix s. sui modelli di s. Maria della febbre: Architekturmodelle der Renaissance: die Harmonie des Bauens von Alberti bis Michelangelo, Berlin, Kunstbibl. im alten Museum, 7 ott. 1995 - 7 gen. 1996, hrsg. v. B. Evers, München, prestel, 1995. Vd. anche il progetto del Museo Ecclesiastico, che illustrava i primi secoli della chiesa (Ch. Hülsen, Il “Museo Ecclesiastico” di Clemente XI Albani, «BulCom», XVIII, 1890, pp. 260-277) e il museo di arte religiosa romana dietro l’attuale cortile della pigna, cui erano destinati pezzi di epoche diverse, dai mosaici staccati di santa sabina al bozzetto berniniano per l’angelo della Cathedra Petri (C.M.s. JoHns, Papal Art and Cultural Politics. Rome in the Age of Clemens XI, Cambridge (ma), Cambridge U.p., 1993, pp. 33-38).
85 rossi pinelli, Chirurgia della memoria, cit., p. 186 e lasCHke, Die Arme, cit., p. 177 s. ipotizzano, ma senza elementi, un intervento di Michelangelo contrario alla soluzione del Bandinelli.
avvolgimento del serpente intorno alla spalla. Una semplificazione che pare suggerita dalla necessità di non appesantire troppo l’aggiunta, che altrimenti avrebbe potuto dare problemi nel tempo. analoghe conside-razioni di ordine pratico hanno indotto lo scultore a far terminare la coda del serpente in corrispondenza della parte esterna della scapola invece di ricollegarla al frammento della spira visibile sul dorso, evi-tando di predisporre un pezzo a parte, dato che l’ultima parte del corpo del serpente non avrebbe potuto essere ricavato dal medesimo blocco del braccio.
tenendo conto del contesto, insomma, Baccio Bandinelli parrebbe un candidato credibile come autore del braccio. Ma tutto il discorso che precede è un suggerimento, l’indicazione di una via da appro-fondire, piuttosto che una proposta attributiva articolata e definitiva. Il braccio deve esser rimosso dalla sua scomoda collocazione sulla faccia posteriore del basamento moderno del Laocoonte, esaminato con attenzione, fotografato, possibilmente esposto al pubblico. Una verifica completa e minuziosa del modo in cui la mano cinquecentesca ha operato sul marmo potrà, forse, fornire qualche indicazione a sup-porto delle ipotesi qui formulate. Il testimone passa agli specialisti di scultura cinquecentesca.
Giovanni Angelo Montorsoli
Il braccio di marmo non fu mai stabilmente installato sul Laocoonte, che restò per un certo numero di anni nella condizione in cui lo ha dise-gnato l’autore della veduta londinese (ds 31, fig. 10). solo quando la copia di Baccio (Co 1, fig. 15) aveva ormai preso la strada di Firenze, il braccio mancante fu finalmente eseguito dal fiorentino giovanni angelo Montorsoli, uno dei collaboratori più fidati di Michelangelo. Vasari attribuisce una certa importanza alla commissione e ne fornisce un resoconto preciso (Le vite, vi, p. 632):
Essendo Michelagnolo a Roma appresso papa Clemente, il qual voleva che l’opera di san Lorenzo si continuasse, e perciò l’aveva fatto chiamare, gli chiese sua santità un giovane che restaurasse alcu-ne statue antiche di Belvedere che erano rotte. perché ricordatosi il Buonarroti di Fra giovann’agnolo, lo propose al papa; e sua santità per un suo breve lo chiese al generale dell’ordine de’ servi, che gliel concedette, per non poter far altro, e malvolentieri. giunto dunque il frate a Roma, nelle stanze di Belvedere che dal papa gli furono date per suo abitare e lavorare, rifece il braccio sinistro che mancava all’apol-lo, ed il destro del Laocoonte, che sono in quel luogo, e diede ordine di racconciare l’Ercole similmente.
Il braccio mancante42
pochi passi de Le vite sono stati altrettanto citati e commentati, ma diversi aspetti della vicenda restano oscuri. Il racconto non contiene alcuna indicazione cronologica, a parte la menzione del pontificato di Clemente VII. per circoscrivere l’epoca dell’intervento è indispen-sabile ricorrere al carteggio michelangiolesco, fonte sempre preziosa di informazioni. Il primo a servirsene è stato adriano prandi, il cui ragionamento merita di essere riportato per intero86:
È del luglio 1532 una lettera di sebastiano del piombo, che comunica a Michelangelo di essere riuscito ad ottenere dal papa che il Montorsoli venisse a Roma, secondo il desiderio espresso dal Buonarroti stesso in una lettera esattamente un mese prima. Il 25 luglio del ’33 ancora sebastiano del piombo scrive a Michelangelo; e dal contesto risulta che il Montorsoli è a Firenze. Il thode avverte che il Montorsoli sulla fine del 1532 lavorava con Michelangelo alla sepoltura di giulio II. Non si ha più notizia del Montorsoli a Roma prima della morte di Clemente VII (1534), che volle il restauro. sì che l’opera del Montorsoli – il braccio di terracotta – non poté essere eseguito che tra il luglio del 1532 e il luglio del 1533; o meglio, tenuto conto dell’installazione dello scultore in Belvedere, dei saggi bene accetti al papa, dei lavori per l’apollo che sembrano aver preceduto quelli per il Laocoonte, si può ritenere che il restauro avvenne sulla fine del 1532, o, com’è più credibile, nei primi mesi del ’33.
La lettera di sebastiano, chiamata in causa per provare che a quella data il Montorsoli era ancora a Firenze, dimostra soprattutto che il racconto de Le vite è impreciso. Vasari attribuisce la volontà di restau-rare le sculture vaticane a Clemente VII, il quale in proposito avrebbe consultato Michelangelo e nel colloquio fra i due sarebbe poi maturata la decisione di affidare l’incombenza a Montorsoli, subito richiesto al priore del convento dell’annunziata. dalle parole di sebastiano si capisce che le cose sono andate in un altro modo87:
per la seconda vostra, facta addì 15 zugnio, mi ricercate che habbi una licentia da Nostro signore che possiate condurre el frate che lavora di marmo de l’ordine de’ servi, et che la licentia se habbia dal generale del ditto hordine, ma non mi havete mandato el nome del generale et el nome del frate, del modo che ho durato fatica a saperlo in Roma, maxime del sculptore: pur l’ò avuto et Nostro signore ha facto fare un breve al sopra detto generale che possiate condurre il detto frate in Roma a piacer vostro [cors. mio].
I restauri 43
86 prandi, La fortuna, cit., p. 83.87 Il carteggio di Michelangelo, cit., III (1980), lett. dCCClxxxi (sebastiano del
piombo, in Roma, a Michelangelo, in Firenze, 15 lug. 1532), p. 419 s.
siamo all’inizio dell’estate del 1532. Michelangelo, che si trova a Firenze e non a Roma, ha scritto a sebastiano, che cura i suoi affari in curia, perché ottenga dal papa un permesso per «il frate che lavora di marmo» a lasciare il suo convento fiorentino. Nonostante qualche contrattempo (Michelangelo non aveva comunicato il nome del frate e nessuno a Roma sapeva chi fosse), la commissione viene eseguita. Clemente autorizza con un breve l’uscita di Montorsoli dal convento, superando d’autorità l’opposizione del priore, e sebastiano il 15 luglio comunica il documento a Michelangelo. L’incombenza per la quale Michelangelo chiede così insistentemente di portare con sè Montorsoli a Roma contro la volontà dei superiori non è il restauro delle sculture del Cortile, cui allora nessuno pensa, bensì un progetto che gli sta molto più a cuore, in quel momento più a cuore di ogni altro: la tomba di giulio II.
Il più grandioso sepolcro dell’era cristiana è tornato d’attualità dopo che in aprile Michelangelo ha firmato il nuovo contratto con gli eredi di giuliano della Rovere, ed è appunto a seguito di quell’accordo che si accinge a tornare a Roma88. Il contratto prevede undici statue, di cui cinque affidate a collaboratori. Montorsoli sarà fra questi, con Baccio d’agnolo, giovanfrancesco Rustici e Raffaello da Montelupo. a termini di contratto il breve di uscita del frate dal convento viene sottoposto al placet del duca di Urbino, Francesco Maria della Rovere, contraente dell’allogazione per conto degli eredi di giulio II89.
Una volta giunti a Roma Michelangelo e il Montorsoli lavorano a pieno ritmo alla tomba. secondo tolnay in novembre Montorsoli ha già sbozzato il Profeta, la Sibilla e la Vergine90. Il lavoro prosegue nei mesi seguenti, e intanto il frate trova il tempo di restaurare le sculture del Cortile. a dispetto dell’enfasi a posteriori che il Vasari pone su questi restauri, interessato com’è ad amplificare il ruolo mediceo nella com-mittenza michelangiolesca, gli interventi in Belvedere sono un affare secondario. anche perché il soggiorno romano dei due artisti è breve.
Il braccio mancante44
88 per la complessa vicenda della tomba di giulio II: Ch. de tolnay, Michelangelo, IV, The Tombe of Pope Julius II, princeton (ma), princeton U.p., 1954, 19702, qui spec. p. 56; una eccellente sintesi è J. pope Hennessy, Italian Renaissance and Baroque Sculpture. An Introduction to Italian Sculpture, III, London, phaidon, 1963, New York, Vintage Book, 19853, pp. 311-324; ora anche i saggi raccolti in Michelangelo: Selected Scholarship in English, ed. by W.E. Wallace, IV, Tomb of Julius II and other Works in Rome, New York, garland, 1995. Fonti e documenti sono raccolti in vasari, La Vita di Michelangelo, cit., III, pp. 1160 ss.
89 Il carteggio di Michelangelo, cit., p. 419: ‘et cossì vi mando il breve, con la reti-fichatione del duca di Urbino, con doi sue littere, credo che siano dell’imbasatore suo’.
90 de tolnay, Michelangelo, cit., 76; cf. C. eCHinger-maUraCH, Michelangelo’s monument for Julius II in 1534, «BurlMag», CXLV, 2003, pp. 336-344; a. forCellino, Le statue della tomba di Giulio II, «Monumentidiroma», I, 2003, pp. 145-149.
Nonostante si dia per certo che Michelangelo arrivi a Roma alla fine di luglio del 1532 e ne riparta nel luglio del 1533, vi è la prova che il tra-sferimento avvenne quasi due mesi più tardi e la partenza quasi un mese prima. La lettera di sebastiano del 15 luglio non è l’ultima ricevuta da Michelangelo in Firenze. Un’altra di Bartolomeo angelini, un fiorentino che frequentava la curia, è del 21 agosto. a un mese e più dal breve pon-tificio i preparativi sono ancora in corso: «fra’ Bastiano mi à detto che di giorno in giorno vi attende qua»91. prima che Michelangelo si metta in viaggio passano altre tre settimane. Il 19 settembre è da poco arrivato a Roma. Quel giorno riceve un’altra lettera dell’angelini da cui si intende che si è appena sistemato nella nuova casa, trovandola abbastanza di suo gusto92. Nel testo c’è un’allusione a Montorsoli, che abita con Miche- langelo: maestro e allievo hanno probabilmente viaggiato insieme.
Michelangelo contava di fermarsi a Roma abbastanza per finire la tomba «di papa Iulio». Ma ancora una volta le sue speranze andarono deluse. Nove mesi dopo è nuovamente a Firenze. sebastiano gli scrive il 17 luglio 153393:
Ho ricevuto una vostra a me gratissima per haver inteso l’esser zonto vui a Firenze sano et salvo con tutta la compagnia, che dio sia rengra-tiato et cet. Hora vi fo intender come io ho mostro la vostra littera a Nostro signore, quale l’ha tenuta dui zorni et àlla studiata molto bene [...] et li piace assai, et molto si contenta de tutte le cosse havete hordi-nate et del Frate, che habi cominciato a lavorare, et de li scarpellini che havete messo in opera et de tutte le cosse havete ordinato et cet.
Con queste parole sebastiano risponde ad una lettera perduta di Michelangelo che annunciava il felice esito del viaggio e l’inizio dei lavori alle statue della sacrestia Nuova, fortemente voluti da Clemente VII94. tenendo conto della durata del tragitto Roma-Firenze (a caval-lo, con i bagagli e tutta la compagnia, sarà occorsa una settimana o poco meno), del fatto che prima di scrivere hanno ripreso il lavoro alla sacrestia, che le loro missive hanno dovuto giungere a Roma (quattro giorni in media), che in una corrispondenza ci sono dei tempi morti (il papa tiene presso di sé doi zorni la lettera di Michelangelo), è evidente che la partenza da Roma risale al mese di giugno95.
I restauri 45
91 Il carteggio di Michelangelo, cit., III (1980), lett. dCCClxxxvii (Bartolommeo angelini, in Roma, a Michelangelo, in Firenze, 21 agosto 1532), p. 429.
92 Il carteggio di Michelangelo, cit., III (1980), lett. dCCCxC (Bartolommeo angelini, in Roma, a Michelangelo, in Roma, 19 settembre 1532), p. 432.
93 Il carteggio di Michelangelo, cit., IV (1983), lett. Cmx (sebastiano del piombo, in Roma, a Michelangelo, in Firenze, 17 luglio 1533), pp. 17-19.
94 Ibid., p. 19.95 per l’itin. Roma-Firenze nel Cinquecento: Comunicazioni stradali attraverso
sappiamo allora che Michelangelo e Montorsoli sono rimasti a Roma al massimo dalla metà di settembre del 1532 alla fine di giugno del 1533 e che in questi nove mesi hanno lavorato alle sculture della tomba. Montorsoli nel frattempo ha restaurato il Laocoonte e l’Apol-lo, e curato che qualcun altro restaurasse l’Ercole-Commodo. Molti impegni per un soggiorno così breve. Impegni di cui probabilmente è proprio il braccio di Laocoonte a fare le spese.
Il braccio che Montorsoli modella per il gruppo è più semplice di quello ‘di Michelangelo’ (figg. 16, 18), qui attribuito a Bandinelli. Nei disegni e nelle incisioni esso appare sollevato e teso, con la mano che afferra il corpo del serpente e lo allontana. I muscoli sono contratti per lo sforzo ma il braccio è libero dalle spire, che formano un occhiello verticale annodandosi all’altezza del bicipite. Un gesto carico d’enfasi, che sottolinea l’opposizione di Laocoonte al destino decretato dagli dei e la cui intensità retorica è accentuata dalla scelta dei disegnatori. I più prediligono un punto di vista frontale e leggermente ribassato che evidenzia la rotazione del busto e delle spalle (ad es. ds 40, fig. 23; 43, fig. 28; 44, 45, fig. 29; 48; 60, fig. 30; 62, fig. 31 etc.), offrendo una visione del braccio dall’interno, con la plica del gomito in avanti, il che accentua l’effetto di distensione. In realtà il braccio era sì levato e lontano dal capo, ma non teso, e si inclinava leggermente in avanti, com’è perfettamente evidente nella splendida vista laterale disegnata da Rubens fra il 1606 e il 1608 (ds 69, fig. 33) e poi nelle puntigliose tavole quotate delle Proportions du corps humain di gerard audran (ds 94, 96, 97, figg. 34-36).
Il problema principale del restauro montorsoliano è di ordine cro-nologico: determinare con esattezza quando il braccio fu messo in opera. abbiamo visto che lo scultore fu a Roma con Michelangelo dal settembre ’32 al giugno ’33. Ma se consideriamo i disegni degli artisti presenti a Roma nello stesso periodo troviamo che il Laocoonte non vi appare mai restaurato. due fogli dei taccuini berlinesi di Marten van
Il braccio mancante46
i tempi. Firenze-Roma, a c. di d. strepos, Novara, de agostini, 1964. alcuni esempi: nel 1503 Niccolò Machiavelli impiega quattro giorni (dalla mattina del 24 alla sera del 27 marzo) andando a Roma «con ogni presteza» (p. 107); il cardinale giovanni de’ Medici che si reca al conclave del 1513 viaggia cinque giorni (dal 22 al 26 feb-braio: p. 113), anch’egli «con grande presteza»; una delegazione solenne come quella di giuliano de’ Medici che porta la Gratulatio a Leone X, con duecento cavalli e i carriaggi, ne impiega nove (dal 17 al 25 maggio 1513: p. 116). per le lettere la durata media del tragitto è quattro giorni: quelle urgentissime di Machiavelli alla signoria con l’annuncio dell’elezione di giulio II (avvenuta nella notte fra il 31 ottobre e il 1 novembre 1503) partono il 1 novembre, una al mattino presto, le altre durante la giornata, e arrivano tutte il 4 novembre (p. 107 s.); la lettera di Bonsignore Bonsignori a Bernardo Michelozzi che annuncia la scoperta del Laocoonte porta la data del 24 gennaio 1506 ed è a Firenze il 28 (maffei, La fama di Laocoonte, cit., p. 101).
Heemskerck (ds 32, fig. 19; ds 36) e la veduta del British Museum (ds 31, fig. 10), supponendo che sia anch’essa di mano del fiammingo, mostrano concordemente il gruppo incompleto. In una pagina dell’al-bum detto London I di amico aspertini (ds 26, fig. 20) Laocoonte ha il braccio ripiegato e la mano aperta appoggiata alla nuca in un gesto di fantasia, del tutto diverso da quello montorsoliano. dal momento che Van Heemskerck fu a Roma fino al 1535 e aspertini vi soggiornò a più riprese fra il ’31 e il ’35, il fatto che entrambi ignorino il nuovo braccio è alquanto strano96. si aggiunga, ad accrescere i dubbi, che le altre statue di cui Vasari attribuisce il restauro al frate, l’Apollo e l’Ercole, sono restaurate, così come il fiume del padiglione simonetti, il cosiddetto Tigri-Arno, la cui testa moderna è tradizionalmente messa in rapporto con Michelangelo97.
Come spiegare l’incongruenza? si potrebbe addirittura supporre che il racconto vasariano sia falso e che il restauro delle statue del cor-tile sia avvenuto secondo altre circostanze e in tempi differenti. Ma per un’ipotesi così estrema il sostegno dei soli disegni di van Heemskerck è probabilmente troppo poco (aspertini potrebbe aver alterato i gesti volutamente)98. È stato proposto che van Heemskerck disegnasse il
I restauri 47
96 sul soggiorno e l’attività di van Heemskerck a Roma la documentazione è raccolta da Ch. Hülsen, H. Egger, Die römische Skizzenbücher von Marten van Heemskerck, II, Berlin, Bard, 1916, p. xv s., che fissano le date di arrivo e di partenza rispettivamente nel 1532 e nel 1537. In seguito lo stesso Egger corresse questa opinio-ne sulla base di una più attenta lettura della biografia del van Mander (H. egger, Zur Dauer von Martens van Heemskerck Aufenhalt in Rom 1532-1535, «Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome», V, 1925, pp. 119-127), anticipando la partenza al 1535. La validità di questa data è stata ribadita da I.M. Veldman, rec. a Facsimile of Ch. Hülsen, H. Egger, Die Römischen Skizzenbücher von Marten van Heemskerck, a c. di a. Netto Bol, soest, 1975, «simiolus», IX, 1977, pp. 106-113; E. filippi, Marten van Heemskerck. Inventio Urbis, Milano, Berenice, 1990, pp. 17 s. e 33, n. 71. da ultimo se ne occupa brevemente L. siCkel, «Maria Mater Dei» und die Antiken Roms. Anmerkungen zu einem Kupferstich nach Marten van Heemskerck, «ZfK», LXI, 1998, pp. 40-54. per quanto riguarda aspertini va osservato che una notazione autografa in fondo al taccuino londinese precisa: «a. 1535 in festo s. Michaelis terminato» (BoBer, Drawings after the Antique, cit., p. 14). Ma il regesto documentario di amico non presenta vuoti tali da rendere possibile una lunga assen-za da Bologna nel periodo 1530-1535: di qui l’ipotesi ormai generalmente accettata di più soggiorni di breve durata. La messa a punto più recente in M. Faietti, d. kelesCian sCaglietti, Amico Aspertini, Modena, artioli, 1995, pp. 68-73. Ulteriori notizie in M. iodiCe, Integrazioni al regesto di Amico Aspertini: vicende pubbliche e familiari di un grande pittore bolognese, «schUmanistiche», n.s., I, 1994, pp. 95-110.
97 Collareta, Michelangelo e le statue antiche, cit., pp. 51-55; R. rUBinstein, The Statue of the River God Tigris or Arno, in Il Cortile delle Statue, cit., pp. 275-286.
98 sulle frequenti ‘licenze’ nei disegni dall’antico del bolognese: g. Cosmo, Aspertini e la scultura antica, «antologia di belle arti», XXI-XXII, 1984, pp. 25-39;
Laocoonte subito dopo il suo arrivo a Roma, nell’estate del 1532, e che tornasse in tempi successivi in Belvedere per disegnare l’Apollo, l’Ercole, il Tigri e le altre statue del cortile. Ma anche questa prudente scappatoia poco risolve. Il fiammingo ha disegnato il Laocoonte molte volte, non una sola; stranamente, però, sempre prima del restauro, come se il suo interesse fosse venuto meno proprio quando il gruppo aveva riacquistato la sua integrità: un’ipotesi che urta contro la comune verosimiglianza. La spiegazione dev’essere un’altra. Essa emerge, mi pare, incrociando i documenti grafici con i resoconti dei viaggiatori, in questo come in tanti altri casi prodighi di notizie importanti non meno che di luoghi comuni.
Le prime rappresentazioni del Laocoonte con il braccio montorso-liano compaiono qualche anno dopo che van Heemskerck e aspertini hanno lasciato Roma. Francisco de Holanda disegna il Laocoonte a c. 9v del codice delle Antigualhas dell’Escorial (ds 38, fig. 21) fra il settembre 1538 e il marzo 1540: nonostante qualche libertà nei par-ticolari il braccio sembra quello di Montorsoli99. La pittoresca e un po’ fantasiosa xilografia del frontespizio delle Stanze sopra la statua del Laocoonte di Eurialo d’ascoli è del 1539 (ds 39, fig. 22) e pare anch’essa presupporre il nuovo braccio. La seconda edizione della Urbis Romae topographia di Bartolomeo Marliani che contiene la xilografia con il Laocoonte, prima immagine sicura del gruppo restau-rato, è del 1544 (ds 40, fig. 23).
La riprova definitiva dell’installazione del braccio prima del ’40 è fornita dal getto bronzeo del Laocoonte a Fontainbleau, il cui stampo fu tratto da Francesco primaticcio su commissione di Francesco I nella primavera di quell’anno (Ca 1, fig. 24)100. sul calco non sono presenti le integrazioni moderne, rimosse durante l’esecuzione dello stampo, ed è dunque ben visibile la zona di frattura della spalla (fig. 25), ove la
Il braccio mancante48
g. sCHWeikHart, Studio e reinvenzione dell’antico nell’opera di Amico Aspertini, in Roma, centro ideale della cultura dell’Antico nei secoli XV e XVI. Da Martino V al Sacco di Roma, atti del Conv. Intern. di st. su Umanesimo e Rinascimento, Roma, 25 - 30 nov. 1985, a c. di s. danesi squarzina, Milano, Electa, 1989, pp. 27-29.
99 e. tormo, «Os Desenhos das antigualhas que vio Francisco d’Ollanda, Pintor Portugués» (...1539-1540...). publicalos, con notas de estudio y preliminares, el prof. E.t., Madrid, s.n., 1940, c. 9v; desWarte-rosa, Francisco de Hollanda, cit., pp. 389-410.
100 s. pressoUyre, Les fontes du Primatice à Fontainbleau, «BulMon», CXXVII, 1969, pp. 223-239; settis, Laocoonte, cit., p. 13 ss.; J.-R. gaBorit, sch. nr. 70, in D’après l’antique, cit., p. 232 s.; d. Cordellier, La mission à Rome en 1540 et les expéditions de 1540 et 1542, in Primatice. Maître de Fontainbleau, paris, Musée du Louvre, 2 sept. 2004 - 3 jan. 2005, comm. d. Cordellier, paris, Réunion d. Mus. Nationaux, 2004, p. 137 s.; g. BresC-BaUtier, Le fontes d’aprés l’antique, ibid., pp. 140-142.
superficie del bronzo ha delle sottili striature irregolari, probabilmente lasciate da uno strumento dentato sulla cera di fusione. Vi si scorgono le tracce dell’otturazione di due fori (a) di alcuni centimetri di diame-tro, che possono essere interpretati solo come i fori di alloggiamento dei perni che sostenevano il braccio del Montorsoli. gli stessi fori (a) si individuano sull’originale fotografato dal Magi dopo la rimozione del braccio nel 1957 (fig. 17): quello superiore sopra l’area interessata dallo scasso per il tenone del braccio non finito; quello inferiore, che cadeva entro l’area scavata e quindi scomparso, tradito dalla scheg-giatura curvilinea sul bordo della mortasa. gli altri fori visibili sul marmo (b), uno in fondo alla mortasa, un altro nella parte superiore destra, sono con ogni probabilità da mettere in relazione con il braccio in terracotta che sostituì quello montorsoliano dopo il taglio della spal-la verso il 1784 (infra, pp. 60 ss.).
se tutti questi indizi sono, come mi pare, significativi e attendibi-li, ne discende una conclusione obbligata: il braccio fu installato sul Laocoonte fra il 1535 e la primavera del 1540, ovvero solo qualche anno dopo il soggiorno romano del Montorsoli. Lo spostamento in basso è abbastanza significativo, ma non implica il rigetto del raccon-to de Le vite, né tanto meno della paternità montorsoliana; costringe invece a ipotizzare una diversa sequenza dei fatti.
pur se ispirato da Michelangelo e materialmente eseguito da Mon-torsoli fra il ’32 e il ’33, il braccio dovette rimanere incompiuto ed essere portato a termine, o semplicemente messo in opera, da qualcu-n’altro prima dell’esecuzione del calco di primaticcio. perché ciò sia accaduto, e fors’anche quando, si comprende se poniamo mente ad una notizia che fluttua vaga e indistinta nella bibliografia, ripetuta di frequente senza precisi riferimenti: il braccio di Montorsoli non era di marmo bensì di terracotta e di aspetto poco rifinito.
La notizia non è tramandata da Vasari, né da altri autori cinquecen-teschi, ma da fonti tarde. La prima, a mia conoscenza, è il commento non firmato alle tavole con il Laocoonte delle Signorum veterum ico-nes (ds 91, 92), un’ambiziosa raccolta di acqueforti pubblicata dall’in-cisore olandese Jan de Bisschop (noto anche con il nome latinizzato di Iohannes Episcopius) fra il 1668 e il 1669101. Il testo contiene un aned-doto significativo: Michelangelo avrebbe ricevuto da giulio II l’ordine di restaurare il Laocoonte ma non volle eseguire l’intervento, ritenendo di non poter competere con i summi artifices antichi; per non disobbedi-re al papa, tuttavia, avrebbe modellato un braccio in stucco al quale per
I restauri 49
101 J.g. van gelder, I. Jost, Jan de Bisschop and his Icones & Paradigmata. Classical Antiquities and Italian Drawings for artistic Instruction in Seventeenth Century Holland, I-II, Beukenlaan, doornspijk davaco, 1985, II, p. 104.
modestia avrebbe evitato di dare l’ultima mano. L’onnipresente topos della modestia è qui usato in chiave inedita: non solo anticipato nel tempo (il pontefice che affida il restauro a Michelangelo è giulio II, non Clemente VII), ma anche riferito ad un oggetto diverso dal braccio mar-moreo che lo avrebbe in seguito monopolizzato (supra, pp. 31 ss.). Una reinterpretazione eziologica ad hoc, che pare fatta apposta per spiegare la presenza sul Laocoonte di un braccio provvisorio, modellato e non scolpito, di aspetto in qualche modo disturbante.
E la riprova che appunto tale era il braccio di Montorsoli è fornita dai loquaci visitatori settecenteschi, in primo luogo dalla penna senza fron-zoli di Johnathan Richardson, che descrive il Laocoonte nel 1720102:
Il braccio destro della figura principale [...] è perduto, al suo posto ne è stato messo uno di terracotta; ma siccome è grezzo, non finito, mal lavorato, e per di più di colore sgradevole, l’occhio ne è in qualche modo disturbato.
a parte la differenza del materiale, la terracotta invece dello stucco, che non costituisce un problema per la sostanziale intercambiabilità dei due termini negli scritti d’arte fino al XIX secolo, è significativa la sequela dei giudizi tecnici negativi: «rough», «unfinish’d», «not good work», «of a colour disagreable», sintomi di un fastidio che sembra nascere proprio dal senso di provvisorietà che il braccio comunica.
E giudizi analoghi si leggono negli scritti di altri viaggiatori, in una ridda di ipotesi nelle quali anche il braccio incompiuto in marmo gioca la sua parte. Il presidente de Brosses, ad esempio, ha raccolto la diceria che, dopo la rinuncia di Michelangelo, l’autore del «progetto» sarebbe stato gianlorenzo Bernini, ma non pare che il nome tanto autorevole condizioni il suo giudizio: «Bernini, più coraggioso, ha eseguito il progetto in terracotta, ma che differenza rispetto all’antico. ti cadono le braccia!»103.
Keyssler, che crede anch’egli alla storia della modestia di Miche- langelo, esprime un giudizio più sobrio ma non più tenero: «il padre ha perso il braccio destro e quello in terracotta che è stato messo al suo posto non si adatta alle altre parti né per colore, né per maniera»104.
Il braccio mancante50
102 [riCHardson sr. & Jr.], An Account of the Statues, cit., p. 277: «the Right arm of the principal Figure [...] is lost, and one of the terra Cotta substituted in its place. this being rough, unfinish’d, and not good work, and moreover of a colour disagrea-ble, the eye is something offended».
103 de Brosses, Lettres Familières, cit., p. 813: «Bernin, plus hardi, a exécuté ce projet en terre cuite, ma quelle comparaison de ceci avec l’antique. on en plis les epaules!».
104 [keyssler], Neueste Reisen, cit., I, p. 585: «die Haupfigur, nämlich der Vater, hat den rechte arm verlohren, und der jenige, den man aus terracotta an seine stelle gefüget, kömmt weder an Farben noch arbeit den übrige stücke bey».
Il Conte di Caylus rispolvera il nome di Baccio Bandinelli, forse confondendosi con il braccio in cera de Le vite. Il suo parere sulla qualità del restauro è più lusinghiero, ma egli si riferisce piuttosto all’invenzione che all’esecuzione105.
Il braccio destro del monumento, il braccio levato che concorre così bene all’azione della figura principale, è stato restaurato da Baccio Bandinelli, il grande scultore fiorentino imitatore di Michelangelo: questo illustre artista non volle restituire il pezzo in marmo nella spe-ranza che si trovasse un giorno l’originale, ed esso è dunque ancor oggi in terracotta.
François de Lalande propone una versione ancora differente: «il braccio in alto è di stucco, opera di Michelangelo, che doveva restau-rare il gruppo [...] ma abbandonò l’impresa»106. Che questo incon-dizionato ammiratore del Buonarroti si astenga da ogni giudizio, pur credendo di trovarsi di fronte ad un un’opera del suo idolo, tradisce la sua delusione più di molte parole.
anche Winckelmann, infine, che nella Geschichte der Kunst des Altertums (1764) aveva ignorato il problema, ritiene di dover dire qual-cosa del braccio nelle Anmerkungen, il libretto riservato alle questioni di dettaglio e alle polemiche suscitate dall’opera maggiore107:
Quindi è che Bernini ha teso l’aggiuntovi braccio di creta per lasciar libera la testa, senza avvicinarle al di sopra nessun’altro oggetto.
Un restauro in terracotta di Bernini: convinzione sorprendente in un uomo così accorto, dato che fra tutte le attribuzioni la berniniana,
I restauri 51
105 le Comte de CaylUs, De la sculpture et des Sculpteurs anciens selon Pline, «Mémoires de l’accadémie des Inscriptions et des Belles Lettres», t. XXV, 1759 (le memorie risalgono agli anni 1752-1754), pp. 302-334: 329: «je ne crois pas devoir oublier que le bras droit de ce monument, celui qui est élevé et qui concourt si bien à l’action de la figure principale, a été restauré par Baccio Bandinelli, grand sculpteur Florentin, imitateur de Michel-ange: ce grand artiste ne voulut point retablir cette partie en marbre, dans l’espérance que l’on trouverait un jour le morceau de l’original, il est donc encore aujourd’houi en terre cuite».
106 [la lande], Voyage d’un Français en Italie, cit., III, p. 235: «le bras d’en haut est de stuc, il a été fait par Michel-ange qui devoit restaurer cette figure; il avoit même commencé à en faire un de marbre, que l’on voit encore ébauché dans un coin de la même niche, mais il abandonna l’entreprise».
107 [WinCkelmann], Anmerkungen, cit., p. 101. Il testo è interpolato nella prima versione italiana della Geschichte: [id.], Storia delle arti del disegno presso gli antichi di g.W., In Milano, Nell’Imperial Monistero di s. ambrogio maggiore, 1779 (rist. anast. con pref. di g. Uscatescu, s. Cristina gela, Ed. Librarie siciliane, 1991), II, p. 194, da cui cito. L’attribuzione al Bernini è riproposta per l’ultima volta, a quan-to mi risulta, da f. Comte de ClaraC, Musée de Sculpture antique et moderne, ou description historique et geographique du Louvre et des toutes ses parties &c., paris, Imprimerie royale [Imperiale], 1841-1853, t. V, testo ad nr. 2092 [vol. 6], tav. 834 [vol. 12] (l’opera è costituita da 6 tt. in 7 voll. di testo e da 6 voll. di tavole).
così popolare nel XVII secolo, è di gran lunga la meno verosimile. puntuale il sarcasmo di Heyne, che non amava il dotto di dresda: «che il braccio sia del Bernini è un’altra favola che, a quanto vedo, anche Winckelmann prende per buona»108.
ad ogni modo le testimonianze, il loro numero, la loro compattezza ci fanno certi che non solo il braccio era di terracotta, ma anche che il suo aspetto «grezzo e non finito» dava ai visitatori l’impressione di un abbozzo o un modello preparatorio. E tale probabilmente era: il model-lo per un restauro non portato a termine; il progetto di un braccio da eseguire in marmo che non fu realizzato. I nove mesi di Montorsoli e Michelangelo a Roma troppo intensamente occupati dalle statue della tomba di giulio II, il ritorno improvviso a Firenze in seguito al cam-bio di programma del maestro non hanno evidentemente consentito al giovane scultore di concludere questa piccola commissione, impegno secondario a paragone delle minacciose pressioni del duca di Urbino da una parte, della volontà del pontefice dall’altra. solo alcuni anni dopo questi fatti dev’esser stato deciso di installare l’abbozzo in luogo del completamento definitivo, che il trascorrere del tempo rendeva più difficile a realizzarsi.
Il motivo dell’installazione tardiva ci sfugge. potrebbe non esser-cene alcuno in particolare, se non la convinzione che l’aspetto del gruppo sarebbe comunque migliorato, pur con un braccio di fortuna. Ma volendone individuare uno, viene da pensare alla visita di Carlo V a Roma nella primavera del 1536, quando un «mastro Joanni domenico pittore» è pagato per aver decorato, o piuttosto rinfrescato, la nicchia in cui il gruppo è deposto, oltre a quella dell’apollo109. se per tanto ospite si rimetteva in ordine il cortile, chissà che anche un Laocoonte integro, o almeno più integro di prima, non sia sembrato preferibile. La circostanza spiegherebbe perché aspertini (ds 26, fig. 20) e soprattutto van Heemskerck (ds 31, fig. 10; 32, fig. 19; 36), già lontani da Roma alla fine del 1535, non videro il restauro e non lo disegnarono, e altrettanto bene perché il braccio sia al suo posto nel Laocoonte di Eurialo d’ascoli e in quello di Francisco de Hollanda (ds 38, fig. 21), inciso l’uno, disegnato l’altro fra il ’38 e il ’39 (ds 39, fig. 22).
Il braccio mancante52
108 [Heyne], Prüfung, cit., p. 14: «dass der angesezte arm von Bernini sey, ist eine andere sage, der, wie ich sehe, auch Winckelmann folgt».
109 aCkermann, The Cortile, cit., app., doc. 34c-d; BrUmmer, The Statue-Court, cit., p. 78. secondo M. Winner, Zum Apoll von Belvedere, «JahrBerlMus», X, 1968, pp. 181-199: 183, i pagamenti sono relativi ad un ritocco della decorazione pittorica delle nicchie, non alla sua esecuzione, che dev’essere precedente. I restauri sono attri-buiti alla visita di Carlo V; dello stesso avviso BrUmmer, The Statue-Court, cit., pp. 49, 78; desWarte-rosa, Francisco de Hollanda, cit., p. 397.
Il restauro del Montorsoli valorizzato da Vasari è, insomma, un lavoro incompiuto, un restauro eseguito a metà. Che il suo braccio in terracotta segnasse nel modo indelebile che conosciamo l’immagine del gruppo più celebre dell’antichità è frutto della volontà d’altri, o semplicemente del caso. Cosa che il Vasari doveva sapere, ma che naturalmente non dice.
Agostino Cornacchini
I restauri cinquecenteschi restarono al loro posto per circa due-cento anni. Una nutrita serie di documenti (ds 38-105, figg. 28-38) consente di seguirne le vicende dalla metà del XVI all’inizio del XVIII secolo.
Ma il gesto inventato da Montorsoli non ha incontrato unanimi consensi, nonostante il possibile concorso di Michelangelo. L’aspetto rude e provvisorio può aver contribuito a questa relativa sfortuna, che si manifesta non tanto in prese di posizione apertamente critiche – per quanto neppur esse manchino – quanto in una lunga serie di congetture e tentativi di individuare soluzioni differenti.
Le repliche in bronzo di piccole dimensioni presentano frequen-temente una soluzione di tipo bandinelliano, con l’arto ripiegato e le spire che ne intrappolano i muscoli rigonfi. Il più antico è il bronzetto del Museo del Bargello firmato da Ludovico Lombardi (Cr 10, fig. 26), eseguito a Roma nel 1545, poco dopo il completamento dell’originale. Il braccio piegato e avviluppato è vicino a quello della copia fioren-tina (Co 1, fig. 15) e presuppone la sconfitta e la morte imminente di Laocoonte. Molte altre copie con braccia simili saranno prodotte nei due secoli successivi (ad es. Cr 11-13; 29, fig. 27). In questa serie si inserisce anche la copia in grandezza naturale modellata da Carlo ginori nel 1748 per la manifattura di doccia (Co 8).
Nel lungo lasso di tempo durante il quale restò in opera il braccio in terracotta non subì gravi danni, salvo la caduta di una parte della spira dietro le spalle, ammesso che il particolare fosse stato completato fin dall’inizio: il che, trattandosi di un abbozzo, non è scontato. Lo stato del braccio nella parte posteriore è documentato, oltre che dal calco di Francesco primaticcio (dal quale le integrazioni montorsoliane sono state rimosse: Ca 1, fig. 25), da un magnifico disegno di Rubens (ds 66) e, circa ottant’anni dopo, dalla veduta di gerard audran (ds 97, fig. 35).
Le braccia dei figli invece andarono soggette ad un progressivo deterioramento, sia per la frequenza con cui dal gruppo si continua-vano a trarre calchi, sia per lo stato generale di incuria in cui versava il cortile nel XVII secolo. ponendo in sequenza i documenti disponi-
I restauri 53
bili è possibile seguire con precisione il progredire dei danni, dalle prime mancanze fino alla completa perdita delle mani. L’eccezionale Laocoonte del taccuino dell’Eton College di Cambridge (ds 45, fig. 29), probabilmente il miglior documento grafico della tradizione moderna, mostra la mancanza di alcune dita delle mani bandinelliane e un tassello di riparazione sulla spira del serpente che avvolge il polpac-cio sinistro del Laocoonte110. Manca anche per la prima volta la testa del serpente, ancora presente nella xilografia pubblicata da Bartolomeo Marliani (ds 40, fig. 23). Nuovi danni si osservano nelle immagini della fine del secolo, come l’acquaforte di anton Eisenhoit (ds 60, fig. 30) e il bel disegno di Hendrik goltzius, probabile modello di una stampa mai realizzata (ds 62, fig. 31): la mano del figlio maggiore ha ormai perduto tre dita, mentre il resto sembra invariato. alla fine del XVII secolo le mani erano completamente rovinate, come documenta la descrizione dell’architetto tessin, sempre accuratissimo nell’anno-tare i dettagli minuti111:
Il figlio sulla destra è privo della mano destra e ha il piede sinistro riattaccato; il figlio sulla sinistra ha anch’esso la mano destra riattac-cata, ma le dita sono perdute.
La tavola di Claude Randon del 1704 (ds 104, fig. 37) riproduce esattamente questa situazione. tale precario stato di conservazione spiega un passaggio della storia dei restauri che molti studiosi, a parti-re da Cicognara, hanno giudicato incomprensibile: il restauro affidato
Il braccio mancante54
110 Eton Coll. Libr., R 17.3. Il tacc. è attribuito a giambologna e datato 1550-1553 da E. dHanens, De Romainse ervaring van Giovanni Bologna, «BulInstBelgRome», XXXV, 1963, pp. 159-190; così E. fileri, Giovanni Bologna e il taccuino di Cam-bridge, «Xenia», X, 1985, pp. 3-54, cui si deve il commento archeologico dei disegni; v. anche ead., Il taccuino di Cambridge e note su Giovanni Bologna, in Scultori del Cinquecento, cit., pp. 129-135. di contro p. gerlaCH, Eine Hand von Guglielmo della Porta? Cavalieri, Tetrode, Perret und der sogennante Antinous von Belvedere, in De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984, hrsg. v. a. Horodisch, amsterdam, Erasmus, 1984, pp. 179-197 estende l’esecuz. al periodo ante 1553-1560 ca, seguito da Liverani, Geschichte des Cortile, cit., p. vi, n. 10. La stampa di anton Eisenhoit per la Metallotheca Vaticana, verso il 1584 (ds 60, fig. 30), la grande tavola di pierre perret del 1581 (ds 55) probabilmente inclusa nell’ed. dello Speculum Romanae magnificen-tiae di antoine Lafrery, un disegno di Hendrik goltzius ad Haarlem del 1591 (ds 62, fig. 31) documentano la mancanza dell’indice della mano del figlio minore e di tre dita di quella del maggiore. all’inizio del XVII secolo i disegni di Rubens (ad es. ds 66, 1601-1602 o 1606-1608, fig. 32) e l’acquaforte di François perrier, 1638 (ds 86) mostrano l’aggravarsi dei danni alle mani dei fanciulli e la scomparsa della punta del piede del padre (in seguito ripristinata, e da Magi creduta a torto originale).
111 [tessin], Studieresor, cit., p. 160: «am sohn zur rechteren ist die rechtere Handt weg undt der linckeren fuess angesetzt; am sohn zur linckeren ist die rechtere Handt auch angesetzt, aber die finger weg».
allo scultore agostino Cornacchini, che visse ed operò a Roma con brevi intervalli dal 1712 al 1756112.
secondo una tradizione di museo riferita per la prima volta dal mar-chese de Lalande, ripresa da Volkmann e da goethe, infine registrata da Ennio Quirino Visconti e da Fea come un fatto notorio, Cornacchini avrebbe rifatto le braccia di entrambi i figli113. Il restauro non è men-zionato dal biografo dello scultore, Francesco gabburri, né ha trovato per ora riscontri archivistici, ma il numero e l’autorevolezza dei testi-moni rendono difficile metterne in dubbio l’esistenza.
Molti studiosi non si capacitano che un compito così importante venisse affidato ad «uno dei più tristi scultori che mai trattassero lo scalpello» (Cicognara)114. Ma è la nostra sensibilità educata allo sto-ricismo ad attribuire tanta importanza e un carattere quasi sacrilego a un intervento che la cultura del primo settecento riteneva d’ordinaria amministrazione. Né può stupire la scelta dello scultore di pescia, oggi di cattiva fama, ma nel 1724 ricevuto membro dell’accademia Clemen- tina in Bologna con la menzione di «celebratissimo scultore»115.
Cornacchini godeva in curia di relazioni cospicue grazie alla prote-zione del cardinale Carlo agostino Fabbroni, cui lo aveva raccoman-dato gabburri. Il potente prelato lo favorì assegnandogli un quartiere nel suo palazzo ai piedi del Campidoglio (attualmente palazzo pecci Blunt), ammettendolo alla sua tavola, «dandoli di tanto in tanto qualche aiuto di abiti e di denari» e, soprattutto, presentandolo ai suoi influenti cugini, i cardinali Rospigliosi, nonché ad uno dei suoi amici di più antica data, papa Clemente XI116. se la protezione del Fabbroni poté ottenere a Cornacchini la commissione del colossale Carlo Magno del nartece di s. pietro, per il quale nel 1720 veniva pagato il blocco di
I restauri 55
112 C. faCCioli, Di Agostino Cornacchini da Pescia scultore a Roma, «stRom», XVI, 1968, pp. 431-445; R. enggass, Early-Eighteenth-Century Sculpture in Rome. An Illustrated Catalogue Raisonné, pennsylvania Univ. park and London, pennsylva- nia U.p., 1976, pp. 193-206; s. Blasio, Cornacchini, Agostino, in Repertorio della scultura fiorentina del Seicento e Settecento, a c. di g. pratesi, Firenze, allemandi, [1993], p. 41.
113 [la lande], Voyage d’un Français en Italie, cit., III, p. 235; [volkmann], Historisch-kritische Nachrichten, cit., II, p. 133; [visConti], Il Museo Pio-Clemen-tino, cit., II, p. 76, nota (b); [WinCkelmann], Storia delle arti del disegno (ed. Fea), cit., II, p. 244 s.
114 Il richiamo al drastico giudizio del Cicognara è in rossi pinelli, Chirurgia della memoria, cit., p. 188, ma similmente si esprimeva già sittl, Empirische Studien, cit., p. 18. La biografia del gabburri è pubblicata in K. lankHeit, Florentinische Barockplastik. Die Kunst am Hofe der letzten Medici. 1670-1743, München, thiemig, 1962, p. 225.
115 enggass, Early Eighteenth-Century Sculpture, cit., p. 194 s.116 Ibid., pp. 200-202.
marmo e che nel 1727 era finito, non ci stupisce che venisse impiegato in piccoli lavori in Belvedere, in specie nella riparazione delle sculture del cortile117.
Così egli si trovò a mettere il suo «tristo» scalpello sul Laocoonte. Nonostante l’indignazione di Cicognara, il restauro fu condotto con buon senso e scrupolo quasi filologico. Egli riparò le parti che nel tempo si erano rovinate: le mani di entrambi i figli, il piede del mino-re, la testa del serpente, alcune scheggiature nel corpo dei mostri. Un intervento di routine che, rapportandoci al linguaggio moderno, potremmo chiamare conservativo piuttosto che di vero e proprio restauro. Il gruppo che esce dalle sue mani è praticamente identico a quello cinquecentesco (ds 105, fig. 38).
Il carattere prudente delle integrazioni, poco visibili, fa onore allo scultore ben più del greve e magniloquente Carlo Magno di san pietro. per un curioso equivoco ha finito invece per nuocere alla sua reputazione. gli viene infatti attribuito un braccio in stucco disteso e piuttosto enfatico collocato sul fanciullo più giovane al tempo di pio VI118. Vedremo più avanti perché, e soprattutto quando, questo braccio sia stato installato in luogo di quello più antico (infra, pp. 61 ss.). Qui importa precisare che, benché nella letteratura specialistica sia correntemente chiamato ‘braccio del Cornacchini’, non ha con il nostro scultore nulla a che fare.
L’aspetto del Laocoonte dopo il restauro è documentato da alcune immagini più o meno coeve, che aiutano anche a datare l’intervento. Una in particolare è di fondamentale importanza: l’acquaforte che giovanni domenico Campiglia ha inciso per la Metallotheca Vaticana (ds 105, fig. 38), la descrizione delle collezioni naturalistiche pontifi-cie che il cardinale Michele Mercati aveva compilato negli anni ses- santa del Cinquecento e che per varie ragioni non aveva mai visto la
Il braccio mancante56
117 Cronologia e documenti: s. poesCHl, Agostino Cornacchinis Reiterstandbild Karls des Grossen am Portikus von Sankt Peter in Rom. Ein Herrscherbild im sakralen Context, in Karl der Grosse und sein Nachleben in Geschichte, Kunst und Literatur, hrsg. v. th. pabst, «Zeitschrift d. aachener geschichtsverein», 2003, pp. 673-703. sui restauri: BrUmmer, The Statue-Court, cit., pp. 87 ss.; Haskell, penny, L’antico nella storia del gusto, cit., p. 341; rossi pinelli, Chirurgia della memoria, cit., p. 188; daltrop, Die Laokoongruppe, cit., p. 25; preiss, Die wissenschaftliche Beschäf-tigung, cit., p. 58.
118 V. ad es. rossi pinelli, Chirurgia della memoria, cit., p. 188: «rimane oscuro con quale autorità il Cornacchini sia potuto intervenire per modificare il gesto del figlio minore, facendogli stendere il braccio verso l’alto, con evidente richiamo al gesto paterno». analogamente: B. andreae, Laokoon und die Gründung Roms, Mainz a. R., von Zabern, 1988, trad. ital. Laocoonte e la fondazione di Roma, Milano, Il saggiatore, 1989, pp. 41 e 187; preiss, Die wissenscaftliche Beschäftigung, cit., pp. 57 e 59.
luce119. Il gruppo vi è riprodotto da destra e da vicino, un punto di vista che valorizza i volti e accentua il chiaroscuro delle superfici. La tavola è intrisa di patetismo barocco ma è molto curata e affidabile120. si vede che il braccio del padre non è stato toccato, mentre la mano del figlio minore è stata rifatta identica alla precedente, rinnovando, proba-bilmente con l’aiuto di vecchie riproduzioni, il bel gesto inventato dal Bandinelli, con l’indice sollevato. Il particolare è documentato anche da una stampa del 1732 incisa da Jean-Justin preissler su disegno di Edmé Bouchardon (ds 107) e da un calco dell’accademia di Belle arti di Firenze (Ca 6, fig. 39), uno dei più antichi esistenti, nel quale il braccio di Cornacchini è perfettamente visibile, anche se l’aspetto complessivo del gruppo è relativo ad una fase più tarda121.
La mano del figlio maggiore differisce da quella del Bandinelli solo per una più accentuata articolazione delle dita: è molto ben disegnata, ad esempio, nella tavola di antonio Muchetti per il secondo volume del Museo Pio-Clementino di Ennio Quirino Visconti (ds 113, fig. 40) oppure nell’acquaforte di giuseppe Bossi per l’edizione romana della Storia delle Arti del Disegno di Winckelmann (ds 114, fig. 41), o
I restauri 57
119 [m. merCati], M.M. Samminiatensis Metallotheca [...] opera autem, et studio Joannis Mariae Lancisii, Romae, Ex officina Jo. Mariae salvioni Romani, 1717. La materia è divisa secondo gli Armaria della collocazione delle pietre nella Metallotheca. delle statue si tratta nell’Armarium X: Marmora, pp. 351-377, ove la loro descrizione è introdotta, secondo il modello pliniano, in rapporto al materiale nel quale sono scolpite. Le sculture sono il Laocoonte (pp. 355-361), l’Apollo (361-363), l’Antinoo (363-365), il Torso (365-367) e la Cleopatra (367). Cf. H. Höllander, Ein Museum der Steine: die Metallotheca des Michele Mercati und die Ordnung des Wissens, in Wunderwerk. Göttliche Ordnung und vermessene Welt. Der Goldschmied und Kupferstecher Antonius Eisenhoit und die Hofkunst 1600, paderborn, Erzbischofl. diozesänmus., s.d., hrsg. v. Ch. stiegmann, Mainz a. R., von Zabern, 2003, pp. 19-30.
120 sulla percezione del gruppo in età barocca: g. Jendritzki, U. roHnstoCk, Die barocke Laokoon-Gruppe aus Bronze: Hinweise zur Herstellung und Restaurierung, «Restauro», CIII, 1997, pp. 460-465.
121 a. gallo martUCCi, Notizia storica delle dotazioni didattiche dell’Accade-mia, in L’Accademia di Belle Arti di Firenze. 1784-1984, Firenze, La Nuova Italia, 1984, pp. 25-39, dalla quale risulta che il calco è anteriore al 1785. Rossi pinelli, Chirurgia della memoria, cit., p. 188 riferisce che potrebbe essere appartenuto ad anton Raphael Mengs, il che comporterebbe una datazione compresa fra il 1753 (primi acquisti di calchi da parte di Mengs) e il 1779 (morte dell’artista). La fonte di questa notizia, non dichiarata, mi è ignota; per ragioni cronologiche, dato che il grup-po ha il braccio del padre installato attorno al 1784 [infra, pp. 60 ss.], l’eventualità sembrerebbe però da escludere. secondo s. roettgen, Zum Antikenbesitz des Anton Raphael Mengs und zur Geschichte und Wirkung seiner Abguss- und Formensamm- lungen, in Antikensammlungen im 18. Jahrhunderts, a c. di H. Beck, p. C. Bol, W. prinz, H. von steuben, Berlin, gruyter, 1981, pp. 129-141: 136, i calchi appartenuti alla collezione Mengs, fra i quali diversi esemplari del Laocoonte, sono dispersi fra Madrid, torino, digione e dresda, e nessuno ha preso la via di Firenze.
ancora nel calco fiorentino appena menzionato (Ca 6, fig. 39). L’accen-tuata articolazione delle dita è in linea col gusto del tempo: si trovano molte mani di questo tipo nelle opere del Cornacchini, dalla Speranza del Monte di pietà (1721-1724) al Carlo Magno vaticano (1720-1727); dal Sant’Elia di s. pietro (1725-1727) alla Battaglia di Anghiari in Laterano (1734-1736).
La data del restauro è determinabile con buona approssimazione. prandi, seguito da Enggass e da altri, proponeva il triennio 1725-1727 in cui viene completato il Carlo Magno e vede la luce il Sant’Elia122. Ma nessuna relazione si può stabilire fra le grandi statue e il restauro, se non che si tratta di commissioni vaticane, cosa che certo non basta a farle dichiarare contemporanee. Né può essere preso come termine ante quem la prima menzione del braccio di marmo non finito nel 1720, non avendo quest’ultimo alcun rapporto con Cornacchini (supra, pp. 54 ss.).
Fornisce un appiglio più solido la tavola di giandomenico Cam- piglia (ds 105, fig. 38), la cui esecuzione si lega, come abbiamo visto, alle vicende editoriali della Metallotheca Vaticana. Il bel volume, stampato nell’officina romana di gian Maria salvioni, porta la data del 1717. sappiamo che quando ne fu progettata la stampa le tavole origi-nali che il cardinal Mercati aveva commissionato ad anton Eisenhoit verso il 1560 non si trovarono, e per questo una nuova serie di acque-forti fu commissionata a diversi incisori, fra i quali Campiglia123. accadde però che diciannove delle lastre cinquecentesche fossero rinvenute mentre il libro era sotto i torchi e che, dopo breve esitazione, si decidesse di stamparle a parte, in una Appendix ad Metallothecam Vaticanam che porta sul frontespizio la data 1719 ma che è sempre rilegata insieme al volume principale, il quale verosimilmente fu distribuito solo dopo il completamento della giunta iconografica124. da queste circostanze si ricava che la tavola del Campiglia fu ese- guita a ridosso del 1717, e al più tardi entro il 1719: quest’ultima data vale anche come termine non ultra quem per il restauro, poiché il grup-po vi è riprodotto completato. Cornacchini era giunto ventenne a Ro-
Il braccio mancante58
122 prandi, La fortuna, cit., p. 98; faCCioli, Di Agostino Cornacchini, cit., p. 436 s.; enggass, Early Eighteenth-Century, cit., p. 87 s.; Haskell, penny, L’antico nella storia del gusto, cit., 341; daltrop, Die Laokoongruppe, cit., p. 16 s.
123 per la partecipazione di Eisenhoit all’impresa della Metallotheca: M. raspe, Eisenhoit in Rom, in Wunderwerk, cit., pp. 75-86.
124 Appendix ad Metallothecam vaticanam Michaelis Mercati &c., Romae, apud Jo. Mariam salvioni, 1719. La storia del ritrovamento delle matrici originali alle pp. 3 ss. Le lastre delle statue del Belvedere portano i nrr. XVI (Laocoonte), XVII (Apollo), XVIII, (Antinoo), XIX (Torso).
ma nel 1712: la forbice cronologica che viene a determinarsi e nel- la quale può collocarsi l’intervento sul Laocoonte è compresa fra que-ste date. In questo lasso di tempo il pistoiese ha lavorato in Belvede- re.
per il restauro del Laocoonte il secondo decennio del secolo è perio-do più propizio del biennio 1725-1727 immaginato da prandi. Cade infatti negli anni della fondazione del museo Clementino e del riassetto del Belvedere, segnati anche dalla ricomparsa del braccio marmoreo accanto al monumento (supra, pp. 39 ss.). Non a caso risulta che negli stessi anni si riparassero l’Apollo e i Fiumi colossali125. È plausibile, quasi naturale, supporre che i due fatti siano correlati. Il ‘restauro’ di Cornacchini e l’esposizione del cimelio ‘michelangiolesco’ sono nella storia del Laocoonte gli esiti visibili della monumentalizzazione cle-mentina del cortile.
I restauri 59
125 La mano destra dell’Apollo rimossa nel derestauro del 1924 (g. galli, rel. s. tit., «Rendpontacc», III, 1924-1925, p. 473; cf. g. daltrop, Zur Überlieferung und Restaurieng des Apollo vom Belvedere des Vatikans, «Rendpontacc», XLVIII, 1975-1976, pp. 127-140) è conservata nei magazzini del Museo priva delle dita (p. liverani, Antikensammlung und Antikenergänzung, in Hoch Renaissance, cit., pp. 227-235: 233 s., figg. 8, 9). si tratta dei resti della mano montorsoliana, come frequentemente ripetuto (ad es. lasCHke, Fra Giovan Angelo, cit., pp. 28-30; M.Winner, Paragone mit dem Belvederischen Apoll. Kleine Wirkungsgeschichte vom Antico bis Canova, in Il Cortile delle Statue, cit., pp. 227-252: 237 s.; liverani, l. cit.), che tuttavia è stata parzialmente reintegrata all’inizio del XVIII secolo. La mano cinquecentesca era caratterizzata dall’indice e dal mignolo ben divaricati, come in Francisco de Holanda, (tormo, Os desenhos, cit., fol. 9r) o anton Eisenhoit (Appendix ad Metallothecam vaticanam, cit., p. 2 [1584 ca]), ma verso la metà del XVII secolo era ridotta al solo anulare (Jan de Bisschop, 1669: van gelder, Jost, Jan de Bisschop, cit., II, tavv. 4-5; anon.: a. BlUnt, H.l. Cook, The Roman Drawings of the XVII and XVIII Centuries in the Collection of her Majesty the Queen at Windsor Castle, London, phaidon, 1960, nr. 373); inoltre Nicodemus tessin: «schade ist es, dass die 4. finger zu rechtern handt weg seijndt» (Studieresor, cit., p. 160); John Richardson: «but one finger remains on the Right hand» (An Account of the Statues, cit., p. 276). Nel 1638 François perrier riproduceva la mano ancora integra ([f. perrier], Ill.mo D.D. Rogerio Du Plessis [...] Segmenta nobilium signorum et statuarum quae temporis dentem invidum evasere Urbis aeternae ruinis erepta Tipys aeneis ab se commissa [...] F.P. D.D.D., s.l., s.n., 1638, tav. 30), ma nel 1653 i danni si erano già prodotti (van gelder, Jost, Jan de Bisschop, cit., II, tav. 4, su disegno di peter doncker, in Italia nel 1653). poiché nel 1650 Velazquez fece eseguire per conto di Filippo IV i calchi delle più belle statue di Roma, fra cui l’Apollo (E. Harris, Velazquez en Roma, «archEsparte», XXXI, 1958, pp. 185-192; a. UBeda de los CoBos, Un élément de pédagogie artistique: la collection de statues de plâtre de L’Académie de San Fernando a Madrid. 1741-1800, in L’anticomanie. La collection d’antiquités aux XVIIIe et XIXe siècles, actes du Coll., Montpellier - Lattes, 9 - 12 juin 1988, éd. par a.F. Laurens, K. pomian, paris, Éditions de l’E.H.E.s.s., 1992, pp. 327-337), i fatti possono essere correlati: l’esecuzione degli stampi è notoriamente una delle cause più comuni di danni alle statue marmoree. La nuova mano è rappresen-tata nella tavola di domenico Campiglia in [merCati], Metallotheca, cit., p. 362, da datarsi prima del 1719 (supra, pp. 53 ss.).
Nuove braccia per Laocoonte e il figlio minore
Le foto ottocentesche che ci hanno tramandato l’immagine del Laocoonte ‘storico’ (fig. 1) mostrano un gruppo diverso da quello riparato da Cornacchini, anche se quasi sempre esso gli viene erronea-mente attribuito.
Il braccio del padre è simile, non identico, a quello di Montorsoli. Ne differisce per essere un po’ più disteso e fluido, e con un diverso andamento delle spire dei serpenti, che si arrotondano e si gonfiano in alto, come se si fosse voluto dare al braccio stesso un profilo che ne attenuasse il moto ascensionale.
Questo braccio, è bene ripeterlo, non è di Cornacchini, che aveva lasciato al suo posto quello montorsoliano. Compare nelle riproduzioni soltanto nella seconda metà del XVIII secolo. Una delle ultime imma-gini attendibili del Laocoonte col braccio cinquecentesco è una statuetta in terracotta che lo scultore spagnolo Isidro Carnicero, pensionante del Re di spagna a Roma, ha modellato di fronte all’originale nell’estate del 1766 (Cr 26), pochi giorni prima di lasciare la città. per la cura con cui è eseguita e la certezza dei dati cronologici, la statuetta è un documento affidabile126. Ma significativo sembra anche un Laocoonte in marmo di Joseph Chinard (Cr 28, fig. 42), lo scultore di Lione che venne a Roma la prima volta nel 1784, soggiornandovi fino al 1786, e vi ritornò nel 1791 per un altro anno127. Il braccio è quello di Montorsoli, ma con l’avambraccio più verticale e la spira del serpente un poco più larga. se fosse stata eseguita dal vero durante il primo soggiorno romano e non copiando, magari a Lione, una statuetta di epoca precedente, si trattereb-be di un riferimento cronologico decisivo.
La prima immagine del nuovo braccio è la tavola del secondo volume del Museo Pio-Clementino di Ennio Quirino Visconti (ds 113, fig. 40). poiché il progetto di incidere in rame le antichità del museo fu lanciato da Ludovico Mirri nel 1778, il disegno di Claudio Matteini e il rame all’acquaforte di antonio Muchetti si collocano fra il ’78 e la pubblicazione del volume, che nel colophon è datata 1784 e non è differibile, eventualmente, che di pochi mesi, dato che il tomo II era
Il braccio mancante60
126 J.J. martin gonzalez, El Laocoonte y la escultura español, «BVallad», LVI, 1990, pp. 459-469: 466. Un aggiornamento bibl. in F. martin, ‘Una copia del modelo que hizo el citado Rusconi’. Zu einem bislang wenig beachten Kopie Isidro Carniceros nach einem Modell Camillos Rusconi, in Opere e giorni, cit., pp. 687-694.
127 per le notizie sul viaggio a Roma dello scultore: [M. roCHer-JeaUneaU], L’oeuvre de Joseph Chinard (1755-1813) au Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon, audin, 1978, sch. nr. [2], p. 8 s.; gaBorit, sch. nr. 92, in D’après l’antique, cit., p. 256 s.
sicuramente in circolazione nell’85128. In quel cruciale 1784 avrem-mo allora l’ultimo Laocoonte con il braccio montorsoliano e il primo con il nuovo braccio, dunque la data ad mensem dell’intervento. Il ragionamento vale naturalmente solo nel caso il marmo di Chinard sia testimone pienamente attendibile (Cr 28, fig. 42), ma in proposito è d’obbligo qualche circospezione, sia perché il braccio del padre è una via di mezzo fra quello montorsoliano e quello di François girardon che sarebbe stato collocato sul gruppo non molti anni dopo (infra, pp. 69 ss.), sia per il rischio sempre in agguato che le copie in piccolo dipendano da altre copie invece che dall’originale.
È comunque un dato di fatto che il Laocoonte muta immagine poco dopo il 1780. si trovano ancora all’inizio del nono decennio riprodu-zioni con il braccio cinquecentesco, ad esempio una stampa di non eccelsa qualità inclusa in due diverse raccolte pubblicate a Roma nel 1778 e 1779 (ds 111, 112)129 e due bronzetti dell’officina di Francesco e Luigi Righetti, uno a Besançon (Cr 27), l’altro a Caserta (Cr 31, fig. 43), il primo eseguito forse intorno al 1780, il secondo gettato nel 1810 ma risalente al medesimo stampo130. di contro abbiamo la testimo-
I restauri 61
128 Le vicende editoriali del Museo Pio-Clementino sono brevemente riferite in a. riCCò trento, Le collezioni e i Musei archeologici nei libri del XVIII e XIX secolo, in L’immagine dell’antico fra Settecento e Ottocento. Libri di archeologia nella Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna, Bibl. Com. dell’archiginna-sio, nov. 1983 - gen. 1984, a c. di C. Bersani, a. Riccò trento, V. Roncuzzi Roversi Monaco, Bologna, grafis Edizioni, 1983, pp. 123-132. V. inoltre p. liverani, The Museo Pio-Clementino at the time of the Grand Tour, «JourHistColl», XII, 2000, pp. 151-159; id., La nascita del Museo Pio-Clementino e la politica canoviana dei Musei Vaticani, in Canova direttore di Musei, I sett. di st. Canoviani, Bassano del grappa, 12 - 15 ott. 1999, atti a c. di M. pastore stocchi, Bassano del grappa, Ist. di ricerca per gli st. su Canova e il Neoclassicismo, 2004, pp. 75-102.
129 [d. magnan], La ville de Rome ou description abrégée de cette superbe ville, divisé en quatre volumes et ornée de 425 planches en taille douce, tome IV, Contenant la description du quartier [...] XIV du Bourg ou du Vatican, a Rome, de l’Imprimerie d’archange Casaletti, a saint Eustache. Chez Venan. Monaldini, Bouchard et gravier, gregoire settari, libraires au cours, 1778, s.n. (ds 111; il nome dell’autore si ricava dalla firma in calce alla dedica); Calcografia di belle statue antiche Degli Dei degli antichi Romani [...] che veggonsi ancora a Roma &c., tomo II, che contiene le statue di alcuni eroi, imperatori &c., Roma, Nella tipografia di Battista Cannetti, all’arco di Ciambella; appresso gaetano Quojani, accanto alle convertite al corso, 1779, II, nr. 9 (ds 112): il gruppo è in uno stato cinquecentesco, con il braccio del padre e le mani dei figli di tipo montorsoliano, senza lacune. È possibile che la stampa sia ricavata da materiale grafico circolante oppure da una copia di piccole dimensioni.
130 Il primo in Roma a produrre piccole repliche bronzee di statue celebri, poco dopo la metà del XVIII secolo, fu giacomo Zoffoli (1731-1785), il cui Marco Aurelio, prima opera firmata, è del 1763 (H. HonoUr, Bronze Statuettes by Giacomo and Giovanni Zoffoli, «the Connoisseur», Nov. 1961, pp. 198-205; I. pfeifer, Giacomo Zoffoli. Kleinbronzen aus Schloß Wörlitz, «Weltkunst», LXVI, 1996, pp.
nianza significativa e precoce del calco in gesso dell’accademia di Belle arti di Firenze col nuovo braccio (Ca 6, fig. 39), sicuramente già realizzato nel 1785131.
Le ragioni della sostituzione del braccio sono oscure. Non sembra che dalla riparazione di Cornacchini il braccio avesse subito danni, almeno a giudicare dalle non numerose immagini di questi decenni (ds 111, 112). tuttavia all’inizio degli anni settanta avevano preso il via importanti lavori di riassetto del Cortile, dalla costruzione del portico ottagono di Michelangelo simonetti al riordino delle collezioni per la nascita del pio-Clementino (i Fiumi lasciavano il posto al centro del cortile alla vasca porfiretica di Villa giulia)132. Intanto si lavorava alla stesura del catalogo che giovanni Battista Visconti coordinava e suo figlio Ennio Quirino di fatto redigeva133. La sostituzione del braccio può ben collocarsi in questo contesto di radicale rinnovamento. sup- pongo si progettasse di collocare il braccio cinquecentesco ‘di Miche- langelo’ per far rivivere il Laocoonte che il maestro aveva immagi-nato e Montorsoli – così nel frattempo pensava e scriveva il giovane
Il braccio mancante62
3232-3234), dopo la sua morte l’attività fu rilevata da giovanni Zoffoli (1745-1805), probabilmente il fratello minore. Il catalogo a stampa della bottega include un Laocoonte, indicato con il nr. 31 e valutato 50 zecchini romani, una somma abba-stanza alta. del catalogo si conosce una sola copia, inviata nel 1795 da sir Charles Heathcote tatham a Henry Holland e attualmente al British Museum; la data di com-pilazione è ignota e non mi risulta siano noti esemplari della statuetta. alla bottega degli Zoffoli si affianca, verso il 1780, quella di Francesco Righetti (1749-1819), allievo di giuseppe Valadier, che nel 1794 pubblica il suo catalogo in cui figura il Laocoonte al prezzo di 60 zecchini (H. HonoUr, After the Antique: Some Italian bronzes of the Eighteenth Century, «apollo», LXXVII, Mar. 1963, pp. 194-200). Il primo esemplare della statuetta si trova al Musée des Beaux-arts di Besançon (Cr 27), un altro nel salottino del Re della Reggia di Caserta (Cr 31), datato 1810 e fir-mato da Francesco e dal figlio Luigi Righetti (r. valeriani, sch. I.17, in Maestà di Roma. Da Napoleone all’unità d’Italia, Roma, scuderie del Quirinale, galleria Naz. d’arte Moderna, Villa Medici, 7 mar. - 29 giu. 2003, a c. di s. pinto con L. Barroero e F. Mazzocca, Milano, Electa, 2003, p. 95).
131 gallo martUCCi, Notizia, cit., p. 33; v. supra, n. 121.132 Consoli, Il Museo Pio-Clementino, cit., pp. 43-50: «on y bâtit encore pour
deposer l’antinoüs, l’apollon, le Laocoon, etc.» (p. 47).133 per il ruolo di Ennio Quirino nel Museo Pio-Clementino e il suo contributo alla
riorganizzazione delle collezioni: supra, n. 128. sulla figura dello studioso, stagliata nettamente al di sopra dei contemporanei: C. CerCHiai, Ennio Quirino Visconti, in Il Collegio Romano dalle origini al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, cat. d. mostra s.d.n.l., a c. di C. Cerchiai, Roma, IpsZ, Libreria d. stato, 2003, pp. 459-461; o. rossi pinelli, Osservare, confrontare, dubitare. Ennio Quirino Visconti e i fon-damenti della storia dell’arte antica, in Villa Borghese. I principi, le arti, la città dal Settecento all’Ottocento, Roma, Villa poniatowsky, 5 dic. 2003 - 21 mar. 2004, a c. di a. Campitelli, Milano, Electa, 2003, pp. 123-130.
Visconti – parzialmente realizzato134. In questa occasione deve essere stato scavato l’alloggiamento nella spalla, con il relativo taglio di una porzione di circa dieci centimetri del marmo originale. Un intervento parso a molti così audace da poter essere attribuito solo a Michelangelo (ne sono state inutilmente cercate le tracce nelle ripro-duzioni cinquecentesche) e invece maturato in un contesto erudito di fine settecento135.
Il tentativo non è riuscito o si è preferito rinunciarvi, forse perché il gruppo non piaceva (fig. 18), forse per l’insorgere di problemi tec-nici, ad esempio la difficoltà di raccordare il serpente cinquecentesco al frammento originale sul dorso di Laocoonte. In ogni caso, che il marmo non sia mai stato in opera è sicuro, ma l’operazione ha avuto le sue conseguenze. Una volta tagliata la spalla, il braccio di terracot-ta, modellato per raccordarsi alla frattura nello stato originale, non poteva tornare al suo posto, a meno di non aggiungere un elemento di raccordo. Fu dunque giocoforza eseguire un nuovo braccio, che fu fatto con cura, ma quasi identico al precedente, con appena la leggera variazione che abbiamo constatato nella disposizione delle spire. Un ‘miglioramento’ discreto che poteva anche passare inosservato, come in effetti è quasi sempre accaduto.
Ciò che in questa vicenda colpisce è la reticenza, il senso di clandestinità che aleggia intorno al taglio della spalla, come se il pentimento per aver troppo osato avesse indotto i responsabili a nascondere il loro operato, o almeno a renderne le conseguenze meno vistose possibile.
In primo luogo il nuovo braccio era modellato in terracotta come il precedente. Una strana scelta se l’obiettivo era di migliorare l’aspetto del gruppo, eliminando quella disparità materica che i viaggiatori ave-vano avvertito e frequentemente lamentato nelle loro pagine.
In secondo luogo Visconti nel Museo Pio-Clementino è reticente, se non proprio in malafede, quando parla del braccio cinquecentesco e lo definisce «il ristauro di terra cotta del braccio destro [...] che siegue ad essere in opera»: la tavola del suo stesso catalogo (ds 113, fig. 40), dove il «ristauro» in opera è il braccio nuovo, lo smentisce136. Non meno stupefacente Carlo Fea, che scrive: «in appresso non so da chi fosse restaurato in terra cotta il braccio del padre, variando dall’idea
I restauri 63
134 Le idee di Ennio Quirino in materia di restauro sono sintetizzate da d. gallo, Ennio Quirino Visconti e il restauro della scultura antica fra Settecento e Ottocento, in Thorwaldsen. L’ambiente l’influsso il mito, a c. di p. Kragelrund, M. Nykjaer, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1991, pp. 101-122.
135 g. agosti, sch. nr. 39, in Michelangelo e l’arte classica, cit., p. 90 s.136 [visConti], Il Museo Pio-Clementino, cit., II, p. 76, nota (a).
del Bandinelli col distenderlo di più, e togliergli l’avvolgimento del serpe»137. parole comprensibili solo se il braccio cinquecentesco non fosse mai stato sostituito, ma anche la tavola della sua edizione della Storia delle arti mostra il braccio appena eseguito (ds 114, fig. 41), lo stesso del Pio Clementino (fig. 40).
Questo silenzio non può aver altro scopo che stornare le possibili polemiche sulla mutilazione del capolavoro, insistendo sulla continui-tà dell’immagine. se tale era l’intenzione, lo scopo è stato raggiunto. Nessuno sembra essersi accorto della sostituzione. I resoconti di viag-gio ripetono i luoghi comuni che correvano da un secolo, soprattutto l’attribuzione a Bernini, magari incoraggiata da voci fatte circolare ad arte138:
Il braccio destro disteso è di restauro ed è di terracotta. [nota: il sig. Consigliere aulico Hayne ha mostrato che fra’ giovanni angelo ha restaurato il braccio del padre. solo che il braccio che fu posto in opera a quel tempo doveva non essere in terracotta, e al tempo di Bernini era già andato perduto; oppure non sarà di mano di questi artisti il braccio che si vede ancora adesso sbozzato in marmo? Il nome del restauratore è troppo incerto perché io possa osare attribuirlo, ma a giudicare dalla morbidezza del trattamento il braccio attuale non è così antico da poter pensare a giovanni angelo {Montorsoli} o al Bandinelli. Mi sembra possedere tutti i tratti della scuola del Bernini. È davvero molto buono. Ciò che il Richardson dice del colore disgustoso ha una sua ragione, poiché la terra brunastra (creta) contrasta con il marmo bianco].
L’occhio non ineducato del nobile Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdhor, che visitò il cortile dopo la sostituzione, coglie lo stile mo-
Il braccio mancante64
137 [WinCkelmann], Storia delle arti del disegno (ed. Fea), cit., III, p. 456.138 [f.W.B. von raHmdor], Über Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom für
Liebhaber des Schönen in der Kunst, von F.W.B.v.R. &c., Erster theil, Der Vatikanische Pallast. Hof des Belvedere nebst dem Porticus, der ihn umgibt, Leipzig, bei Weidmanns Erben und Reich, 1787 (a me non accessibile; cito da preiss, Die wissenschaftliche Beschäftigung, cit., Anhang I. Quellentexte, s.v. Ramdhor Friedrich Wilhelm Basilius von, s.n.p., [6] del testo dattiloscritto): «der rechte ausgedehnte arm ist angesetz, und von gebrannter Erde [nota: der Herr Hofrath Heyne hat gezeigt, dass Fra gio. angelo den rechten arm des Laocoon einmahl ergänzt habe. allein sollte nicht der arm, der dazumahl angezetzt wurde, entweder aus gebrannter Erde verfertigt, und gegen die Zeiten des Bernini abgängig geworden, oder der arm, den man noch jetzt as aus dem groben in Marmor gehauen sieht, von diesen Künstlern verfertigt seyn? der Nahme des Ergänzers ist zu zweifelhaft, als dass ich wagen dürtfe ihn anzugeben. Nach der Weichheit der Behandlung zu urtheilen, ist der gegenwärtige arm nicht aus so frühen Zeiten, als gio. agnolo und Bandinelli voraussetzen. Mir scheint er alle Kennzeichen der Berninischen schule an sich zu tragen. Es ist würkli-ch gut. Was Richardson von der widrigen Farbe sagt, hat einen gründ darin, dass di bräunliche Erde (creta) gegen den weissen Marmor absticht]».
derno del restauro e con garbo contesta le tesi di Visconti, negando che il modellato dei muscoli possa essere cinquecentesco. Egli non sa che il braccio che sta osservando, a suo parere così ben eseguito, non è più quello visto e descritto dai suoi predecessori, che, come Johnathan Richardson, giudicavano ancora il vero braccio montorsoliano. L’ade-sione all’ipotesi del restauro berniniano gli pare dunque il modo più ragionevole di risolvere la questione dello stile.
anche l’amico e collaboratore di goethe, Johann Heinrich Meyer, disegnatore-erudito espertissimo di arte antica, cade nell’equivoco139:
solo il braccio destro di restauro di Laocoonte è ben lavorato, di terracotta e, come moltissimi suppongono, opera del Bernini, che in questo caso sembra essersi superato. gli altri restauri sono in marmo, fatti con molta diligenza ma con minor arte, spasmodicamente ruotati secondo il gusto della scuola del Bernini. dovrebbero essere di un tal Cornacchini.
È significativo che, come Ramdhor, Meyer trovi il braccio del padre ben fatto e adeguato all’eccellenza del capolavoro antico. Eviden- temente, a differenza del vecchio e nonostante fosse modellato in terra-cotta, il nuovo braccio non era un abbozzo ma un lavoro finito e curato. Il mancato uso del marmo, sorprendente, accresce i dubbi sul mo- vente dell’operazione. pare veramente che il rifacimento puntasse, più che a migliorare l’aspetto del gruppo, a ripristinare l’integrità della figura del padre celando la scomparsa del braccio cinquecentesco.
In verità quando Meyer vide il Laocoonte assieme a goethe, che aveva accompagnato nel viaggio in Italia del 1786-1788, il gruppo aveva già subito una nuova modifica140. Il riferimento alla spasmo-
I restauri 65
139 J.H. meyer, Einige Bemerkungen über die Gruppe Laokoons und seiner Söhne, in Propyläen, zweiten Bandes erstes Stück, 1799, pp. 175 ss. Non ho potu-to consultare l’originale; cito da preiss, Die wissenschaftliche Beschäftigung, cit., Anhang I. Quellentexte, s.v. Goethe, J.W. von, s.n.p. (che attribuisce lo scritto a goethe, confondendolo con il più noto Über Laokoon: infra, n. 141): «nur der restau-rierte rechte arm des Laokoons ist gut gearbeitet, von gebranntes ton und wie die meisten behaupten von Bernini, welcher sich aber darin selbs übertroffen haben muss. die andern angezeigten Ergänzungen sind von Marmor, zwar fleißig gemacht aber von schlechter Kunst, im geschmack der Berninischen schüle kramphaft verdreht. Ein gewisser Cornacchini soll sie verfertigt haben».
140 per il soggiorno di goethe a Roma: [p. CHiarini], Cronologia del soggiorno romano, in Goethe a Roma (1786-1788). Disegni e acquarelli da Weimar, Roma, Mus. Napoleonico, 10 mar. - 24 apr. 1988, a c. di p. Chiarini, Roma, artemide, 1988, pp. 55-57; inoltre id., Goethe, Roma e il viaggio in Italia, ibid., pp. 15-25. durante il soggiorno romano goethe fece eseguire i calchi in gesso delle teste di L. (Ca 8) e dei figli (Ca 9): Goethe e l’Italia. Goethe und Italien, trento, palazzo trentini, 16 set. - 6 nov. 1989, Milano, Electa, 1989, sch. nrr. 74-76, p. 86.
dica tensione rotatoria delle braccia dei figli appare inspiegabile se pensiamo al braccio ricadente cinquecentesco che Cornacchini aveva rifatto. Ma anche goethe in Über Laokoon ha un’osservazione simile, in apparenza parimenti incongrua: «il figlio più giovane cerca di farsi spazio levando in alto il braccio destro»141.
In realtà sul figlio minore c’era ormai un braccio nuovo, rigido, teso verso il padre e con la mano completamente aperta. Il braccio che è stato parte dell’immagine del gruppo fino agli anni Cinquanta del Novecento e che ha procurato ingiuste critiche a Cornacchini, cui anche nella letteratura recente viene attribuito142. Il Laocoonte che goethe e Meyer vedono nel 1786 è quello dell’acquaforte di giacomo Bossi per il secondo volume della Storia delle arti del disegno di Winckelmann curata da Carlo Fea (ds 114, fig. 41)143. Né l’uno né l’altro sanno che il braccio che li disturba risale ad un rifacimento di pochi mesi prima, che ancora una volta riusciamo a datare con precisione.
Il braccio non compare nella tavola del secondo tomo del Pio-Clementino (ds 113, fig. 40), già stampato alla fine del 1784. È invece nella tavola del secondo della Storia delle arti (ds 114, fig. 41), datato anch’esso 1784, ma in realtà andato in stampa nell’estate del 1785 e in circolazione nei primi mesi del 1786. grazie ad un polemico scambio di libelli fra Carlo Fea e onofrio Boni in cui si discutono puntigliose que-stioni di priorità nella datazione dei templi di Paestum, l’intricata vicenda tipografica della Storia delle arti, in cui ogni tomo porta sul frontespizio la data d’inizio e non di fine dell’impressione, risulta comprensibile144. Il consistente décalage fra l’anno di stampa dichiarato nel frontespizio e
Il braccio mancante66
141 J.W. goetHe, Über Laokoon (Propyläen, ersten Bandes erstes Stück, 1798, pp. 1-18), in Goethes Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrter hrsg. v. prof. dr. K. Heinemann, 22. Band, Schriften über bildende Kunst I, Leipzig und Wien, Bibliograph. Institut, 1900, pp. 105-116: 113: «der jüngste sohn will sich durch Erhöhung des rechten arms Luft machen». Cf. Sul Laocoonte, trad. a c. di M. Cometa, in Laocoonte 2000, a c. di L. Russo et al., palermo, Centro Intern. di studi di Estetica d. Fac. di Lett. e Fil. dell’Univ. di palermo, 1992, pp. 93-102.
142 ad es. Haskell, penny, L’antico nella storia del gusto, cit., p. 342; rossi pinelli, Chirurgia della memoria, cit., p. 188; andreae, Laocoonte e la fondazione di Roma, cit., pp. 41 e 187, did. alla fig. 53; sorprendentemente anche preiss, Die wissenschaftliche Beschäftigung, cit., pp. 57, 59.
143 [WinCkelmann], Storia delle Arti del disegno (ed. Fea), cit., III, tav. 4.144 [C. fea], Risposta dell’Abate C.F. Giureconsulto alle osservazioni del Sig. Cav.
Onofrio Boni sul tomo III. della Storia delle Arti del Disegno di Giov. Winckelmann pubblicata in Roma nelle sue memorie per le Belle arti, né mesi di Marzo, aprile, Maggio e giugno del corrente anno 1787, In Roma, dalla stamperia pagliarini, 1787. L’opuscoletto risponde alle accuse di plagio di onofrio Boni. Fea ammette la discuti-bile prassi di porre sul frontespizio la data d’inizio e non di conclusione della stampa: «il tomo fu cominciato a stampare nell’anno 1784, così misi sul frontespizio la data di quell’anno, come avevo fatto nei due tomi precedenti, che furono cominciati a stam-
l’effettiva stampa dei fascicoli, che prosegue nei mesi e addirittura negli anni successivi, spiega perché nel commento alla tavola del Laocoonte, alla fine del tomo III, Fea sia in grado di citare la descrizione del Pio-Clementino nonostante quest’ultima citi a sua volta il tomo II della Storia delle arti. Ci sono buone ragioni per pensare che il disegno di giuseppe Bossi, pubblicato come tavola iv (su un totale di undici) del volume secon-do, sia stato eseguito fra il 1784 e il 1785; la tavola del Pio-Clementino è di poco precedente, così il calco dell’accademia di Firenze (Ca 6, fig. 39). Nel 1786 ci sono le testimonianze indirette di goethe e Meyer (supra, p. 66 s.). Il risultato è una forbice strettissima che circoscrive la sostitu-zione del braccio a pochi mesi a cavallo tra l’84 e l’85, ovvero subito dopo la sostituzione del braccio del padre. In sostanza Laocoonte e suo figlio hanno cambiato braccia in un anno o poco più, mentre i migliori antiquari del tempo si occupavano di loro e i lavori per l’allestimento del pio-Clementino continuavano, nonostante nel 1784 fosse già stata posta all’entrata del museo la lapide commemorativa dell’inaugurazione: un intervento evidentemente contestualizzato145. È però interessante che lo scarto cronologico di oltre sessant’anni fra questi restauri e la riparazione di Cornacchini sia sostanzialmente sfuggito ai contemporanei come agli studiosi dei sue secoli successivi, nonostante i documenti fossero, nella loro notorietà, sotto gli occhi di tutti.
Comunque verso il 1786, mentre siede sul soglio quel che tredici anni dopo subirà l’umiliazione della deportazione, il Laocoonte è giun-to provvisoriamente alla fine delle sue vicissitudini e ha assunto l’aspet-to che sarà familiare agli archeologi del XX secolo. È il Laocoonte della magistrale tavola di Francesco piranesi nel Choix des meilleurs statues antiques (ds 117) e di innumerevoli disegni inediti nei gabinetti dei disegni di tutte le principali pinacoteche e accademie d’Europa146.
In questa fase abbiamo anche, grazie allo scrupolo di Johann Heinrich Meyer, una recensione dello stato dei restauri degna di un moderno catalogo di museo147:
I restauri 67
pare, e a pubblicare dal frontespizio nel 1783, come fanno tanti altri autori in Roma, e fuori» (p. 20). Nel t. III alle note delle pp. 431 e 435 sono menzionate le Iscrizioni della villa, e dei palazzi Albani di Marini, pubbl. nell’agosto 1785 ([fea], Risposta, cit., p. 19): la parte finale del volume fu dunque redatta nella seconda metà dell’anno, compresa la nota esplicativa alla tavola del Laocoonte, e l’intero volume non potè essere congedato prima del 1786.
145 per i lavori sopr. C. pietrangeli, I Musei Vaticani al tempo di Pio VI, «Rend-pontacc», L, 1977-1978, pp. 196-233; id., Il Cortile, cit., pp. 426-429.
146 Choix des meilleurs statues antiques &c., paris, s.n., s.d., tav. 1 (vol. in 2° gr. senza front., dedicato a pio VI e contenente una serie di tavole 650x480 mm. di autori diversi, datate 1780-1792).
147 meyer, Einige Bemerkungen, cit., p. 176 (preiss, Die wissenschaftliche Beschäftigung, cit., Anhang I. Quellentexte, s.v. Goethe, J.W. von, s.n.p.): «an den
Nei serpenti una parte considerevole è lavoro moderno, e probabil-mente tutte e due le teste. Nella figura di Laocoonte. Il braccio destro fino all’articolazione della spalla. Le cinque dita del piede sinistro; il piede destro, al contrario, si è conservato assolutamente integro. Nel figlio maggiore. La punta del naso. La mano destra. tre dita del piede sinistro. La punta del pollice del piede destro. Il ventre è leggermente danneggiato sul lato destro, e il danno riparato. Nel figlio minore. Il braccio destro. due dita della mano sinistra. Le cinque dita del piede destro.
Il Laocoonte a Parigi: François Girardon
Nello stato descritto da goethe il Laocoonte fu visto da dominique Vivant-denon e dagli altri commissari francesi incaricati delle requisi-zioni previste dal trattato di tolentino, firmato il 19 febbraio 1797148.
Come gli altri capolavori della collezione pontificia, il Laocoonte prese la strada di parigi nella primavera del 1798 e, dopo un viaggio faticoso e non privo di rischi, il 27 e il 28 luglio sfilò in processione per le vie della capitale francese assieme ai dipinti, ai libri e alle altre rarità provenienti dall’Italia149. secondo la descrizione del pittore Étienne delécluze, allievo di david, le statue antiche ebbero il privilegio di chiudere il corteo ma sfilarono imballate, cosicché ciò che effettiva-mente videro i parigini furono delle grandi casse con scritti a caratteri cubitali i nomi dei capolavori150.
Il braccio mancante68
schlangen ist ein beträchtlicher theil neue arbeit, und wahrscheinlich beyde Köpfe. an der Figur des Laokoon: der rechte arm bis nahe ans schultergelenk. die fünf zehen des linken Füßes; der rechte Fu? ist hingegen ganz unbeschädigt geblieben. am ältern sohn. die spitze der Nase. die rechte Hand. die drey Zehen des linken Füßes. am rechten Fuß die spitze des daums. der Bauch ist auf der rechten seite ein wenig beschädigt, und die Beschädigung ausgebessert. am jüngern sohn. die Nasenspitze. der rechte arm. Zwey Finger der linken Hand. alle fünf Zehen des rechten Fußes».
148 Numerosi studi mettono in luce l’importanza dell’operato di Vivant-denon: J. CHatelain, Dominique Vivant Denon et le Louvre de Napoléon, paris, Libr. acad. perrin, s.d. [1973]; p. lelievre, m. BarBin, Vivant-Denon: homme des lumières, «ministre des arts» de Napoleon, paris, picard, 1993; Vivant-Denon, Colloque de Chalon s. saône, 14 et 15 mai 1999, textes réc. p. F. Claudon et B. Bailly, Chalon s. saône, Comité Nat. p. le dévelop. de la Rech. et des Ét. s. la Vie et l’oeuvre de Vivant-denon, 1999; Dominique Vivant-Denon. L’oeil de Napoléon, paris, Musée du Louvre, 20 oct. 1999 - 17 jan. 2000, Comm. de l’éxp. p. Rosenberg; Comm. dél. M.-a. dupuy, paris, Réunion d. Mus. Nationaux, 1999.
149 p. WesCHer, Kunstraub unter Napoleon, Berlin, gebrüder Mann, 1976, trad. ital. I furti d’arte. Napoleone e la nascita del Louvre, torino, Einaudi, 1988, pp. 67-76; daltrop, Die Laokoongruppe, cit., p. 23 s.
150 E. deléClUze, Luis David. Son école e son temps (paris 1955), p. 206 s., cit. in
La processione è rappresentata in modo piuttosto fantasioso su un cratere della manifattura di sèvres dipinto da antoine Beranger su disegno di Joseph-Étienne Valois (da 5). Vi si vedono lo Zeus di Otricoli, l’Urania del museo pio-Clementino, l’Apollo del Belvedere, l’Eros di Centocelle, il Laocoonte e la Venere dei Medici: una sorta di estemporaneo catalogo del meglio della collezione. all’estremità destra un ingresso con grandi colonne ioniche e l’iscrizione Musée Napoleon indica con consapevole anacronismo – il nome Musée Napoleon sareb-be stato attribuito solo nel 1803 a quello che era allora il Musée Central des Arts – la destinazione finale di tutti quei capolavori151.
al Musée le antichità furono in un primo momento collocate insie-me al pianterreno, nell’ex-appartamento della regina anna d’austria, ma il Laocoonte e l’Apollo si videro ben presto riconoscere un rango speciale ed ebbero l’onore di una loro sala, detta appunto Salle du Laocoon, in cui il gruppo occupava una nicchia nella parete di fronte all’ingresso. Questa monumentale sistemazione è documentata da un acquerello di Benjamin Zix che illustra la visita notturna alla statua alla luce delle torce, un’abitudine divenuta di moda alla fine del settecento anche a Roma (fig. 45)152.
Il Laocoonte giunse a parigi privo di restauri. a Roma, le principali integrazioni moderne erano state rimosse, una decisione abbastanza sorprendente che fu presa dagli stessi funzionari, cioè di fatto da Vivant-denon, come risulta dal verbale della riunione dei Conservatori del Musée Central il 28 Brumaio an. VIII153. È possibile che questo
I restauri 69
Neoclassicism and Romanticism. 1750-1850. Sources and Documents, a c. di L. E.a. Eitner, Engelwood Cliffs (nJ), prentice-Hall, 1970, II, p. 8 s.
151 a. BUsiri viCi, Un vaso di Sèvres documenta le asportazioni napoleoniche dall’Italia, «antViva», X, 1971, 3, pp. 55-64. sulla storia del Musée Napoléon ora: ph. malgoUyres, Le Musée Napoléon, paris, Réunion d. Mus. Nationaux, 1999; I. Jenkins, ‘Gods Without Altars’: the Belvedere in Paris, in Il Cortile delle Statue, cit., pp. 460-469; d. gallo, Les antiques au Louvre, in Dominique Vivant-Denon, cit., pp. 182-194.
152 N. Himmelmann, Utopische Vergangenheit. Archäologie und moderne Kultur, Berlin, Mann, 1976, trad. ital. Utopia del passato. Archeologia e cultura moderna, Bari, de donato, 1981, pp. 121-126.
153 E. MiCHon, La restauration du Laocoon et le modèle de Girardon [tit. nell’in-dice del vol.], «Bsocant», 1906, pp. 271-280 [il saggio, pubbl. come comunicazione senza titolo durante la seduta del 27 giu. 1906, è citato così dall’autore in Fondation E. Piot. Monuments et Memoire, XXI, 1913, p. 14, nota 2]: 276 s.: «les commissaires chargés de recueillir les monuments antiques en Italie n’ayant pas jugé à propos d’ap-porter le bras droit de ce groupe et ceux de ses deux entfants, restauration d’un sculp-teur italien nommé Cornacchini» [i Commissari incaricati di raccogliere monumenti antichi in Italia non avevano ritenuto portare il braccio destro di Laocoonte, né quelli dei figli, restauro di uno scultore italiano di nome Cornacchini]. Cf. Ch. aUlanier,
scrupolo puristico, che non coinvolge le altre sculture del Cortile, sia stato indotto dalla situazione sfortunata di quelle braccia: quello del padre in terracotta e non finito, seppur da molti creduto di Bernini; quelli dei figli attribuiti a «uno scultore italiano di nome Cornacchini» che toccava allora il culmine della sfortuna.
Constatata all’apertura delle casse la mancanza delle braccia, i Conservatori deliberarono di procedere ad un nuovo restauro, per il quale fu deciso di bandire un concorso aperto a tutti gli scultori france-si. In attesa che questo fosse espletato, un Commissario propose come soluzione temporanea di integrare il gruppo prendendo a modello il braccio di Laocoonte di un calco dell’École de Dessin154:
Un membro propone che, in attesa che si metta a concorso il restau-ro, si faccia modellare o prendere a stampo il braccio di gesso del Laocoonte esposto nella sala dell’École de dessin per collocarlo provvisoriamente sul gruppo, dopo avergli dato il colore del marmo. Egli pensa che tale integrazione sia necessaria allo sviluppo di questo sublime gruppo e che soddisferà momentaneamente gli artisti e il pub-blico, dato che il braccio da riprodurre è stato fatto con sentimento e intelligenza da girardon.
La proposta fu approvata. I Commissari ritennero preferibile che il gruppo non fosse esposto al pubblico privo di una parte così impor-tante. E, cosa non secondaria, il braccio da installare era ‘d’autore’, essendo stato modellato che da François girardon155. Il fatto che l’École des Beaux-Arts possedesse un calco del gruppo non sorprende, ma che il più reputato scultore francese del XVII secolo vi avesse spe-rimentato una soluzione diversa da quella del braccio montorsoliano è di grande interesse. della sua operazione condotta «con intelligenza e sentimento» non restano chiare tracce, né ne è stata tramandata notizia, salvo questa. Bisognerà allora cercare di individuare quello che nella letteratura scientifica è ormai da tempo ‘il braccio di girardon’.
Il braccio mancante70
Histoire du Palais et du Musée du Louvre, V, Le Petit Galerie. Appartement d’Anne d’Autriche. Salles romaines, paris, Éd. d. Mus. Nationaux, 1955, p. 70.
154 miCHon, restauration, cit., p. 277: «un membre propose qu’en attendant qu’on puisse mettre cette restauration importante au concours on fasse mouler ou estamper le bras du plâtre de Laocoon exposé dans la salle de l’école de dessin pour le placer provisoirement, après lui avoir donné la teinte du marbre, au goupe du Laocoon. Il pense que cette adjonction est nécessaire au développement de ce groupe sublime et satisfera momentanément les artistes et le public, les bras à mouler sur ce plâtre ayant été faits avec intelligence et sentiment par girardon».
155 Ibid., p. 277: «le Conseil se range à cet avis et arrète qu’il sera écrit au citoyen Renou, surveillant de l’école, afin qu’il donne des ordres pour que le mouleur qui sera chargé de ce travail puisse s’en occuper sans délai et sans empêchement».
Il concorso votato nel 1798 fu bandito nella primavera del 1800156. Il premio per il vincitore era una somma considerevole, diecimila fran-chi, ma la competizione andò deserta157.
Nessuno dei nostri abili statuari, scrivono gli autori delle note della Galerie du Musée Napoléon, si presentò: il loro rispetto per questo capolavoro è lo stesso già mostrato da Michelangelo, che aveva comin-ciato il restauro ma che lasciò l’opera imperfetta, disperando di poter raggiungere la sublime bellezza dell’originale.
La leggenda della modestia di Michelangelo che continuava a profilarsi dietro il braccio incompiuto del Vaticano – per inciso: i com-missari di Vivant-denon non avevano ritenuto opportuno trasferirlo a parigi – poteva giustificare l’insuccesso del concorso. Ma esso adom-bra anche, e forse di più, la nascente consapevolezza degli artisti che non sarebbe stato possibile modificare con nuove soluzioni un’imma-gine consolidatasi nei secoli.
si può ritenere questo il primo caso in cui la fama di un’opera agisce come elemento d’opposizione a un nuovo, organico completa-mento? se è così, il fatto può e deve essere letto come la sanzione dello status speciale di cui godeva il Laocoonte nel corpus dei capolavori più celebrati del mondo, ma anche come avvisaglia di una svolta nel rapporto con l’antico, poiché solo la consapevolezza del valore storico dell’opera d’arte può difenderla dalle esigenze prevaricanti della col-locazione museografica e del gusto, imponendo un’integrità non più materiale ma iconografica e stilistica. al Laocoonte, grazie alla fama, questo riconoscimento è venuto in anticipo e senza che il suo esempio potesse estendersi e generalizzarsi, tuttavia l’episodio non deve essere sottovalutato.
dai documenti apprendiamo che non solo il braccio del padre, ma tutte le braccia del gruppo furono modellate sul calco della École des Beaux-Arts e installate sull’originale in quello stesso anno, probabil-mente ancor prima che si conoscesse l’esito negativo del concorso. Lo conferma la prima edizione della Notice des Statues, Bustes, Bas-Reliefs, et autres objects composants la Galerie des Antiques du Musée Central des Arts, pubblicato a più riprese fino al 1815: «il braccio destro del padre e due delle braccia dei fanciulli mancano;
I restauri 71
156 Ibid., p. 278 (riproduce il testo dell’arreté del Ministro dell’Interno Chaptal che fissa i termini del concorso in data 14 messidoro an. IX).
157 Galerie du Musée Napoléon. Cours historique et élèmentaire de peinture, I-X, paris, Filhol, an XII [1804-1814], X, tav. 720, p. 8: «aucun de nos habiles statuaires ne se présenta: leur respect pour ce chef-d’oeuvre avait dejà été imité par Michel-ange, qui avait tenté cette restauration, ma laissa son ouvrage imparfait, désespérant d’ap-procher de la sublimité de l’original». Cf. miCHon, restauration, cit., p. 279 s.
senza dubbio saranno un giorno eseguite in marmo, ma provvisoria-mente sono state sostituite con delle braccia calcate sul gruppo in gesso, restaurato da girardon, che si vede nella sala dell’École de peinture»158.
Il ricorso alle braccia di girardon per tutte le figure, confermato dalle note di Jacques-Benjamin-Maximilien Bins, comte de saint-Vic-tor al Musée des Antiques del pittore e incisore pierre Bouillon159, era stato consigliato dall’opportunità di collocare rapidamente il gruppo nella sua sede definitiva, cioè nella nicchia in fondo alla parete della Salle du Laocoon. Il fallimento del concorso del 1800 finì per attribui-re a questa soluzione un carattere permanente. Quando la seconda edi-zione della Notice des statues vide la luce (1802-1803), il Laocoonte era al suo posto con le braccia di gesso, e tale rimase in seguito per tutta la durata del soggiorno a parigi.
si è insistito sulla difficoltà di individuare l’aspetto delle braccia di girardon: le stampe che ritraggono il Laocoonte nel Musée Napoleon (ds 122-128) sembrerebbero, almeno a prima vista, identiche a quelle anteriori al trasferimento. Ma se le consideriamo con attenzione osser-veremo che esse mostrano invece un braccio del padre più verticale e teso di quello montorsoliano, con la spira del serpente lievemente più stretta. anche le braccia dei figli sono state modificate nei dettagli. La mano destra del fanciullo morente ha le dita più orizzontali e tese della mano di Baccio (restaurata da Cornacchini), cosa che attribuisce al gesto forte enfasi e una certa artificiosità. Il commento di Jacques-Benjamin de saint-Victor alla bella tavola del Musée des Antiques (ds 125) attira l’attenzione del lettore proprio su queste differenze, certo minime ma non insignificanti160:
Il braccio mancante72
158 Notice des Statues, Bustes, Bas-Reliefs et autres objects composants la Galerie des Antiques du Musée Central des Arts, ouverte pour la première fois le dix-huit Brumaire de l’an 9, À paris, de l’Imprimerie des sciences et arts, s.d. [1800], p. 44, nr. 108. Il testo è anche in miCHon, restauration, cit., p. 272 s.
159 [J.-B. de saint-viCtor], Musée des Antiques dessiné et gravé par p. Bouillon peintre, avec des notices explicatives par J.-B. de s.-V., II, Heros, personnages grecs et romains, À paris, chez p. didot, l’ainê, s.d. [3 voll., pubbl. forse tra il 1821 e il 1827], c. 32v.
160 [saint-viCtor], Musée des Antiques, cit., c. 35v, n. 2: «le bras [du père] est maintenant restauré en plâtre d’après un modèle de girardon. Baccio Bandinelli en fit une restauration differente dans la copie de ce groupe, qu’il executa en marble, de la grandeur de l’original, et qu’on voit encore, dans la galerie de Florence. Frère gioan angelo avait restauré ce bras en terre cuite à peu près dans le même mouvement que le bras modelé par girardon, mais dans une attitude moins forcée». Non trovo men-zione del gesso né in F. soUCHal, French Sculptors of the 17th and 18th Centuries. The Reign of Louis XIV. Illustrated Catalogue, I-IV, oxford, Cassirer, 1977-1993, II (1981), s.v. Girardon, François, p. 14 s., né in a. klidis, François Girardon.
Il braccio [del padre] è ora restaurato in gesso sulla base di un model-lo di girardon. [...] Fra’ giovan angelo aveva restaurato il braccio in terracotta più o meno con lo stesso movimento di girardon, ma in atteggiamento meno forzato.
abbiamo insomma la ragionevole certezza che le braccia di girardon siano quelle che si vedono nelle incisioni napoleoniche (ds 122, fig. 49; ds 124, fig. 46). Il calco originale modificato dallo scul-tore non è stato individuato fra i calchi della collezione dell’École des Beaux-Arts, trasferita dal 1970 a Versailles, ma le riprove indirette non mancano161. In primo luogo uno dei calchi più antichi della serie, secondo Eugène Müntz appartenente al nucleo di Luigi XIV, ha le braccia di quel tipo162. In secondo luogo il getto in bronzo del salone della villa di Houghton Hall nel Norfolk, già residenza di campagna di sir Horace Walpole, acquistato a parigi dalla fonderia Keller, dove era stato gettato sotto la supervisione di girardon (Ca 3), ha anch’esso le braccia verticali163. da altra fonte apprendiamo che girardon si era occupato di tre calchi che alla morte di Jakob Keller (1702) erano stati trovati nell’atelier, e che fra questi vi era un Laocoonte, il quale con ogni probabilità servì da modello per il getto di Houghton Hall164. Il braccio di girardon è su un calco dell’accademia delle scienze di stoccolma (Ca 4, fig. 48) e sulla copia in marmo che Jean-Baptiste tuby ha eseguito nel 1692 per i giardini di Versailles (Co 6, fig. 47), oggi collocata a destra dell’ingresso del Tapis Vert. anche in questo caso sappiamo che il modello della scultura fu un calco dell’École des Beaux-Arts.
Vale come controprova il fatto che un altro Laocoonte gettato dai Keller nel 1687, ma a differenza dei precedenti non derivato dagli
I restauri 73
Bildhauer in königlichen Diest 1663-1700, Weimar, Verl. u. datenbank f. geistwiss., 2001. Jacques Buirette, allievo di girardon, ha modellato un bronzetto che ne ripete le braccia: soUCHal, French Sculptors, cit., I (1977), p. 77, nr. 18.
161 C. pinatel, Origines de la colléction des moulages d’antiques de l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris, aujourd’hui à Versailles, in L’anticomanie, cit., pp. 307-325.
162 e. müntz, Le musée de l’École des Beaux-Arts. I. Les origines de la collec-tion, «gazBeauxarts», 1890, 1, pp. 274-276. Un calco del Laocoonte risulta offerto da Luigi XIV all’École nel 1692, ma non è noto se abbia relazione con girardon: H. van Helsdingen, Laokoon in the Seventeenth Century, «simiolus», X, 1978-1979, pp. 127-141: 132, n. 40.
163 BieBer, Laocoon, cit., p. 16, n. 7; d. koCks, Antikenaufstellung und Antiken-ergänzung im 18. Jahrhundert in England, in Antikensammlung im 18. Jahrhundert, akten d. Intern. symposium, Frankfurt a. M., Liebighaus, dez. 1978, hrsg. v. H. Bec, p.C. Bol, W. prinz & H.von steuben, Berlin, de gruyter, 1981, pp. 317-331: 320.
164 van Helsdingen, Laokoon, cit., p. 132.
esemplari passati sotto la supervisione di girardon bensì da un calco di proprietà di guillaume Cassegrain modellato probabilmente su un esemplare già presente nelle collezioni regie, riproduce il gruppo come si presentava a Roma prima dei restauri di Cornacchini (Ca 2, fig. 44).
Le braccia di girardon innalzano di qualche punto il livello di enfasi retorica del gruppo, rispondono peraltro ad un gusto diffuso che induce molti incisori contemporanei a preferire la visione esterna e dal basso, dal lato del fanciullo morente: uno scorcio che valorizza il pathos del volto di Laocoonte. Nonostante il gruppo risulti un po’ più rigido di quello montorsoliano, le differenze sono così poco significative che si può parlare di continuità d’immagine. E appunto questa continuità avrà suggerito ai Commissari del Musée Central l’adozione immediata delle braccia di girardon. Essi ripristinavano l’affascinante situazione del grande artista moderno che mette il suo genio al servizio del capo-lavoro antico, come già si credeva che avesse fatto Michelangelo, ma allo stesso tempo evitavano ai visitatori assuefatti all’immagine tricen-tenaria del padre che lotta con il serpente la sorpresa di una soluzione troppo innovativa. In fondo, senza esserne pienamente consapevoli, essi hanno fatto ciò che piacerebbe forse fare anche a noi: riportare il gruppo indietro nel tempo quanto basta per far sì che il Laocoonte di pio VI e di Visconti tornasse ad essere il Laocoonte di Clemente VII e di Michelangelo.
Il ritorno a Roma: Antonio Canova
alla fine del 1815, dopo il ritorno di Napoleone dall’esilio dell’iso-la d’Elba, il governo dei Cento giorni e la disfatta finale di Waterloo, il Laocoonte e gli altri capolavori antichi presero la strada di Roma165.
La loro restituzione era stata chiesta da antonio Canova, apposita-mente inviato dal governo pontificio, durante i lavori del Congresso di Vienna, ma senza troppa insistenza, dato che Roma condivideva la linea anglo-russa di non indebolire la rinata monarchia borbonica con l’immediata confisca delle opere d’arte, alla quale certamente l’opinione pubblica avrebbe reagito con ostilità166. dopo, tuttavia, lo
Il braccio mancante74
165 WesCHer, I furti d’arte, cit., pp. 141-157; daltrop, Die Laokoongruppe, cit., p. 24.
166 g. Contarini, Canova a Parigi nel 1815, Feltre, Castoldi, 1891; M. pomponi, Fonti per la storia dei monumenti di Roma, II, Nuove evidenze sulla missione di Canova a Parigi, «Rendpontacc», s. ix, V, 1994, pp. 739-761; J.-M. leniaUd, Canova et la question des spoliations d’oeuvres d’art, in Antonio Canova e il suo ambiente storico fra Venezia, Roma e Parigi, a c. di g. pavanello, Venezia, Ist. ven. di sc., Lett. e arti, 2000, pp. 481-490. per una valutazione della congiuntura politico-istituzionale:
spirito di rivalsa che improntò la politica degli alleati accelerò brusca-mente le operazioni di rientro ed il rischio che ragioni di opportunità politica potessero lasciare per sempre a parigi gli antichi capolavori del Belvedere svanì.
Il compito di organizzare il rimpatrio fu affidato a Canova stesso, che lo portò a termine assistito dal suo segretario, il cavaliere antonio d’Este, cercando di distinguere fra le opere per le quali il governo francese aveva già versato agli ex-proprietari delle somme di denaro a titolo di rimborso (e delle quali poteva ormai legittimamente riven-dicare la proprietà), e quelle che invece dovevano tornare in Italia167. a questo problema si aggiungevano le difficoltà del trasporto, che scoraggiavano il recupero di pezzi troppo grandi e pesanti, come il Tevere che era stato un tempo al centro del cortile, o la Melpomene che si trova oggi nell’omonima sala del Louvre. Il convoglio che riportava le opere trafugate (41 carri con duecento cavalli e una scorta di mili-tari tedeschi) partì da parigi il 24 ottobre 1815. durante la dura ascesa al colle del Moncenisio, nella notte del 23 novembre, la cassa del Laocoonte cadde dal carro che la trasportava e il gruppo rovinò a terra, subendo gravi danni, specialmente alla figura del padre, la cui parte inferiore si staccò completamente168. Il viaggio proseguì in queste condizioni fino a Milano, dove il convoglio venne smistato e riorganiz-zato. dodici carri proseguirono per Roma, e verso la fine di dicembre tutti i dipinti e le sculture avevano ripreso il loro posto nelle rispettive sedi, non sempre peraltro quello occupato prima della partenza. Non è il caso del Laocoonte, che fu ricollocato nella nicchia della parete sud del cortile del Belvedere in cui era sempre stato dal giugno 1506.
secondo il conte di Clarac, al momento della collocazione nel cortile furono riadattate al gruppo le braccia rimosse dai commis-sari napoleonici, cioè il braccio in terracotta ‘viscontiano’, il brac-cio del figlio minore del tempo di pio VI e quello del maggiore del Cornacchini169. La notizia è confermata dalle fonti figurative: tutte le illustrazioni posteriori al 1815 mostrano il gruppo in uno stato identico a quello che precede la requisizione francese (fig. 1).
I restauri 75
E. pommier, Réflexions sur le problème des restitutions d’oeuvres d’art en 1814-1815, in Dominique Vivant-Denon, cit., pp. 254-257. Interessante anche a. Campami, Sul- l’opera di Antonio Canova pel recupero dei monumenti d’arte italiani a Parigi. Cor- rispondenza Canova-Angeloni, Roma, tip. dell’Unione Coop., 1892.
167 a. d’este, Memorie di Antonio Canova. scritte da a. d’E. e pubblicate per cura di alessandro d’Este. Con note e documenti, Firenze, Le Monnier, 1864.
168 Ibid., p. 241 s.169 ClaraC, Musée de sculpture, cit., V, testo ad nr. 2092 [vol. 6], tav. 834 [vol. 12]:
«a Rome, le groupe a repris le restaurations en stuc, qui sont l’oeuvre du Bernin».
tuttavia, quando Filippo Magi procedette al derestauro del gruppo per installare il braccio Pollack, gli arti che si trovavano sul monumento, compreso quello del padre, nonostante fossero perfettamente identici a quelli delle incisioni ottocentesche, erano in gesso. data l’identità formale deve trattarsi di calchi tratti dalle integrazioni settecentesche ed installati al loro posto, probabilmente per rendere più omogeneo e neutro l’aspetto del gruppo. È possibile che essi siano stati gettati durante l’importante intervento di consolidamento che il gruppo subì nel 1816, per porre rimedio ai danni subiti al Moncenisio, ma il Certificato che documenta l’avvenuta riparazione, redatto in Vaticano il 14 gennaio 1816 da giovanni pierantoni e Francesco Massimiliano Laboureur sotto la supervisione di Canova, menziona solo le opera-zioni necessarie per il ricongiungimento e il consolidamento delle parti staccate, che, come ha constatato Magi, fu operato con largo uso di mistura forte e non ha richiesto ulteriori interventi fino al dere-stauro degli anni Cinquanta170. Il senso dell’operazione è comunque chiaro: ‘cancellare’ la differenza cromatica fra l’originale e le parti di restauro che aveva disturbato i viaggiatori nel XVIII secolo (supra, p. 50 s.). Il tono sordo del gesso, che una mano di vernice a base di grasso animale poteva ulteriormente abbassare, contribuiva a rendere meno vistoso lo scarto fra antico e moderno, in linea con le esigenze dell’incipiente clima puristico, che sempre più insistentemente chie-deva ai restauratori di operare con discrezione.
Il braccio non più mancante: il ‘rispristino’ di Filippo Magi
Il Laocoonte patetico, con le braccia protese verso l’alto, che esce dalle mani dei restauratori vaticani nel 1816 è destinato a rimanere per lungo tempo ‘il’ Laocoonte.
L’archeologia, che attraverso gli scritti di Friedrich thiersch, di Friedrich Welcker, di Carl otfried Müller, di gottfried Herrmann e di altri avrebbe presto cominciato a dibattere la collocazione stilistica del gruppo, specialmente la questione poi centrale del Grieche oder Römer?, deve fare i conti con questa interpretazione enfatica e ne viene nel bene e nel male influenzata171. Le pagine della Geschichte
Il braccio mancante76
170 magi, Il ripristino, cit., p. 65; M. pavan, I Musei Vaticani, il Canova e il governo napoleonico (1809 - 1814), in Studi in onore di Elena Bassi, Venezia, arsenale, 1998, pp. 135-154.
171 Un panorama della bibliografia ottocentesca: E. Brizio, Gli studi sul Laocoonte, «Nuovant», s. iii, XXI, 1889, pp. 1-25; ibid., XXII, 1890, pp. 252-273; più brevemente BieBer, Laocoon, cit., pp. 31-36.
der Griechischen Künstler di Heinrich Brunn (1853), avanguardia di una lunghissima serie di analisi della forma espressiva, hanno come punto di partenza la critica al braccio proteso, che lo studioso di Monaco credeva rinascimentale.
Ma la sistemazione canoviana, consegnata per sempre alla nostra memoria visiva dalle magnifiche foto ottocentesche (fig. 1), è stata inopinatamente messa in crisi da quello che possiamo considerare l’evento più importante nella storia del Laocoonte: la scoperta del braccio mancante da quattro secoli (fig. 50).
La trouvaille fu effettuata da Ludwig pollack nel 1905 presso uno scalpellino romano che aveva bottega sulla via Labicana, a poche cen-tinaia di metri dal luogo in cui il gruppo era venuto alla luce. pollack, singolare figura di conoscitore, un po’ studioso e un po’ mercante, ne diede annuncio dalle pagine delle Mitteilungen dell’Istituto germanico di Roma del 1905, con un tempismo che a posteriori pare straordinario rispetto alla scadenza del quattrocentesimo anno dal ritrovamento172. Nonostante il rilievo della scoperta l’articolo è breve e di tono dimes-so: non vi è precisato quando il braccio fu trovato, né il nome dello scalpellino che lo possedeva, né l’ubicazione della bottega, che si saprà poi per altra via173.
In realtà è probabile che una serie di circostanze abbia fuorviato pollack e gli altri membri dell’Istituto. Il marmo apparentemente diverso, le proporzioni giudicate più piccole, il pessimo stato di con-servazione, una lacuna di almeno dieci centimetri fra il braccio e la parte conservata della spalla fecero loro credere che il nuovo fram-mento non appartenesse al gruppo del Belvedere ma ad una delle molte copie di cui si era creduto di trovar traccia nel corso dei secoli174. Ciò sembrava attribuire al braccio una rilevanza più documentaria che artistica, non trascurabile, ma diversa da quella che avrebbe avuto se si fosse trattato del braccio autentico.
pure già l’anno successivo georg treu, direttore dell’albertinum di dresda, ottenne da pollak un calco in gesso del frammento e ne tentò la sistemazione su un calco del gruppo in possesso del museo (fig.
I restauri 77
172 l. pollaCk, Der rechte Arm des Laokoon, «RM», XX, 1905, pp. 277-282. Cf. daltrop, Die Laokoongruppe, cit., pp. 24-26.
173 Il rinvenimento non è ricordato in L. pollak, Römische Memoiren. Künstler, Kunstliebhaber und Gelehrter 1893-1943, hrsg. v. M. Merkel guldan, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1994. per un inquadramento: L. mUsso, “Römische Memoiren” di Ludwig Pollak: l’archeologo, il conoscitore, il commerciante d’arte antica, «studi germanici», XXX, 1995, pp. 95-110. Una rievocazione della personalità di p.: V. perretta, Un ebreo ‘Romano’, ibid., pp. 91-94.
174 sulla questione delle copie: settis, Laocoonte, cit., pp. 13-17.
51)175. La pionieristica intuizione non sembra essere stata seguita dal resto della comunità scientifica, che diede scarso peso alla scoperta. si aggiunga che a lungo aleggiò anche qualche sospetto sull’autenticità del braccio, un po’ per le circostanze oscure della scoperta, un po’ per la dubbia fama di pollack. Ragioni sufficienti, comunque, a mantener-lo in posizione defilata rispetto al dibattito che si andava sviluppando e per escludere che si considerasse la possibilità di installarlo al posto dei calchi delle braccia settecentesche.
Una drastica svolta si verificò, a mezzo secolo dalla scoperta, con la pubblicazione nella rivista dell’Istituto di archeologia e storia del-l’arte di un lungo articolo di Ernesto Vergara Caffarelli in cui l’autore sosteneva per la prima volta apertamente la pertinenza del braccio al gruppo, dimostrando infondate almeno le riserve sulle dimensioni e la qualità del marmo176.
L’accoglimento delle tesi di Vergara, sostanzialmente immediato, segnava la totale rivalutazione del braccio Pollack e una ripresa di interesse per il Laocoonte, grazie al quale, sovrapponendosi fra l’altro con effetto moltiplicatore la scoperta dell’eccezionale complesso di sperlonga, maturava negli ambienti dei Musei Vaticani le decisione di operare il ‘ripristino’ del Laocoonte ‘originale’ con la rimozione delle braccia settecentesche e la messa in opera del braccio antico (fig. 52), nella convinzione che il gruppo dovesse ormai essere offerto al pub-blico non nella sua dimensione storica ma in quella autentica, il più vicino possibile al Laocoonte pensato e realizzato dai summi artifices antichi177.
L’operazione «lunga, laboriosa e dispendiosa» ha avuto luogo, sotto la direzione di Filippo Magi, fra il 1957 e il 1959, ed è descritta con relativa ampiezza nel Ripristino del Laocoonte, nono volume delle Memorie della pontificia accademia di archelogia: sola, preziosa ma ormai inevitabilmente inadeguata documentazione scientifica del gruppo in tutte le sue componenti.
Con il «ripristino», che ci ha restituito il Laocoonte odierno, si chiude la storia dei restauri del Laocoonte. Nonostante il tempo e la fama del monumento, molti fatti e passaggi erano rimasti in ombra. È mia speranza averli convincentemente recuperati.
Il braccio mancante78
175 I. raUmsCHlüssel, Zur rekostruktion des Laokoon durch Georg Treu, in Das Albertinum vor 100. Jahren. Die Skulpturensammlung Georg Treus, dresden, albertinum, 1994-1995, hrsg. v. K. Knoll, dresden, 1994, pp. 277-280.
176 vergara Caffarelli, Studio, cit., pp. 35-69.177 magi, Il ripristino, cit. per le sculture di sperlonga vd. Ulisse: il mito e la
memoria, Roma, palazzo delle Esposizioni, 22 feb. - 2 set. 1996, a c. di B. andreae, C. parisi presicce, Roma, progetti Museali, 1996; settis, Laocoonte, cit., pp. 52-56, con bibl.
Le immagini del Laocoonte 81
LE IMMAGINI DEL LAOCOONTE
Disegni e stampe (ds)
ds 1 disegnatore dell’Italia settentrionale. penna e acquerello su carta bianca lavée in bistro, 373x280 mm. düsseldorf, Kunstmuseum, inv. Fp 7032. 1506-1508.
gruppo del L. privo di restauri. stato precedente l’installazione sulla base moderna. Bibliografia: Winner, Zum Nachleben, 99 ss. (scuola bolognese?); daltrop, Die
Laokoongruppe, 14 s.; HoWard, On the Reconstruction, 58; Himmelmann, Laokoon, 97 s.; lasCHke, Die Arme, 175; nesselratH, sch. nr. 235, in Hoch Renaissance, 515 (giov. antonio da Brescia); reBaUdo, I restauri, 231 s.
ds 2 Miniatore italiano. Bordura miniata del messale del card. antoniotto pallavicini (rita-gliata e incollata su supporto cartaceo). Inchiostri policromi su carta bianca. già Londra, mercato antiquario (sotheby’s, 21 giugno 1988). 1506-1507(?).
Fregio policromo di foglie di acanto su fondo oro, tondo a camaïeu d’or con il gruppo del L. privo di restauri. Riproduzione libera e parzialmente di fantasia.
Bibliografia: sotheby’s, European Newsletter, June 1988: sale on the 21th June, 1988. giUliano, Due nuove rappresentazioni, 187; lasCHke, Die Arme, 175.
ds 3 disegnatore fiorentino o senese. gesso nero e rosso su carta bianca, 335x220 mm. In basso a sin., penna e inch. nero: Sansovino. Firenze, galleria d. Uffizi, gab. disegni e stampe, inv. 1453F. primo o secondo decennio del XVI sec.
L., integrazione congetturale del braccio destro. Bibliografia: middeldorf, Unknown Drawings, 242 (Jac. sansovino); BrUmmer, The
Statue-Court, 103 s. (Jac. sansovino); Winner, Zum Nachleben, 112 (Jac. sansovino); de marCHi, sub sch. nr. 179, in Domenico Beccafumi, 511 (expertise di E. petrioli tofani: sodoma); BoUCHer, The Sculpture, I, 10 e II, 377, nr. 129 (Jac. sansovino); zamBrano, sch. nr. 19, in La tribuna del Duomo, 252 (sodoma); Winner, La colloca-zione, 127 (Fra’ Bartolomeo); Cordellier, sch. nr. 73, in D’après l’antique, 234-237 (Jac. sansovino).
ds 4 disegnatore fiorentino o senese. gesso rosso su carta bianca lavée di beige, 275x105 mm. In basso a sin., penna e inch. nero: 46. parigi, Louvre, dép. d. arts graphiques, inv. 2712. primo o secondo decennio del XVI sec.
Figlio minore, integrazione congetturale del braccio destro. Bibliografia: Berenson, I disegni, I, 520; II, nr. 2379a (dom. puligo, vicino a Fra’
Bartolomeo); BrUmmer, The Statue-Court, 103 s. (Jac. sansovino); Winner, Zum Nachleben, 112 (Jac. sansovino); BoUCHer, The Sculpture, I, 9 e II, 377, nr. 130 (Jac. sansovino); Winner, La collocazione, 127 s. (Fra’ Bartolomeo); Cordellier, sch. nr. 72, in D’après l’antique, 234-237 (Jac. sansovino).
ds 5 Raffaello sanzio. penna e inchiostro bruno su carta giallastra, 265x182 mm. Windsor Castle, inv. 12760. 1511.
testa di L. (studio per la testa di Omero del Parnaso). Bibliografia: popHam, Wilde, The Italian Drawings, nr. 796.
ds 6 Jacopo Carrucci d. il pontormo. sanguigna su carta bianca, 175x127 mm. Firenze, galleria d. Uffizi, gab. disegni e stampe, inv. 6581F. 1515-1517.
testa di L.? Bibliografia: Clapp, Les dessins, 166, nr. 6581; Pontorno. Disegni, sch. s.n.p., ad tav. 11.
ds 7 giovanni antonio da Brescia. stampa al bulino, 279x249 mm. Iscrizioni: Laocoon | Io An Bx̃. 1515-1520(?).
gruppo del L. in controparte, privo di restauri. stato precedente l’installazione sulla base moderna.
Bibliografia: B. XIII, 326, nr. 15; The ill. B. 25, 352, nr. 029; Hind V, 43; magi, Il ripristino, 13, nota 55; 17; BrUmmer, The Statue Court, 82 s.; Winner, Zum Nachleben, 102; daltrop, Die Laokoongruppe, 15; krUft, Metamorphosen, 4; kosHikaWa, sch. nr. 48, in High Renaissance (Engl. text suppl.), 65 s.; DA, XII, s.v. Giovanni Antonio da Brescia, 698; nesselratH, sch. nr. 235, in Hoch Renaissance, 515.
ds 8 Marco dente. stampa al bulino, 472x324 mm. (es. gNs, FC 30567). Iscrizioni: Laochoon | M[a]rcvs Ravênas | Romae in palatio pont. in | loco qvi vvlgo dicitvr | Belvi-dere. 1515-1523.
gruppo del L. privo di restauri, installato sulla base moderna. sullo sfondo muro in rovi-na. Frequentemente copiata: Bos (ds 41); Beatrizet (ds 43, 44); Inc. italiano (ds 109). V. anche ds 20, 30.
Bibliografia: B. XIV, 268, nr. 353; tHode, Die Antiken, 13 ss., nr. 35; vergara Caffarelli, Studio, 66; prandi, La fortuna, 78; aCkerman, The Cortile, 46 s.; van essen, La découverte, 303; Dialogé, sch. nr. 35; BieBer, Laocoon, 15 s.; steadman sHeard, sch. nr. 60, in Antiquity in the Renaissance; spike, sch. nr. 34, in Rome and Venice, 53 s.; krUft, Metamorphosen, 4; Borea, Dente, Marco, 790; kosHikaWa, sch. nr. 49, in High Renaissance (Engl. text suppl.), 66; sframeli, sch. nr. 37, in L’officina della maniera, 146; gnamm, sch. nr. 176, in Roma e lo stile classico, 368.
ds 9 andrea del sarto. Matita rossa su carta, 283x217 mm. Firenze, galleria d. Uffizi, gab. disegni e stampe, inv. 339F. 1520 ca.
gamba del figlio maggiore (tre viste). Bibliografia: sHearman, Andrea del Sarto, tav. 73b; Gabinetto disegni e stampe, nr.
169F.
ds 10 andrea del sarto. Matita nera e tracce di matita rossa su carta bianca, 243x172 mm. oxford, ashmolean Museum. 1520 ca.
testa di L. liberamente rielaborata. Bibliografia: parker, Catalogue, nr. 694; forlani tempesti, sch. nr. 41, in Il primato,
65.
ds 11 Frescante romano. affresco policromo. Vaticano, appartamento delle guardie Nobili, in situ. Inizio XVI secolo.
Il gruppo del L. in ambientazione paesaggistica. Bibliografia: BrUmmer, The Statue-Court, 86, fig. 71.
ds 12 Baccio Bandinelli. Cartone per l’esecuzione della copia in marmo (Co 1), tecnica e misure ignote. Menzionato in una lettera di Leonardo sellaio, in Roma, a Michelangelo, in Firenze, 11 feb. 1520. perduto. 1520 ca.
gruppo del L. a grandezza naturale. Bibliografia: Il carteggio, nr. Cdlvii, 216; agosti, sub sch. nrr. 17 e 18, in Michelan-
gelo e l’arte classica, 58-60; Cordellier, sub sch. nr. 74, in D’après l’antique, 237- 240.
ds 13 Baccio Bandinelli. penna e inchiostro bruno su carta, 417x265 mm. Firenze, galleria d. Uffizi, gab. disegni e stampe, inv. 14786 F/r. 1520-1525.
L., privo del braccio destro. Bibliografia: middeldorf, Unknown Drawings, 242; prandi, La fortuna, 86 s.; Ciardi
dUpre, Per la cronologia, 153 s.; agosti, sch. nr. 17, in Michelangelo e l’arte clas- sica, 58-60; Heikamp, Die Laokoongruppe, 349, 365; sframeli, sub sch. nr. 38, in L’Officina della maniera, 148; Cordellier, sch. nr. 74, in D’après l’antique, 237-240.
ds 14 Baccio Bandinelli. Matita rossa su carta bianca, 279x214 mm. Firenze, galleria d. Uffizi, gab. disegni e stampe, inv. 14785 F/r. 1520-1525.
testa e torso di L., privo del braccio destro. Bibliografia: Ciardi dUpre, Per la cronologia, 153 s.; BrUmmer, The Statue-Court, 71;
agosti, sch. nr. 17, in Michelangelo e l’arte classica, 58-60; kosHikaWa, sch. nr. 50, in High Renaissance (Engl. text suppl.), 67 s.; sframeli, sub sch. nr. 38, in L’officina, 148.
Il braccio mancante82
Le immagini del Laocoonte 83
ds 15 Baccio Bandinelli. penna e inchiostro bruno su carta bianca. paris, Fondation Custodia, Coll. F. Lugt, inv. I, 955. 1520-1525.
Figlio maggiore, posa del braccio destro modificata. Bibliografia: Cordellier, sub sch. nr. 74, in D’aprés l’antique, 239.
ds 16 disegnatore italiano (Biagio pupini?). penna, inchiostro bruno e guazzo su carta, 299x279 mm (smarginato). Firenze, galleria d. Uffizi, gab. disegni e stampe, inv. 14734F/v. ante 1538.
torso di L., privo di restauri. Bibliografia: nesselratH, Montorsolis Vorzeichnung, 172.
ds 17 Francesco Mazzola d. il parmigianino. gesso rosso su carta bianca, 120x110 mm. In basso a ds., penna e inch. nero: Parmigianino. Chatsworth, the Chatsworth settlement, Coll. of the duke of devonshire, inv. 347b. 1524-1527.
testa di L. Bibliografia: popHam, Catalogue, I, 205, nr. 694; Cordellier, sub sch. nr. 75, in
D’après l’antique, 241.
ds 18 Francesco Mazzola d. il parmigianino. gesso rosso su carta bianca, 114x73 mm. paris, Louvre, Cab. d. dessins, inv. 6424. 1524-1527.
testa del figlio maggiore? Bibliografia: popHam, Catalogue, I, 144, nr. 404.
ds 19 Francesco Mazzola d. il parmigianino. gesso nero e guazzo bruno con rialzi di bianco su carta bianca, 120x142 mm. Firenze, galleria d. Uffizi, gab. disegni e stampe, inv. 743E. 1524-1527.
testa del figlio maggiore, doppio studio. Bibliografia: popHam, Catalogue, I, 65, nr. 71.
ds 20 disegnatore italiano? Matita su carta, misure non precisate. amsterdam, Boymans Mus-eum. dopo il 1523.
gruppo del L., con integrazione di fantasia delle braccia dei figli. Copia da Marco dente (ds 8).
Bibliografia: inedito?
ds 21 artista toscano (Michelangelo Buonarroti?). Carboncino su intonaco. Firenze, s. Lorenzo, cripta sotto la sacrestia Nuova, in situ. Verso il 1530?
testa di L. Bibliografia: magi, Michelangelo; dal poggetto, I disegni murali, 88; andreae,
Michelangelo; Collareta, Intorno ai disegni murali, 172 s.; nesselratH, sch. nr. 30, in Le génie du sculpteur, 144 s.
ds 22 Michelangelo Buonarroti. disegno, tecnica e misure ignote. già proprietà di Fulvio orsini. disperso.
gruppo del L.? Bibliografia: de noHlaC, Une galerie, nr. 72, 434.
ds 23 antonio da sangallo il Vecchio. penna su carta bianca, 340x271 mm. Wien, graphische sammlung albertina, inv. 48/v. 1531 ca.
progetto di nicchia per la sistemazione della copia di Bandinelli (Co 1) nel cortile di palazzo Medici a Firenze.
Bibliografia: BrUmmer, The Statue-Court, 114; Birke, kertész, Die italienische Zeichnungen, 27 s., inv. 48; kosHikaWa, sch. nr. 50, in High Renaissance (Engl. text suppl.), 66 s.; satzinger, Der “Statuenhof” Clemens’ VII.
ds 24 disegnatore fiorentino d’ambito michelangiolesco. Carboncino su carta bianca, 404x290 mm. Iscrizioni, penna e inchiostro bruno: questa serpe fala no(n) rotta | e questa fala cosi. Collezione privata francese. 1530 ca.
L. e figlio minore, con abbozzo del figlio maggiore, in ambientazione architettonica (recto).
Bibliografia: lasCHke, Fra Giovan Angelo, 143, n. 16; nesselratH, Montorsolis Vorzeichnung (Montorsoli).
ds 25 disegnatore fiorentino d’ambito michelangiolesco. Carboncino su carta bianca, 404x290 mm. Iscrizione, penna e inchiostro bruno: questo e panno. Collezione privata francese. 1530 ca.
Figlio minore, con abbozzo di L., in ambientazione architettonica (verso). Bibliografia: nesselratH, Montorsolis Vorzeichnung (Montorsoli).
ds 26 amico aspertini. penna e inchiostro bruno su carta, 225x170 mm. London, British Museum, album London I, c. 16v-17.
gruppo del L. fra altre sculture antiche. Braccio di L. di fantasia. Bibliografia: BoBer, Drawings, ad folio 16 verso-17, 61 s.; BrUmmer, The Statue-
Court, 108; Heikamp, Die Laokoongruppe, 370; faietti, kelesCian sCagliarini, Amico Aspertini, 70.
ds 27 amico aspertini? penna, matita nera, acquerello marrone chiaro, lumeggiature bianche su carta preparata marrone chiaro, 321x490 mm. già mercato antiquario. Ubicazione attuale ignota. 1531-1534.
gruppo del L.? Bibliografia: faietti, kelesCian sCagliarini, Amico Aspertini, 321, nr. 39R.
ds 28 Jean de gourmont. stampa al bulino. Iscrizioni: monogramma JG. 1506-1551. gruppo del L. di fantasia fra le rovine davanti a un portico, sullo sfondo il Colosseo. Bibliografia: roBert dUmesnil VI, 26, nr. 20; BieBer, Laocoon, 16; Cordellier, sub
sch. nr. 76, in D’après l’antique, 242.
ds 29 disegnatore italiano. gesso rosso su carta, 181x94 mm. Coll. privata. 1515-1550. L., senza braccia. Bibliografia: steadman sHeard, sch. nr. 62, in Antiquity in the Renaissance.
ds 30 disegnatore italiano. penna, inchiostro bruno e guazzo su carta avana, 475x325 mm. Budapest, Museo di Belle arti, inv. 58.983. prima metà XVI sec.
gruppo del L. in nicchia, privo di restauri. Copia da Marco dente (ds 8) in nicchia simile a Beatrizet (ds 43).
Bibliografia: giUliano, Due nuove rappresentazioni, 187 (vicino a Baccio Bandinelli, verso il 1525).
ds 31 Marten van Heemskerck (attr.). penna e lavis bistro su carta bianca, 233x354 mm. London, British Museum, dep. of prints and drawings, inv. 1946-7-13-6391. 1532-1535.
Veduta del cortile del Belvedere. Bibliografia: Winner, in «Max-planck-gesJhb» 1987; liverani, nesselratH, sch. nr.
36, in High Renaissance (Engl. text suppl.), 57 s.; Winner, La collocazione, 118 s.
ds 32 Marten van Heemskerck (attr.). penna su carta. Berlin, staatliches Museum d. preuß. Kulturbesitz, Kupferstichkab., 79 d2, c. 23v. 1532-1535.
torso di L. da destra, braccio mancante; piede sinistro di L.; part. dell’anca di L., da sinistra.
Bibliografia: Hülsen, egger, Die römische Skizzenbücher, 13.
ds 33 Marten van Heemskerck (attr.). penna su carta. Berlin, staatliches Museum d. preuß. Kulturbesitz, Kupferstichkab., 79 d2, c. 39. 1532-1535.
testa di L. e retro del piede destro. Bibliografia: miCHaelis, Römische Skizzenbücher, 145; Hülsen, egger, Die römische
Skizzenbücher, 21.
ds 34 Marten van Heemskerck (attr.). penna su carta. Berlin, staatliches Museum d. preuß. Kulturbesitz, Kupferstichkab., 79 d2, c. 39v. 1532-1535.
testa di L. Bibliografia: miCHaelis, Römische Skizzenbücher, 145; Hülsen, egger, Die römische
Skizzenbücher, 21; D’après l’antique, 230, fig. 5.
Il braccio mancante84
Le immagini del Laocoonte 85
ds 35 Marten van Heemskerck (attr.). penna su carta. Berlin, staatliches Museum d. preuß. Kulturbesitz, Kupferstichkab., 79 d2, c. 67v. 1532-1535.
part. della gamba e del braccio sinistro di L. (copie da altro artista). Bibliografia: miCHaelis, Römische Skizzenbücher, 152; Hülsen, egger, Die römische
Skizzenbücher, 35.
ds 36 Marten van Heemskerck (attr.). penna su carta. Berlin, staatliches Museum d. preuß. Kulturbesitz, Kupferstichkab., 79 d2, c. 74. 1532-1535.
torso di L., veduta posteriore; braccio destro mancante. Bibliografia: Hülsen, egger, Die römische Skizzenbücher, 41.
ds 37 Marten van Heemskerck (attr.). penna su carta. Berlin, staatliches Museum d. preuß. Kulturbesitz, Kupferstichkab., 79 d2, c. 74v. 1532-1535.
Coscia sinistra di L. (copia da altro artista). Bibliografia: miCHaelis, Römische Skizzenbücher, 153; Hülsen, egger, Die römische
Skizzenbücher, 41.
ds 38 Francisco de Hollanda. Matita su carta, 390x270 mm ca. Madrid, Museo dell’Escorial, ms. 28 I 20, c. 9v. 1538-1540.
gruppo del L. in nicchia dipinta. Bibliografia: tormo, Os Desenhos, c. 9v; BrUmmer, The Statue-Court, 78; desWarte-
rosa, Francisco de Hollanda, 400-402.
ds 39 Intagliatore italiano. silografia. Iscrizione: Laocoonte. In Stanze d’Eurialo d’Ascoli sopra le statue di Laocoonte &c., Roma, Valerio dorico & Luigi fratelli bresciani, 1539, frontespizio.
gruppo del L. restaurato, parzialmente di fantasia. Bibliografia: desWarte-rosa, Francisco de Hollanda, 394-398; maffei, fama, 138-
140.
ds 40 Incisore italiano. stampa al bulino. In Urbis Romae Topographia B. Marlianis &c., Impressum Romae, per antonium Blodum, in aedibus dom. Ioan. Bap. de Maximis, 1544, 80.
gruppo del L. restaurato in nicchia. Bibliografia: BrUmmer, The Statue-Court, 94, fig. 80; krUft, Metamorphosen, 6, fig.
11.
ds 41 Cornelis Bos. stampa al bulino. Iscrizioni: Cornelius Bos faciebat 1548. 1548. gruppo del L. Copia da Marco dente (ds 8), in controparte. Bibliografia: nagler I, 970, nr. 2316; Hollstein III, 124, nr. 60 (indica erroneamen-
te copia da N. Beatrizet); förster, Noch zwei Laokoondenmäler, 47, nr. 9; sittl, Empirische Studien, 15.
ds 42 e. delaune (su disegno di Jean delaune). stampa al bulino, 43x100 mm. 1580 ca. Quattro personaggi sullo sfondo di monumenti romani, fra cui il L. Bibliografia: roBert dUmesnil IX, 70, nr. 214; Fond Français I, 262, nr. 225.
ds 43 Nicolas Beatrizet. stampa al bulino, 450x300 mm. Iscrizioni: Lachoon | Ant. Lafreri. | Romae in palatio pont. qui vulgo dicitur Belvedere. In Speculum Romanae Magnificen-tiae, ed. antoine Lafrery. 1540-1565.
gruppo del L. restaurato, in nicchia. Copia da Marco dente (ds 8) con aggiunta delle braccia dei figli.
Bibliografia: B. XV, 264, nr. 91; The ill. B. 29, 352, nr. 91; förster, Noch zwei Laokoondenmäler, 47, n. 9; The University of Chicago Library [...] A descriptive cata-logue, a 107; Nicolas Beatrizet, sch. nr. 45.
ds 44 Nicolas Beatrizet. stampa al bulino, 480x320 mm. 1° stato. Iscrizioni: Lachoon | Ant. Lafreri | Romae in palatio pont. qui vulgo dicitur
Belvedere. Incluso in Speculum Romanae Magnificentiae, ed. antoine Lafrery. 1540-1565.
2° stato. Iscrizioni: Lachoon | Romae Claudij Duchetti Formis | Romae in palatio pont. qui vulgo dicitur Belvedere. In Speculum Romanae Magnificentiae, ed. Claude duchet. 1581-1586.
gruppo del L. Copia da Marco dente (ds 8), priva del muro di fondo, con aggiunta del braccio montorsoliano liberamente riprodotto e delle altre braccia moderne.
Bibliografia: B. XV, 264, nr. 90; The ill. B. 29, 351, nr. 90; förster, Noch zwei Laokoondenmäler, 47, n. 9 (riconosce la dipendenza da M. dente); Hülsen, Das Speculum, 168; The University of Chicago Library [...] A descriptive catalogue, a 121; Nicolas Beatrizet, sch. nr. 45.
ds 45 disegnatore dell’Italia settentrionale o fiammingo. gesso rosso su carta preparata, 460x300 mm. Iscrizioni: Lacon. Cambridge, Eton College, album R 17, 3, c. 2. 1550-1553.
gruppo del L. restaurato, braccio del padre tipo Montorsoli. Bibliografia: dHanens, De Romainse, 179, nr. 2 (giambologna, 1550-1553); krUft,
Metamorphosen, 6; fileri, Giovanni Bologna, 10 s., nr. 2 (giambologna, 1550-1553); lasCHke, Die Arme, 178 s.; gerlaCH, Eine Hand (1550-1562 ca).
ds 46 giovanni ambrogio Figino. Matita nera e inchiostro bruno su carta bianca, 290x204 mm. Venezia, gallerie dell’accademia, inv. 1077. 1580 ca.
torso di L. di tre quarti da destra (come ds 47). Bibliografia: Ciardi, Giovan Ambrogio Figino, 157, nr. 116; perissa torrini, Gallerie
dell’Accademia, 94, nr. 68.
ds 47 giovanni ambrogio Figino. Matita nera su carta nocciola, 435x298 mm. Venezia, galle-rie dell’accademia, inv. 984. 1580 ca.
torso di L. di tre quarti da destra (come ds 46). Bibliografia: Ciardi, Giovan Ambrogio Figino, 157, nr. 117; perissa torrini, Gallerie
dell’Accademia, 93, nr. 67; perissa torrini, sch. nr. 29, in Le génie du sculpteur, 142 s.
ds 48 giovanni ambrogio Figino. Matita nera su carta azzurra, 412x245 mm. Windsor, Royal Library, inv. 6921. 1580 ca.
L. di profilo dal basso. Bibliografia: popHam, Wilde, The Italian Drawings, nr. 51; Ciardi, Giovan Ambrogio
Figino, 157, nr. 118.
ds 49 giovanni ambrogio Figino. Matita nera su carta azzurra, 253x420 mm. Windsor, Royal Library, inv. 6920. 1580 ca.
L. di tre quarti. Bibliografia: popHam, Wilde, The Italian Drawings, nr. 52; Ciardi, Giovan Ambrogio
Figino, 157, nr. 119; Collareta, sch. nr. 27, in Le génie du sculpteur, 138 s.
ds 50 giovanni ambrogio Figino. Matita rossa su carta azzurra, 235x188 mm. Venezia, gallerie dell’accademia, inv. 1053. 1580 ca.
testa di L. (abbozzo). Bibliografia: Ciardi, Giovan Ambrogio Figino, 157, nr. 120; perissa torrini, Gallerie
dell’Accademia, 91, nr. 66.
ds 51 giovanni ambrogio Figino. Matita nera su carta bianca, 130x88 mm. Venezia, gallerie dell’accademia, inv. 340. 1580 ca.
testa e busto di L., di profilo da sinistra. Bibliografia: Ciardi, Giovan Ambrogio Figino, 157, nr. 121; perissa torrini, Gallerie
dell’Accademia, 90, nr. 64.
ds 52 giovanni ambrogio Figino. Matita nera su carta azzurra con lumeggiature di biacca, 214x275 mm. Windsor, Royal Library, inv. 6919. 1580 ca.
Corpo di L. (visibile la frattura fra la spalla e il braccio). Bibliografia: popHam, Wilde, The Italian Drawings, 326, nr. 53; Ciardi, Giovan Ambro-
gio Figino, 158, nr. 122.
Il braccio mancante86
Le immagini del Laocoonte 87
ds 53 giovanni ambrogio Figino. Matita nera e sanguigna su carta bianca, 347x245 mm. Venezia, gallerie dell’accademia, inv. 999. 1580 ca.
testa e busto di L. di tre quarti anteriore da sinistra. Bibliografia: Ciardi, Giovan Ambrogio Figino, 158, nr. 123; perissa torrini, Gallerie
dell’Accademia, 90, nr. 63; perissa torrini, sch. nr. 28, in Le génie du sculpteur, 140 s.; Cordellier, sch. nr. 77, in D’aprés l’antique, 243 s.
ds 54 pierre perret (attr.). sanguigna su carta bianco-grigia, 413x285 mm. dresden, staatsgal., Kupferstichkab., inv. C1968/ 627. 1581 ca.
gruppo del L. probabile disegno preparatorio per ds 55. Bibliografia: Dialogé, sch. nr. 4; van der meUlen, Ancient copies, II, 95 s., n. 13.
ds 55 pierre perret. stampa al bulino. 1° stato. 413x320 mm (es. gNs neg. 44359, smarginato). Iscrizioni: Pierre Perret f.
1581 | Staetius Formis RomaE. 1581. 2° stato. Iscrizioni: Pierre Perret f. 1581. In Speculum Romanae Magnificentiae, ed. C.
duchet? prima del 1585. 3° stato. 450x345 mm (es. gNs neg. 44360, smarginato). Iscrizioni: Pierre Perret f.
1581 | Giovanni Orlandis parp.io (†) formis Roma. Inizio XVII secolo. 4° stato. 450x345 mm (es. gNs neg. 44360, smarginato). Iscrizioni: Pierre Perret f.
1581 | Henricus van Schoel excudit. Inizio XVII secolo. gruppo del L., testa del serpente e tre dita della mano del figlio maggiore mancanti.
Nel 3° stato accentuata l’ombreggiatura a tratteggio obliquo sul lato corto della base; tratteggio orizzontale nel cielo in alto a sinistra. Copie e derivazioni: ds 56 (Vaccaria); 58 (van aelst et al.).
Bibliografia: Hollstein XVII, 50, nr. 36; Benezit VIII, 233; BrUmmer, The Statue-Court, 83; QUeyrel, Une nouvelle image, 308; mC donald, Pedro Perret, 43.
ds 56 Incisore italiano. stampa al bulino. Iscrizioni: Laocoontis signúm e marmore mira arte factum in pontificio viridario Romae | Non quale a Virgilio ac Plinio sed Cuiusmodi a graecis poetis describitur | 48. In Antiquarum Statuarum Urbis Romae, Quae in publicis privatisque locis visuntur, Icones, Romae, Ex typis Laurentij Vaccarij ad signum palmae Victricis, 1584, tav. 48.
gruppo del L. Copia da pierre perret (ds 55), in controparte. Ristampe: Antiquarum Statuarum Urbis Romae, Quae in publicis privatisque locis visuntur, Icones, Romae, Ex typis gottifredi de schaichis ad signum aquilae nigrae, 1621, tav. [11]. Copie: ds 58 (van aelst et al.).
Bibliografia: Dialogé, sub sch. nr. 4; asHBy, Antiquae statuae, 125 s.; Weeke, Ein römisches Antikenstichwerk, 147, nr. 48.
ds 57 giovanni Battista Cavalieri. stampa al bulino. Iscrizioni: Laocoontis signum e marmore mira arte factum &c. in Pontificio viridario, Romae non quale Virgilio, ac Plinio, sed cuiusmodi e Graecis Poetis describitur. Bulino. In Antiquarum Statuarum Urbis Romae liber primus et secundus liber &c., Romae, Io Baptista de Cavalleriis authore, 1585, tav. [1].
gruppo del L. restaurato, braccio tipo Montorsoli, riproduzione libera. Ristampe: 1) Anti- quarum Statuarum Urbis Romae, Liber tertius, Romae, Jachomo Marchucci, 1623, tav. 16; 2) Insigniores Statuarum Urbis Romae Icones, Liber secundus statuarum Romae, Romae, apud Joannes dominicus de Rubeis ad pacem formis, 1645, tav. [73]; 3) Insigniores Statuarum Urbis Romae Icones, Liber secundus statuarum Romae, Romae, apud Joannes Iacobus de Rubeis ad pacem formis, [ante 1594], tav. 78 (numerazione aggiunta: 78).
Bibliografia: asHBy, Antiquae Statuae, 131 ss.; gerlaCH, Eine Hand, 184.
ds 58 Incisore italiano. stampa all’acquaforte con ritocchi al bulino. Iscrizioni: Laocoontis signúm e marmore mira arte factum in Pontificio Viridario Romae non quale a | Virgilio ac Plinio sed cuiusmodi á graecis poetis describitur. In Insigniores Statuarum Urbis Romae Icones &c., Romae, Nicolaus van aelst Bruxellensis, [1608-1613], tav. 31. Ristampe: 1) Insigniores Statuarum Urbis Romae Icones &c., Romae, Ioseph de Rubaeis Mediols. Formis, 1619, tav. 31; 2) Insigniores Statuarum Urbis Romae Icones [...] Liber secundus statuarum Romae, Romae, apud Joannes Iacobus de Rubeis ad pacem formis,
[ante 1594], tav. 78; 3) Insigniores Statuarum Urbis Romae Icones [...]-Liber secundus statuarum Romae, Romae, apud Joannes dominicus de Rubeis ad pacem formis, 1645, tav. [73]; 4) Antiquarum Statuarum Urbis Romae primus et secundus liber & c., Romae, gio. Bat. Rossi in piazza Navona, 1668, tav. s. nr. (con ritocchi).
gruppo del L. restaurato, braccio tipo Montorsoli. Copia da ds 56 (Vaccaria), rovesciata. Bibliografia: asHBy, Antiquae Statuae, 138 s.
ds 59 Incisore italiano. stampa all’acquaforte, 331x468 mm. (es. gNs, CL 2333 12848). Iscrizioni: Laocontis statua e(st) reperta: qua(m) in eade(m) | domo collocata(m) esse asserit Plin. his ver|bis: Laocoon in Titi imp. Domo opus o(mn)ibus, | et picturae, et statuariae artis praeferéndu(m): | ex uno lapide cu(m) et liberos draconum | mirabi-les nexus de consilij sententia | fecere sum(m)i artifices Agesander et | Polidorus et Antenodorus Rodij: et | quamqua(m) hi ex Virgilij descriptione lib. 2° statua(m) hanc formavisse vide(n)tur. Haec | statua in Vaticano nunc est collocata.-In Antiquae Urbis Splendor Hoc est eivsdem Templa, Amphitheatra, Theatra, circi Navmachiae Arcvs Trivmphales &c. item Trivmphalis et colossearum imaginvm [...] Descriptio Opera & industria Jacobi Lauri romani in aes incisa &c., Romae, s.n., 1612, 23.
gruppo del L. restaurato, braccio tipo Montorsoli. Copia ridotta da ds 56 (Vaccaria) o da una delle ristampe iscritta in cornice ionica con decoro vegetale agli angoli.
Bibliografia: –
ds 60 anton Eisenhoit. stampa all’acquaforte, 201x129 mm. Iscrizioni: Laocoon.-In Appendix ad Metallothecam vaticanam Michaelis Mercati &c., Romae, apud Jo. Mariam salvioni typographum Vaticanum, 1719. 1584 ca.
gruppo del L. restaurato. Bibliografia: raspe, Eisenhoit, 85 s.
ds 61 girolamo Franzini. silografia, 55x65 mm. Iscrizione: Laochoonte. In Icones Antiquarum Statuarum Urbis Romae, Romae, 1589, tav. a 2. prima del 1588.
gruppo del L. parzialmente di fantasia, rovesciato. Ristampe: ad. es. 1) L’antichità di Roma di andrea Fulvio antiquario Romano, di nuovo con ogni diligenza corretta e ampliata &c., Venetia, per gir. Francini libraro in Roma, 1588, 89; 2) Trattato nuovo delle cose maravigliose dell’alma Città di Roma [...] composto da F. pietro Martire Felini da Cremona &c., In Roma, per Bartolomeo Zanetti, 1610, 329; 3) Roma sacra e moderna già descritta dal panciroli [...] di nuovo con somma diligentia e studio riordinata da gio. Francesco Cecconi &c., Roma, Nella stamperia del Mainardi, 1725, 358.
Bibliografia: asHBy, Note; sCHUdt, Le guide, 30, nrr. 174, 224; krUft, Metamorphosen, 9.
ds 62 Hendrik goltzius. Matita nera su carta blu con rialzi di bianco, 390x350 mm. Haarlem, tylers stichting Museum, inv. K III, 33. 1591.
gruppo del L. Bibliografia: rezniCek, Die Zeichnungen, nr. K 209; BrUmmer, The Statue-Court, 91
s.; sCalliérez, sch. nr. 78, in D’aprés l’antique, 244 s.
ds 63 Incisore italiano? stampa al bulino, 236x213 mm. Iscrizioni: Laocoon Filivs Priami Ex Hecvba | Romae In Palatio Pont In Loco |-Qvi Vvlgo Dicitvr Belvidere. seconda metà XVI secolo.
testa di L. in tondo contorniato. Bibliografia: straUss, Hendrik Goltzius, nr. 118
ds 64 Jacques grandhomme. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: Jac. Granthô secapesit. In II pars Antiquitatum Romanarum seu Topographia Romanae Urbis &c., Francfordii, artifice theodoro de Bry Leod., 1597, c. M4.
gruppo del l. Copia da Marco dente (ds 8). Bibliografia: Fond Français, 453, nr. 29; förster, Noch zwei Laokoondenmäler, 47, n.
9; krUft, Metamorphosen, 4; QUeyrel, Une nouvelle image, 305, nota 14.
ds 65 peter paul Rubens. Matita nera su carta, 475x354 mm. Milano, Biblioteca ambrosiana, inv. F 249 inf., c. 4. 1601 ca.
gruppo del L. restaurato, vista dal lato del figlio maggiore (su foglio a parte incollato).
Il braccio mancante88
Le immagini del Laocoonte 89
Braccio di Montorsoli; testa del serpente mancante; dita delle mani dei figli rotte o man-canti.
Bibliografia: fUBini, Held, Padre Resta’s, 125, 131; Jaffè, Rubens and Italy, 81; van der meUlen, Copies, II, 98, nr. 76; foUCart, sch. nr. 79, in D’aprés l’antique, 245-247.
ds 66 peter paul Rubens. gesso nero su carta, 440x283 mm. Milano, Biblioteca ambrosiana, inv. F. 249 inf., c. 5. 1602-1603 o 1605-1608.
L., vista posteriore dal basso e da destra. Bibliografia: fUBini, Held, Padre Resta’s, 125, 131; van der meUlen, Copies, II, nr. 81;
foUCart, sub sch. nr. 79, in D’aprés l’antique, 245-247.
ds 67 peter paul Rubens. gesso nero su carta, 411x260 mm. Milano, Biblioteca ambrosiana, F. 249 inf., c. 6. 1602-1603 o 1605-1608.
Figlio minore, vista frontale. Bibliografia: fUBini, Held, Padre Resta’s, 125, 133; van der meUlen, Copies, II, 103,
nr. 92; foUCart, sub sch. nr. 79, in D’aprés l’antique, 245-247.
ds 68 peter paul Rubens. gesso nero su carta, 475x107 mm. Milano, Biblioteca ambrosiana, inv. F. 249 inf., c. 7. 1602-1603 o 1605-1608.
Figlio maggiore. Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 103, nr. 91 (v. nr. 76); foUCart, sub sch. nr.
79, in D’aprés l’antique, 245-247.
ds 69 peter paul Rubens. gesso nero su carta, 456x296 mm. dresden, staatliche Kunstsamm-lung, Kupferstichkab., inv. C 1874-22a. 1606 ca.
torso di L., vista dal basso, lato destro. Bibliografia: miesel, Rubens’ Study, 316; fUBini, Held, Padre Resta’s, 131; Jaffè,
Rubens and Italy, 81, nr. 30; Dialogé, sch. nr. 60; van der meUlen, Copies, II, 96 s., nr. 77; foUCart, sub sch. nr. 79, in D’aprés l’antique, 245-247.
ds 70 peter paul Rubens. tecnica e misure ignote. Ubicazione ignota. torso di L., vista dal basso, lato destro. peter paul Rubens. Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 97, nr. 78.
ds 71 peter paul Rubens. tecnica e misure ignote. Ubicazione ignota. torso di L., vista di tre quarti. Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 97, nr. 79.
ds 72 peter paul Rubens. tecnica e misure ignote. Ubicazione ignota. torso di L., vista frontale. Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 97 s., nr. 80.
ds 73 peter paul Rubens. tecnica e misure ignote. Ubicazione ignota. Braccio sinistro di L., vista posteriore. Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 98 s., nr. 82.
ds 74 peter paul Rubens. tecnica e misure ignote. Ubicazione ignota. torso di L., vista posteriore da sinistra (lato del figlio maggiore). Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 99, nr. 83.
ds 75 peter paul Rubens. tecnica e misure ignote. Ubicazione ignota. due studi della testa di L. Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 100, nr. 84.
ds 76 peter paul Rubens. tecnica e misure ignote. Ubicazione ignota. Coscia sinistra di L., vista di tre quarti. Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 100, nr. 85.
ds 77 peter paul Rubens. tecnica e misure ignote. Ubicazione ignota. Coscia sinistra di L., vista di tre quarti. Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 100 s., nr. 86.
ds 78 peter paul Rubens. tecnica e misure ignote. Ubicazione ignota. gamba destra di L., vista frontale. Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 101, nr. 87.
ds 79 peter paul Rubens. tecnica e misure ignote. Ubicazione ignota. gamba destra di L., vista frontale. Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 101, nr. 88.
ds 80 peter paul Rubens. tecnica e misure ignote. Ubicazione ignota. gamba sinistra di L., vista posteriore. Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 102, nr. 89.
ds 81 peter paul Rubens. tecnica e misure ignote. Ubicazione ignota. piede sinistro di L. e piede sinistro del figlio maggiore. Bibliografia: van der meUlen, Copies, II, 101 s., nr. 90.
ds 82 sisto Badalocchio. stampa all’acquaforte, 375x300 mm. Iscrizioni: Sisto Ba. F. | Andreas Vaccarius formis Romae | 1606.
gruppo del L., in controparte. Bibliografia: BieBer, Laokoon, 17; reBaUdo, Per la fama di Laocoonte, 63 s.
ds 83 Joachim von sandrart. sanguigna su carta con rialzi di bianco. dresden, staatliche Kunst-sammlung, Kupferstichkab. 1629-1635.
L. restaurato, vista frontale. Bibliografia: klemm, sub sch. nr. 82, in D’aprés l’antique, 249.
ds 84 Jacques de gheyn III. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: I. D. de Gheyn Fe. H. Hondius exc. 1631.
gruppo del L., calco bronzeo di Francesco primaticcio e Vignola a Fontainbleau. Bibliografia: Hollstein VII, 195, 18; van regteren altena, Jacques de Gheyn, II, iii,
nr. 88; III, 246, nr. 18 (ripr.).
ds 85 Francesco Curradi. sanguigna su carta, 158x121 mm. Roma, gabinetto Nazionale delle stampe, inv. F.C. 126155, vol. 157 g. II. dopo il 1631?
testa del figlio maggiore. Bibliografia: di Castro, fox, Disegni dall’antico, 119-121, nr. 57.
ds 86 François perrier. stampa all’acquaforte, 238x166 mm. Iscrizioni: F. Perrier f. In Ill.mo D.D. Rogerio Du Plessis [...] Segmenta nobilium signorum et statuarum quae temporis dentem invidum evasere Urbis aeternae ruinis erepta tipys aeneis ab se commissa [...] Franciscus perrier d.d.d., s.l., s.n., 1638, tav. 1.
gruppo del L. restaurato, vista frontale. Copie e derivazioni: trippel (ds 87); Incisore francese, in montfaUCon (ds 106); Incisore francese, in deseine (ds 88).
Bibliografia: fUBini, Held, Padre Resta’s, 125, 131; BieBer, Laocoon, 17; Jaffè, Rubens and Italy, 81; van der meUlen, Copies, II, 97, nr. 76; 101, nr. 91.
ds 87 a. trippel. disegno. sanguigna su carta, misure non precisate. schaffausen, Museum zu allerheiligen, inv. B 2354. XVII secolo.
gruppo del L., copia da François perrier (ds 86). Bibliografia: –
ds 88 Incisore francese. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: Laocoön et ses Enfans. In Rome moderne, première Ville de l’Europe avec toutes ses magnificences et ses delices [...] par le sr. François deseine, IV, Leide, pierre van der aa, 1713, 184.
gruppo del L., copia ridotta con inquadramento architettonico di fantasia da François perrier (ds 86), in controparte.
Bibliografia: sCHUdt, Le guide, 129 s., nr. 557.
Il braccio mancante90
Le immagini del Laocoonte 91
ds 89 Incisore italiano. stampa all’acquaforte con ritocchi al bulino. Iscrizioni: Laochoon. In Ritratto di Roma moderna &c., In Roma, per il Mascardi. ad istanza di pompilio totti, 1638, 20.
gruppo del L., vista frontale. Copia da girolamo Franzini (ds 61). Ristampe: 1) Ritratto di Roma moderna &c., In Roma appresso Francesco Moneta. ad istanza di Filippo de’ Rossi, 1645, 20; 2) Ritratto di Roma moderna &c., Roma, Nella Libreria di Michel’angelo Rossi, 1689, 28.
Bibliografia: sCHUdt, Le guide, nrr. 184, 186, 191.
ds 90 Incisore italiano. stampa all’acquaforte con ritocchi al bulino. In Descrizione di Roma moderna &c., Roma, Nella libreria di Michelangelo e pier Vincenzo Rossi, 1697, 28.
gruppo del L. Nuova tiratura della lastra di giovanni Battista de Rossi (ds 58) con ritoc-chi (reincisa la mano destra del figlio maggiore, visibili i tratti dell’incisione primitiva). Ristampe: 1) Descrizione di Roma moderna &c., Roma, Michel’angelo e pier Vincenzo Rossi all’insegna della salamandra, 1719; 3) Descrizione di Roma moderna &c., Roma, Fratelli de’ Rossi, 1727.
Bibliografia: sCHUdt, Le guide, nrr. 193, 199, 201.
ds 91 Jan de Bisschop su disegno di peter doncker (1653), stampa all’acquaforte. In Signo- rum Veterum Icones &c., I, amstelodami, Ex officina Nicvolai Visscher, s.d. [1668], tav. 16.
gruppo del L. restaurato, braccio del padre tipo Montorsoli. Bibliografia: BieBer, Laocoon, 17; van gelder, Jost, Jan de Bisschop, II, 102 ss.
ds 92 Jan de Bisschop su disegno di Willem doudijns (1662-1666). stampa all’acquaforte. In Signorum Veterum Icones &c., I, amstelodami, Ex officina Nicvolai Visscher, s.d. [1668], tav. 17.
gruppo del L. Bibliografia: BieBer, Laocoon, 17; van gelder, Jost, Jan de Bisschop, II, 102 ss.
ds 93 Incisore. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: Laocoon ab serpentibus cruciatus. In J. gronoviUs, Thesaurus Graecarum Antiquitatum [...], I, Venetiis, 1732, c. Rrrr.
gruppo del L. privo di restauri. Copia da Jacques grandhomme (ds 64) che copia Marco dente (ds 8).
Bibliografia: –
ds 94 gérard audran. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: misure. In Les proportions du corps humain mesurées sur les plus belles figures de l’Antiquité à Paris, paris, par gèrard audran Imprimeur ordinaire du Roy, 1683, tav. 1.
L. restaurato, vista anteriore, braccio tipo Montorsoli. Bibliografia: Besterman, Old Art Books, 6; BieBer, Laocoon, 17, nota 8; krUft,
Metamorphosen, 8; montagU, The Expression, 81; 207, nota 87; 224.
ds 95 gérard audran. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: misure. In Les proportions du corps humain &c., tav. 2.
L. restaurato, vista laterale destra, braccio tipo Montorsoli. Bibliografia: Besterman, Old Art Books, 6; montagU, The Expression, 81; 207, nota
87; 224.
ds 96 gerard audran. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: misure. In Les proportions du corps humain &c., tav. 3.
L. restaurato, vista laterale sinistra, braccio tipo Montorsoli. Bibliografia: Besterman, Old Art Books, 6.
ds 97 gérard audran. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: misure. In Les proportions du corps humain &c., tav. 4.
L. restaurato, vista posteriore, braccio tipo Montorsoli. Bibliografia: Besterman, Old Art Books, 6.
ds 98 gérard audran. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: misure. In Les proportions du corps humain &c., tav. 24.
Figlio maggiore, vista anteriore e laterale. Bibliografia: Besterman, Old Art Books, 6; krUft, Metamorphosen, 8.
ds 99 gérard audran. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: misure. In Les proportions du corps humain &c., tav. 25.
Figlio minore, vista anteriore; figlio maggiore, vista posteriore. Bibliografia: Besterman, Old Art Books, 6.
ds 100 Incisore italiano. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: da Vincenzo Billy alla Ghiesa Nov. XVII secolo.
gruppo del L. Bibliografia: –
ds 101 Incisore italiano. stampa all’acquaforte, 483x348 mm. (es. gNs, CL 1234 12990). Iscrizioni: Statva di Laocoonte in Belvedere in Vaticano | Prima vedvta di faccia consi-derata anatomicamente | Tavola XXVII | 43. prima del 1691.
L., vista frontale, privo dei serpenti. In controparte. Bibliografia: petrUCCi, Catalogo, 133.
ds 102 Incisore italiano. stampa all’acquaforte, 473x347 mm (foglio, es. gNs, CL 1234 12991). Iscrizioni: L’istesso Laocoonte seconda vedvta di profilo | Date in luce da Domenico Figliuolo et erede di Gio. Giacomo de Rossi in Roma alla Pace con priu. S. P. prima del 1691.
L., veduta laterale da sinistra, privo dei serpenti. In controparte. Bibliografia: petrUCCi, Catalogo, 133.
ds 103 Incisore italiano. stampa all’acquaforte, 482x349 mm (foglio, es. gNs, CL 1234 12992). Iscrizioni: L’istesso Laocoonte terza vedvta dalla schiena | Tavola XXIX. 45. prima del 1691.
L., da dietro, privo dei serpenti. In controparte. Bibliografia: petrUCCi, Catalogo, 133.
ds 104 Claude Randon. stampa al bulino, 528x354 mm. Iscrizioni: Il Laocoonte gia ammirato nel palazzo di Tito, e scolpito da Agesandro Polidoro, et | Atenodoro Rodij Plin: lib. 36. c. 5. | C. Randon Sculp. | Negl’orti Vaticani. Nella Stamp.a di Domenico de Rossi erede di Gio. Giacomo de Rossi in Roma alla Pace, con Priuil. del Som. Pont. In Raccolta di statue antiche e moderne date in luce [...]-da domenico de Rossi illustrata colle sposizioni a ciascheduna immagine di pavolo alessandro Maffei &c., In Roma, nella stamperia alla pace, 1704, tav. 1.
gruppo del L., braccia di restauro danneggiate. Bibliografia: petrUCCi, Catalogo, 213; krUft, Metamorphosen, 9.
ds 105 gian domenico Campiglia. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: Laocoon | Io Dom. Campiglia delin. et scul. In Michaelis Mercati Samminiatensis Metallotheca vatica-na-[...]-Opera autem, et studio Joannis Mariae Lancisii, Romae, Ex officina Jo. Mariae salvioni in archigymnasio sapientiae, 1717.
gruppo del L., con restauri di Cornacchini. Bibliografia: reBaUdo, I restauri, 246.
ds 106 anonimo francese. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: Laocoon | Marbre Romain. In J.-B. de montfaUCon, L’Antiquitée expliquée et représentée en figures &c., I, paris 1719, tav. lxxxvii.
Copia da ds 86 (perrier), con basamento modificato e riquadratura. Bibliografia: krUft, Metamorphosen, 9.
ds 107 Jean-Justin preisler su disegno di Edmé Bouchardon. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: tav. 32. In J.-J. preisler, Statuae antiquae ab Edmundo Bouchardon Gallo sculptore
Il braccio mancante92
Le immagini del Laocoonte 93
egregio Romae delineatae a se in aere incisae, Norimbergae, 1752, tav. 40. 1732. Figlio minore. Bibliografia: magi, Il ripristino, 26.
ds 108 Incisore italiano. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: Statua di Laocoonte nel Vaticano. In Roma antica e moderna ossia nuova descrizione della moderna città di Roma, e di tutti gli edifizj notabili, che sono in essa [...] Abbellita con duecento e più figure in rame &c., I, In Roma, Nella stamperia di giovanni Zampel. ad istanza di gregorio Roisecco, Mercante di libri in piazza Navona, 1745, 77.
Copia semplificata e ridotta da Eisenhoit (ds 60). Incisa sulla matrice con la Cleopatra del Belvedere. Ristampe: 1) Roma antica e moderna &c., In Roma, appresso gregorio Roisecco, 1750, I, 98.
Bibliografia: preiss, Die wissenschaftliche Beschäftigung, 39.
ds 109 Incisore italiano. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: Roma apud Carolum Losi 1774. gruppo del L., privo di restauri. Copia da Marco dente (ds 8). Bibliografia: –
ds 110 Bénigne gagneraux. Matita nera e sanguigna su quattro fogli di carta bianca incollati, 880x685 mm. dijon, Musée des Beax-arts, inv. E.s. 46. 1777-1780.
torso di L., senza braccia né testa. Bibliografia: lemoine, sch. nr. 88, in D’après l’antique, 253.
ds 111 Incisore italiano. stampa al bulino, 143x166 mm. Iscrizioni: Laocoontis statua vetus marmorea. In [d. magnan], La ville de Rome ou description abrégée de cette superbe ville, divisé en quatre volumes et ornée de 425 planches en taille douce, IV, a Rome, de l’Imprimerie d’archange Casaletti &c., 1778.
gruppo del L. Bibliografia: –
ds 112 Incisore italiano. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: Laocoontis statua vetus marmorea. In Calcografia di belle statue antiche Degli Dei degli antichi Romani [...] che veggonsi ancora in Roma, II, Roma 1779, nr. 9.
gruppo del L. restaurato, braccio del padre tipo Montorsoli. Bibliografia: –
ds 113 antonio Muchetti su disegno di giuseppe Matteini. stampa all’acquaforte, 480x320 mm. In [E.Q. visConti], Il Museo Pio-Clementino descritto da giambattista Visconti prefetto delle antichità di Roma, II, In Roma, da Ludovico Mini, 1784, tav. xxxix. 1778-1784.
gruppo del L., braccio del padre tardo-settecentesco; braccia dei figli di Cornacchini. Bibliografia: riCCo’ trento, Le collezioni, 159 s., nr. 15.
ds 114 giuseppe Bossi su disegno di stefano piale. stampa all’acquaforte, 307x230 mm. Iscrizioni: Piale del: | Bossi inc: In Storia delle arti del disegno presso gli antichi &c., In Roma, dalla stamperia pagliarini, 1783-1784 [ma 1783-1786], II, tav. 4.
gruppo del L. restaurato, situazione tardo-settecentesca. Bibliografia: Bersani, Le pubblicazioni, 187 s., nr. 3.
ds 115 Jean-pierre saint ourse. Matita nera con rialzi di gesso bianco su carta azzurrina, 710x510 mm. Iscrizioni: St. Ours f. | Mme Ceard. 1781. génève, Musée d’art et d’Hi-stoire, Cabinet des dessins, inv. 0.11.
solo L., senza braccio destro. Bibliografia: grange, Une collection, 143, n. 9; CUzin, sch. nr. 89, in D’après l’antique,
254 s.
ds 116 Ferdinando gregori su disegno di antonio Fedi. stampa all’acquaforte con ritocchi al bulino, 475x275 mm. Iscrizioni: Laocoonte, Sacerdote d’Apollo, divorato da’ draghi, insieme con due suoi figliuoli, tal quale la á immaginato Virgilio, Aeneid. lib. II eseguito in marmo da eccellente Scalpello antico, il cui originale esiste in Roma ed una copia |
di Baccio Bandinelli nella Galleria di Firenze.-| Ant. Fedi del. | F. Gregori Scol. | Ap- presso Giuseppe Bardi in Firenze | N.V. disegno1781-1795 (estremi dell’attività di F. Fedi); stampa prima metà XIX secolo.
gruppo del L. restaurato, stato anteriore all’installazione del nuovo braccio del figlio minore, senza ambientazione, con riquadratura. Riproduce il calco dell’accademia di Belle arti di Firenze?
Bibliografia: –
ds 117 Francesco piranesi su disegno di Bernardino Nocchia. stampa all’acquaforte, 650x480 mm. Laocoonte | Bernardino Nocchi disegnò | Cav. Francesco Piranesi incise 1790. Opera d’Agesandro di Polidoro e d’Atenodoro scultori di Rodi, lodata da Plinio, e collocata già nel palazzo di Tito, ora in vaticano Alla Santità di Nrô Sig.re Pio Sesto Pontefice Massimo delle Antichità Investigatore vigilantissimo e delle belle Arti Protettore Magnificentissimo. In Choix des meilleurs statues antiques, paris, s.d. (serie di 41 tavole in folio incise da F. p. fra il 1780 e il 1792 e dedicate a pio VI).
gruppo del L. restaurato, braccia settecentesche definitive. Bibliografia: –
ds 118 Luis ducros su disegno di giovanni Volpato. stampa all’acquaforte colorata all’acque-rello. Lastra originale: Roma, Calcografia Nazionale, inv. 1615-21. 1787-1792.
Veduta del lato meridionale del cortile del Belvedere con L. in nicchia (da una serie di 14 vedute del museo pio-Clementino).
Bibliografia: raddrizzani, Le Laocoon, 357 s.; pietrangeli, Il Cortile delle Statue, 429.
ds 119 Incisore tedesco. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: Laocoon mit seinen Kindern, von Agesander, Polidorus und Athenodorus. In Abbildungen der vorzüglichsten alten Sta-tuen und Gruppen die sich theils in Rom theils in Paris befinden &c., Wien, 1797, 4.
gruppo del L. restaurato, braccio tipo Montorsoli. Copia da ds 86 (perrier). Il volume costituisce una ristampa della raccolta di perrier con commento di Josef Ernest.
Bibliografia: –
ds 120 pierre duflos. stampa all’acquaforte, 299x164 mm. Iscrizioni: Gruppe de Laocoon | P. Duflos. 1780-1810.
gruppo del L. restaurato sopra un alto basamento, braccio tipo Montorsoli. Copia da ds 86 (perrier). Riquadrata.
Bibliografia: –
ds 121 gilles-antoine demarteau su disegno di Mesnier. stampa all’acquaforte. Iscrizioni: Un des fils du Laocoon d’après l’Antique | Dessiné par Mesnier ancien Pensionnaire de la République à Rome | Gravé par Demarteau.-prima del 1802.
Figlio maggiore, vista frontale. Bibliografia: roUx, Graveurs du XVIII siècle, VI, 327 ss.
ds 122 thomas piroli. stampa all’acquaforte. In [L. petit-radel], Les Monuments antiques du Musée Napoleon dessinés et gravés par thomas piroli avec une explication par Mr. L. p.-R., IV, paris, par F. e t. piranesi, frères, 1804.
gruppo di L., braccia di girardon. Bibliografia: –
ds 123 godefroi Engelmann su disegno di Joseph auguste. Litografia. Iscrizioni: Jph. Auguste del. | Lith. de Engelmann. 1797-1815.
gruppo di L. in ambientazione naturale, braccia di girardon. Bibliografia: Fond Français (ap. 1800).
ds 124 Charles-Clement Bervic su disegno di pierre Bouillon. stampa all’acquaforte con ritoc-chi al bulino, 423x312 mm. Iscrizioni: Dessiné par Bouillon | Gravé par Bervic, Membre de l’Institut Imperial de France | Imprimé par Ramboz. In Le Musée français, recueil complet des tableaux, statues et bas-reliefs qui composent la Collection nationale [...] par E.Q. Visconti et t.-B. Emeric david, III, À paris, pubblié per Robillard-péronville & Laurent, 1807, c. 182.
Il braccio mancante94
Le immagini del Laocoonte 95
gruppo di L. restaurato nella nicchia della Salle du Laocoon, braccia di girardon. Bibliografia: le BlanC I, 324.
ds 125 pierre Bouillon. stampa al bulino. In Musée des Antique, dessiné et gravé par pierre Bouillon [...]-avec des notices explicatives par Jean-Baptiste de saint Victor, II, paris, s.d., fol. 32v.
gruppo del L. restaurato, braccia di girardon. Bibliografia: –
ds 126 pierre Chevallier. Litografia. Iscrizioni: P. Cheva. lith. l’Album | Signe N. 5 (2e periode) - 4e année |-Pag. 89. 1797-1815.
gruppo del L. nella nicchia della Salle du Laocoon, braccia di girardon. opera di pro-venienza non identificata.
Bibliografia: –
ds 127 F. Quevedo, C. siquel l’ainé (su disegno di C. Bourdon). stampa all’acquaforte. Iscrizioni: Laocoon, Fils de Priam, et Pretre d’Apollon | Dessiné par C. Bourdon | Gravé à l’eau-forte par Quevedo | Term.é par C. Siquel l’Ai.é. 1897-1815.
gruppo del L. in ambientazione naturale, braccia di girardon. Bibliografia: –
ds 128 disegnatore anonimo. gesso nero su carta bianca, misure non precisate. già London, sotheby’s, Jul. 1993. Ubicazione attuale ignota. 1803-1815.
Veduta della Salle du Laocoon al Louvre, con gruppo di L. restaurato in nicchia, braccia di girardon.
Bibliografia: Jenkins, ‘God without Altars’, 464.
ds 129 pietro Nobile(?). Matita nera, penna e inch. rosso, acquerello rosato e grigio su carta, 433x277 mm. trieste, sovrintendenza B.a.a.a.s. del Friuli-Venezia giulia, Castello di Miramare, Fondo Nobile, vol. 24, c. 122. primo quarto del XIX secolo.
torsi di L. Braccia omesse. teste abbozzate. Bibliografia: Inedito. sul vol.: de veCCHi, sch. s.n., in Pagine architettoniche, 198 s.
ds 130 pietro Nobile(?). Matita nera su carta, 433x278 mm. trieste, sovrintendenza B.a.a.a.s. del Friuli-Venezia giulia, Castello di Miramare, Fondo Nobile, vol. 24, c. 128. primo quarto del XIX secolo.
torso di L., vista anteriore. Braccia omesse. Bibliografia: Inedito. sul vol.: de veCCHi, sch. s.n., in Pagine architettoniche, 198 s.
ds 131 pietro Nobile(?). Matita nera, penna e inch. nero e rosso, acquerello rosato, 431x276 mm. trieste, sovrintendenza B.a.a.a.s. del Friuli-Venezia giulia, Castello di Miramare, Fondo Nobile, vol. 24, c. 131. primo quarto del XIX secolo.
torso di L., vista anteriore. Braccia omesse. Bibliografia: Inedito. sul vol.: de veCCHi, sch. s.n., in Pagine architettoniche, 198 s.
ds 132 pietro Nobile(?). Matita nera, penna, inch. rosso, acquerello rosato, 431x276 mm. trieste, sovrintendenza B.a.a.a.s. del Friuli-Venezia giulia, Castello di Miramare, Fondo Nobile, vol. 24, c. 132. primo quarto del XIX secolo.
torso di L., vista posteriore. Braccia e testa omesse. Bibliografia: Inedito. sul vol.: de veCCHi, sch. s.n., in Pagine architettoniche, 198 s.
ds 133 pietro Nobile(?). Matita nera, penna e inch. rosso, acquerello, 428x281 mm. trieste, sovrintendenza B.a.a.a.s. del Friuli-Venezia giulia, Castello di Miramare, Fondo Nobile, vol. 20, c. 128. primo quarto del XIX secolo.
testa di L., tre scorci. Bibliografia: Inedito. sul vol.: de veCCHi, sch. s.n., in Pagine architettoniche, 194 s.
ds 134 pietro Nobile(?). penna e inch. nero e rosso, acquerello, 428x281 mm. trieste, sovrintendenza B.a.a.a.s. del Friuli-Venezia giulia, Castello di Miramare, Fondo Nobile, vol. 20, c. 129. primo quarto del XIX secolo.
testa di L., tre scorci. Bibliografia: Inedito. sul vol.: de veCCHi, sch. s.n., in Pagine architettoniche, 194 s.
ds 135 pietro Nobile(?). Matita nera, penna e inch. nero, acquerello su carta, 267x191 mm. trieste, sovrintendenza B.a.a.a.s. del Friuli-Venezia giulia, Castello di Miramare, Fondo Nobile, vol. 20, c. 129v (foglio incollato). primo quarto del XIX secolo.
testa di L., tre scorci. Bibliografia: Inedito. sul vol.: de veCCHi, sch. s.n., in Pagine architettoniche, 194 s.
ds 136 giovanni Battista Frulli. Matita nera su carta bianca. Bologna, Biblioteca Comunale del-l’archiginnasio, gabinetto disegni e stampe, Raccolta disegni, autori vari, inv. 98. Inizio del XIX secolo.
Figlio maggiore, vista laterale da destra. Bibliografia: –
ds 137 disegnatore bolognese. Matita nera su carta bianca, misure non precisate. Bologna, pinacoteca Nazionale, gabinetto disegni e stampe, inv. p.R. 709. Inizio XIX secolo.
gruppo del L. restaurato, braccia settecentesche definitive. Modello per un’incisione? Bibliografia: Inedito. M. Faietti, com. orale: vicino alla maniera di a. Rosaspina (luglio
1993).
ds 138 giovanni Battista II Cipriani su disegno di Filippo Ferrari. stampa all’acquaforte, 85x114 mm. Iscrizioni: Laocoonte | Litografia Tipografia Salviucci | V. 1821
gruppo del L. Bibliografia: –
ds 139 Nicola sangiorgi su disegno di paolo guglielmi. stampa all’acquaforte, 337x237 mm. Iscrizioni: Laocoonte | P. Guglielmi dis. | N. Sangiorgi inc. | A. Valentini pubblicò in Roma | con diritto di proprietà. dopo il 1844.
gruppo del L. Bibliografia: –
ds 140 Incisore francese. Litografia. Iscrizioni: Le torse du Laocoon.-In Courses de dessin par Ch. Bargue, avec le concours de J.L. gérome. première partie. Modèles d’aprés la bosse. sixième[?] Livraison, april 1870, paris, s.n., tav. 31.
Busto di L., di fronte. Bibliografia: –
ds 141 Incisore francese. Litografia. Iscrizioni: Le même-vu par derrière. In Courses de dessin &c., sixième[?] Livraison, april 1870, paris, s.n., tav. 32.
Busto di L., vista posteriore. Bibliografia: –
Dipinti e affreschi (da)
da 1 tommaso Bernabei d. il papacello (attr.). affresco, h 1,65 m. Cortona, Villa del Cardinal silvio passerini, salone d’onore, in situ. 1525-1527.
gruppo del L. riquadrato da colonne sullo sfondo di un’arcata. Braccio del padre di fantasia.
Bibliografia: salmi, Tommaso Bernabei, 169; Winner, Zum Nachleben, 103, nota 55 e 117, nota 102; magi, Laocoonte a Cortona.
da 2 tommaso Bernabei d. il papacello (attr.). affresco a monocromo, h 2,16 m. Cortona, Villa del Cardinal silvio passerini, ‘Camera del cardinale’, in situ. 1525-1527.
gruppo del L. Braccio del padre di fantasia. Bibliografia: Winner, Zum Nachleben, 103, nota 55 e 117, nota 102. magi, Laocoonte
a Cortona; krUft, Metamorphosen, 6.
Il braccio mancante96
Le immagini del Laocoonte 97
da 3 daniele da Volterra(?). affresco a monocromo. Roma, palazzo dei Conservatori, sala del trono, in situ. 1544.
gruppo del L. Braccio di Montorsoli liberam. riprodotto. Bibliografia: pietrangeli, La Sala del Trono.
da 4 artista francese (ambito di Jean Cousin?). dipinto a olio su tavola, 453x290 mm. dignes-les-Bains, Musée Municipal, inv. 92. 1540-1550.
gruppo del L. privo di restauri. Copia con lievi modifiche da Marco dente (ds 8). Bibliografia: QUeyrel, Une nouvelle image; settis, Laocoonte di bronzo, 132; settis,
Laocoonte, 116.
da 5 Manifattura di sèvres e antoine Bérnager (disegno di Joseph-Étienne Valois). Vaso di por-cellana dipinta, h 1 m. sèvres, Musée de la Manifacture de sèvres, inv. non ind. 1813.
sfilata dei capolavori antichi a parigi il 9-10 termidoro an. VI (27-28 lug. 1798). Bibliografia: BUsiri viCi, Un vaso; settis, Laocoonte, 4; gallo, Les antique, 193.
Calchi (ca)
Ca 1 Francesco primaticcio e giacomo Barozzi d. il Vignola. Fusione in bronzo da calco in gesso, h 1,91 m. Fontainbleau, Musée du palais Royal. 1540.
gruppo del L. privo delle parti di restauro. Bibliografia: magi, Il ripristino, 64 s.; pressoUyre, Les fontes, 227 s.; Jean-rené
gaBorit, sch. nr. 70, in D’aprés l’antique, 232 s.
Ca 2 guillaume Cassegrain e Manifattura di Balthasar Keller. Fusione in bronzo da calco in gesso, h 1,91 m. Iscrizione: Fondu par le Keller 1687. paris, assemblé Nationale. 1684-1687.
gruppo del L. restaurato, situazione dopo i restauri di Bandinelli e Montorsoli (tutte le parti integre).
Bibliografia: koCks, Antikenaufstellung, 320; gaBorit, sch. nr. 71, in D’aprés l’anti-que, 233 s.
Ca 3 François girardon e Manifattura Keller (attr.). Fusione in bronzo da calco in gesso, h 1,91 m. Houghton Hall, Norfolk. Fine del sec. XVII.
gruppo intero. probabilmente ricavato da un calco in gesso modificato da girardon. Bibliografia: BieBer, Laocoon, 16, nota 7; koCks, Antikenaufstellung, 320; gaBorit,
sub sch. nr. 71, in D’aprés l’antique, 233 s.
Ca 4 Modellatore anonimo. Calco in gesso. stoccolma, Royal academy of Fine arts. prima del 1697.
gruppo del L. Bibliografia: BrUmmer, The Statue-Court, 99.
Ca 5 Modellatore anonimo. Calco in gesso. Bologna, accademia di Belle arti. prima del 1714.
gruppo del L. attualmente in frammenti. Bibliografia: lavarra-del rio, La Gipsoteca, 223 s.
Ca 6 Modellatore anonimo. Calco in gesso. Firenze, accademia di Belle arti. Verso il 1784. gruppo del L., situazione posteriore all’installazione del braccio settecentesco di L. Bibliografia: gallo martUCCi, Notizia storica, 26; rossi pinelli, Chirurgia, 187.
Ca 7 Modellatore anonimo. Calco in gesso. Leipzig, Leipziger akademie der schönen Künste, inv. non riportato. prima del 1774.
L. restaurato, braccio tipo Montorsoli. Bibliografia: Die Skulpturen, 110, nr. 39.
Ca 8 Modellatore anonimo. Calco in gesso. Weimar, goethe Nationalmuseum, schloss tierfurt, inv. 14. 1786-1788(?).
testa di L. Bibliografia: Goethe e l’Italia, 86, sch. nr. 74.
Ca 9 Modellatore anonimo. Calco in gesso. Weimar, goethe Nationalmuseum, gartenhaus, inv. 67. 1786-1788(?).
testa del figlio maggiore. Bibliografia: Goethe e l’Italia, 86, sch. nr. 75.
Ca 10 Jean-pierre saint ourse. Calco in gesso, h 1,90 m. génève, Musée d’art et d’histoire, inv. non ind. 1789.
gruppo del L. restaurato, braccia settecentesche definitive. Bibliografia: grange, Une collection, 142.
Ca 11 Modellatore anonimo. Calco in gesso. Carrara, accademia di Belle arti. prima del 1847. gruppo del L., tratto da un calco esistente in Lucca. Bibliografia: lavarra-del rio, La Gipsoteca, nr. 5.
Copie in grandezza naturale (co)
Co 1 Baccio Bandinelli. Copia in marmo. Firenze, galleria degli Uffizi. 1519-1525. gruppo del L. Bibliografia: Winner, Zum Nachleben, 114-117; agosti, sch. nrr. 17 e 18, in Miche-
langelo e l’arte classica, 58-60; reiss, Cardinal Giulio de’ Medici, 427-432; satzinger, Der “Statuenhof”; Winner, La collocazione, 120 s.; lasCHke, Die Arme, 176-178; lavin, Ex uno lapide, 198 s.; reBaUdo, I restauri, 235-241; lieBenWein, Clemens VII und der Laokoon.
Co 2 Baccio Bandinelli (attr.). Copia in marmo. Londra, mercato antiquario (Heim gallery, summer Exhib. 1970, inv. 10). prima metà del XVI secolo.
testa di L. Bibliografia: magi, Michelangelo, 156 s.; favaretto, La tradizione, 80 s.
Co 3 scultore italiano. Copia in marmo (framm. rilavorato di cornice architettonica antica), h 0,322 m. Wien, Kunsthist. Museum, Kunstkammer, inv. 5449. Metà del XVI secolo?
testa del figlio maggiore. Bibliografia: leitHe-Jasper, sch. nr. 240, in Hoch Renaissance, 517.
Co 4 scultore veneto. Copia in pietra calcarea, h 0,42 m. torcello, Museo provinciale, inv. 143. XVII secolo.
testa di L. Bibliografia: favaretto, La tradizione, 75 s.
Co 5 scultore italiano. Copia in marmo, h 0,78 m. paris, Museé du Louvre, inv. MR2466. XVII secolo.
Busto di L. Bibliografia: gaBorit, sch. nr. 81, in D’aprés l’antique, 248 s.
Co 6 Jean-Baptiste tuby. Copia in marmo. Reggia di Versailles, parco, ingresso del Tapis Vert. 1696.
gruppo del L. Braccio tipo girardon. Bibliografia: lami, Dictionnaire, 477.
Co 7 M. anguier. Copia(?). Menzionata dall’autore in un discorso tenuto all’academie Royale des Beaux arts di parigi, agosto 1670. perduta?
Il braccio mancante98
Le immagini del Laocoonte 99
gruppo del L.? Bibliografia: van elsdingen, Laocoon, 132, nota 40, 140.
Co 8 Manifattura di doccia (attribuito a Carlo ginori). Maiolica policroma, h 1,91 m. Milano, collezione privata. 1748 ca.
gruppo del L. Bibliografia: mottola molfino, L’arte della porcellana, I, nr. 469.
Copie ridotte (cr)
CR 1 Jacopo sansovino. Copia ridotta in bronzo, misure ignote. già collezione di domenico grimani, card. di s. Marco, poi collezione di Jean de guise, card. di Lorena. dispersa. 1507-1508.
gruppo del L. Bibliografia: ventUri, Il gruppo, 10; BrUmmer, The Statue-Court, 101-103; BesCHi,
Collezioni di antichità, 14-22; perry, Cardinal Domenico, 219-221; favaretto, La tradizione, 86; BoUCHer, The Sculpture, II, 361, nr. 83; Cordellier, sub sch. nr. 74, in D’après l’antique, 236.
CR 2 Jacopo sansovino. Copia ridotta in stucco, misure ignote. donata nel 1525 da pietro aretino a Federico gonzaga, duca di Mantova. dispersa. 1507-1508(?).
gruppo del L. Bibliografia: ventUri, Il gruppo, 10; perry, Cardinal Domenico, 219-221; BrUmmer,
The Statue-Court, 101 s.; favaretto, La tradizione, 87; BoUCHer, The Sculpture, II, 361, nr. 84; Cordellier, sub sch. nr. 74, in D’après l’antique, 236.
CR 3 Jacopo sansovino. Copia ridotta in stucco, misure ignote. proprietà di Francesco sansovino, figlio di Jacopo. dispersa. 1507-1508(?).
gruppo del L. Bibliografia: ventUri, Il gruppo, 10; perry, Cardinal Domenico, 219-221; favaretto,
La tradizione, 87; agosti, sub sch. nr. 16, in Michelangelo e l’arte classica, 57; BoUCHer, The Sculpture, II, 361, nr. 85; Cordellier, sub sch. nr. 74, in D’après l’anti-que, 236.
CR 4 antonio Elia. Copia ridotta in bronzo, misure ignote. Menzionata in una lettera di Caradosso ad alfonso I d’Este, duca di Ferrara. dispersa. prima del 1517.
gruppo del L. Bibliografia: ventUri, Il gruppo, 107-109.
CR 5 Baccio Bandinelli. Copia ridotta in cera. dispersa. 1520. gruppo del L. Bibliografia: agosti, sch. nr. 17, in Michelangelo e l’arte classica, 58.
CR 6 Fonditore toscano (già attribuito ad antonio Elia e Jacopo sansovino). Copia ridotta in bronzo, h 0,275 m. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, inv. 427B. prima del 1523.
gruppo di L. privo di restauri. Bibliografia: ventUri, Il gruppo, 107-109 (ant. Elia); mariaCHer, in Alvise Cornaro,
275 (Jac. sansovino); geese, Antike als Programm, 40; agosti, sch. nr. 16, in Michelangelo e l’arte classica, 57; BoUCHer, Jacopo Sansovino, II, nr. 4, 314 s. (Jac. sansovino); BartsCH, sch. nr. 236, in Hoch Renaissance, 516 (Jac. sansovino).
CR 7 Fonditore italiano. Copia ridotta in bronzo, h 0,165 m. Berlin, staatliche Museen, skulpturensamml., inv. 7118. 1520-1530.
gruppo di L. restaurato, braccio di L. di fantasia. Bibliografia: Winner, Zum Nachleben, 112; Beschwörung des Kosmos, nr. 1, 56 s.;
BartsCH, sch. nr. 238, in Hoch renaissance, 517 (aspertini).
CR 8 Fonditore italiano. Copia ridotta in bronzo, misure non precisate. Firenze, Museo Nazionale del Bargello. prima metà XVI secolo.
gruppo del L. restaurato, braccio di L. tipo Montorsoli. Bibliografia: geese, Antike als Programm, 40.
CR 9 Fonditore italiano. Copia ridotta in bronzo, misure non precisate. Firenze, Museo Nazionale del Bargello. prima metà XVI secolo.
gruppo del L. (copia di Baccio Bandinelli). Bibliografia: geese, Antike als Programm, 40.
CR 10 Ludovico Lombardi. Copia ridotta in bronzo, h 0,32 m. Iscrizione sotto la base: Lodovico fecit MDXLV. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, inv. 91 B. 1545.
gruppo del L. restaurato, braccio di L. di fantasia. Bibliografia: geese, Antike als Programm, 40; agosti, sch. nr. 40, in Michelangelo e
l’arte classica, 92 s.
CR 11 Fonditore fiorentino o romano. Copia ridotta in bronzo, h 0,30 m. Brescia, Musei Civici, inv. 55. prima metà del XVI secolo (prima del 1538-1539?).
gruppo del l. restaurato, con braccio di L. di fantasia. Bibliografia: geese, sch. nr. 10, in Natur und Antike, 328 s.
CR 12 Fonditore dell’Italia settentrionale. Copia ridotta in bronzo, h 0,166 m. Wien, Kunsthi-storisches Museum, inv. 5611. Metà del XVI secolo?
gruppo del L. restaurato, braccia di fantasia. Bibliografia: geese, sch. nr. 11, in Natur und Antike, 329 s.; Beschwörung des Kosmos,
nr. 2, 58 s.; leitHe-Jasper, sch. nr. 239, in Hoch Renaissance, 517.
CR 13 Fonditore italiano. Copia ridotta in bronzo, h 0,310 m. New York, Michael Hall, Esquire. prima metà del XVI secolo.
gruppo del L. restaurato, braccio di L. di fantasia. Bibliografia: steadman sHeard, sch. nr. 61, in Antiquity in the Renaissance, 72;
steadman sHeard, sch. nr. 26, in Le génie du sculpteur, 136 s.
CR 14 Modellatore italiano. Copia ridotta in terracotta, h. 0,68 m. princeton, art Museum of princeton University, inv. 68-118. Metà del XVI secolo (?).
gruppo del L. restaurato, braccio di L. tipo Montorsoli; braccia dei figli somiglianti alla copia di Bandinelli (Co 1).
Bibliografia: BrUmmer, The Statue-Court, 103.
CR 15 Modellatore italiano. Copia ridotta in terracotta, h 0,80 m. princeton, art Museum of princeton University, inv. 68-119. Metà del XVI secolo (?).
gruppo del L. restaurato, braccio di L. tipo Montorsoli. Bibliografia: BrUmmer, The Statue-Court, 103 s.
CR 16 Fonditore anonimo. Copia ridotta in bronzo a fusione piena, h 12,25”. già mercato antiquario. Ubicazione attuale ignota. XVI secolo.
gruppo del L. Bibliografia: Roma, Bibliotheca Hertziana, Fototeca, nr. 250 (sch. inventariale).
CR 17 Fonditore francese. Copia ridotta in bronzo, h. 0,40 m. paris, Musée du Louvre, dép. des objets d’arts, inv. oa 9144. XVII secolo.
gruppo del L. restaurato, braccia di L. e dei figli tipo Montorsoli. Bibliografia: BoUCHer, The Sculpture, II, sub nr. 4, 314 s.; gaBorit, sch. nr. 80, in
D’après l’antique, 247 s.
CR 18 Fonditore italiano o francese. Copia ridotta in bronzo, h 0,379 m. già collezione della Corona di Francia. Ubicazione attuale ignota. prima del 1662.
gruppo del L. Bibliografia: Le Bronzes de la Couronne, sch. nr. 11, 77.
Il braccio mancante100
Le immagini del Laocoonte 101
CR 19 Fonditore italiano o francese. Copia ridotta in bronzo, h 0,460 m. già Collezione della Corona di Francia. Ubicazione attuale ignota. prima del 1684.
gruppo del L. Bibliografia: Les Bronzes de la Couronne, sch. nr. 81, 98.
CR 20 scultore italiano o francese. Copia ridotta in bronzo, h 0,375 m. già collezione della Corona di Francia, donazione Errard. Collezione privata. prima del 1689.
gruppo del L. Bibliografia: Les Bronzes de la Couronne, sch. nr. 241, 149.
CR 21 scultore italiano o francese (già attribuito a giambologna). Copia ridotta in bronzo, h 0,335 m. già collezione della Corona di Francia, donazione Le Nôtre. paris, Musée du Louvre, inv. oa 5436. prima del 1693.
gruppo del L. restaurato, braccio del padre tipo Montorsoli, mano del figlio minore tipo Bandinelli con lievi modifiche.
Bibliografia: gUiffrey, Testament, 224; samoyaUlt, Le remplois, 179, nr. 124; Les Bronzes de la Couronne, sch. nr. 222, 144 s.
CR 22 anonimo. Copia ridotta in bronzo, misure ignote. già collezione della Corona di Francia, donazione Le Nôtre. Ubicazione attuale ignota. prima del 1693.
gruppo del L. Bibliografia: Les Bronzes de la Couronne, sch. nr. 223, 145.
CR 23 gaspard Marsy. Copia ridotta in bronzo, misure ignote. dresden, skulpturensammlung, inv. non ind. seconda metà XVII secolo (?).
gruppo del L. restaurato, braccio tipo girardon. Bibliografia: Dialogé, sch. nr. 35 (menzione senza riferimenti inventariali, non ripro-
dotto).
CR 24 giuseppe piamontini. Copia ridotta in maiolica policroma, misure non precisate. 1716 ca. gruppo del L. Bibliografia: mottola molfino, L’arte della porcellana, I, nr. 469 (menzione senza
misure né rif. inventariale).
CR 25 Manifattura di Capodimonte. Copia ridotta in maiolica policroma. Misure non precisate. Roma, Musei Capitolini, Coll. Cini, inv. 355. prima del 1759(?).
gruppo del L. restaurato. Braccio di L. e del figlio minore tipo Montorsoli; serpenti di fantasia.
Bibliografia: arch. Mus. Capitolini, Cam. II Antichità e Belle Arti, b. 6, fasc. 169.
CR 26 Isidro Carnicero. Copia ridotta in terracotta, misure non precisate. Madrid, Real academia de Bellas artes de san Fernando. 1766.
gruppo del L. restaurato, braccio del padre tipo Montorsoli; braccia dei figli perdute. Bibliografia: azCUe Brea, Inventario, 266; martinez iBañez, Isidro Carnicero;
martin gonzalez, El Laoconte, 466.
CR 27 Francesco Righetti. Copia ridotta in bronzo, h 0,50 m ca. Besançon, Musée des Beaux-arts. dopo il 1780.
gruppo del L. restaurato, situazione successiva al restauro Cornacchini. Bibliografia: HonoUr, After the Antique, 198 (menzione).
CR 28 Joseph Chinard. Copia ridotta in marmo, h 0,80 m. Iscrizioni: Chinard de Lyon. Lyon, Musée des Beaux-arts, inv. s 2913. 1784-1786.
gruppo del L. restaurato, situazione successiva al restauro Cornacchini. Bibliografia: gaBorit, sch. nr. 92, in D’après l’antique, 256 s.
CR 29 Manifattura di doccia (attribuito a giuseppe Bini). Copia ridotta in terracotta, misure non precisate. Firenze, Museo della porcellana di doccia, inv. 1305. 1793(?).
gruppo del L. restaurato, braccio di L. di fantasia. Bibliografia: lankHeit, Florentinishe Barockplastik, 122.
CR 30 Manifattura di Capodimonte (Francesco de simone?). Copia ridotta in porcellana, h 0,50 m. Napoli, Museo Filangieri, inv. 40. 1802 ca.
gruppo del L., braccia di L. e del figlio minore post 1784-1786. Bibliografia: gonzalez palaCios, Lo scultore Filippo Tagliolini, 157, nr. 11.
CR 31 Francesco e Luigi Righetti. Copia ridotta in bronzo, base originale in marmo statuario e porfido, h 0,52 m. Caserta, palazzo Reale, salottino del Re, inv. (1977-78) 697. 1810.
gruppo del L., situazione posteriore al restauro Cornacchini. Bibliografia: gonzalez palaCios, Il gusto, 307 s.; valeriani, sch. I.17, in Maestà di
Roma, 95.
CR 32 Manifattura di Heinrich Keller. Copia in scala 1:2. Bronzo? Ubicazione ignota. Citata in Libro delle memorie, anno 1803, c. 41v. Zurich Kunsthaus, inv. 1924/24. 1800 ca.
gruppo del L. Bibliografia: raddrizzani, Entre le serpent et la pomme, 365.
Placchette e medaglie (pm)
pM 1 anonimo. placchetta. Washington d.C., National gallery of art, Kress Collection. Inizio XVI secolo.
Bibliografia: pope Hennessy, Renaissance Bronzes, nr. 383.
pM 2 tommaso Mercandetti. Medaglia di pio VII per la celebrazione del ritorno del Laocoonte in Vaticano, Ø 4,2 cm. 1818.
gruppo del L. (restauri post 1786). Legenda: T. M. | Pio VII Pont.-Max. Ann. XVII. Bibliografia: preiss, Die wissenschaftliche Beschäftigung, 62.
Il braccio mancante102
1. agesandros, polidoros e athanodoros di Rodi; restauratori moderni. Gruppo del Laocoonte con i restauri storici. Marmo e gesso. seconda metà del I sec. a.C.; prima del 1957. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Cortile del Belvedere.
Repertorio iconografico 103
2. anonimo disegnatore dell’Ita- lia settentrionale. Il gruppo del Laocoonte. penna e bistro su carta, fondo acquerellato blu. 1506-1508. düsseldorf, Kunstmuseum. (ds 1)
Il braccio mancante104
3. giovanni antonio da Brescia. Laocoon. stampa al bulino. prima del 1520. (ds 7)
4. Marco dente, Gruppo del Laocoonte davanti a un muro in rovina. stampa al bulino. 1515-1523. (ds 8)
Repertorio iconografico 105
5. Miniatore del XIV sec. Laocoonte accorre in aiuto dei figli; Laocoonte divorato dai serpenti. Inchiostri policromi su pergamena. Inizio del XIV sec. Città del Vaticano, Biblioteca apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 2761, c. 15v.
Il braccio mancante106
Repertorio iconografico 107
6. antonio Lombardo. Fucina di Vulcano (part): Zeus. Marmo. 1507-1508. san pietro- burgo, Museo dell’Ermitage.
7. Fonditore toscano del XVI sec. (già attribuito a Jacopo sanso- vino e antonio Elia). Gruppo del Laocoonte. Bronzo. prima del 1523. Firenze, Museo Nazionale del Bargello. (Cr 6)
Il braccio mancante108
8. galeazzo Mondella detto il Moderno. Flagellazione di Cristo. argento parzialmente dorato. secondo decennio del XVI sec. Vienna, Kunsthistorisches Museum.
Repertorio iconografico 109
9. disegnatore fiorentino o senese. Laocoonte. gesso rosso su carta bianca lavée di beige. primo o secondo decennio del XVI sec. parigi, Musée du Louvre, département des arts graphi-ques.
10. Marten van Heemskerck (attr.). Veduta del Cortile del Belvedere. penna e lavis su carta bianca. 1532-1535. Londra, British Museum, department of prints and drawings. (ds 31)
Il braccio mancante110
Repertorio iconografico 111
11. disegnatore anonimo. Pian- ta del Cortile del Belvedere. In- chiostro nero su carta. 1730 ca. Londra, British Museum, depart- ment of prints and drawings.
12. tommaso Bernabei detto il papacello (attr.). Gruppo del Laocoonte davanti ad un’architettura di fantasia. affresco policromo. 1525 ca. Cortona, Villa-residenza del cardinale silvio passerini, in situ. (da 1)
13. disegnatore fiorentino d’ambi-to michelangiolesco. Carboncino su carta bianca. Gruppo del Laocoonte in ambientazione architettonica. 1530 ca. Collezione privata francese. (ds 24)
Il braccio mancante112
14. disegnatore fiorentino d’ambito michelangiolesco. Carboncino su carta bianca. Figlio maggiore di Laocoonte in ambientazione architettonica. 1530 ca. Collezione privata francese (verso della fig. 13). (ds 25)
Repertorio iconografico 113
15. Baccio Bandinelli. Gruppo del Laocoonte. Marmo. 1519-1525. Firenze, galleria degli Uffi-zi. (Co 1)
16. Baccio Bandinelli (qui attr.). Braccio destro di Laocoonte. Marmo. 1523-1525. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Cortile del Belvedere.
Il braccio mancante114
17. scultore del XVI sec. e restauratore del XVIII sec. Fori di imperniatura e mortasa scavata nella spalla destra di Laocoonte: a) tracce di fori per il fissaggio del braccio di Montorsoli; b) fori per il fissaggio del braccio settecentesco. 1536-1540 e 1784 ca. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Cortile del Belvedere.
Repertorio iconografico 115
18. Filippo Magi. Prova di instal-lazione del braccio di Laocoonte qui attribuito a Baccio Bandinelli. 1957-1959. già Città del Vaticano, Musei Vaticani, Cortile del Belvedere.
Il braccio mancante116
19. Marten van Heemskerck. Torso e altri particolari del gruppo del Laocoonte. penna su carta bianca. 1532-1535. Berlino, staat- lisches Museum der preußischer Kultur- besitz, Kupferstichkabinett, ms. 79d2, c. 23v. (ds 32)
20. amico aspertini. Gruppo del Laocoonte e altre sculture antiche del Cortile del Belvedere. penna e inchiostro bruno su carta. 1531-1534. Londra, British Museum, album London I, c. 16v-17. (ds 26)
Repertorio iconografico 117
21. Francisco de Hollanda. Gruppo del Laocoonte nella nicchia affresca-ta del Cortile del Belvedere. Matita su carta. 1538-1540. Madrid, Museo dell’Escorial, ms. 28 I 20, c. 9v. (ds 38)
Il braccio mancante118
22. Intagliatore italiano. silografia. Laocoonte. In Stanze d’Eurialo d’Ascoli sopra le statue di Laocoonte &c., Roma, Valerio dorico & Luigi fra-telli bresciani, 1539, frontespizio. (ds 39)
23. Incisore italiano. Gruppo del Laocoonte. stampa al bulino. In Urbis Romae Topographia B. Marlianis &c., Impressum Romae, per antonium Blodum, in aedibus dom. Ioan. Bap. de Maximis, 1544, p. 80. (ds 40)
Repertorio iconografico 119
24. Francesco primaticcio e giaco- mo Barozzi da Vignola. Gruppo del Laocoonte. Fusione in bronzo da calco in gesso. 1540. Fontainbleau, Musée du palais Royal. (Ca 1)
Il braccio mancante120
25. part. della fig. 24. Spalla destra di Laocoonte con tracce dei fori di fissaggio del braccio di Montorsoli (a).
26. Ludovico Lombardi. Gruppo del Laocoonte. Bronzo. Iscrizione sotto la base: Lodovico fecit MDXLV. 1545. Firenze, Museo Nazionale del Bargello. (Cr 10)
Repertorio iconografico 121
27. Manifattura di doccia (attr. a giuseppe Bini). Gruppo del Lao- coonte. terracotta. 1793(?). Firen- ze, Museo della porcellana di doc- cia. (Cr 29)
28. Nicolas Beatrizet. Lachoon. stampa al bulino. 1540-1565. In Speculum Romanae Magnificentiae, ed. antoine Lafrery. (ds 43)
Il braccio mancante122
29. disegnatore dell’Italia settentrionale o fiammingo (Jean de Boulogne, detto giambologna?). Gruppo del Laocoonte. Matita su carta preparata. 1550-1553. Cambridge, Eton College, album R 17, 3, c. 2. (ds 45)
Repertorio iconografico 123
30. anton Eisenhoit. Laocoon. stampa all’acquaforte.-1584 ca. In Appendix ad Metallothecam vaticanam Michaelis Mercati &c., Romae, apud Jo. Mariam salvioni typographum Vaticanum, 1719. (ds 60)
Il braccio mancante124
31. Hendrik goltzius. Gruppo del Laocoonte. Matita nera su carta blu con rialzi di bianco. 1591. Haarlem, tylers stichting Museum. (ds 62)
Repertorio iconografico 125
32. peter paul Rubens. Gruppo del Laocoonte. Matita nera su carta. 1601-1602 o 1606-1608. Milano, Biblioteca ambrosiana, album inv. F 249 inf, c. 4. (ds 65)
Il braccio mancante126
33. peter paul Rubens. Torso di Laocoonte visto dal basso. gesso nero su carta. 1606 ca. dresden, staatliche Kunstsammlung, Kupferstichkabinett. (ds 69)
Repertorio iconografico 127
34. gerard audran, Laocoonte quotato, vista anteriore. stampa all’acquaforte. In Les proportions du corps humain &c., À paris, s.n., 1683, tav. 1. (ds 94)
35. gerard audran, Laocoonte quotato, vista posteriore. stampa all’acquaforte. In Les proportions du corps humain &c., À paris, s.n., 1683, tav. 4. (ds 97)
Il braccio mancante128
36. gerard audran, Laocoonte quotato, vista laterale sinistra. stampa all’acquaforte. In Les pro-portions du corps humain &c., À paris, s.n., 1683, tav. 3. (ds 96)
37. Claude Randon. Il Laocoonte gia ammirato nel palazzo di Tito &c. stampa al bulino. In Raccolta di statue antiche e moderne date in luce [...]-da domenico de Rossi illustrata colle sposizioni a ciascheduna immagine di pavolo alessandro Maffei &c., In Roma, nella stamperia alla pace, 1704, tav. 1. (ds 104)
Repertorio iconografico 129
38. gian domenico Campiglia. Laocoon. stampa all’acquaforte. In Michaelis Mercati Sammi-niatensis Metallotheca vaticana [...] Opera autem, et studio Joannis Mariae Lancisii, Romae, Ex officina Jo. Mariae salvioni in archigymnasio sapientiae, 1717. (ds 105)
Il braccio mancante130
39. Modellatore anonimo. Gruppo del Laocoonte. Calco in gesso. Verso il 1784. Firenze, accademia di Belle arti. (Ca 6)
Repertorio iconografico 131
40. antonio Muchetti su disegno di giuseppe Matteini. Gruppo del Laocoonte. stampa all’ac-quaforte. 1784 ca. In [E.Q. visConti], Il Museo Pio-Clementino descritto da E.Q.V., II, In Roma, da Ludovico Mini, 1784, tav. xxxix. (ds 113)
Il braccio mancante132
41. giuseppe Bossi su disegno di stefano piale. Gruppo del Laocoonte. 1784-1785. stampa all’acquaforte. In Storia delle arti del disegno presso gli antichi &c., In Roma, dalla stamperia pagliarini, 1783-1784 [ma 1783-1786], II, tav. 4. (ds 114)
Repertorio iconografico 133
42. Joseph Chinard. Gruppo del Laocoonte. Firmato: Chinard de Lyon. 1784-1786. Lyon, Musée des Beaux-arts. (Cr 28)
Il braccio mancante134
43. Francesco e Luigi Righetti. Gruppo del Laocoonte. Bronzo. 1810. Caserta, palazzo Reale, sa- lottino del Re. (Cr 31)
44. guillaume Cassegrain e mani-fattura Keller. Gruppo del Lao- coonte con i restauri cinquecente-schi. Fusione in bronzo da calco in gesso. 1687. parigi, assemblée Na- tionale. (Ca 2)
Repertorio iconografico 135
45. Benjamin Zix. Napoleone visita la Salle du Laocoon nel Musée Napoléon alla luce delle torce. penna, inchiostro e lavis su carta bianca. 1805 ca. parigi, Musée del Louvre, Cabinet des dessins.
46. Charles-Clement Bervic su disegno di pierre Bouillon. Gruppo del Laocoonte con il braccio modellato da François Girardon. stampa all’acquaforte con ritocchi al bulino. 1807 ca. In Le Musée français &c., par E.Q. Visconti et t.-B. Emeric david, III, À paris, pubblié per Robillard-péronville & Laurent, 1807, c. 182. (ds 124)
Il braccio mancante136
47. Jean-Baptiste tuby. Gruppo del Laocoonte con il braccio modellato da François Girardon. 1692. Reggia di Versailles, parco, ingresso del Tapis Vert. (Co 6)
Repertorio iconografico 137
48. Modellatore anonimo. Gruppo del Laocoonte con il braccio modella-to da François Girardon. Calco in ges- so. prima del 1697. stoccolma, Royal academy of Fine arts. (Ca 4)
Il braccio mancante138
49. thomas piroli. Gruppo del Lao- coonte con il braccio modellato da François Girardon. stampa all’acqua- forte, in Le Monuments antiques du Musée Napoleon dessinés et gravés par Thomas Piroli avec une explica-tion par Mr. Louis Petit-Radel, IV, paris, par F. e t. piranesi Frères, 1804. (ds 122)
50. agesandros, polidoros e athanodoros di Rodi. Braccio di Laocoonte, detto ‘braccio Pollak’. seconda metà del I sec. a.C. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Cortile del Belvedere.
Repertorio iconografico 139
51. georg treu. Rico- struzione del gruppo del Laocoonte con il ‘braccio Pollak’. Calco in gesso. 1906-1907. disperso. Foto dresda, Museum alberti- num, archivio.
52. agesandros, polidoros e athanodoros di Rodi. Gruppo del Laocoonte. Situazione dopo il ripristino di Filippo Magi, 1957-1959. Marmo. seconda metà del I sec. a.C. Città del Vaticano, Musei vaticani, Cortile del Belvedere.
Il braccio mancante140
Fig. 1 da settis, Laocoonte, 1999
Fig. 2 da Winner, Zum Nachleben, 1974
Fig. 3 da Winner, Zum Nachleben, 1974
Fig. 4 foto autore
Fig. 5 da settis, Laocoonte, 1999
Fig. 6 da Il Cortile delle Statue, 1989
Fig. 7 Michelangelo e l’arte classica, 1987
Fig. 8 da Renaissance Master Bronzes, 1986
Fig. 9 da BoUCHer, The Sculpture, 1991
Fig. 10 da Il Cortile delle Statue, 1989
Fig. 11 da Il Cortile delle Statue, 1989
Fig. 12 foto gab. Fotografico sNs pisa
Fig. 13 da Il Cortile delle Statue, 1989
Fig. 14 da Il Cortile delle Statue, 1989
Fig. 15 da Il Cortile delle Statue, 1989
Fig. 16 da magi, Il ripristino, 1960
Fig. 17 da magi, Il ripristino, 1960
Fig. 18 da magi, Il ripristino, 1960
Fig. 19 da Il Cortile delle Statue, 1989
Fig. 20 da BoBer, Drawings, 1957
Fig. 21 da Il Cortile delle Statue, 1989
Fig. 22 da settis, Laocoonte, 1999
Fig. 23 foto gab. Fotografico sNs pisa
Fig. 24 da magi, Il ripristino, 1960
Fig. 25 da magi, Il ripristino, 1960
Fig. 26 da Il Cortile delle Statue, 1989
Fig. 27 foto autore
Fig. 28 foto gab. Fotografico sNs pisa
Referenze fotografiche 141
Fig. 29 da fileri, Giovanni Bologna, 1985
Fig. 30 foto autore (esemplare BU pisa)
Fig. 31 da Ciardi, Giovan Ambrogio, 1968
Fig. 32 da van der meUlen, Rubens’ Copies, 1994-1995
Fig. 33 da van der meUlen, Rubens’ Copies, 1994-1995
Fig. 34 foto BN paris
Fig. 35 foto BN paris
Fig. 36 foto BN paris
Fig. 37 foto gab. Fotografico sNs pisa
Fig. 38 foto gab. Fotografico sNs pisa
Fig. 39 gallo martUCCi, Notizia storica, 1984
Fig. 40 da L’immagine dell’antico, 1986
Fig. 41 foto autore (esemplare BU pisa)
Fig. 42 da D’aprés l’antique, 2004
Fig. 43 da D’aprés l’antique, 2004
Fig. 44 da D’aprés l’antique, 2004
Fig. 45 da Il Cortile delle Statue, 1989
Fig. 46 foto BN paris
Fig. 47 foto autore
Fig. 48 da BrUmmer, The Statue-Court, 1970
Fig. 49 foto BN paris
Fig. 50 da pollak, Der rechte Arm, 1905
Fig. 51 da vergara Caffarelli, Studio, 1954
Fig. 52 da settis, Laocoonte, 1999
REFERENZE FotogRaFICHE
BIBLIogRaFIa
Le opere sono elencate secondo l’ordine alfabetico degli autori. I volumi miscellanei sono inseriti nell’elenco sotto il nome del primo autore, ove gli autori siano indicati sul frontespizio; sotto il titolo (compreso l’eventuale articolo iniziale: es. Il Cortile delle Statue), ove risultino solo i nomi di curatori/editori.periodici, collane e serie sono abbreviati secondo il siglario pubblicato in «archäologischer anzeiger» 1997, pp. 612-628. In caso di periodici non compresi nella lista sono adottate sigle entrate nell’uso comune (es. «IMU» = «Italia Medievale e Umanistica»), ovvero il nome è riportato per esteso.I testi a stampa anteriori al 1850 (Fonti) sono citati in forma letterale, tranne nel caso di edizioni critiche recenti, alle quali è stato applicato il criterio bibliografico moderno. Il nome dell’autore, se individuabile, è riportato fra parentesi quadre all’inizio del lemma ai fini dell’ordinamento alfabetico.
Abbreviazioni bibliografiche
B. a. BartsCH, Le Peintre-Graveur, I-XXI, À Vienne, degen, 1803-1821
The ill. B. The illustrated Bartsch, gen. ed. W.L.-strauss, 1-165, New York, abaris Book, 1978-1999
Benezit e. Benezit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculp-teurs, dessinateurs et graveurs, paris, Librairie gründ, 1976
DA The Dictionary of Art, ed. by J. turner, I-XXXIV, London, McMillan, 1996; New York, grove, 19982
DBI Dizionario Biografico degli Italiani, a c. di M. pavan, a. ghisalberti, F. Bartoccini et al., Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1960-
Fond Français Bibliothèque Nationale. Departement des Estampes. Inventaire du Fond Français. Graveurs du Sèizième siècle, a c. di a. Linzeler & J. adhémar, paris, Floch, 1932-1971 [2 voll. in 3 tt.]
Fond Français (ap. 1800) J. adHémar-letHeve, Bibliothèque Nationale. Cabinet des Estampes. Inventaire du Fond Français après 1800, paris, Floch, 1954
Hind a.m. Hind, Early Italian Engravings. A Critical Catalogue, I-V, London, Knoedler & C., 1938-1948
Hollstein f.H.W. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1450-1700, amsterdam, Hertzberger, 1949-
le BlanC Ch. le BlanC, Manuel de l’amateur d’estampes &c., paris, p. Jannet, 1854-1889
LIMC Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), I-IX, Zürich, artemis Verlag, 1981-1999.
nagler g. k. nagler, Die Monogrammisten (Fortgesetz von a. andresen und C. Clauss), München, Franz, 1858-1879
roBert dUmesnil a.p.f. roBert dUmesnil, Le Peintre-Graveur français &c., paris, Warée et Huzard, 1835-1871
FontiAppendix ad Metallothecam vaticanam Michaelis Mercati &c., Romae, apud Jo. Mariam
salvioni, 1719[aUdran, g.], Les proportions du corps humain mesurées sur les plus belles figures de l’Anti-
quité à Paris, À paris, s.n., 1683
Il braccio mancante142
[Blainville, J. de Wargnier, le sieur de], Travels trough Holland, Germany, Switzerland, but especially Italy in three volumes by the late Monsieur de Blainville, London, printed for John Noon, 1757
— Herrn von Blainville [...] Reisebeschreibung durch Holland, Oberdeutschland und die Schweiz besonders aber durch Italien &c., III, Reisebeschreibung besonders durch Italien enthaltend die Fortsetzung der Beschreibung von Rom &c., Lemgo, in der Meyerschen Buchhandlung, 1766
[Boissard, J.J.], II Pars Antiquitatum Romanarum seu Topographia Romanae Urbis [...] a I.I. B. primum ad theodorum de Bry missa &c., Francfordii, artifice theodoro de Bry Leod., 1597. Fa parte di I[-VI] Pars Romanae Urbis Topographiae et Antiquitatum &c., Francfordii, artifice theodoro de Bry Leod., 1597
Boselli, o., Osservazioni sulla Scoltura Antica. I manoscritti di Firenze e Ferrara, a c. di a.p. torresi, Ferrara, Liberty House, 1994
Calcografia di belle statue antiche Degli Dei degli antichi Romani [...] che veggonsi ancora a Roma &c., tomo II, che contiene le statue di alcuni eroi, imperatori &c., Roma, Nella tipografia di Battista Cannetti, all’arco di Ciambella; appresso gaetano Quojani, accanto alle convertite al corso, 1779
[CaylUs, le Comte de], De la sculpture et des Sculpteurs anciens selon Pline, par Le Comte de Caylus &c., «Mémoires de l’accadémie des Inscriptions et des Belles Lettres», t. XXV, 1759 [le memorie contenute risalgono agli anni 1752-1754], pp. 302-334
Choix des meilleurs statues antiques &c., paris, s.n., s.d., (vol. in-2° gr. senza front., dedicato a pio VI e contenente una serie di tavole 650x480 mm di autori diversi, datate 1780-1792)
ClaraC, f., Comte de, Musée de Sculpture antique et moderne, ou description historique et geographique du Louvre et des toutes ses parties &c., paris, Imprimerie royale [Imperiale], 1841-1853 [6 tt. in 7 voll. di testo, 6 voll. di tavole]
de Brosses, Ch., Lettres familières, text éd. par g. Cafasso; intr., notes et bibl. par L. Norci, II, Naples, Centre Jean Bérard, 1992
[dU Bos, J.-B.], Refléxions critiques sur la Poesie e sur la peinture par l’abbé d. B. &c., paris, chez J. Mariette, 1719 [2 voll.]
— Réflexions critique sur la poésie et la peinture, pref. de d. désirat, paris, Éc. Nat. sup. d. Beaux-arts, 1993
— Riflessioni critiche sulla poesia e sulla pittura, a c. di M. Mazzocut-Mis e p. Vincenzi, trad. ital. di M. Bellini e p. Vincenzi, palermo, Centro Intern. di st. di Estetica, 2005
[eUrialo d’asColi, pseud. di morani de’ gUideroCCHi, a.], Stanze d’E. d’A. sopra le statue di Laocoonte, di Venere et d’Apollo, al gran Marchese del Vasto, Roma, Valerio e Luigi dorico, 1539
[fea, C.], Risposta dell’Abate C.F. Giureconsulto alle osservazioni del Sig. Cav. Onofrio Boni sul tomo III. della Storia delle Arti del Disegno di Giov. Winckelmann pubblicata in Roma nelle sue memorie per le Belle arti, né mesi di Marzo, aprile, Maggio e giugno del corrente anno 1787, In Roma, dalla stamperia pagliarini, 1787
[fragonard, H., Bergeret de granCoUrt, p.-J.-o.], Bergeret et Fragonard. Journal inedit d’un voyage en Italie. 1773-1774, préc. p. un étude p. M.a. tornzey, paris, Librairies-impr. réunies, 1895
Galerie du Musée Napoléon. Cours historique et élèmentaire de peinture, I-X, paris, Filhol, an XII [1804-1814]
goetHe, J.W., Über Laokoon (Propyläen, ersten Bandes erstes Stück, 1798, pp. 1-18), in Goethes Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrter hrsg. v. prof. dr. K. Heinemann, 22. Band, Schriften über bildende Kunst I, Leipzig und Wien, Bibliograph. Institut, 1900, pp. 105-116
— Sul Laocoonte, trad. a c. di M. Cometa, in Laocoonte 2000 (v), pp. 93-102[Heyne, C.g.], Prüfung einiger Nachrichtungen und Behauptungen vom Laokoon im Belvedere,
in Sammlung antiquarischer Aufsätze von Chr.g.H., zweites stück, Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich, 1779, pp. 1-52
[keyssler, J.g.], J.G.K. [...] neueste Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen &c., I, Hannover, im Verlage sel. N. Försters und sohns Erben, 1751
Bibliografia 143
[la lande, J.-J., le français de], Voyage d’un Français en Italie, fait dans les années 1765 & 1766 contenant l’histoire & les anecdotes plus singulières de l’Italie &c., À Venise, et se trouve à paris, chez desaint, 1769 [8 voll.]
Le Musée royal, éd. par Henri Laurent, graveur du cabinet du roi; ou, Recueil de gravures d’apres les plus beaux tableaux, statues et bas-reliefs de la collection royale, avec description des sujets, notices littéraires et discours sur les arts &c., paris, Impr. de p. didot, l’aîné, 1816-1818 [2 tt.; contiene testi di E.Q. Visconti, F. de Clarac, F.p.g. guizot]
[Maffei, p.a.], Raccolta di statue antiche e moderne data in luce sotto i gloriosi auspici della santità di N.s. papa Clemente XI. da domenico de Rossi illustrata. Colle sposi-zioni a ciascheduna immagine di pavolo alessandro Maffei &c., In Roma, nella stamperia alla pace, 1704
[magnan, d.], La ville de Rome ou description abrégée de cette superbe ville, divisé en quatre volumes et ornée de 425 planches en taille douce, tome IV, Contenant la description du quartier [...] XIV du Bourg ou du Vatican, a Rome, de l’Imprimerie d’archange Casaletti, a saint Eustache. Chez Venan. Monaldini, Bouchard et gravier, gregoire settari, libraires au cours, 1778
[marliani, g.B.], Urbis Romae Topographia Bartholomaei Marliani ad Franciscum regem gal-lorum, Romae, Impressum Romae per antonium Bladum, 1544.
[merCati, M.], Michaelis Mercati Samminiatensis Metallotheca [...] opera autem, et studio Joannis Mariae Lancisii, Romae, Ex officina Jo. Mariae salvioni Romani, 1717 (rilegato con Appendix ad Metallothecam vaticanam [v])
meyer, J.H., Einige Bemerkungen über die Gruppe Laokoons und seiner Söhne, in Propyläen, zweiten Bandes erstes Stück, 1799, pp. 175 ss.
Notice des Statues, Bustes, Bas-Reliefs et autres objects composants la Galerie des Antiques du Musée central des Arts, ouverte pour la première fois le dix-huit Brumaire de l’an 9, À paris, de l’Imprimerie des sciences et arts, s.d. [1800]
Notice des Statues, Bustes, Bas-Reliefs et autres objects composant la Galerie des Antiques du Musée Central des Arts, ouverte pour la première fois le dix-huit Brumaire de l’an 9, À paris, de l’imprimerie des sciences et arts, l’an XI [1802-1803]
Notice des Statues, Bustes, Bas-Reliefs et autres objects composant la Galerie des Antiques du Musée Central des Arts, ouverte pour la première fois le dix-huit Brumaire an 9, À paris, de l’imprimerie des sciences et arts, s.d. [1811]
[perrier, f.], Ill.mo D.D. Rogerio Du Plessis [...] Segmenta nobilium signorum et statuarum quae temporis dentem invidum evasere Urbis aeternae ruinis erepta Tipys aeneis ab se commissa [...] F.P. D.D.D., s.l, s.n., 1638
[petit-radel, L.], Le Monuments antiques du Musée Napoleon dessinés et gravés par thomas piroli avec une explication par Mr. L. petit-Radel, publiés par F. e t. piranesi, frères, IV, paris, Imprimerie de la Vve panckoucke, 1806 [L’opera è costituita da quattro tomi in un volume in-4°, di cui i primi tre, con le spiegazioni di g. schweig- auser portano la data An XII (1804), il tomo IV, con la spiegazione di petit-Radel, porta la data 1806]
Raccolta d’Antiche Statue, Busti, Bassirilievi et altre Sculture restaurate da Bartolomeo Cavaceppi Scultore Romano, I, Roma, salomoni, 1768
[riCHardson, J.sr., riCHardson, J.Jr.], An Account of the Statues, Bas-reliefs, Drawings and Pictures in Italy, etc. with Remarks. By Mr. Richardson sen. and Jun., London, printed for J. Knapton at the Crown in st. paul’s Churchyard, 1722
[saint-viCtor, J.-B. de], Musée des Antiques dessiné et gravé par p. Bouillon peintre, avec des notices explicatives par J.-B. de s.-V., II, Heros, personnages grecs et romains, À paris, chez p. didot, l’aîné, s.d. [3 voll., pubbl. forse tra il 1821 e il 1827]
Sommario del Viaggio degli oratori Veneti che andarono a Roma a dar l’obbedienza a Papa Adriano VI, in Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato, a c. di E. albéri, s. iii, III, Firenze, La Nuova Italia, 1946, pp. 77-120
[tessin, n.], N.T. d. Y:s Studieresor i Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike och Italien; ante-ckningar, bref och ritningar, a c. di o. sirén, stockholm, Norsted, [1914]
vasari, g., Le vite de più eccellenti pittori, scultori ed architettori, scritte da G.V., pittore areti-no. Con nuove annotazioni e commenti di g. Milanesi. Ultima impressione, I-VII,
Il braccio mancante144
Bibliografia 145
Firenze, sansoni, 1906, rist. anast., ibid., sansoni, 1981 (con i tt. VIII [Ragionamenti sopra le invenzioni da lui dipinte in Firenze &c.] e IX [Indici, aggiunte e correzioni] costituiscono le Opere di Giorgio Vasari)
— La Vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, a c. di p. Barocchi, I-V, Milano e Napoli, Ricciardi, 1968
[visConti, g.B.], Il Museo Pio-Clementino descritto da g.B.V.-tomo primo &c., Roma, da Ludovico Mini, 1782
[visConti, e.Q.], Il Museo Pio-Clementino descritto da E.Q.V.-tomo secondo &c., Roma, da Ludovico Mini mercante di quadri incontro il palazzo Bernini, 1784
[visConti, e.Q., emeriC david, t.B.], Le Musée français. Recueil complet des tableaux, statues et bas-reliefs qui composent la Collection nationale [...] par E.Q.V et t.-B.E.-d. publié per Robillard-péronville & Laurent, III, paris, Imprimerie de Mame frères, 1807 [l’opera è costituita da 4 tt. gr.-folio (1803-1809), di cui i primi due portano il nome di s.-C. Croze Magnan in luogo di quelli di Visconti ed Emeric-david]
[volkmann, J.J.], Historisch-Kritische Nachrichten von Italien [...] aus des neuesten französischen und englischen Reisebeschreibungen und aus eigenen anmerkungen zusammengetra-gen von J.J. Volkamnn, Leipzig, Verlegts Kaspar Fritsch, 1770[-1771] [3 voll.]
[von ramdoHr, F.W.B.], Über Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst, von F.W.B.v.R. &c., Erster theil, Der Vatikanische Pallast. Hof des Belvedere nebst dem Porticus, der ihn umgibt, Leipzig, bei Weidmanns Erben und Reich, 1787
[WinCkelmann, J.J.], Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Altertums &c., Erster theil, dresden 1767 (rist. anast. Baden-Baden und strasbourg, Heitz, 1966)
— Storia delle arti del disegno presso gli antichi di g.W., In Milano, Nell’Imperial Monistero di s. ambrogio maggiore, 1779 (rist. anast. con pref. di g. Uscatescu, s. Cristina gela, Ed. Librarie siciliane, 1991)
— Storia delle arti del disegno presso gli antichi di Giovanni Winckelmann, tradotta dal tedesco e in questa edizione corretta e aumentata dall’abate Carlo Fea, In Roma, dalla stamperia pagliarini, 1783-1784 (ma 1783-1786)
StudiaCkermann, J.s., The Belvedere as a classical villa, «JWCI», XIV, 1951, pp. 78-90— The Cortile del Belvedere, Città del Vaticano, tipografia poliglotta Vaticana, 1954 (st. e doc.
per la storia del palazzo apostolico Vaticano, 3)agosti, g., Il paragone tra Michelangelo e gli antichi, in Michelangelo e l’arte classica (v), p.
107 s.alföldi, a., alföldi, E., Die Kontorniat-Medaillons. Teil 1. Katalog. In neuer Bearb. von a.a.
und E.a.; unter Mitwirk. von C.L. Clay, Berlin, de gruyter, 1976 (antike Münzen und geschnittene steine, Bd. 6/1)
Alvise Cornaro e il suo tempo, padova, Loggia e odeo Cornaro, sala del palazzo della Ragione, 7 set. - 9 nov. 1980, padova, Comune di padova, 1980
amelUng, W., Die Skulpturen des Vatikanischen Museums, II, Berlin, in Komm. bei georg Reimer, 1908
andreae, B., Odisseus. Archäologie des europäischen Menschenbildes, Frankfurt a. M., Frankfurter societäts-druckerei, 1982, trad. ital. L’immagine di Ulisse. Mito e archeologia, torino, Einaudi, 1983
— Laokoon und die Gründung Roms, Mainz a. Rh., von Zabern, 1988, trad. ital. Laocoonte e la fondazione di Roma, Milano, Il saggiatore, 1989
— Michelangelo und die Laokoon-Gruppe, in Bathron, Beiträge zur Architektur und verwandten Künsten für Heinrich Drerup zu seinem 80. Geburtstag von seinen Schulern und Freunden, hrsg. v. H. Busig, F. Hiller, [saarbrucken], saarbrucker druckerei und Verlag, 1988, pp. 31-39
— Pretorivm spelvncae. L’antro di Tiberio a Sperlonga, Cosenza, Rubbettino, 1995
andreae, B., anger, k., granino, m.g. et al., Museo Pio Clementino. Cortile Ottagono, a c. di J. Köhler, ed. B. andreae, Berlin und New York, de gruyter, 1998
Antiquity in the Renaissance, Northampton (ma), smith College Museum of art, 6 apr. - 6 Jun. 1978, ed. by W. steadman sheard, Northampton (ma), smith College Museum of art, 1978
Architekturmodelle der Renaissance. Die Harmonie des Bauens von Alberti bis Michelangelo, Berlin, Kunstbibliothek im alten Museum, 7 ott. 1995 - 7 gen. 1996, hrsg. v. B. Evers, München, prestel, 1995
asHBy, th., Antiquae Statuae Urbis Romae, «pBsR», IX, 1920, pp. 107-158— Note sulle varie guide di Roma che contengono xilografie di Girolamo Franzini, «Roma», I,
1923, pp. 345-352Åström, p., Suggerimento per una nuova ricostruzione del Laocoonte, «Collsod», s. ii, II, 1968-
1970, pp. 11-20aUlanier, C., Histoire du Palais et du Musée du Louvre, V, Le Petit Galerie. Appartement d’An-
ne d’Autriche. Salles romaines, paris, Éd. d. Musées Nationaux, 1955 azCUe Brea, L., Inventario de las colecciones de escultura de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, «academia», LXII, 1986, p. 266Barkan, l., Unearthing the past. Archaeology and Aesthetics in the Making of Renaissance
Culture, New Haven, Yale U.p., 1999Bartolomeo Cavaceppi (1717-1799) scultore romano, Roma, Museo di palazzo Venezia, 25 gen.
- 15 mar. 1994, a c. di M.g. Barberini, C. gasparri, Roma, palombi, 1994Berenson, B., The Drawings of the Florentine Painters, (London 1903; Chicago 19382), trad.
ital. rivista e ampliata, I disegni dei pittori fiorentini, I-III, Milano, Mondadori, 19613
Bersani, C., Le pubblicazioni archeologiche delle raccolte enciclopediche settecentesche ai primi periodici specializzati, in L’immagine dell’antico (v), pp. 173-196
Bertolotti, a., Bartolomeo Marliano, archeologo in Roma nel secolo XVI, «atMemdepstp Emilia», n.s., IV, 1880, pp. 107-138
BesCHi, l., Collezioni di antichità a Venezia ai tempi di Tiziano, «aquilN», XLVII, 1976, coll. 14-22
Besterman, th., Old Art Books, London, Maggs Bros., 1975BetHe, E., Laokoon, in Paulys Real-Encyclopädie des Classischen Altertumswissenschaft. Neue
Bearbeitung begonnen von Georg Wissowa, XII.1, hrsg. v. W. Kroll, stuttgart, Metzlerschen Verlagsbuchhandlung, 1924, coll. 736-737
Bibliothèque Nationale. Departement des Estampes. Inventaire du Fond Français. Graveurs du Sèizième siècle, éd. par a. Linzeler, J. adhémar, I/1, paris, Floch, 1932
BieBer, M., Laocoon. The influence of the group since its rediscovery. Revised and enlarged edition, detroit, Wayne state U.p., 1967
Birrke, v., kertész, J., Die italienische Zeichnungen der Albertina. General-Verzeichnis, Bd. I, General-Verzeichnis 1-1200, Wien, Köln und Weimar, Böhlau, 1992
Blomë, B., Åström, p., The Laocoon-group: a tentative reconstruction, stockolm, svenska Institutet i Rom, 1994
Blasio, s., Cornacchini, Agostino, in Repertorio della scultura fiorentina del Seicento e Settecento, a c. di g. pratesi, Firenze, allemandi, [1993]
BlUnt, a., Cook, H.l., The Roman Drawings of the XVII and XVIII Centuries in the Collection of her Majesty the Queen at Windsor Castle, London, phaidon, 1960
BoBer, p., Drawings after the Antique by Amico Aspertini, London and Leiden, Brill, 1957 (stud. of the Warburg Inst., 21)
BoBer p[ray], p., olitsky rUBinstein, r., Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Handbook of Sources, London, Miller, 1986
Borea, e., Dente, Marco, in DBI, XXXVIII, 1990, pp. 790-795BoUCHer, B., The sculpture of Jacopo Sansovino, I-II, London and New Haven, Yale U.p., 1991BresC-BaUtier, g., Le fontes d’aprés l’antique, in Primatice (v), pp. 140-142Brizio, e., Gli studi sul Laocoonte, «Nuovant», s. iii, XXI, 1889, pp. 5-24; ibid., XXII, 1890,
pp. 252-273
Il braccio mancante146
Bibliografia 147
BrUmmer, H.H., The Statue-Court in the Vatican Belvedere, stockholm, almquist & Wiksell & p.a. Norstedt & söner, 1970 (stockholm st. in the Hist. of art, 20)
BUlst, W., Uso e trasformazione del palazzo Mediceo fino ai Riccardi, in Il palazzo Medici Riccardi di Firenze (v), pp. 98-129
BUsiri viCi, a., Un vaso di Sèvres documenta le asportazioni napoleoniche dall’Italia, «antViva», X, 1971, 3, pp. 55-64
Caglioti, F., Due ‘restauratori’ per le antichità dei primi Medici: Mino da Fiesole, Andrea del Verrocchio e il ‘Marsia rosso’ degli Uffizi. I, «prospettiva», 72, nov. - dic. 1993, pp. 17-42
— Due ‘restauratori’ per le antichità dei primi Medici: Mino da Fiesole, Andrea del Verrocchio e il ‘Marsia rosso’ degli Uffizi. II, «prospettiva», 73-74, gen. - apr. 1994, pp. 74-96
Campami, a., Sull’opera di Antonio Canova pel recupero dei monumenti d’arte italiani a Parigi. Corrispondenza Canova-Angeloni, Roma, tip. dell’Unione Coop., 1892
Canova, l., Baccio Bandinelli, in Scultori del Cinquecento (v), pp. 21-40Castro, B., Vincenzo de’ Rossi. Uno scultore tra Roma e Firenze, in Scultori del Cinquecento
(v), pp. 110-128CerCHiai, C., Ennio Quirino Visconti, in Il Collegio Romano dalle origini al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, cat. d. mostra s.d.n.l., a c. di C. Cerchiai, Roma, IpsZ, Libreria d. stato, 2003, pp. 459-461
CHastel, a., The Sack of Rome. 1527, Washington d.C., princeton U.p., 1983, trad. ital. Il sacco di Roma. 1527, torino, Einaudi, 1983
CHatelain, J., Dominique Vivant Denon et le Louvre de Napoléon, paris, Libr. acad. perrin, s.d. [1973]
[CHiarini, p.], Cronologia del soggiorno romano, in Goethe a Roma (v), pp. 55-57— Goethe, Roma e il viaggio in Italia, in Goethe a Roma (v), pp. 15-25Ciardi, R., Giovan Ambrogio Figino, Firenze, Marchi & Bertolli, 1968Ciardi dUpré, M.g., Per la cronologia dei disegni di Baccio Bandinelli fino al 1540,
«Commentari», XVII, 1966, pp. 146-170— Il modello originale della ‘Deposizione’ del Bandinelli per Carlo V, in Festschrift Ulrich
Middeldorf, hrsg. v. a. Kosegarten, p. tiegler, Berlin, de gruyter, 1968, pp. 269-275
Clapp, F.M., Les dessins de Pontormo, paris, Champion, 1914CoHen, s., Some Aspects of Michelangelo’s creative Process, «art&Hist», XXXVII, 1998, pp.
43-63Collareta, M., Michelangelo e le statue antiche, un probabile intervento di restauro,
«prospettiva», 43, 1985, pp. 51-55—-Intorno ai disegni murali della Sagrestia Nuova, in Michelangelo Drawings, Washigton,
Nga, Center for advanced studies in the Visual arts, 7 - 8 oct. 1988, ed. by C.H. smith, a. gilkerson, Hannover and London, U.p. of New England, 1992 (st. in the Hist. of art, 33), pp. 163-172
Collezioni di antichità a Venezia nei secoli della Repubblica (dai libri e documenti della Bilbioteca Marciana), Venezia, BN Marciana, 27 mag. - 31 lug. 1988, a c. di M. Zorzi, Roma, IpZs, 1988
Comunicazioni stradali attraverso i tempi. Firenze-Roma, a c. di d. strepos, Novara, de agostini, 1964
Consagra, F., The De Rossi family print publishing shop. A study in the history of print industry in Seventeenth-Century Rome, phd diss., ann arbor, Univ. of Michigan, 1992
Consoli, g.p., Il Museo Pio-Clementino. La scena dell’antico in Vaticano, Modena, panini, 1996 (Il riuso dell’antico, 2)
Contarini, g., Canova a Parigi nel 1815, Feltre, Castoldi, 1891Cordellier, d., La mission à Rome en 1540 et les expéditions de 1540 et 1542, in Primatice
(v), p. 137 s.
Corsi, J., La cultura romana negli affreschi del Palazzone di Cortona, «Boll. d’Informazione. Brigata aretina d. amici d. Monumenti», XXXIII, 1999, pp. 58-64
Cosmo, g., Aspertini e la scultura antica, «antologia di belle arti», XXI-XXII, 1984, pp. 25-39
dal poggetto, p., I disegni murali di Michelangelo e della sua scuola nella Sacrestia Nuova di S. Lorenzo, Firenze, Centro di, 1979
daltrop, g., Zur Überlieferung und Restaurieng des Apoll vom Belvedere des Vatikans, «Rendpontacc», XLVIII, 1975-1976, pp. 127-140
— Die Laokoongruppe im Vatikan. Ein Kapitel aus der römischen Museumsgeschichte und der Antiken-Erkundung, Konstanz, Universitätsverlag Konstanz, 1982 (Xenia, Konstanzer althist. Vortr. u. Forsch., 5)
— Zur Aufstellung antiker Statuen in der Villetta di Belvedere des Vatikans, «Boreas», VI, 1983, pp. 217-232
— Antike Götterstatuen im Vatikan. Die vatikanische-römische Tradition der klassischen Archäologie, Basel und Frankfurt a. M., Lang, 1987 (Vortr. d. aeneas-silvius-stift. an d. Univ. Basel, 22)
D’après l’antique, paris, Musée du Louvre, 16 oct. 2000 - 15 jan. 2001, comm. de l’exp. J.-p. Cuzin, J.-R. gaborit, a. pasquier, paris, Réunion d. Mus. Nationaux, 2000
de nolHaC, p., Une galerie de peinture au XVI siècle. La collection de Fulvio Orsini, «gazBeauxarts», XXIX, 1884.
dent Weil, p., Contributions toward a history of Sculpture. I. Orfeo Boselli on the Restoration of antique Scultpure, «studCons», XII, 3, agosto 1967, pp. 81-101
de rossi, g., Lettera sopra il restauro di un’antica statua di Antinoo, e sopra il restauro degli antichi marmi nei tre secoli precedenti al nostro, «Nuovo giornale de’ Letterati», XIII, 1826, pp. 23-38
d’este, a., Memorie di Antonio Canova. scritte da a. d’E. e pubblicate per cura di alessandro d’Este. Con note e documenti, Firenze, Le Monnier, 1864
desWarte-rosa, s., Francisco de Hollanda et le Cortile del Belvedere, in Il Cortile delle Statue (v), pp. 389-410
de tolnay, C., Michelangelo, IV, The Tombe of Pope Julius II, princeton, princeton U.p., 1954, 19702
dHanens, E., De Romainse ervaring van Giovanni Bologna, «BullInstBelgRome», XXXV, 1963, pp. 159-190
Dialogé. Kopie, Variation und Metamorphose alter Kunst in Graphik und Zeichnung vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart, dresden, Kupferstichkab. der staatl. Kunst- sammlung, 27 sept. - 31 dez. 1970, hrsg. v. W. schmidt, dresden, Veb polydruck, 1970
di Castro, d., fox, s.p., Disegni dall’antico dei secoli XVI e XVII dalle collezioni del Gabinetto Nazionale delle Stampe, Roma, de Luca, 1983 («Xenia», Quaderni, 3)
Die Skulpturen der Sammlung Wallmoden. Ausstellung zum Gedenken an Christian Gottlob Heyne (1729-1812), archäologisches Institut d. Univ. göttingen, s.d., göttingen, goltze-druck, 1979
Domenico Beccafumi e il suo tempo, siena, pinacoteca Naz., 16 giu. - 16 set. 1990, Milano, Electa, 1990
Dominique-Vivant Denon: l’oeil de Napoléon, paris, Musée du Louvre, 20 oct. 1999 - 17 jan. 2000, Comm. de l’exp. p. Rosenberg; Comm. dél. M.-a. dupuy, paris, Réunion d. Mus. Nationaux, 1999
Early Italian Engravings from the National Gallery of Art, ed. by J.a. Levenson, K. oberhuber, J.L. sheerman, Washigton dC, National gallery of art, 1973
eCHinger-maUraCH, C., Michelangelo’s monument for Julius II in 1534, «BurlMag», CXLV, 2003, pp. 336-344
egger, H., Zur Dauer von Martens van Heemskerck Aufenhalt in Rom 1532-1535, «Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome», V, 1925, pp. 119-127
enggass, r., Early-Eighteenth-Century Sculpture in Rome. An Illustrated Catalogue Raisonné, pennsilvania Univ. park and London, pennsylvania U.p., 1976
Il braccio mancante148
Bibliografia 149
faCCioli, C., Di Agostino Cornacchini da Pescia scultore a Roma, «stRom», XVI, 1968, pp. 431-445
Faietti, M., kelesCian sCaglietti, d., Amico Aspertini, Modena, artioli, 1995farinato, a.m., È di Michelangelo: si vede dalla subbia e dallo scalpello, «Il giornale dell’ar-
te», XVII, 1999, fasc. 177, p. 10favaretto, I., La tradizione del Laocoonte nell’arte veneta, «atIstVen», CXLI, 1982-1983, pp.
75-92ferri, s., Aspetti ipotetici di un ulteriore restauro del gruppo del Laocoonte, «archCl», II, 1950,
pp. 66-69ferritti, M., Niccolò Tribolo, in Scultori del Cinquecento (v), pp. 69-90Festschrift Ulrich Middeldorf, hrsg. v. a. Kosegarten, p. tiegler, Berlin, de gruyter, 1968fileri, E., Giovanni Bologna e il taccuino di Cambridge, «Xenia», X, 1985, pp. 3-54— Il taccuino di Cambridge e note su Giovanni Bologna, in Scultori del Cinquecento (v), pp.
129-135filippi, E., Marten van Heemskerck. Inventio Urbis, Milano, Berenice, 1990forCellino, a., Le statue della tomba di Giulio II, «Monumentidiroma», I, 2003, pp. 145-149förster, R., Laokoon im Mittelalter und in der Renaissance, «JhbpreusKs», XXVII, 1906, pp.
146-178— Laokoon, «JdI», XXI, 1906, pp. 1-32— Noch zwei Laokoondenkmäler, «JdI», IX, 1894, pp. 43-50From Pergamon to Sperlonga. Sculpture and context, ed. by t. de grummond, B. sismondo
Ridgway, Berkeley, U.C.p., 2000frommel, C.L., I tre progetti bramanteschi per il cortile del Belvedere, in Il Cortile delle Statue
(v), pp. 17-66fUBini, g., Held, J.J., Padre Resta’s Rubens Drawings after Ancient Sculpture, «Mastdraw», II,
1964, pp. 123-141Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi. Inventario. Disegni di figura. 1, a c. di a.M. petrioli
tofani, Firenze, olschky, 1991gaBorit, J.-r., Un relief du musée des Beaux-Arts d’Orleans: la Flagellation par Baccio
Bandinelli, «Bsocantiq», 1994, pp. 146-152galli, g., rel. s. tit., «Rendpontacc», III, 1924-1925, p. 473gallo, d., Ennio Quirino Visconti e il restauro della scultura antica fra Settecento e Ottocento,
in Thorvaldsen. L’ambiente l’influsso il mito, a c. di p. Kragelrund, M. Nykjaer, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1991 («analRom», suppl. XVIII), pp. 101-122
— Les antiques au Louvre, in Dominique Vivant-Denon (v), pp. 182-194gallo martUCCi, a., Notizia storica delle dotazioni didattiche dell’Accademia, in L’Accademia
di Belle Arti di Firenze. 1784-1984, Firenze, La Nuova Italia, 1984, pp. 25-39garrard, m.d., The Early Sculpture of Jacopo Sansovino. Florence and Rome, phd diss.,
Baltimore, the John Hopkins Univ., 1969, ann arbor (mi), UMI, 1970 geese, U., Antike als Programm. Der Statuenhof des Belvedere im Vatikan, in Natur und Antike
in der Renaissance (v), pp. 24-50gerlaCH, p., Eine Hand von Guglielmo della Porta? Cavalieri, Tetrode, Perret und der sogen-
nate Antinous von Belvedere, in De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984, hrsg. v. a. Horodisch, amsterdam, Erasmus, 1984, pp. 179-197
giUliano, a., Due nuove rappresentazioni del Laocoonte, in Il Cortile delle Statue (v), pp. 187-190
Giulio Romano pinxit et delineavit. Opere grafiche autografe, di collaborazione e bottega (cat. d. mostra s.d. e ind. di luogo), a c. di s. Massari, Roma, palombi, 1993
gnamm, a., I giovani artisti a Roma dalla morte di Raffaello al Sacco di Roma, in Roma e lo stile classico (v), pp. 31-57
gonzalez-palaCios, a., Lo scultore Filippo Tagliolini e la porcellana di Napoli, torino, allemandi, 1988
— Il gusto dei Principi, Milano, Mondadori, 1993
Goethe a Roma (1786-1788). Disegni e acquarelli da Weimar, Roma, Mus. Napoleonico, 10 mar. - 24 apr. 1988, a c. di p. Chiarini, Roma, artemide, 1988
Goethe e l’Italia. Goethe und Italien, trento, palazzo trentini, 16 set. - 6 nov. 1989, Milano, Electa, 1989
grange, d., Une collection genevoise méconnue: les moulages d’aprés l’antique, «aK», XXXV, 1992, pp. 142-145
gUiffrey, J.J., Testament et inventaire après décès de André Le Nostre et autres documents le concernent, «Bulletin de la société de l’Histoire de l’art Français», 1911, pp. 217-282
Haldi, J.-p., Die Rezeption römischer Antikensammlungen durch “Grand Touristen” in 18. Jahrhundert, in Von der Schönheit (v), pp. 17-22
Harris, E., Velazquez en Roma, «archEsparte», XXXI, 1958, pp. 185-192Haskell, F., penny, N., Taste and the antique. The lure of classical sculpture 1500-1900, New
Haven and London, Yale U.p., 1981, trad. ital. L’antico nella storia del gusto. La seduzione della scultura classica 1500-1900, torino, Einaudi, 1984
Heikamp, d., Die Laokoongruppe des Vincenzo de’ Rossi, «MKIF», XXXIV, 1990, pp. 343-378Helms, M.g., The Materials and Techniques of Italian Renaissance Sculpture, in Looking
at Italian Renaissance Sculpture, ed. by s. Blake McHam, Cambridge (ma), Cambridge U.p., 1998, pp. 18-39
High Renaissance in the Vatican. The Age of Julius II and Leo X, tokio, National Museum of Western art, 21 sept. - 28 Nov. 1993, ed. by a. Nanjo, Y. Miyegawa, tokio, the National Museum of Western art & NtN Corp., 1993 (testi in lingua giapponese)
High Renaissance in the Vatican. The Age of Julius II and Leo X, text suppl., tokio, National Museum of Western art, 21 sept. - 28 Nov. 1993, a c. di M. Koshikawa, M.J. McCormack, tokio, the National Museum of Western art & NtN Corp., 1993 (testi in lingua inglese, senza apparato iconografico)
Himmelmann, N., Utopische Vergangenheit. Archäologie und moderne Kultur, Berlin, Mann, 1976, trad. ital. Utopia del passato. Archeologia e cultura moderna, Bari, de donato, 1981
— Laokoon, «antK», XXXIV, 1991, pp. 97-115— Sperlonga. Die homerische Gruppen und ihre Bildquellen, opladen, Westdt. Verl., 1996 («Vortr.
Nordrhein-Westfälischen akad. der Wiss., düsseldorf. geisteswiss.» g 340)Hoch Renaissance im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste I. 1503-1534, Bonn,
Kunst- und ausstellungshalle d. Bundesrep. deutschland, 11 dez. 1998 - 11 apr. 1999, Katalogkoord. p. Krause, Bonn, Kunst- und ausstellungshalle d. Bundesrep. deutschland, 1998
Hofter, m.r., Laokoons Arm, in Wiedererstandene Antike. Ergänzung antiker Kunstwerke seit der Renaissance, München, Biering & Brinkmann, 2003, pp. 261-265
Höllander, H., Ein Museum der Steine: die Metallotheca des Michele Mercati und die Ordnung des Wissens, in Wunderwerk (v), pp. 19-30
HonoUr, H., Bronze Statuettes by Giacomo and Giovanni Zoffoli, «the Connoisseur», Nov. 1961, pp. 198-205
— After the Antique: Some Italian Bronzes of the Eighteenth Century, «apollo», LXXVII, Mar. 1963, pp. 194-200
HoWard, s., On the Reconstruction of the Vatican Laocoon Group, «aJa», LXIII, 1959, pp. 365-369
— Pulling Herkles’ Leg. Della Porta, Algardi and Others, in Festschrift Ulrich Middeldorf (v), pp. 402-407
— Laocoon rerestored, «aJa», LXXXXIII, 1989, pp. 417-422— Albani, Winckelmann and Cavaceppi. The Transition from Amateur to professional Antiqua-
rianism, «JHistColl», IV, 1992, pp. 27-38 Hülsen, C., Il “Museo Ecclesiastico” di Clemente XI Albani, «BCom», XVIII, 1890, pp. 260-277— Das Speculum Romanae Magnificentiae des Antonio Lafreri, in Collectanea variae doctrinae
Leoni S. Olschki, bibliopolae florentino, sexagenario obtulerunt Ludwig Bertalot, Giulio Bertoni &c., Monachii, Rosenthal, 1921, pp. 121-170.
Il braccio mancante150
Bibliografia 151
Hülsen, Ch., Egger, H., Die römische Skizzenbücher von Marten van Heemskerck, I-II, Berlin, Bard, 1913-1916
Hyskell, F., The Museo Pio-Clementino in Rome and the views by Ducros and Volpato, in Images of the Grand Tour. Louis Ducros 1748-1810, London, the Iveagh Bequest, Kenwood, 4 sept. - 31 oct. 1985; Manchester, the Whitworth art gallery, University of Manchester, 10 Jan. - 22 Feb. 1986; Lausanne, Musée Cant. d. Beaux-arts, 21 mar. - 19 mai 1986, éd. par p. Chessex, genève, Éd. du tricorne, 1985, pp. 36-39.
Il Camerino d’alabastro. Antonio Lombardo e la scultura all’antica, a c. di M. Ceriana, Cinisello Balsamo e Milano, silvana Editoriale, 2004 (Gli Este a Ferrara, coord. a. Rossetti, R. Cerri et al., 3)
Il carteggio di Michelangelo. Edizione postuma di giovanni poggi, a c. di p. Barocchi, R. Ristori, I-IV, Firenze, s.p.E.s., 1967-1983
Il Cortile delle Statue. Der Statuenhof des Belvedere im Vatikan, akten d. intern. Kongr. zu Ehren v. Richard Krautheimer, Roma, Bibliotheca Hertziana, deut. archäologisches Institut, Musei Vaticani, 21 - 23 ott. 1992, a c. di M. Winner, B. andreae, C. pietrangeli (†), Mainz, von Zabern, 1998
Il palazzo Medici Riccardi di Firenze, a c. di g. Cherubini, g. Fanelli, Firenze, giunti, 1990Il Torso del Belvedere. Da Aiace a Rodin, München, staatl. antikensammlungen und glyptothek,
21 gen. - 29 mar.; Citta del Vaticano, Musei Vaticani, 19 nov. 1998 - 31 gen. 1999, a c. di R. Wünsche, Città del Vaticano, tipografia Vaticana, 1998.
Indice delle stampe Intagliate in Rame a bulino, e in acqua forte Esistenti nella Stamperia di Lorenzo Filippo De Rossi. Appresso Santa Maria della Pace in Roma, MDCCCXXXV. Contributo alla Storia di una Stamperia romana, a c. di a. grelle Iusco, Roma, artemide, [1996]
iodiCe, M., Integrazioni al regesto di Amico Aspertini: vicende pubbliche e familiari di un grande pittore bolognese, «schUmanistiche», n.s., I, 1994, pp. 95-110
isHii, M., Antonio Lombardo e l’antico: qualche riflessione, «artVen», LI, 1997, pp. 6-19Jaffe’, M., Rubens and Italy, oxford and Ithaca (ny), phaidon, 1977James, C., The Letters of Giovanni Sabadino degli Arienti (1481-1510), Firenze, olschky; perth,
the Univ. of W. australia, dep. of Italian, 2002 (Ital. Med. and Ren. studies, 8)Jean-Baptiste du Bos e l’estetica dello spettatore, a c. di L. Russo, palermo, Centro Intern. di
st. di Estetica, 2005Jendritzki, g., roHnstoCk, U., Die barocke Laokoon-Gruppe aus Bronze. Hinweise zur
Herstellung und Restaurierung, «Restauro», CIII, 1997, pp. 460-465Jenkins, i., “God without Altars”. The Belvedere in Paris, in Il Cortile delle Statue (v), pp.
459-470JoHns, C.m.s., Papal Art and Cultural Politics. Rome in the Age of Clemens XI, Cambridge (ma),
Cambridge U.p., 1993JosepHson, R., Nicodemus Tessin D.Y. Tiden, mannen, verket, stockholm, Norstedt, [1930-1931]klidis, a., François Girardon. Bildhauer in königlichen Diest 1663-1700, Weimar, Verl. u.
datenbank f. geistwiss., 2001koCks, d., Antikenaufstellung und Antikenergänzung im 18. Jahrhundert in England, in
Antikensammlung im 18. Jahrhundert, akten d. Intern. symposium, Frankfurt a. M., Liebighaus, dez. 1978, hrsg. v. H. Beck, p.C. Bol, W. prinz, H. von steuben, Berlin, de gruyter, 1981, pp. 317-331
kreikenBom, d., Cavaceppis Maximen zur Antikenrestaurierung, in Von der Schönheit (v), pp. 85-92
krUft, H.-W., Metamorphosen des Laokoon. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschmacks, «pantheon», LXII, 1984, pp. 3-11
La collezione Boncompagni Ludovisi. Algardi, Bernini e la fortuna dell’antico, Roma, Fondazione Memmo, palazzo Ruspoli, 5 dic. 1992 - 30 apr. 1993, a c. di a. giuliano, Venezia, Marsilio, 1992
ladendorf, H., Antikenstudium und Antikenkopien. Vorarbeiten zu einer Darstellung ihrer Wirkung in der Mittelalterlichen und neuren Zeit, Berlin, akademie Verl., 1953, 19582
La Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, a c. di s. Russo, Massa, s.n., 1992lami, s., Dictionnaire des Sculpteurs de l’Ecole Française sous le règne de Louis XIV, paris,
Champion, 1906— Storia degli scavi di Roma e notizie intorno alle collezioni romane di antichità. Volume Primo
(1000-1530), I, Roma, Loescher, 1902 (Ed. integrale sotto gli auspici dell’Istituto Nazionale di archeologia e storia dell’arte, Roma, Quasar, 19892)
lankHeit, K., Florentinische Barockplastik. Die Kunst am Hofe der letzten Medici. 1670-1743, München, thiemig, 1962
L’anticomanie. La collection d’antiquités aux XVIII et XIX siècles, actes du Coll., Montpellier-Lattes, 9 - 12 juin 1988, éd. par a.F. Laurens, K. pomian, paris, Éditions de l’E.H.E.s.s., 1992
Laocoonte 2000, a c. di L. Russo et al., palermo, Centro Intern. di studi di Estetica d. Fac. di Lett. e Fil. dell’Univ. di palermo, 1992 (aesthetica preprint, 35)
larsson, L.o., Imitatio and aemulatio. Adrien de Vries and the classical sculpture, in sCHolten, Adrien de Vries (v), pp. 52-58
lasCHke, B., Montorsolis Entwürfe für das Siegel der Accademia del Disegno in Florenz, «MKIF», XXXI, 1987, pp. 392-402
— Fra Giovan Angelo da Montorsoli. Ein florentiner Bildhauer des XVI. Jahrhunderts, Berlin, Mann, 1993
— Die Arme des Laokoon, in Il Cortile delle Statue (v), pp. 175-186La Sculpture. Méthode et Vocabulaire, éd par M.t. Baudry, paris, Impr. Nationale, 1978La Tribuna del Duomo di Pisa. Capolavori di due secoli, pisa, Museo Naz. di s. Matteo, cat. sotto
la dir. di R.p. Ciardi, Milano, Electa, 1995lavarra-del rio, g., La gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, «strenna storica
bolongnese», XXXIV, 1984, pp. 217-239lavin, I., Ex uno lapide: The Renaissance Sculptor’s tour de Force, in Il Cortile delle Statue
(v), pp. 192-210.La Vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, con comm. secolare di p. Barocchi,
I-V, Milano e Napoli, Ricciardi, 1968Le génie du sculpteur dans l’oeuvre de Michel-Ange, Montreale, Musée des Beaux-arts, 12 juin
- 13 sept. 1992, Montereal, Éd. de Beax-arts, 1992Le guide antiche di Roma nelle collezioni comunali. 1500-1850, Roma, palazzo delle Esposizioni,
11 - 26 mag. 1991, a c. di a.M. di stefano, C. salvi, Roma, Carte segrete, 1991lelievre, p., BarBin, m., Vivant Denon: homme des lumieres, «ministre des arts» de Napoleon,
paris, picard, 1993leniaUd, J.-M., Canova et la question des spoliations d’oeuvres d’art, in Antonio Canova e il
suo ambiente storico fra Venezia, Roma e Parigi, a c. di g. pavanello, Venezia, Ist. ven. di sc., Lett. e arti, 2000, pp. 481-490
Les bronzes de la Couronne, paris, Musèe du Louvre, Hall Napoleon, 12 avr. - 12 juil 1999, éd. par s. Baratte, g. Bresc-Bautier, s. Castelluccio et al., paris, Réunion d. Mus. Nationaux, 1999
lieBenWein, W., Clemens VII und Laokoon, in Opere e Giorni (v), pp. 525-532L’immagine dell’antico fra Settecento e Ottocento. Libri di archeologia nella Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio, Bologna, Bibl. Com. dell’archiginnasio (nov. 1983 - gen. 1984), a c. di C. Bersani, a. Riccò trento, V. Roncuzzi Roversi Monaco, Bologna, grafis Edizioni, 1983
liverani, p., Geschichte des Cortile Ottagono im Belvedere, in andreae, B., anger, k. et al., Museo Pio Clementino (v), pp. v-xv
— Antikensammlung und Antikenergänzung, in Hoch Renaissance (v), pp. 227-235— The Museo Pio-Clementino at the time of the Grand Tour, «JourHistColl», XII, 2000, pp.
151-159— La nascita del Museo Pio-Clementino e la politica canoviana dei Musei Vaticani, in Canova
direttore di Musei, I sett. di st. Canoviani, Bassano del grappa, 12 - 15 ott. 1999, atti a c. di M. pastore stocchi, Bassano del grappa, Ist. di ricerca per gli st. su Canova e il Neoclassicismo, 2004, pp. 75-102
Il braccio mancante152
L’officina della maniera. Varietà e fierezza nell’arte fiorentina del Cinquecento fra le due Repubbliche 1494-1530, Firenze, galleria d. Uffizi, 28 set. 1996 - 6 gen. 1997), a c. di a. Cecchi, a. Natoli, C. sisi, Venezia, Marsilio, 1996
loret, m., I lavori artistici nel Vaticano durante il pontificato di Clemente XI (1700-1721), «archivi d’Italia», s. ii, III, 1936, pp. 54-59
mC donald, M., Pedro Perret and Pedro de Villafranca. Printmakers to the Spanish Hapsburgs, «Melbourn art Journal», IV, 2000, pp. 37-51
Maestà di Roma. Da Napoleone all’unità d’Italia, Roma, scuderie del Quirinale, galleria Naz. d’arte Moderna, Villa Medici, 7 mar. - 29 giu. 2003, a c. di s. pinto con L. Barroero e F. Mazzocca, Milano, Electa, 2003
maffei, s., La fama di Laocoonte nei testi del Cinquecento, in settis, Laocoonte (v), pp. 85-230magi, F., Il ripristino del Laocoonte, «Mempontacc», s. iii, IX, 1, Città del Vaticano, tipografia
poliglotta Vaticana, 1960— Laocoonte a Cortona, «Rendpontacc», XL, 1967-1968, pp. 275-294— Michelangelo e il suo disegno del Laocoonte recentemente scoperto, «Rendpontacc»,
XLVIII, 1975-1976, pp. 151-177malgoUyres, ph., Le Musée Napoléon, paris, Réunion d. Mus. Nationaux, 1999martin, F., ‘Una copia del modelo que hizo el citado Rusconi’. Zu einem bislang wenig beachten
Kopie Isidro Carniceros nach einem Modell Camillos Rusconi, in Opere e giorni (v), pp. 687-694
martin gonzalez, J.J., El Laocoonte y la escultura español, «BVallad», LVI, 1990, pp. 459-469martinez iBañez, m.a., Isidro Carnicero Leguina. Director en Escultura de la Academia,
«academia», LXIX, 1989, pp. 397-413massari, s., Marco Dente, in Giulio Romano pinxit et delineavit. Opere grafiche autografe, di
collaborazione e bottega (cat. d. mostra s.d. e indic. di luogo), a c. di s. Massari, Roma, Fratelli palombi, 1993
maUraCH, g., Der vergilische und der vatikanische Laokoon. Mit einem anhang zu Miche-langelos Laokoon-Zeichnung und tafeln i-viii, «gymnasium», XCIX, 1992, pp. 227-247
miCHaelis, a., Geschichte des Statuenhofes im vaticanischen Belvedere, «JdI», V, 1890, pp. 5-72— Römische Skizzenbücher Marten van Heemskercks und anderer nordischer Künstler des XVI.
Jahrhunderts, «JdI», VI, 1891, pp. 125-172Michelangelo e l’arte classica, Firenze, Casa Buonarroti, 15 apr. - 15 ott. 1987, a c. di g. agosti,
V. Farinella, Firenze, Cantini, 1987Michelangelo: selected Scholarship in English, ed. by W.E. Wallace, IV, Tomb of Julius II and
other Works in Rome, New York, garland, 1995MiCHon, e., La restauration du Laocoon et le modèle de Girardon, «Bsocant», 1906, pp. 271-
280 [il saggio, pubblicato come comunicazione senza titolo letta durante la seduta del 27 giu. 1906, è così citato dall’autore in Fondation E. Piot. Monuments et Memoire, XXI, 1913, p. 14, nota 2]
middeldorf, U., Unknown Drawings of the two Sansovino, «BurlMag», LXIV, 1934, pp. 159-164 (poi in Raccolta di scritti that is Collected Writings, I, 1924-1938, Firenze, s.p.E.s., 1979, pp. 147-154)
miesel, V.H., Rubens’ Study Drawings after Ancient Sculpture, «gazBeauxarts», 1963, pp. 311-326
montagU, J., The Expression of the Passions. The Origin of the Influence of Charles Le Brun’s Confèrence sur l’éxpression général et particulière, New Haven and London, Yale U.p., 1994
mottola molfino, a., L’arte della porcellana in Italia, I-II, Busto arsizio, Bramante, 1976-1977müller-kaspar, U., Cavaceppi zwischen Theorie und Praxis, in Von der Schönheit (v), pp.
93-108Müntz, E., Les antiquités de la ville de Rome aux XIVe, XVe et XVIe siècle, paris, Leroux, 1886— Le musée de l’École des Beaux-Arts. I. Les origines de la collection, «gazBeauxarts», 1890,
1, pp. 274-276
Bibliografia 153
mUsso, L., “Römische Memoiren” di Ludwig Pollak: l’archeologo, il conoscitore, il commer-ciante d’arte antica, «studi germanici», XXX, 1995, pp. 95-110
Natur und Antike in der Renaissance, Liebighaus, Museum alter plastik, Frankfurt a. M., 5 dez. 1985 - 2 Mär. 1986, hrsg. v. H. Beck, p.C. Bol, Frankfurt a. M., Hassmüller, 1985
Neoclassicism and Romanticism. 1750-1850. Sources and Documents, ed. by L.E.a. Eitner, Engelwood Cliffs (nJ), prentice-Hall, 1970
nesselratH, a., Il Cortile delle Statue. Luogo e storia, in Il Cortile delle Statue (v), pp. 1-16— Montorsolis Vorzeichnung für seine Ergänzung des Laokoon, in Il Cortile delle Statue (v),
pp. 165-174Nicolas Beatrizet. Un graveur lorrain à Roma au XVIe siècle, Lunéville, Mus. Municipal, 6 juin
-13 sept. 1970, Lunéville, paradis, s.d. [1970]Opere e Giorni. Studi su mille anni di arte europea dedicati a Max Seidel. Werke und Tage: tau-
send Jahre europäischer Kunstgeschichte. Studien zu Ehren von Max Seidel, a c. di K. Bergdolt, g. Barsanti, Venezia, Marsilio, 2001
Pagine architettoniche. I disegni di Pietro Nobile dopo il restauro, a c. di R. Fabiani, s.l., s.n., 1997 (Relaz. d. sopr. B.a.a.a.s del Friuli Venezia giulia, 10)
parker, K.t., Catalogue of the Collection of Drawings in the Ashmolean Museum. The Italian School, oxford, Clarendon press, 1956
pavan, M., I Musei Vaticani, il Canova e il governo napoleonico (1809-1814), in Studi in onore di Elena Bassi, Venezia, arsenale, 1998 (Coll. di st. ateneo Veneto, 11), pp. 135-154
perissa torrini, g., Gallerie dell’Accademia di Venezia. Disegni del Figino, Milano, silvana Ed., 1987
perretta, V., Un ebreo ‘Romano’, «studi germanici», XXX, 1995, pp. 91-94petrioli tofani, a.M., Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Inventario. Disegni di figura.
1, Firenze, olschky, 1991— Appunti per un corpus grafico di Giovanni Angelo Montorsoli, «artista», 2003, pp. 150-163petrUCCi, a., Una vittima del Sacco di Roma, «Il Messaggero», 17 marzo 1959, p. 3petrUCCi, C.a., Catalogo generale delle stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcogra-
fia Nazionale, Roma, Libr. d. stato, 19532
pfeifer, i., Giacomo Zoffoli. Kleinbronzen aus Schloß Wörlitz, «Weltkunst», LXVI, 1996, pp. 3232-3234
pietrangeli, C., Il Museo Pio-Clementino Vaticano, «Rendpontacc», XXVII, 1951-1954, pp. 87-107 — I Musei Vaticani al tempo di Pio VI, «Rendpontacc», L, 1977-1978, pp. 196-233— Il Cortile delle Statue nel Settecento, in Il Cortile delle Statue (v), pp. 421-430pinatel, C., Origines de la colléction des moulages d’antiques de l’École Nationale des Beaux-
Arts de Paris, aujourd’hui à Versailles, in L’anticomanie (v), pp. 307-325poesCHl, s., Agostino Cornacchinis Reiterstandbild Karls des Grossen am Portikus von Sankt
Peter in Rom. Ein Herrscherbild im sakralen Context, in Karl der Grosse und sein Nachleben in Geschichte, Kunst und Literatur, hrsg. v. th. pabst, «Zeitschrift d. aachener geschichtsverein», 2003, pp. 673-703
pollak, l., Der rechte Arm des Laokoon, «RM», XX, 1905, pp. 277-282— Römische Memoiren. Künstler, Kunstliebhaber und Gelehrter 1893-1943, hrsg. v. M. Merkel
guldan, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1994pommier, E., Réflexions sur le problème des restitutions d’oeuvres d’art en 1814-1815, in
Dominique Vivant-Denon (v), pp. 254-257pomponi, M., Fonti per la storia dei monumenti di Roma, II, Nuove evidenze sulla missione di
Canova a Parigi, «Rendpontacc», s. ix, V, 1994, pp. 739-761Pontormo. Disegni, intr. e cura di s.s. Nigro, genova, Costa & Nolan, 1991pope Hennessy, J., Renaissance Bronzes from the Samuel H. Kress Collection: Reliefs,
Plaquettes, Statuettes &c., London and New York, Miller, 1965— Italian Renaissance and Baroque Sculpture. An Introduction to Italian Sculpture, III, London,
phaidon, 1963, New York, Vintage Book, 19853
popHam, a.e., Catalogue of the Drawings of Parmigianino, 3 voll., New Haven and London, Yale U.p., 1971
Il braccio mancante154
popHam, a.e., Wilde, J., The Italian Drawings of the XV and XVI Centuries in the Collection of His Majesty the King at Windsor Castle, London, phaidon, 1949
prandi, a., La fortuna del Laocoonte dalla sua scoperta nelle terme di Tito, «RIa», n.s., III, 1954, pp. 78-107
pray BoBer, p., rUBinstein olitsky, r., Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Handbook of Sources, London, Miller, 1986
preiss, B., Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Laokoongruppe. Die Bedeutung Christians Gottlob Heynes für die Archäologie des 18. Jahrhunderts, Inaugural-diss. Rhein. Friedrichs-Wilhelms-Univ. zu Bonn, 1992, Bonn, Verlag u. datenbank f. geisteswiss., 1992
pressoUyre, s., Les fontes du Primatice à Fontainbleau, «BulMon», CXXVII, 1969, pp. 223- 239
Primatice. Maître de Fontainbleau, paris, Musée du Louvre, 2 sept. 2004 - 3 jan. 2005, comm. d. Cordellier, paris, Réunion d. Mus. Nationaux, 2004
QUeyrel, f., Une nouvelle image du Laocoon, «REa», VC, 1993, 1-2, pp. 301-315raddrizzani, d., Entre le serpent et la pomme: le Laocoon chez les néo-classiques suisses,
«Kunst + architektur in schweiz», XLVI, 1995, 4, pp. 356-367ramage HirsCHland, n., The Pacetti-Papers and the Restoration of Ancient Sculpture in the
18th Century, in Von der Schönheit (v), pp. 79-84raspe, M., Eisenhoit in Rom, in Wunderwerk (v), pp. 75-86raUmsCHlüssel, I., Zur rekostruktion des Laokoon durch Georg Treu, in Das Albertinum vor
100. Jahren. Die Skulpturensammlung Georg Treus, dresden, albertinum, 1994-1995, hrsg. v. K. Knoll, dresden, 1994, pp. 277-280
reBaUdo, L., I restauri del Laocoonte, in settis, Laocoonte (v), pp. 231-258— Per la fama di Laocoonte, «pdp», LIX, 2004, pp. 55-72reiss, s.e., Cardinal Giulio de’ Medici as a patron of art, 1513-1523, phd diss., princeton,
princeton Univ. (ma), 1992, I-III, ann arbor (mi), UMI, 1993Renaissance Master Bronzes from the collection of the the Kunsthistorisches Museum Wien,
smithsonian Institution traveling Exhibition serv. (Washington d.C., National gallery of art et alias), ed. by M. Leithe-Jasper, London, scala Books (in ass. with the smithsonian Inst. trav. Exhib. serv., Washington d.C.), 1986
renier, r., rec. a Joanne sabadino de li arienti, Gynevera de le clare donne, a c. di C. Ricci, a. Bacchi della seta (disp. 223a della scelta di Curiosità Letterarie), Bologna, Romagnoli dell’acqua, 1888, in «giornale storico della Letteratura Italiana», XI, 1888, pp. 205-218
reUmont, H., Urkundliches zur italienischen Kunstgeschichte. 4. Die Laokoongruppe del Bandinelli, «Kunstblatt», 1849, Heft 7, p. 26 s.
rezniCek, E.I.K., Die Zeichnungen von Hendrik Goltzius, Utrecht, Haentjens dekker & gumbert, 1961 (Utrechtse Kunsthistorische studien, 6)
riCCò trento, a., Le collezioni e i Musei archeologici nei libri del XVIII e XIX secolo, in L’immagine dell’antico (v), pp. 123-132
rinaldi, s., La tecnica della scultura nei trattati del Rinascimento. antologia di testi 1400-1584, [Roma], Lithos, 1994
— Tecnica e restauro della scultura lapidea nelle fonti dal Barocco al Neoclassicismo. antologia di testi 1650-1802, Roma, Lithos, 1996
[M. roCHer-JeaUneaU], L’oeuvre de Joseph Chinard (1755-1813) au Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon, audin, 1978
roCkWell, p., Lavorare la pietra. Manuale per l’archeologo, lo storico dell’arte e il restaura-tore, Roma, NIs, 1989
— Gli angeli di Ponte S. Angelo. La tecnica dello scultore, in La via degli Angeli. Il restauro della decorazione scultorea di ponte S. Angelo, a c. di L. Cardilli aloisi, M.g. tolo- meo speranza, Roma, de Luca, 1988
roettgen, s., Zum Antikenbesitz des Anton Raphael Mengs und zur Geschichte und Wirkung seiner Abguss- und Formensammlungen, in Antikensammlungen im 18. Jahrhunderts, a c. di H. Beck, p.C. Bol, W. prinz, H. von steuben, Berlin, gruyter, 1981, pp. 129-141
Bibliografia 155
Roma e lo stile classico di Raffaello. 1515-1527, Mantova, gall. Civica di palazzo te, 20 mar. - 30 mag. 1999; Wien, graphische samml. albertina, 23 giu. - 5 set. 1999, a c. di K. oberhuber, a. gnann, Milano, Electa, 1999
Rome and Venice. Prints of the High Renaissance, Cambridge (ma), Fogg art Museum, ed. by K. oberhuber, Cambridge, Cambridge U.p., 1974
rossi pinelli, o., Chirurgia della memoria. Scultura antica e restauri storici, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, III, Dalla tradizione all’archeologia, a c. di s. settis, torino, Einaudi, 1986, pp. 181-250
— Scultori e restauratori a Villa Borghese, in Collezionismo e ideologia. Mecenati, artisti e teorici dal classico al Neoclassico, a c. di E. debenedetti, Roma, Multigrafica, 1991, pp. 259-272
— Osservare, confrontare, dubitare. Ennio Quirino Visconti e i fondamenti della storia dell’arte antica, in Villa Borghese. I principi, le arti, la città dal Settecento all’Ottocento, Roma, Villa poniatowsky, 5 dic. 2003 - 21 mar. 2004, a c. di a. Campitelli, Milano, Electa, 2003, pp. 123-130
roWland, i.d., The Culture of the High Renaissance: Ancients and Moderns in sixteenth-century Rome, Cambridge and New York, Cambridge U.p., 1998
rUBinstein, r., The Statue of the River God Tigris or Arno, in Il Cortile delle Statue (v), pp. 275-286
salmi, m., Tommaso Bernabei detto il Papacello, «Bda», s. ii, III, 1923-1924, pp. 162-175.samoyaUlt, J.p., Le rémplois de sculpture et d’objècts d’art dans la décoration e l’ameublement
du Palais de Saint-Cloud sous le Consulat et le début de l’Empire, «Bulletin de la société de l’Histoire de l’art Français», 1971, pp. 153-191
sarCHi, a., Per Antonio Lombardo: fortuna e collezionismo. I rilievi per Alfonso d’Este, «artLomb», n.s., CXXXII, 2001, pp. 48-58
satzinger, g., Der “Statuenhof” Clemens’ VII. im Garten des Palazzo Medici in Florenz. Zur Laokoon-Zeichnungen der Albertina, inv. 48v, und zu Folio 28v im Codex Geymüller der Uffizien, A 7818v, in ‘Ars naturam adiuvans’. Festschrift für Matthias Winner zum 11 März 1996, a c. di V.V. Fleming, s. schütze, Mainz a. R., von Zabern, 1996, pp. 208-227
saUron, g., Un conflit qui s’éternise: la ‘Guerre de Sperlonga’, «Ra», 1997, 2, pp. 261-296sCHolten, F., Adrien de Vries (1556-1626) Imperial Sculptor, with contrib. by R. Mulcahy et al.,
amsterdam, Rijksmuseum; stockholm, Nationalmuseum; Los angeles, J.p. getty Museum, 1998
sCHUdt, l., Le guide di Roma. Materialien zu einer Geschichte der römischen Topographie. Benützung des Handschriftlichen Nachlasses von oskar pollak hrsg. v. L.s., Wien und augsburg, Benno Filser Verl., 1930 (Quelleschriften zur geschichte der Barock-Kunst in Rom)
sCHWeikHart, g., Studio e reinvenzione dell’antico nell’opera di Amico Aspertini, in Roma, centro ideale della cultura dell’Antico nei secoli XV e XVI. Da Martino V al Sacco di Roma, Roma, 25 - 30 nov. 1985, a c. di s. danesi squarzina, Milano, Electa, 1989, pp. 27-29
Scultori del Cinquecento, a c. di s. Valeri, Roma, Lithos, 1998settis, s., Laocoonte. Fama e stile, Roma, donzelli, 1999sHearman, J., Andrea del Sarto, 2 voll., oxford, Clarendon press, 1965siCCa, C.M., Pawns of international finance and politics: Florentine sculptors at the court of
Henry VIII, «Renstud», XX, 2006, pp. 1-34siCHtermann, H., Der wiederhergestellte Laokoon, «gymnasium», LXX, 1963, pp. 193-211siCkel, L., «Maria Mater Dei» und die Antiken Roms. Anmerkungen zu einem Kupferstich nach
Marten van Heemskerck, «ZfK», LXI, 1998, pp. 40-54sigHinolfi, L., Nicolò Tribolo e le sculture delle porte minori di S. Petronio, Modena, Ferraguti,
1910simon, e., Laokoon und die Geschichte der antiken Kunst, «aa», IC, 1984, pp. 643-672— Laokoon, in LIMC, VI/1 (1992), pp. 196-201
Il braccio mancante156
sittl, K., Empirische Studien über die Laokoongruppe, Würzburg, Kommissionverl. des städ. KB. Hof- und Universitäts-Buch- und Kunstverhandlung, 1895 (IV Jahresb. d. Kunstgeschichtlichen Museums d. Kgl. Univ. Würzburg)
Sotheby’s. Dessins Italiens du XIVe au XVIIe siècle. Michel Gand, München, 20 giugno 1987soUCHal, F., French Sculptors of the 17th and 18th Centuries. The Reign of Louis XIV. Illustrated
Catalogue, I-IV, oxford, Cassirer, 1977-1993sparti, d., Tecnica e teoria del restauro scultoreo a Roma nel Seicento, con una verifica sulla
collezione di Flavio Chigi, «storia dell’arte», XCII, 1998, pp. 60-131steadman sHeard, W., Antonio Lombardo’s reliefs for Alfonso d’Este’s Studio di Marmi: their
significance and impact on Titian, in Titian 500, a c. di J. Manca, «stHistart», XLV, 1993, pp. 314-357
straUss, W.L., Hendrik Goltzius, 1558-1617. The Complete Engravings and Wodcuts, New York, abaris Book, 1977
The University of Chicago Library. Departement of Special Collections. A Descriptive Catalogue of Engravings from the University of Chicago Library’s Speculum Romanae Magnificentiae (dattiloscritto).
tHode, H., Die Antiken in den Stichen Marcantons, Agostino Venezianos und Marco Dentes, Leipzig, Bibliograph. Institut, 1881
— Michelangelo. Kritische Untersuchungen über seine Werke, I-II, Berlin, de gruyter, 1908Titian and the Venetian Woodcuts, a Loan Exhib. org. and circulated by International Exhibitions
Foundation, ed. by d. Rosand, M. Muraro, Meriden (Co), Meridan gravure, 1976Tiziano e la silografia veneziana del Cinquecento, a c. di M. Muraro e d. Rosand. Introduzione
di F. Benvenuti. presentazione di R. pallucchini [Venezia, Fondazione giorgio Cini, s.d.], Vicenza, Neri pozza, 1976 (grafica veneta, s.n.)
tormo, e., «Os Desenhos das antigualhas que vio Francisco d’Ollanda, Pintor Portugués» (...1539-1540...). publicalos, con notas de estudio y preliminares, el prof. E.t., Madrid, s.n., 1940
UBeda de los CoBos, a., Un élément de pédagogie artistique: la collection de statues de plâtre de L’Académie de San Fernando a Madrid. 1741-1800, in L’anticomanie (v), pp. 327-337
Ulisse: il mito e la memoria, Roma, palazzo delle Esposizioni, 22 feb. - 2 set. 1996, a c. di B. andreae, C. parisi presicce, Roma, progetti Museali, 1996
van der meUlen, m., Rubens’ Copies after the Antique, 3 voll., London, Harvey Miller, 1994-1995 (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, part XXIII)
Van essen, C.C., La decouverte du Laocoon, «Medelingen der Koninklik Nederlandiske akademie van Wetenschappen/ofd. Letterkunde», XVIII, 1955, pp. 291-308 (poi in volume, con nuova pag.: La decouverte du Laocoon, amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1955)
van gelder, J.g., Jost, I., Jan de Bisschop and his Icones & Paradigmata. Classical Antiquities and Italian Drawings for artistic Instruction in Seventeenth Century Holland, I (tavv.)-II (testo), Beukenlaan, doornspijk davaco, 1985
van Helsdingen, H., Laokoon in the Seventeenth Century, «simiolus», X, 1978-1979, pp. 127-141.
van Regteren altena, I.Q., Jacques de Gheyn. Three Generations, 3 voll., the Hague, Boston and London, Nijhoff, 1983
Veldman, I.M., rec. a Facsimile of C. Hülsen, H. Egger, Die Römischen Skizzenbücher von Marten van Heemskerck, a c. di a. Netto Bol, soest 1975, «simiolus», IX, 1977, pp. 106-113
VentUri, a., Il gruppo del Laocoonte e Raffaello, «archstarte», II, 1889, pp. 97-112vergara Caffarelli, e., Studio per la restituzione del Laocoonte, «RIa», n.s., III, 1954, pp.
29-69Vivant-Denon, Colloque de Chalon-s.-saône, 14 et 15 mai 1999, textes réc. p. F. Claudon et B.
Bailly, Chalon-s.-saône, Comité Nat. p. le dévelop. de la Rech. et des Ét. s. la Vie et l’oeuvre de Vivant-denon, 1999
Bibliografia 157
Vivant Denon, Colloque de Chalon-s.-saône du 22 mars 1997, textes rec. p. F. Claudon et B. Bailly, Chalon-s.-saône, Univ. pour tous de Bourgogne & Ville de Chalon-s.-saône, 1999
Von der Schönheit weissen Marmors: zum 200. Todestag Bartolomeo Cavaceppis, schloss Wörlitz, galerie am grauen Haus, 19 Jun. - 5 sept. 1999, hrsg. v. th. Weiss, Mainz a. R., von Zabern, 1999 (Wiss. Bestandskat. d. staatl. schlösser und gärten Wörlitz, oranienbaum, Luisium, 2)
von salis, a., Antike und Renaisssance. Über Nachleben und Weiterwirken der Alten in der Neuen Kunst, Erlenbach und Zürich, Rentsch, 1947
von steUBen, H., Das Museo Pio-Clementino, in Antikensammlungen im 18. Jahrhunderts, a c. di H. Beck, p.C. Bol, W. prinz, H. von steuben, Berlin, de gruyter, 1981, pp.149-165
Weeke, W., Ein Römisches Antikenstichwerk von 1584, Frankfurt a. M., Berlin, Bern &c., Lang, 1997 (Europ. Hoschschulschr., R. xxxviii, Bd. 68)
Weil garris, K., On Pedestals: Michelangelo’s David, Bandinelli’s Hercules and Cacus and the Sculpture of the Piazza della Signoria, «RömJhbKg», XX, 1983, pp. 376-415
WesCHer, p., Kunstraub unter Napoleon, Berlin, Mann, 1976, trad. ital. I furti d’arte. Napoleone e la nascita del Louvre, torino, Einaudi, 1988
Winner, M., Zum Apoll von Belvedere, «JahrBerlMus», X, 1968, pp. 181-199— Zum Nachleben des Laokoon in der Renaissance, «JhbBerlMus», XVI, 1974, pp. 82-121— La collocazione degli dei fluviali nel Cortile delle Statue e il restauro del Laocoonte del
Montorsoli, in Il Cortile delle Statue (v), pp. 117-128— Paragone mit dem Belvederischen Apoll. Kleine Wirkungsgeschichte vom Antico bis Canova,
in Il Cortile delle Statue (v), pp. 227-252WittkoWer, R., Sculpture. Processes and Principles, London, penguin Books, 1977 (trad. ital.
La scultura raccontata da Rudolf Wittkower. Dall’antichità al Novecento, torino, Einaudi, 1985)
Wunderwerk. Göttliche Ordnung und vermessene Welt. Der Goldschmied und Kupferstecher Antonius Eisenhoit und die Hofkunst 1600, paderborn, Erzbischofl. diozesänmus; s.d., hrsg. v. Ch. stiegmann, Mainz a. R., von Zabern, 2003
Il braccio mancante158
p. 7» 13» 15» 16» 24» 30» 42» 53» 60» 68» 74» 76
» 81» 96» 97» 98» 99» 102
» 103
» 141
» 142
INdICE gENERaLE
paRtE I - I REstaURI dEL LAOCOONTE
I restauri
Lo stato di conservazione .............................................................La sequenza tradizionale dei restauri ..........................................Ipotesi virgiliane ...........................................................................Un’espunzione: Jacopo Sansovino ..............................................Baccio Bandinelli? .......................................................................Il braccio non finito ‘di Michelangelo’ ........................................Giovanni Angelo Montorsoli ........................................................Agostino Cornacchini ...................................................................Nuove braccia per Laocoonte e il figlio minore ..........................Il Laocoonte a Parigi: François Girardon ..................................Il ritorno a Roma: Antonio Canova .............................................Il braccio non più mancante: il ‘rispristino’ di Filippo Magi .......
paRtE II - IMMagINI dEL LAOCOONTE
Disegni e stampe (ds) ..................................................................Dipinti e affreschi (da) ................................................................Calchi (Ca) ...................................................................................Copie in grandezza naturale (Co) ...............................................Copie ridotte (Cr) ........................................................................Placchette e medaglie (pm) ..........................................................
REpERtoRIo ICoNogRaFICo ...............................................
REFERENZE FotogRaFICHE ................................................
BIBLIogRaFIa ..........................................................................
lUdoviCo reBaUdo
Il braccio mancante. I restauri del Laocoonte (1506-1957)Nuova edizione aggiornata
Ristampa riveduta e corretta della seconda edizione
«Varie dal passato» - 2
Editreg srlvia Ugo Foscolo 26, I-34139 trieste
tel./fax +39/040/362879; e-mail: [email protected]
IsBN 978-88-88018-60-7
Finito di stampare nel mese di luglio 2007 presso Lithostampa srl - via Colloredo 126, 33037 pasian di prato (Ud)