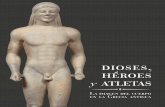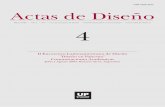La invención del cuerpo escultural. El desnudo en la Grecia clásica
Dalla Grecia a Palermo: riflessioni sull’immagine di una Vergine
Transcript of Dalla Grecia a Palermo: riflessioni sull’immagine di una Vergine
ISTITUTO SICILIANO DI STUDI BIZANTINI E NEOELLENICI“BRUNO LAVAGNINI”
Q U A D E R N I
18
BYZANTINO - SICULA VILA SICILIA E BISANZIONEI SECOLI XI E XII
Atti delle X Giornate di Studiodella Associazione Italiana di Studi Bizantini
(Palermo, 27-28 Maggio 2011)
a cura di Renata Lavagnini e Cristina Rognoni
PA L E RMO 2 0 1 4
Associazione italiana di studi bizantini
Byzantino-sicula 6. : La Sicilia e Bisanzio nei secoli 11. e 12. : atti delle 10. giornatedi studio della Associazione italiana di studi bizantini (Palermo, 27-28 maggio 2011)/ a cura di Renata Lavagnini e Cristina Rognoni. - Palermo : Istituto siciliano di studibizantini e neoellenici Bruno Lavagnini, 2014. (Quaderni / Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici Bruno Lavagnini ; 18) ISBN 978-88-904623-3-71. Sicilia – Sec. 11.-12. – Atti di congressi.I. Lavagnini, Renata. II. Rognoni, Cristina.945.803 CDD-22 SBN Pal0273000
CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”
Pubblicato con il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana
ISBN: 9788890462337
ISSN: 0075-1545
© Copyright Istituto Siciliano di Studi bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini” 2014
SOMMARIO
PROGRAMMA DEL CONVEGNO . . . . . Pag. VII
SPADAROM. D. , Rivendicazioni bizantine della Sicilia nel-le fonti storico-cronachistiche . . . . » 1
KOUTRAKOU N., The eye of Costantinople: continuity and change in the 11th. - 12th. century byzantine perception of Sicily . . . . . . . » 21
GENTILE MESSINA R., I rapporti tra Sicilia e Bisanzio (sec.XII) nelle fonti bizantine e occidentali . . . » 51
ORIGONE S., La Sicilia nelle relazioni tra Bisanzio e le cit-tà italiane . . . . . . . » 63
STRANO G., La campagna antinormanna per la riconquista di Corfù (1149): schemi ideologici e contingenza storicanelle fonti letterarie bizantine . . . . » 75
BURGARELLA F., Bisanzio e gli Altavilla . . . » 95
ACCONCIA LONGO A., La letteratura italogreca nell’XI e XII secolo . . . . . . . » 107
LUCÀ S., La produzione libraria . . . . » 131
NEIRYNCK S., Nil Doxapatres et son De Oeconomia Dei. La théologie byzantine en terre sicilienne au XIIe siècle » 175
BUCCA D., I manoscritti innografico-musicali greci nella Sicilia normanna: qualche riflessione . . . » 187
ENZENSBERGER H., Modelli romani in Sicilia? Santa Ma-ria della Grotta a Palermo . . . . » 201
VON FALKENHAUSEN V., I documenti greci di S. Maria del-la Grotta rinvenuti a Termini Imerese . . . » 215
MORETTI S., Dalla Grecia a Palermo: riflessioni sull’im-magine di una Vergine . . . . . » 243
BRENK B., Concetto e significato dei mosaici e delle pittu-re della Cappella Palatina a Palermo . . . » 257
ZORIć V., Considerazioni sulla Cappella Palatina. . » 275
LONGO R., Opus sectile a Palermo nel secolo XII. Siner-gie e mutuazioni nei cantieri di Santa Maria dell’Am-miraglio e della Cappella Palatina . . . » 299
INDICE DEI NOMI . . . . . . » 343
TAVOLE . . . . . . . » 377
SIMONA MORETTI
DALLA GRECIA A PALERMO:RIFLESSIONI SULL’IMMAGINE DI UNA VERGINE
Giorgio, primo ministro e grande ammiraglio di Ruggero II, dovevarientrare a Palermo abbastanza soddisfatto delle sue vittorie: la campagnadel 1147 aveva infatti permesso la conquista di Tebe e dei territori circo-stanti. Ingenti tesori erano stati raccolti nella fortezza di Acrocorinto, ca-duta in mano normanna, e assieme a questi anche uomini di Tebe e Corinto,esperti nella manifattura della seta, narrano le fonti, vennero portati in Si-cilia1.
IL DOCUMENTO E LA SUA MINIATURA
Tra i tesori saccheggiati vi era probabilmente anche il documento grecoda cui il nostro racconto prende avvio.
Prima di licenziare per la stampa questo contributo mi fa piacere ringraziare il prof. Antonio Ia-cobini per i suggerimenti e la lettura del testo quando ancora era privo delle note, la prof.ssa RenataLavagnini e il dott. Lorenzo Riccardi per le indicazioni bibliografiche, la prof.ssa Marina Scarlataper avermi segnalato gli atti del 1328 (citati alla fine dell’articolo), la prof.ssa Maria Tilde Bettetiniper l’incoraggiamento nell’interpretazione delle fonti medievali, i dott.ri Stefano Riccioni, GiuliaGrassi e Livia Bevilacqua per le interessanti conversazioni su alcuni aspetti dello studio. Nell’estatedello stesso anno in cui presentai i risultati di queste ricerche alla X Giornata di Studi dell’Asso-ciazione Italiana di Studi Bizantini, ne diedi notizia al Congresso Internazionale di Studi Bizantini(Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011,III, Abstracts of Free Communications, ed. by A. Nikolov, with the assistance of E. Kostova andV. Angelov, Sofia 2011, pp. 350-351), in attesa della pubblicazione degli Atti che qui vedono la luce.
1 NICETA CONIATA, Grandezza e catastrofe di Bisanzio (narrazione cronologica), I, Libri I-VIII,Introduzione di A. KAZHDAN, Testo critico e commento a cura di R. MAISANO, traduzione di A.PONTANI, Roma-Milano 1994 (Scrittori greci e latini), pp. 172-177 (III.2, 4-6); per i tessitori: ibid.,pp. 224-225 (III.13, 10).
Si tratta dello statuto della confraternita clerico-laicale di S. Maria diNaupaktos, redatto nel 1048, ma riscritto, perché corroso, e firmato nuo-vamente 1080 e 1120 o, più precisamente, tra 1092 e 1118 (fig. 1)2. La con-fraternita era dedita a promuovere il culto dell’icona della VergineNaupattitissa proprietà delle monache di Naupaktos stabilitesi nei pressidi Tebe. Questa più recente versione del cosiddetto typicon, costituita dadue fogli di pergamena lunghi circa 143 cm e larghi circa 42, è conservatanel Tesoro della Cappella Palatina a Palermo (Tabulario n. 1)3.
La pergamena, a partire dalla metà del Settecento, è stata ripetutamentepubblicata4, dunque il documento è ben noto; altrettanto celebre è la mi-niatura, che appare sul primo foglio in alto, con la figura stante di Maria inatteggiamento di supplica verso Cristo evocato – si vede oggi una stella – oforse effigiato – come alcuni studiosi hanno creduto di vedere nelle tracce
S. MORETTI244
2 Le datazioni sono fornite rispettivamente in J. NESBITT, J. WIITA, A Confraternity of theComnenian Era, in Byzantinische Zeitschrift, 68, 1975, pp. 360-384: 375-376, e A. CUTLER, W.NORTH, The Gift of Service: the Charter of the Confraternity of the Virgin of Naupaktos, in Dona-tion et donateurs dans le monde byzantin, éd. par J.-M. SPIESER, É. YOTA, Actes du colloque in-ternational de l’Université de Fribourg (13-15 mars 2008), Paris 2012 (Réalités byzantines, 14),pp. 207-219: 214.
3 Nell’inventario della Cappella Palatina del 1309 la pergamena è così menzionata: «Privile-gium unum habens figuram Virginis Mariae in carta membrana de litera greca»: cfr. L’età nor-manno e sveva in Sicilia. Mostra storico-documentaria e bibliografica, a cura di R. LA DUCA,catalogo della mostra (Palermo, Palazzo dei Normanni, 18 novembre-15 dicembre 1994), Palermo1994, pp. 28-29, nr. 1. Sull’inventario si veda ora M. ANDALORO, La Cappella Palatina di Palermoe l’inventario del 1309 fra analisi e ragionamenti, in Nobiles Officinae. Perle, filigrane e trame diseta dal Palazzo Reale di Palermo, a cura di M. ANDALORO, catalogo della mostra (Palermo, Pa-lazzo dei Normanni, 17 dicembre 2003-10 marzo 2004 / Vienna, Hofburg, Schweizerhof, AlteGeistliche Schatzkammer, 30 marzo-13 giugno 2004), II, Catania 2006, pp. 91-115. Il fatto chenell’inventario sia registrata anche la presenza dell’immagine della Vergine è un dato significa-tivo.
4 Per la bibliografia sulla pergamena mi limito a rimandare a M.R. MENNA, La miniatura conla Vergine Haghiosoritissa nella pergamena della confraternita di S. Maria la Naupattitissa, in No-biles Officinae, I, pp. 546-547, nr. VIII.15 (con bibliografia). A cui aggiungo N.K. KAPÔNÊS, ΗΜεσοβυζαντινή Aδελφότητα της Παναγίας “Ναυπακτιωτίσσης”. Συμβολή στην μελέτη της ιδιωτικήςλατρείας των μέσων χρόνων στην Θήβα, in Βυζαντινός Δόμος, 12, 2001, pp. 49-64 (ripubbl. nel2008); N.K. KAPÔNÊS, Ιστορικές αναφορές και μαρτυρίες για την λατρεία της Παναγίας στην Ναύ-πακτο την βυζαντινή περίοδο, in Βυζαντινός Δόμος, 15, 2006, pp. 233-249, e, per alcuni aspetti sto-rico-artistici, in ultimo CUTLER, NORTH, The Gift of Service, p. 213 (la miniatura, considerandoil rapporto tra testo e immagine, «is not an icon of the Virgin but an icon of an icon, of the vene-ration she received in the monastery in question and, by extension, of her cult in the spaces towhich she traveled») e S. MORETTI, I colori della fede: icone a smalto e a mosaico tra X e XIVsecolo, in Vie per Bisanzio, a cura di A. RIGO, A. BABUIN, M. TRIZIO, Atti del VII congresso na-zionale dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini (Venezia, 25-28 novembre 2009), Bari 2013,pp. 997-1011: 1007-1008 (con considerazioni differenti).
di colore – nel segmento di cielo a sinistra (fig. 2)5. Si è supposto che tale rappresentazione ritragga l’icona venerata dalla
confraternita: lo proponeva già Gioacchino Di Marzo nel 1859 (fig. 3)6 elo ha affermato più recentemente, nel 1992, anche Nicolas Oikonomides7.
UN’ICONA A SMALTO O A MOSAICO?
Se l’ipotesi è, come credo, corretta, non si è mai affrontato invece il pro-blema di quale potesse essere, tecnicamente parlando, l’aspetto dell’iconache questa miniatura riproduce8. A mio avviso infatti la copia su pergamenaci fornisce alcuni indizi per suggerire che l’icona venerata dalla confraternita,più che un’opera su tavola dipinta a tempera, fosse piuttosto un preziosoesemplare a smalto o a mosaico. In particolare mi sembrano dichiararlo lacornice interna a crocette (che appare su diverse icone musive) e il pavi-mento a scacchiera (quest’ultimo, ad esempio, lo ritroviamo, seppure conmotivi diversi, su numerose immagini a micromosaico di epoca paleologa).
Il motivo a pelte del suppedaneo su cui sta la Vergine evoca testimo-nianze di antica memoria, dai pavimenti a mosaico alla scultura, ma lo rin-veniamo pure su opere a smalto dell’XI secolo. La cornice esterna, rossa,potrebbe rappresentare la cornice in legno dell’icona originale.
La miniatura misura 28 x 13 cm e non è escluso che possa costituire,eccezionalmente, la copia uno a uno dell’icona da cui essa deriva, come miha suggerito Antonio Iacobini, che ringrazio, durante un sopralluogo fattoinsieme ormai circa tre anni fa nel Tabulario della Palatina. Le misure dellaminiatura concordano con quelle delle icone a micromosaico dell’età pa-leologa9, mentre più difficile si presenta il confronto – sempre sul piano
5 NESBITT, WIITA, A Confraternity, p. 362; KAPÔNÊS, Ιστορικές αναφορές, p. 234. Cfr. inoltreCUTLER, NORTH, The Gift of Service, p. 210.
6 G. DI MARZO, Delle Belle Arti in Sicilia dai Normanni sino alla fine del secolo XIV, II, Pa-lermo 1859, p. 23: «pur la Madonnina che vi sta in capo miniata è senza dubbio ritratta dalla pri-mitiva immagine che nel santuario veneravasi». Come si evince dall’incisione di Saverio Pistolesi,su disegno dell’abate Patricola (Giovanni Patricolo?), che Di Marzo pubblica, la stella nel semi-cerchio del cielo era già presente a quella data.
7 N. OIKONOMIDES, The First Century of the Monastery of Hosios Loukas, in Dumbarton OaksPapers 66, 1992, pp. 245-255: 248.
8 Questione già anticipata in MORETTI, I colori della fede, pp. 1007-1008.9 Segnalo alcuni casi le misure qui riportate escludono la cornice che invece nel caso della
miniatura, qualora la cornice rossa alludesse a quella lignea originale, la includerebbero): l’icona
DALLA GRECIA A PALERMO 245
delle dimensioni – con le icone a smalto giunte sino a noi, per la scarsitàdelle testimonianze e per il destino che la storia ha riservato spesso a questipezzi, frutto di reimpiego o di stratificazioni di interventi10.
L’interpretazione che la miniatura costituisca una copia fedele, anchein termini di misure, dell’icona del monastero delle Naupattitisse si accordainoltre armoniosamente con quanto si legge di essa nel typicon: l’icona cam-biava spesso luogo, sostando periodicamente, per la durata di un mese, inuna chiesa per poi passare ad un’altra chiesa accompagnata da una proces-sione con canti; processione per partecipare alla quale i membri della con-fraternita, provenienti anche da altre città e località della Grecia centrale,accorrevano. Questo uso liturgico, di cui altri hanno discusso l’origine, po-teva essere agevolato appunto dalle dimensioni ridotte dell’immagine11,anche se esso non rappresenta – è naturale – un dato riferibile solo alleopere di piccolo formato.
È già stato ampiamente sottolineato il nesso tra icone a smalto e icone amosaico, evidente nella concordanza sia di motivi decorativi sia dell’effettodella materia12. E di recente sono stati cercati i legami tra queste opere mi-nute di età paleologa e sia le imprese monumentali, pittoriche e musive deltempo, sia gli artisti di quel periodo, come Manuele Panselinos, MicheleAstrapas ed Eutychios13.
In ogni caso il ‘dialogo’, se così vogliamo chiamarlo, tra opere suntuariea smalto e a mosaico è evidente ed è registrabile anche sul piano lessicale,perlomeno in tempi moderni14.
S. MORETTI246
con la Crocifissione nella Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst degli Staa-tliche Museen di Berlino (Nr. 6431), della fine XIII-inizio XIV secolo, è alta 26 cm e larga 19,5;l’icona con i Quaranta Martiri di Sebaste nella Byzantine Collection del Dumbarton Oaks di Wa-shington (BZ.1947.24), del XIV secolo, è alta 22 cm e larga 16; l’icona con san Giovanni Crisostomonella stessa collezione americana (BZ.1954.2), sempre del XIV secolo, è alta 18 cm e larga 13.
10 Mi limito qui a riportare pochi esempi: l’icona con san Michele a mezzo busto nel Museodi San Marco a Venezia, databile alla seconda metà/fine X - prima metà XI secolo, misura con lacornice, che è frutto di un intervento duecentesco, 47,8 x 35,8 cm, senza cornice 23,5 x 20,2 cm;l’icona con san Michele stante sempre nello stesso Museo, della fine XI - inizi XII secolo, misuracon la cornice (coeva) 46,5 x 35 cm; l’icona con san Demetrio nel Kunstgewerbemuseum degliStaatliche Museen di Berlino (Nr. 1927, 21), dell’XI secolo, misura 14,5 x 8,7 cm; mentre la placcacon Cristo Pantocrator al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia a Roma (PV 1485), ricondottaalla fine XII-inizio XIII secolo, è una delle più grandi e misura ben 69 x 19,5 cm.
11 MORETTI, I colori della fede, n. 58 a p. 1008.12 I. FURLAN, Le icone a mosaico, Milano 1979, pp. 10-11.13 E.C. RYDER, Micromosaic Icons of the Late Byzantine Period, PhD Thesis, supervisor: prof.
T. Matthews, New York University, 2007.14 Cfr. MORETTI, I colori della fede, pp. 1005-1006.
A PALERMO NEGLI ANNI DI RUGGERO II
Ma torniamo ora a Palermo e agli anni del regno di Ruggero II (1130-1154), quando compaiono nel giro forse di un decennio diverse immaginidell’Haghiosoritissa.
Abbiamo già visto le probabili modalità dell’arrivo nella capitale del ty-picon della confraternita greca; puntiamo ora l’attenzione sul ben noto mo-saico in S. Maria dell’Ammiraglio con la Vergine e Giorgio di Antiochia(fig. 4), un tempo nel nartece della chiesa, dove è rappresentato lo ktetoringinocchiato ai piedi di Maria – a cui l’antiocheno è particolarmente de-voto – che intercede.
A seconda della datazione che sosterremo per la realizzazione del pan-nello (cioè ante 1140 oppure post 1146), allora il rapporto tra la miniaturae l’immagine, che qui supponiamo esistere, cambia: la miniatura potrebbecostituire un ricordo nel caso della cronologia anticipata oppure potrebbeaver funzionato da ispirazione nel secondo caso.
Se seguiamo l’ipotesi, di recente ribadita, di Augusta Acconcia Longo,che ritiene la chiesa del potente ammiraglio conclusa, anche nel suo appa-rato musivo, già nel 114015, allora si potrebbe ipotizzare che, durante lacampagna bellica in Grecia, fosse stato proprio Giorgio di Antiochia aprendere con sé e a portare a Palermo la pergamena della confraternita diS. Maria di Naupaktos, perché quell’immagine gli ricordava la Vergine cheintercedeva per lui e per i suoi cari nella sua chiesa palermitana.
Se invece aderiamo alla datazione generalmente abbracciata dagli storicidell’arte, che collocano la fondazione della chiesa e la sua decorazione mu-siva tra il 114316 (o poco prima) e il 1151, e in particolare l’esecuzione dei
15 A. ACCONCIA LONGO, Gli epitaffi giambici per Giorgio di Antiochia per la madre e per lamoglie, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 61, 1981, pp. 25-59; A. ACCONCIA LONGO, S. Maria Chrysè e S. Maria dell’Ammiraglio a Palermo, in Rivista di studibizantini e neoellenici n.s. 25, 1988, pp. 165-183; A. ACCONCIA LONGO, Considerazioni sulla chiesadi S. Maria dell’Ammiraglio e sulla Cappella Palatina di Palermo, in Νέα Ρώμη 4, 2007, pp. 267-293.
16 Si tratta dell’anno riportato sull’atto di dotazione, scritto in lingua greca ed araba, per il qualemi limito a citare: B. LAVAGNINI, L’epigramma e il committente, in Dumbarton Oaks Papers 41, 1987,pp. 339-350; E. KITZINGER, I mosaici di Santa Maria dell’Ammiraglio a Palermo, Palermo 1990 (Isti-tuto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici. Monumenti, 3), pp. 15-16; C. ROGNONI, Donazionie ricompense: la retorica bizantina al servizio del potere normanno, in Byzantino-Sicula V. Giorgio diAntiochia. L’arte della politica in Sicilia nel XII secolo tra Bisanzio e l’Islam, Atti del Convegno Inter-nazionale (Palermo, 19-20 Aprile 2007), a cura di M. RE, C. ROGNONI, Palermo 2009 (Istituto Sici-liano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini. Quaderni 17), pp. 203-218: 208.
DALLA GRECIA A PALERMO 247
mosaici del nartece tra il 1146 e il 115117, allora possiamo ipotizzare che l’-Haghiosoritissa del famoso pannello monumentale sia, per così dire, ispirataalla pregiata miniatura bizantina arrivata da poco a Palermo. Thomas Dit-telbach, qualche anno fa, sottolineava appunto come l’iconografia presentesul pannello musivo fosse già nota a Palermo proprio grazie alla miniaturache fa da incipit al nostro documento18.
Volendo potrebbe esserci anche una terza via, improbabile a dire il vero,che salva la datazione avanzata da Acconcia Longo e la ‘derivazione’ pro-posta da Dittelbach: i mosaici del nartece potrebbero essere stati eseguiti adistanza di tempo da quelli dell’interno. Ostacola però quest’ultima spie-gazione il dato stilistico: i mosaici del nartece sono infatti di mano deglistessi maestri attivi all’interno, anche se forse possono considerarsi di unafase un po’ più tarda19; insostenibile, dunque, pensare ad un ritorno in locodella medesima bottega dopo sei/sette anni, forse di più.
In quel torno di tempo, cioè in età ruggeriana, dovrebbe aver fatto lasua comparsa a Palermo anche la Vergine Haghiosoritissa, oggi conservataal Museo Diocesano della città (inv. 1; fig. 5), ma proveniente dalla catte-drale dove è attestata almeno dal 185920. Secondo Maria Andaloro, che perprima ha sollevato l’attenzione sull’opera, il pezzo potrebbe risalire all’etàruggeriana o, con meno probabilità, al tempo di Guglielmo II (1166-
S. MORETTI248
17 La prima data è fornita da un documento del 1146 dove si registra l’acquisto presso lachiesa di una casa, una stalla e un terreno con ruderi, anno che può costituire il termine postquem per la costruzione del portico, dell’atrio e del campanile che andarono ad occupare quellospazio appena comprato. La seconda data è l’anno di morte di Giorgio, che compare vivo nelpannello musivo con la Vergine. Sul documento del 1146 (ma non sugli epigrammi sepolcrali e iversi trascritti sul retro) mi limito a menzionare: L. PERRIA, Una pergamena greca dell’anno 1146per la chiesa di S. Maria dell’Ammiraglio, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archivenund Bibliotheken 61, 1981, pp. 1-24; LAVAGNINI, L’epigramma e il committente, pp. 343, 346-348;KITZINGER, I mosaici di Santa Maria dell’Ammiraglio, pp. 16-17 e n. 12. Sui mosaici del nartecesegnalo solamente l’ormai classico KITZINGER, I mosaici di Santa Maria dell’Ammiraglio, pp. 190-213, 315-320; per l’architettura del nartece S. ĆURčIĆ, L’architettura, ibid., pp. 27-104: 42-48. Peruna recente lettura del pannello musivo con Cristo e Ruggero II, lettura che si discosta da quellageneralmente accettata dalla critica, si veda M. VAGNONI, Le rappresentazioni del potere. La sa-cralità regia dei Normanni di Sicilia: un mito?, Bari 2012, pp. 13, 19, 40-43, 63, 71-74, 110-111 epassim. La chiesa di S. Maria dell’Ammiraglio è stata recentemente oggetto di un restauro duratocirca due anni (2010-2012).
18 T. DITTELBACH, The Image of the Private and the Public King in Norman Sicily, in RömischesJahrbuch der Bibliotheca Hertziana 35, 2003-2004 (ma 2005), pp. 149-172: 157.
19 KITZINGER, I mosaici di Santa Maria dell’Ammiraglio, pp. 232-235, 264.20 Mi limito a segnalare: M. ANDALORO, La Vergine Haghiosoritissa della Cattedrale di Palermo,
in Nobiles Officinae, I, pp. 558-559, nr. VIII.19, che rimanda alla testimonianza di DI MARZO,Delle Belle Arti in Sicilia, II, n. 2 a p. 110.
1189)21. Al confronto già proposto dalla studiosa tra questa immagine e al-cuni brani musivi nel santuario della Cappella Palatina (siamo negli anniQuaranta del XII secolo22), aggiungo quello con la Vergine rappresentataproprio sul pannello dedicatorio di Giorgio d’Antiochia (fig. 4).
L’opera del Museo Diocesano è stata restaurata, come è evidente in di-versi punti e nel fondo, completamente rifatto, dove, stranamente, noncompare l’aureola23. Mi chiedo se anche quest’immagine – che non sap-piamo se fosse in origine così isolata o parte di una Deesis, a mezzobusto oa figura intera – non potesse essere accompagnata dal Figlio, evocato op-pure effigiato nel segmento di cielo24. In base ai dati attualmente disponibilinon è dato sapere.
Ora nella citazione delle opere mi arresto al contesto palermitano e aglianni del regno di Ruggero II (escludendo quindi le testimonianze di incertacronologia o inquadramento come, ad esempio, la Deesis25 che comparesulla Stauroteca di Cosenza, datata anche alla metà del XII secolo26, oppurei mosaici del catino absidale della Cappella Palatina dove la santa Madda-lena, risultato dei restauri settecenteschi, potrebbe sostituire la Vergine che
21 ANDALORO, La Vergine Haghiosoritissa, p. 559.22 Per la maggior parte degli studiosi i mosaici delle pareti del santuario vennero realizzati
negli anni successivi al 1143 (data riportata alla base della cupola), per Brenk invece tutto – ilproblema riguarda prevalentemente i mosaici della navata – doveva essere già concluso verso il1143 o poco dopo [B. BRENK, L’importanza e la funzione della Cappella Palatina di Palermo nellastoria dell’arte, in La Cappella Palatina a Palermo - Saggi, a cura di BRENK, Modena 2010 (MirabiliaItaliae, 17), pp. 27-78: 34-37; BRENK, Rhetorik, Anspruch und Funktion der Cappella Palatina inPalermo, in Die Cappella Palatina in Palermo. Geschichte, Kunst, Funktionen, hrsg. TH. DITTEL-BACH, Künzelsau 2011, pp. 247-271: 259-260; B. BRENK, I volti delle botteghe bizantine. Nuoveosservazioni e conclusioni sulle tecniche dei mosaicisti nella Cappella Palatina di Palermo, in Artemedievale IV, s. 3, 2013, in corso di stampa]. La Cappella Palatina è stata riaperta al pubblico nel2008 dopo i lavori di restauro che hanno dato avvio ad una rinnovata fase di studi.
23 È documentato un intervento di Rosario Riolo nel XIX secolo (DI MARZO, Delle Belle Artiin Sicilia, II, n. 2 a p. 110). Cfr., inoltre, E. KITZINGER, I mosaici del periodo normanno in Sicilia,VI, La cattedrale di Cefalù, La cattedrale di Palermo e il Museo Diocesano, Mosaici profani, Palermo2000, p. 16 e, in ultimo, ANDALORO, La Vergine Haghiosoritissa, p. 559.
24 L’immagine, che oggi misura 49/45 x 33/32 cm, potrebbe essere stata resecata. In occasionedella mostra La bella Italia (cit. a n. 33) è stato eseguito dal dott. Mauro Sebastianelli un restauroconsistente in una manutenzione ordinaria; purtroppo ho tentato invano di recuperare notiziesu questo intervento e al momento ignoro se sia stato possibile analizzare il pezzo senza cornice,come già auspicato da ANDALORO (in ultimo La Vergine Haghiosoritissa, p. 558).
25 Pur ricordando l’indipendenza dell’Haghiosoritissa dalla Deesis, ma la difficile distinzionefra l’Haghiosoritissa e la Vergine della Deesis a partire dal XII-XIII secolo (M. ANDALORO, Notesui temi iconografici della Deesis e della Haghiosoritissa, in Rivista dell’Istituto Nazionale d’Ar-cheologia e Storia dell’Arte n.s. 17, 1970, pp. 85-153: 137-143).
26 M.P. DI DARIO GUIDA, Stauroteca, in Nobiles Officinae, I, pp. 226-231, nr. III.33.
DALLA GRECIA A PALERMO 249
intercede27, o ancora l’icona, trasformata in pace, nel Tesoro della cattedraledi Palermo che mostra l’Haghiosoritissa dipinta nel Trecento forse su unmodello precedente, del XII secolo28) e mi domando: tra i mosaici citati ela miniatura/icona venerata dalla confraternita greca vi è effettivamente unacorrelazione? E qualora la correlazione vi fosse, interessa solo l’iconografiao anche la scelta del medium da utilizzare?
Proviamo a rispondere. Anzi facciamo rispondere le testimonianze visivee i documenti scritti del tempo. Abbiamo visto come negli anni del regnodi Ruggero II compaiano nella stessa Palermo diverse immagini dell’Ha-ghiosoritissa; iconografia assente, a quanto mi è dato sapere, nei decenniprecedenti e nel panorama della Sicilia bizantina29. Certamente i Bizantini,
S. MORETTI250
27 Cfr. O. DEMUS, The Mosaics of Norman Sicily, London 1949, pp. 37, 55 e nt. 77 a p. 63; A.CUTLER, Under the Sign of the Deesis: on the Question of Representativeness in Medieval Art andLiterature, in Dumbarton Oaks Papers, 41, 1987, pp. 145-154: 145. Sui restauri della Palatina siveda ora M.G. AURIGEMMA, Palinsesto Palatina. Le arti, le trasformazioni, gli usi e i restauri daFederico II ai Savoia, in La Cappella Palatina a Palermo - Saggi, pp. 203-272: 221 e n. 255 a p. 264.Cfr., inoltre, BRENK, Il presbiterio, in La Cappella Palatina a Palermo - Schede, pp. 669-676: 673,676. L’inventario della Cappella Palatina di Palermo del 1309 menziona tre icone che formanouna Deesis, ma ovviamente non è dato sapere a che età risalgano (ANDALORO, La Cappella Palatinadi Palermo e l’inventario del 1309, pp. 91-115: 108, n. 73).
28 Mi limito a menzionare: ANDALORO, Note sui temi iconografici, pp. 85-92; M.C. DI NATALE,Ori e argenti del Tesoro della Cattedrale di Palermo, in DI NATALE, M. VITELLA, Il Tesoro dellaCattedrale di Palermo, saggio introduttivo di L. BELLANCA e G. MELI, Palermo 2010, pp. 39-107:54-55. Si veda, inoltre, con ulteriore bibliografia: http://www.unipa.it/oadi/index.php?option=com_content&task= view&id=360&Itemid=242
29 Monete e sigilli raffiguranti l’Haghiosoritissa circolavano in età comnena nell’impero bi-zantino (mi limito a menzionare: T. BERTELÈ, La Vergine aghiosoritissa nella numismatica bizantina,in Revue des études byzantines 16, 1958, pp. 233-234; ANDALORO, Note sui temi iconografici, pp.120-122). Un sigillo della chiesa di Agrigento, datato però 1182, quindi più tardo dell’età di Rug-gero II, riporta sul recto proprio questo tipo della Vergine (L’età normanno e sveva, pp. 98-99,nr. 32), mentre il sigillo di Giorgio di Antiochia sulla pergamena del maggio 1143 (Palermo, Cap-pella Palatina, Tabulario, n. 8) presenta sul recto la Vergine orante con le braccia aperte ed elevate(ibid., pp. 58-61, nr. 13). Questo tipo della Madre di Dio (frontale e con le braccia alzate) comparesu una moneta di Teodoro Comneno Duca, imperatore di Salonicco (1224-1230), coniata dunquedalla zecca tessalonicese, e viene definito Haghiosoritissa (BERTELÈ, La Vergine aghiosoritissa, p.234: lo studioso sottolinea questa mescolanza di tipi figurativi; ANDALORO, Note sui temi icono-grafici, p. 121, fig. 30). Sulla problematica questione del rapporto tra l’immagine e il suo “nome”si veda: A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Vergine orante e Vergine in preghiera: l’immagine e il suo nome,in Deomene. L’immagine dell’orante fra Oriente e Occidente, a cura di A. DONATI, G. GENTILI,catalogo della mostra (Ravenna, Museo Nazionale, 25 marzo-24 giugno 2001), Milano 2001, pp.33-39. Sulle icone e i loro epiteti cfr. anche B.V. PENTCHEVA, Icone e potere. La Madre di Dio a Bi-sanzio, Milano 2010 (ed. ingl. The Pennsylvania State University 2006), pp. 100-108. Su alcunisigilli dell’ammiraglio: V. PRIGENT, L’archonte Georges prôtos ou émir?, in Revue des études byzan-tines, 59, 2001, pp. 193-207; V. PRIGENT, Notes sur la tradition sigillographique byzantine dans leroyaume normand de Sicile, in L’héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle), II, Les cadres ju-
ma anche i Normanni, erano devoti alla Vergine, e il culto verso la Madredi Dio è attestato a Palermo, oltre che dalle testimonianze visive e monu-mentali, dalle fonti e, in seguito, dalla letteratura erudita. Per quanto ri-guarda le fonti ricordo, a titolo di esempio, il documento su cui Vera vonFalkenhausen ha sollevato l’attenzione: in S. Maria della Grotta a Palermosi venerava un’immagine della Vergine, infatti Eugenio του� Καλοῦ, legato aquesto monastero greco, nel 1183, per far fronte ad una grave malattia deipiedi che lo assillava, offre per l’illuminazione di tale immagine un orto vi-cino alla sinagoga di Palermo30. Relativamente alle letture erudite sia suffi-ciente citare i contributi sei e settecenteschi di Ottavio Caietano, TommasoTamburini e Antonino Mongitore, che ricordano, tra altro, un’antica im-magine di Maria con il Bambino, «dipinta in tavola alla greca» e dispensa-trice di miracoli, venerata proprio in S. Maria della Grotta.31
Il rapporto tra la miniatura del typikon (fig. 2) e il pannello di dedicadella Martorana (fig. 4) per ora non si può chiarire oltre una certa misura,ma appare innegabile dal momento che entrambe le opere vedono coin-volto il grande ammiraglio del primo sovrano normanno. Abbiamo poimenzionato il pezzo del Museo Diocesano (fig. 5), ritenuto ora icona32 ora
ridiques et sociaux et les institutions publiques, études réunies par J.-M. MARTIN, A. PETERS-CUS-TOT, V. PRIGENT, Actes des tables rondes tenues à Rome les 4 et 5 mai 2009 et les 26 et 27 février2010, Rome 2012 (Collection de l’École française de Rome, 461), pp. 605-641: 610, 613-614, 626,figg. 5, 15 e 15bis.
30 V. VON FALKENHAUSEN, I funzionari greci nel regno normanno, in Giorgio di Antiochia, pp.165-202: 194. Riguardo alla venerazione di un’altra immagine della Theotokos in Palermo, intornoal 1140, sulla cui esistenza però la critica non concorda, si veda più avanti nel testo. Sulla diffu-sione del culto dell’icona costantinopolitana dell’Hodighitria alla corte normanna mi limito a ri-mandare a S. PIAZZA, L’Odighitria della cosiddetta cripta della Palatina, in Nobiles Officinae, I,pp. 548-549, nr. VIII.16: 549.
31 T. TAMBURINI in O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti della Santissima Vergine Nostra Signorapiù celebri, che si riveriscono in varie Chiese nell’Isola di Sicilia, aggiuntavi una breve relationedell’Origine e Miracoli di quelli…, Palermo 1664, rist. anastatica Palermo 1991, p. 107; A. MON-GITORE, Palermo divoto di Maria Vergine e Maria Vergine protettrice di Palermo, I-II, Palermo1719-1720: II, p. 259-264; MONGITORE, Storia delle chiese di Palermo. I conventi, edizione criticaa cura di F. LO PICCOLO, II, Palermo 2009, p. 132 e incisione da Caietano a p. 155. Per l’operadi Caietano e Tamburini, e in particolare per l’icona mariana nella grotta, si veda: DI NATALE,“Cammini” mariani per i tesori di Sicilia – Parte II, in OADI. Rivista dell’Osservatorio per le ArtiDecorative in Italia 1, 2010, 2, pp. 13-39 (consultabile on line): 33-34 e fig. 39. La citazione travirgolette è tratta da MONGITORE, Palermo divoto, II, p. 260.
32 In ultimo ANDALORO, La Vergine Haghiosoritissa, p. 558. La studiosa riporta la testimo-nianza di Gioacchino Di Marzo che descriveva l’opera come «lavoro a musaico sopra tavola» (DI
MARZO, Delle Belle Arti in Sicilia, II, n. 2 a p. 110) e alcune riflessioni a sostegno dell’ipotesi.
DALLA GRECIA A PALERMO 251
frammento di mosaico monumentale33. Senz’altro il genere del mosaicoportatile è attestato nella Sicilia normanna e anche oltre nel tempo. Lo sve-lano infatti i documenti. Riassumo: un’icona probabilmente musiva concornice d’argento fu donata – come testimoniato da due diplomi (marzo emaggio 1171) – da Matteo d’Aiello, cancelliere e vicecancelliere dei sovraninormanni, al monastero di S. Maria de Latinis da lui stesso fondato a Pa-lermo entro l’anno 117134. Il secondo documento, con particolare riferi-mento alla menzione di questa immagine, è stato di recente ripubblicatoda Mark Johnson il quale però non traduce l’espressione «cum miesivo»(che potrebbe risultare dall’errata lettura o trascrizione di «cum musivo»),per la quale lo studioso propone con dubbio un riferimento alla cornice35.
Nell’inventario del 1309 della Cappella Palatina, che riporta informa-zioni in gran parte risalenti al 1277, troviamo menzionata un’icona musivadi san Giorgio36, e nell’inventario di S. Maria dell’Ammiraglio del 1333sono citate quattro «yconas de opere musivo subtili»37.
S. MORETTI252
33 G. TRAVAGLIATO, Madonna supplicante (Vergine Haghiosoritìssa), in La bella Italia. Arte eidentità delle città capitali, a cura di A. PAOLUCCI, catalogo della mostra (Reggia di Venaria, Scu-derie Juvarriane, 17 marzo-11 settembre 2011; Firenze, Palazzo Pitti, 11 ottobre 2011-12 febbraio2012), Cinisello Balsamo (MI) 2011, pp. 214-215, nr. 5.1.2. Giovanni Travagliato scrive, a pro-posito del restauro di Rosario Riolo: «A nostro parere, in occasione di tale intervento [ndr: laporzione di mosaico] fu montata su supporto di ardesia, entro l’attuale cornice Impero con pas-separtout in marmo rosso» (ibid., p. 215). Il pezzo sarebbe definito “Madonna della Luce” [milimito a menzionare: M. C. DI NATALE, Arti Minori nel Museo Diocesano di Palermo, Premessadi A. BUTTITTA, Palermo 1986 (Quaderno dell’Archivio Fotografico delle Arti Minori in Sicilia,3), p. 35; G. TRAVAGLIATO, Iconae graece, latine imago dicitur: culture figurative a confronto inSicilia (secc. XII-XIX), in Tracce d’Oriente. La tradizione liturgica greco-albanese e quella latina inSicilia, a cura di DI NATALE, catalogo della mostra (Palermo, Palazzo Bonocore, 26 ottobre-25novembre 2007), Palermo 2007, pp. 41-59, 240: 43; DI NATALE, Il Museo Diocesano di Palermo,Palermo 2010, p. 27; G. TRAVAGLIATO, Madonna supplicante, p. 214]. Mongitore però descrivecon questo nome una Vergine «a musaico, in divoto atteggiamento, col divino Pargoletto in brac-cio» (MONGITORE, Palermo divoto, I, p. 651).
34 D. FIORENTINO, Tra Bisanzio e la Sicilia normanna: le committenze artistiche di Matteod’Aiello, tesi di Laurea triennale in Storia dell’Arte Bizantina, relatore prof. A. IACOBINI, SapienzaUniversità di Roma, a.a. 2008-2009, pp. 51, 91, 99 (l’icona è ricordata nei due diplomi, che atte-stano la fondazione del monastero da parte di d’Aiello, la donazione di beni e l’obbedienza allaregola benedettina). Così leggiamo sul primo documento: «Iconam cum miesivo, que habet li-bram argenti unam et mediam»; mentre il secondo recita: «iconam, que est cum masibo que habetlibram argenti unam et mediam». La chiesa del cancelliere venne distrutta nel 1943.
35 M. JOHNSON, Sacred Gifts: Icon Giving and Veneration in Norman Italy, in Bollettino dellaBadia Greca di Grottaferrata s. III 7, 2010, pp. 103-116: 103-106.
36 ANDALORO, La Cappella Palatina di Palermo e l’inventario del 1309, pp. 97, 114 («iconamunam de ligno S. Georgii ad musias») e n. 73 a p. 108.
37 A. GAROFALO, Tabularium regiae ac imperialis capellae collegiatae Divi Petri sacri et regiipalatii Panormitani, Palermo 1835, p. 152; ANDALORO, La Cappella Palatina di Palermo e l’inven-tario del 1309, p. 97.
Immagini musive portatili sono attestate anche in età moderna in Sicilia38,dove, ovviamente, non è escluso possano esser giunte tramite il mercato anti-quario.
Per quanto riguarda invece le icone a smalto mancano testimonianzeesplicite nei documenti palermitani39, o meglio ne ignoro l’esistenza, benchésenz’altro le nobiles officinae del Palazzo Reale producessero opere asmalto, come provato da diversi oggetti d’arte suntuaria. A questo puntola domanda è d’obbligo: con il bottino normanno dalla Grecia arrivò a Pa-lermo anche l’icona venerata dalla confraternita di S. Maria di Naupaktos?Icona che, a questo punto, siamo più inclini a credere fosse di mosaico chenon a smalto. È lecito pensarlo, ma non è dato sapere e non è corretto, inassenza di elementi concreti, forzare l’ipotesi.
Apprendiamo che nel bottino riportato dal saccheggio dei territori grecivi era un’immagine di san Teodoro,40 e perché allora – ci si potrebbe chie-dere – non viene ricordata la nostra icona? Insomma non appare necessariospiegare la presenza di icone musive nella Palermo normanna con l’arrivodi un’icona non altrimenti documentata.
A conclusione di questo percorso forse un po’ tortuoso, alcuni dati, no-nostante le incertezze, mi sembrano comunque registrabili in maniera ine-quivocabile; li elenco rapidamente:
1) la curiosa coincidenza (motivi decorativi, misure) tra la miniatura deltypicon e le icone a micromosaico di età paleologa;
2) la comparsa dell’iconografia dell’Haghiosoritissa a Palermo al tempodi Ruggero II (in concomitanza certo con una diffusione del tipo che si re-gistra anche nei territori dell’impero bizantino);
3) la documentata presenza di icone a mosaico nella Sicilia normanna epost-normanna.
38 MORETTI, I colori della fede, pp. 1001-1002.39 Nell’inventario del 1309 della Cappella Palatina vengono elencate quindici icone, tra queste
alcune (una in argento dorato, due in rame e un’altra in argento: cfr. ANDALORO, La Cappella Pa-latina di Palermo e l’inventario del 1309, pp. 114-115), più probabilmente di altre, potevano esserearricchite da smalti, ma questo non è segnalato. Poiché nello stesso documento si precisa che icandelabri appaiono «cum smaltis» e un’ampolla è «smaltatam» (ibid., p. 109), si potrebbe de-durre che le immagini menzionate nell’inventario fossero prive di questo prezioso corredo.
40 NICETA CONIATA, Grandezza e catastrofe di Bisanzio, pp. 174-175 (III.2, 6). Secondo Vla-dimir Zorić anche le ante della porta sud-occidentale della Cappella Palatina potrebbero esserearrivate a Palermo con questo bottino, sottratte a qualche palazzo (mi limito a rimandare a V.ZORIĆ, Le porte bronzee della Cappella Palatina, in Nobiles Officinae, II, pp. 33-45: 42 e n. 71 ap. 45). Su queste ante si veda in ultimo G. GASBARRI, Navata settentrionale. Lato ovest. La portabronzea (sec. XII), in La Cappella Palatina a Palermo – Schede, pp. 418-422.
DALLA GRECIA A PALERMO 253
254 S. MORETTI
Last, but not least mi fa piacere chiudere con una interessante notizia,per la conoscenza della quale sono grata a Marina Scarlata: si narra in alcunidocumenti delle processioni e delle funzioni religiose che si svolsero a Pa-lermo il 31 dicembre 1328 per festeggiare la guarigione del re Federico IIId’Aragona e del figlio Pietro, colpiti da una malattia41. Le processioni par-tivano dalla cattedrale, trasportando il corpo di santa Cristina e altre reli-quie, per giungere a S. Maria dell’Ammiraglio e pregare dinanzi all’yconadella beatissima Vergine Maria, chiamata santa Maria monaca (ma pre-ghiere e celebrazioni si svolsero anche nelle adiacenze della chiesa); poi lefonti puntualizzano che il re, ogni qual volta si trovava a Palermo, si recavail sabato a pregare dinanzi a quell’icona42. L’immagine doveva mostraresenz’altro la Madre di Dio, definita nei testi poc’anzi citati «beatissima ver-gine», «madre e figlia», e «monaca» forse perché ‘associata’ a un monasteroo ad una pia confraternita, forse perché con il capo velato, probabilmentecon il Figlio43. Non sembra troppo azzardato ipotizzare che l’icona fosselegata all’età normanna, della cui tradizione Federico III si sentiva erede erestauratore.
A questo punto, si potrebbero aprire due vie per l’identificazione del-l’icona venerata dal re aragonese, vie che al momento appaiono comunqueil risultato di semplici congetture. L’immagine di santa Maria potrebbe es-sere quella del monastero femminile greco, trafugata e depositata da Gior-gio nella sua chiesa (nell’inventario di S. Maria dell’Ammiraglio del 1333 èmenzionata una «ycona domini admirati» della Vergine forse con il Figlio44);
41 M. SCARLATA, Lo spazio del potere civile e religioso nella Palermo normanna. S. Maria del-l’Ammiraglio, S. Maria del Cancelliere, S. Maria Nuova o dei Marturano, in Giorgio di Antiochia,pp. 309-339: 338-339.
42 Acta Curie felicis Urbis Panormi. 5: Registri di lettere ed Atti (1328-1333), a cura di P. COR-RAO, Palermo 1986 (Collana di atti medievali della città di Palermo), pp. 83-86, nrr. 44-45. Cfr.,inoltre, S. FODALE, Federico III e la Chiesa romana, in Il Mediterraneo del ‘300: Raimondo Lulloe Federico III d’Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, a cura di A.MUSCO, M.M.M. ROMANO, Atti del Seminario Internazionale di Palermo (Castelvetrano – Seli-nunte, 17-19 novembre 2005), Turnhout 2008 (Instrumenta Patristica et Mediaevalia 49; SubsidiaLulliana, 3), pp. 3-13: 11.
43 «[…] ad ecclesiam Sancte Marie de Admirato pervenimus ibique coram divino conspecto etvotive ycone figura Beatissime Virginis Marie vocate Sancta Maria Monacha ubi serenissimus do-minus noster Rex Fridericus cum Panormi feliciter adest ingentem devocionem habens quolibetdie sabbati ante illam Sanctam Mariam Monacham orat, dominamque ipsam devote rogavimus utsalvatorem omnium cuius est mater et filia […]» (dal primo documento: Acta Curie, p. 85).
44 GAROFALO, Tabularium, p. 152. Escludendo l’ipotesi di un viaggio, per taluni ritorno, del-l’icona a Naupaktos: cfr. CUTLER, NORTH, The Gift of Service, p. 215.
45 «[…] la espressione del documento, ἡ λεγoμένη Χρυσή, presume che l’appellativo fossepopolare e invalso da assai tempo nell’uso corrente» (LAVAGNINI, L’epigramma e il committente,n. 12 a p. 344; critica verso questa interpretazione è ACCONCIA LONGO, S. Maria Chrysè, p. 173).Anche l’immagine citata nei documenti trecenteschi ha ereditato un appellativo dalla tradizione:«[…] vocate Sancta Maria Monacha» (per i testi: Acta Curie, pp. 84-85). Infine ricordo che nel-l’inventario di S. Maria dell’Ammiraglio del 1333 sono elencate quattro yconas a mosaico e moltealtre realizzate con diverse tecniche, tra cui quella dell’ammiraglio poc’anzi citata e una di suamoglie (GAROFALO, Tabularium, pp. 151-152).
46 Mi limito a menzionare LAVAGNINI, L’epigramma e il committente (per la citazione nel testo:p. 344). Queste donne, che sono monache per ACCONCIA LONGO (S. Maria Chrysè, pp. 173-174),vengono ricordate anche nell’atto di dotazione della chiesa del 1143 e successivamente non più,forse la comunità si estinse e l’icona, se concordiamo sulla sua esistenza, poté passare alla chiesadell’ammiraglio.
47 «[…] le parole del documento del 1140 indicano un’istituzione di religiose e non un’im-magine sacra» (ACCONCIA LONGO, S. Maria Chrysè, p. 173). In ultimo ACCONCIA LONGO, Con-siderazioni (la citazione nel testo è tratta da p. 274). Cfr., inoltre, SCARLATA, Lo spazio del potere,pp. 320, 324.
48 Come già affermava Gioacchino Di Marzo: cfr. DI NATALE, Ave Maria. La Madonna in Si-cilia: immagini e devozione, Introduzione di M. LUZI, Palermo 2003, p. 14. Sull’uso e la venera-zione tributata alle icone nell’Italia normanna si veda JOHNSON, Sacred Gifts.
255DALLA GRECIA A PALERMO
oppure si tratterebbe di quella tavola custodita, secondo Bruno Lavagnini,dalla comunità di pie donne legate all’ammiraglio e a sua madre (definitaChrysè45 nel documento greco del 1140 con il quale Ruggero II, su richiestadi Giorgio, vende alle «pie vecchie» parte di una vigna del fisco regale)46.Sull’esistenza di questa immagine la Acconcia Longo ha sollevato alcunidubbi, identificando la «Santissima Madre di Dio denominata “d’oro”»non con un’immagine, ma con la chiesa stessa edificata da Giorgio47.
Indipendentemente da una ricostruzione certa dei fatti, difficile e com-plessa per diversi fattori, è interessante sottolineare come queste notiziepermettano ancora una volta di testimoniare l’importante funzione di di-vulgazione del Cristianesimo svolta dalle immagini su tavola durante il glo-rioso regno degli Altavilla48. Siamo giunti così alla fine del nostro raccontodalla Grecia, e più in generale da Bisanzio, a Palermo.
S. MORETTITavola VI
Fig. 1. Palermo, Cappella Palatina, Tesoro, Tabulario n. 1: ty-picon della Confraternita clerico-laicale di S. Maria di Naupak-tos (da Nobiles Officinae).
Fig. 2. Palermo, Cappella Pa-latina, Tesoro, Tabulario n. 1:miniatura con la Vergine (daNobiles Officinae).
Fig. 3. Incisione con “Minia-tura dell’anno 1048” (da DI
MARZO, Delle Belle Arti in Si-cilia).