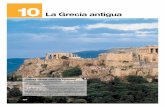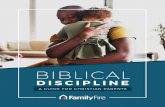L'Atletica nell'antichità. Discipline e manifestazioni agonali nell'antica Grecia
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'Atletica nell'antichità. Discipline e manifestazioni agonali nell'antica Grecia
L'Atletica nell'antichitàDiscipline e manifestazioni agonali nell'antica Grecia 1
Introduzione
Questo contributo intende illustrare e delineare in maniera sintetica, anche se l’argomentoè oggetto di dibattito nel mondo accademico, un quadro dell’atletica e dello sportnell’antichità, nella fattispecie nel mondo greco. La tradizione atletica del mondo classico,oltre ad essere all’origine dello sport moderno, è per gli occidentali e per noi italiani inparticolare, storia e tradizione, dunque parte integrante della nostra cultura millenaria.
Naturalmente ci si soffermerà nello specifico sugli aspetti riguardanti l’Atletica, inparticolare la corsa, tenendo in considerazione anche le altre discipline praticate negliagoni, per dare un quadro chiaro dell’importanza e del valore dell’aspetto sportivo per gliantichi Greci. Lo sport per gli antichi Greci era visto in maniera del tutto differente rispetto all’accezionecontemporanea.
La pratica dell’Atletica e di tutte le altre attività fisiche era legata alla sfera religiosa, ovverogli agoni erano parte integrante dell’aspetto sacro e della sua ritualità, e come tali eranointesi e vissuti in quanto i partecipanti erano alla ricerca dell’eccellenza, della vittoria, perprimeggiare ed avere un rapporto privilegiato col dio. Infatti i vincitori, in particolare quellidei giochi olimpici, erano considerati esseri divini. In questa parte introduttiva faremo unaccenno alle discipline che si svolgevano negli agoni ellenici, per poi illustrare le disciplineproprie dell’atletica, delineandone, ove possibile, l’origine, e illustrandone le caratteristichetecniche e di svolgimento. Si accennerà anche ai principali agoni che si svolgevanonell’antica Grecia, di cui successivamente si delineerà una breve storia, dagli aspetti ritualia quelli organizzativi, mettendo l’accento sul legame fra sacro e sport, indispensabile percomprendere il valore che l’aspetto agonale aveva nel mondo ellenico.Possiamo definire gli antichi Greci i padri dell’Atletica moderna, in quanto per primistabilirono ed in un certo senso canonizzarono le regole delle diverse gare e tutto questo apartire dal 776 a.C., anno in cui si celebrarono le prime Olimpiadi. Accanto ai GiochiOlimpici, vi erano altre feste dove si svolgevano giochi panellenici, a sottolinearel’importanza degli agoni sportivi. I principali erano i Giochi Pitici, che si svolgevano a Delfidurante le feste pitiche, i Giochi Istmici, che si svolgevano presso il santuario di Poseidonevicino Corinto, i Giochi Nemei, che si svolgevano nella Valle Nemea nell’Argolidesettentrionale, e i Giochi Panatenaici, che si svolgevano ad Atene durante la festa dellePanatenee.
L’Atletica.Le gare di corsa.
Il bisogno di misurarsi è stato sempre insito nell’uomo e la corsa è stata sicuramente unodei primi, se non addirittura il primo, modo di confrontarsi fra gli uomini. Nell’antica Greciala pratica della atletica, come delle altre discipline, aveva un carattere sacrale intimamentelegato alla guerra in quanto imitazione di essa, fondamentale nell’educazione della mentee del corpo. Di questo aspetto ce ne dà testimonianza Omero nell’Iliade, quando descrive iMirmidoni di Achille che “si dilettavano nel disco, nel giavellotto e nel lancio delle frecce”(Iliade, II, vv. 773-774). Inoltre va ricordato che lo stesso Omero definisce Achille, ilprincipale eroe della guerra di Troia, nonché il guerriero più forte, “piè veloce” a volereindicare il suo primeggiare anche nella corsa.
1 Pubblicato in cinque parti su:http://www.toptraining.it/index.php?option=com_content&view=category&id=67&Itemid=89
Le principali competizioni, che oggi definiremo proprie dell’Atletica, erano la Corsa, il Salto,i Lanci, il Péntathlon. Accanto a queste discipline vi erano il Pugilato, il Pancrazio ovvero lalotta, le gare ippiche e le gare di araldi, classiche discipline olimpiche. Vanno inoltrericordate altre competizioni che si svolgevano negli altri giochi, come le gare poetiche,molto importanti ai Giochi Pitici, ma c’erano anche concorsi letterari e musicali e gare didanza. Per quanto riguarda la corsa vi erano diverse gare, che prendevano il nome dalladistanza da coprire. Le principali gare di corsa erano lo Stàdion, il Dìaulos e il Dòlichos,che erano le classiche discipline olimpiche, come diremmo oggi, visto che si svolgevanoad Olimpia. Insieme ad esse vanno ricordate l’Ippios dromos, l’Oplitodromìa eLampadedromìa; infine lo stàdion femminile, che si svolgeva solo alle Heraia, le feste inonore di Era che si svolgevano ad Olimpia.
Lo Stàdion era una gara di velocità che si svolgeva sulla distanza dello stàdion, appunto,che differiva da agone ad agone (circa 200m). È dal nome di questa gara che prende ilnome odierno di stadio. Ad Olimpia lo stàdion misurava 192,27m; ai giochi Pitici misurava177,50m; ad Epidauro misurava 181,30m, mentre a Pergamo 210m. La gara consistevanel percorrere la lunghezza dello stadio, partendo solitamente da una linea tracciata sulterreno o da una lastra di pietra detta balbìs, ed era disputata da tre categorie, ragazzi,efebi, adulti. La partenza, da fare in piedi, veniva data con uno squillo di tromba, mentre lafalsa partenza veniva punita con una bastonata. Lo stàdion rivestiva un importantissimoruolo rituale, soprattutto perché gli atleti si contendevano il privilegio di accendere il fuocodell’altare di Zeus Olimpio. Questa fu la prima gara olimpica e rimase l’unica fino alla XIVolimpiade (724 a.C.).
Il Diaulos è il doppio stàdion, dunque corrisponde agli attuali 400m. Venne introdotto nellaXIV olimpiade a fianco allo stàdion e la sua origine è legata alla cerimonia iniziale, in cui gliaraldi percorrevano lo stadio una volta per invitare il pubblico al rito, poi ritornavanoindietro per annunciare l’inizio della festa e degli agoni. Infatti la gara si svolgeva partendonelle stesse modalità dello stàdion, poi si girava intorno al traguardo della gara più breveper poi arrivare alla linea di partenza.
Il Dòlichos è una gara di corsa prolungata, dunque una gara di resistenza, o meglio dimezzofondo, di cui non si conosce la distanza precisa, in quanto le fonti ne citano diverse,dai 7 ai 24 stàdia, ovvero da 1,35km a 4,6km. Doveva svolgersi nelle stesse modalità deldiaulos.
Al giorno d’oggi definiremmo l’Ippios dromos una gara di mezzofondo veloce, in quanto sisvolgeva sulla distanza di 4 stàdia, circa 800m.
L’Oplitodromìa, invece, era la corsa in armi, in cui gli atleti correvano con scudo, elmo eschinieri, sulla distanza del diaulos.
La Lampadedromìa era una staffetta che si svolgeva alle Panatenee partendo dall’ara diPrometeo, vicino l’Accademia, fino all’Acropoli: il cosiddetto testimone era una fiaccolaaccesa al fuoco dell’ara.
Infine lo Stàdion femminile si svolgeva su una distanza corrispondente a circa 160m, 5/6di uno stàdion.
I lanci ed i salti
Fin qui abbiamo parlato delle varie distanze corse nei giochi nell’antica Grecia. Mal’Atletica non era, e non è solo corsa, e dunque accanto ad esse vi erano i concorsi dilancio, il salto e il Péntathlon. La disciplina più nota, anche per le famose rappresentazionicome il discobolo di Mirone, di quella che potremmo definire “atletica pesante” è
sicuramente il lancio del disco, di cui Filostrato, autore che visse tra il II ed il III sec. d.C.,nella sua opera Le Immagini illustra la tecnica di lancio, che veniva effettuato inun’apposita pedana, descrivendo un quadro che raffigurava la morte di Giacinto. Daquesto documento sappiamo che l’atleta compiva una torsione a destra piegando ilbraccio con cui reggeva il disco, per poi lanciarlo con una semirotazione. La statua diMirone fotografa l’attimo precedente il lancio, in cui l’atleta concentra al massimo le sueenergie che confluiranno nell’azione del getto del disco. L’attrezzo in origine era in pietra,successivamente venne sostituito da un disco in bronzo, del peso di circa 2kg e daldiametro di circa 20-30cm. È probabile che le misure più lunghe toccassero i 25m.L’attrezzo veniva chiamato dìscos o sòlos. Questo doppio nome ha fatto ipotizzare che iltermine sòlos si riferisse ad un ulteriore attrezzo, probabilmente un peso. È dunquepossibile che si praticasse anche il lancio del peso, disciplina che richiede una tecnicameno raffinata e maggior forza, per cui è molto probabile che tale competizione esistesse,come prova di forza individuale.
Infine veniva effettuata anche la gara del lancio del giavellotto,disciplina intimamente legata all’aspetto guerresco, che, come giàdetto, era all’origine della nascita degli agoni. Infatti le primecitazioni riguardo a gare di lancio del giavellotto si devono adOmero nell’Iliade riguardo alle attività praticate dai Mirmidoni neltempo libero (II, vv. 773-774), ma in passo successivo (XXIII, vv.884-897) accenna ad una gara di lancio del giavellotto, poi nondisputata, durante i giochi funebri in onore di Patroclo. Il lancio,dal punto di vista tecnico, veniva effettuato nelle stesse modalitàattuali, ovvero con una breve rincorsa con l’attrezzo, tenutoall’altezza del capo, che poi veniva portato indietro con braccioteso e lanciato. In seguito al giavellotto venne legato un cordino incuoio, chiamato ankùle, che faceva ruotare l’attrezzo, dandogli piùvelocità. Naturalmente esisteva un limite entro cui si potevalanciare l’attrezzo, costituito da una colonnina, come descritto daPindaro (Olimpiche, X 71). La gara del lancio del giavellotto,inoltre, veniva praticata in diverse varianti, come il lancio da terra
verso un bersaglio o il lancio compiuto da cavallo al galoppo. L’attrezzo era del tutto similea quello utilizzato in guerra, ovvero un asta in abete o frassino lunga 1,5-2m. Dalle fontiche fanno riferimento al lancio del giavellotto possiamo dedurre che i lanci più lunghipotevano superare i 45m.
Per quanto riguarda i salti si ha documentazione di una competizione che si svolgeva nelleseguenti modalità: si poteva effettuare una ricorsa mentre la pedana era costituita da unlimite, detto batér, che oggi chiameremmo tavoletta, da cui si saltava, e dallo skàmma,ovvero l’area di atterraggio, lungo circa 15m. La misurazione veniva effettuata attraversodelle apposite aste, denominate kanònes. Va ricordato che il salto ebbe una suaevoluzione nella tecnica, in particolare con l’introduzione degli haltéres, ovvero deimanubri, che pesavano da 1,5 kg a 4 kg, utilizzati per prolungare lo slancio nel salto. Latradizione ricorda il favoloso salto di Phayllos di Crotone, che raggiunse i 55 piedi, quasi17m.! Questo racconto fa pensare ad un salto composito, equiparabile all’odierno saltotriplo, ma è probabile che la tradizione sul salto di Phayllos sia inficiata dalla mitizzazionedell’atleta, visto come una divinità per le sue qualità al di sopra della norma. Questo, però,non esclude che si praticasse una disciplina simile al nostro salto triplo. In ognuna diqueste gare il gesto dell’atleta veniva cadenzato dal suono di flauti.
Discobolo di Mirone, copia
Il Péntathlon e altre discipline olimpiche .
Il Péntathlon venne introdotto nella XVIII Olimpiade, disputata nel 708 a.C. e vedevaimpegnati gli atleti in 5 diverse discipline: una gara di corsa, il salto, il lancio del disco, illancio del giavellotto e la lotta. Delle prime 4 discipline abbiamo già parlato.
La Lotta, insieme al pugilato ed al pancrazio,apparteneva alle cosiddette discipline pesanti.Questa può essere assimilata all’odierna lottagreco-romana, anche se in antico non esistevanodistinzioni in categorie. Anche la lotta aveva le sueorigini mitiche, legate alle figure di Eracle e diTeseo, e anche una sua divinità, Palaìstra, figlia diErmes, da cui prende il nome pàle, la lotta appunto.Si praticavano due tipi di lotta, in piedi o a terra. Gliincontri avvenivano per sorteggio in presenza degliagnoteti, giudici; lo scopo era quello di atterrarel’avversario utilizzando delle prese, cosa cherisultava abbastanza difficile, visto che gli atletilottavano nudi o con un perizoma e si ungevano il corpo con olio. Anche per quantoriguarda questa disciplina è Omero che dà la prima attestazione letteraria nell’Iliade (XXIII,vv. 700-739).
Il Pugilato venne introdotto nella XXIII Olimpiade nel 688 a.C., ma le sue origini sonoantichissime, come attestano le raffigurazioni provenienti da Cnosso e Haghia Triada aCreta. I pugili coprivano l’avambraccio e le mani, ma non le dita, con le meilìchai esphaìrai, strisce di cuoio; in seguito furono adottate anche gli imàntes, borchie di metallo. Ilcombattimento prevedeva il solo uso dei pugni, non esistevano categorie e gli atleti siscontravano nudi, fino alla resa di uno dei due che veniva indicata sollevando l’indice dellamano destra.
Il Pancrazio è più recente rispetto alla lotta e al pugilato e venne introdotto nella XXXIIIOlimpiade nel 648 a.C.. Essa prendeva spunto dalle altre due discipline pesanti ed eradunque più violenta, visto che si utilizzavano prese, pugni e calci. Lo scopo era quello dicostringere l’avversario alla resa, attraverso diverse tecniche, fra cui lo strangolamento.Nell’antichità queste discipline erano molto amate, ma erano particolarmente apprezzati ilottatori che riuscivano a vincere nello stesso giorno nella lotta, nel pugilato e nelpancrazio, in uno sorta di triathlon.
Le gare ippiche richiamavano moltissimo pubblico in antico, greco prima e romano poi. Laprima fu le corse dei carri, le quadrighe e le bighe. Queste si svolgevano nell’ippodromoche aveva la lunghezza di circa 800m, 4 stàdia, e si svolgeva su distanze da minimo 2 amassimo 12 giri. Vincitore veniva dichiarato il proprietario dei cavalli. Insieme alle gare deicarri, si svolgevano, nel giorno successivo, le competizioni di cavalli montati, nellemedesime modalità in cui si svolge oggi il Palio di Siena: si partiva tutti insieme e se ilcavallo arrivava primo da solo la vittoria veniva comunque assegnata al proprietario.Vanno ricordate inoltre le gare di araldi e trombettieri, che vennero introdotte nella XCVIOlimpiade nel 396 a.C. Gli araldi avevano un ruolo primario nelle competizioni olimpiche,in quanto precedevano gli atleti nelle sfilate, ne bandivano il nome prima delle gare e neannunciavano le vittorie. Il vincitore era colui che aveva la voce più melodiosa.
Le manifestazioni agonali più importanti: i Giochi olimpici
Gli agoni più importanti dell’antica Grecia erano i Giochi Olimpici, che si svolgevano
Lottatori, particolare da Anfora panatenaica afigure nere (Badishes Landen Museum,Karlsruhe)
presso il santuario di Zeus ad Olimpia, nel Peloponneso, ogni 4 anni. La nascita dei giochiè legata ad origini mitiche. Pindaro, nella I Olimpica, ha raccontato il mito che ha datoorigine ai giochi: Enòmao di Elide indisse una corsa di cavalli per i pretendenti alla manodella figlia Ippodàmia. Costoro partirono con un vantaggio rispetto ad Enòmao ma venneroraggiunti dal suo carro, trainato da cavalli divini donati da Fetonte, e vennero tutti uccisitranne Pelope, il quale aveva allentato le ruote del carro con l’aiuto del servo Mirtilo.Enòmao si schianto e morì, e Pelope istituì giochi funebri in suo onore, i Giochi Olimpici.Un ulteriore racconto, narrato ancora da Pindaro e da Aristotele, vede protagonista Eraclecome fondatore dei Giochi in onore di Pelope. Numerose sono le leggende sulla nascitadei Giochi e questo indica l’importanza della manifestazione agonale; la prima edizione sidata nel 776 a.C. Ai Giochi potevano partecipare tutti i cittadini greci, iscritti alle listeciviche e senza precedenti penali; successivamente, con l’annessione della Grecia allostato romano come provincia di Acaia, i Romani furono i primi barbaroi, stranieri, adessere ammessi.
La data di svolgimento erastabilita dai sacerdoti, inbase ad un rigidocalendario religioso, percui il giorno centrale dellamanifestazione, il terzo,coincideva col solstiziod’estate. I trenta giorniprecedenti i Giochi, atleti,giudici e allenatori sisottoponevano ad unasorta di ritiro rituale, in cuiveniva data loro l’idoneitàa partecipare. Ci sipreparava alle gare, sisvolgevano delle prove, edurante questo periodo cisi poteva ritirare, cosa
assolutamente vietata durante i Giochi. Atleti e allenatori, prima dell’inizio, giuravano difronte alla statua di Zeus Horkios di rispettare le regole e non usare mezzi illeciti. I Giochivenivano propagandati in tutta la Grecia dagli araldi, che ne annunciavano la data d’inizioe proclamavano l’ekecheiria, la tregua sacra. La tregua sacra imponeva la momentaneainterruzione delle guerre durante lo svolgimento degli agoni olimpici, una sorta diarmistizio. Questo aspetto mette in evidenza, più di ogni altro, la sacralità dei GiochiOlimpici per tutti i Greci.
Per quanto riguarda i regolamenti delle gare olimpiche esisteva un consiglio, composto dasacerdoti e personalità di Olimpia, i numophùlakes, che aveva il compito di custodirle edeventualmente modificarle. Naturalmente esistevano dei giudici, gli ellanodìkai, chevigilavano sullo svolgimento delle gare e sulla corretta interpretazione delle regole. Essi siriunivano 10 mesi prima per studiare le regole impartite dal consiglio, ed erano soggetti alsuo giudizio in caso di errore sull’interpretazione di un risultato, che comunque non venivamodificato. Nel mese precedente gli agoni gli ellanodìkai supervisionavano gli atleti inritiro, imponendo anche punizioni o multe in caso di scorrettezze.
I Giochi Olimpici duravano 5 giorni ed erano inaugurati da una processione di tutti ipartecipanti, giudici, allenatori, sacerdoti, etc., che partiva da Elide e attraversando la ViaSacra giungeva al recinto sacro di Olimpia, presso la fonte Piera, dove avveniva la
Tempio di Zeus ad Olimpia
purificazione; poi si passava la notte nell’uliveto sacro della collina di Crono, in attesa delprimo giorno di gare. Sul programma gare esistono diverse ipotesi, di certo si sa che ilprimo ed il quinto giorno erano dedicati alle cerimonie religiose, mentre durante il terzoavveniva l’ecatombe, ovvero il sacrificio di 100 buoi, le cui carni erano offerte nelbanchetto, aperto a tutti, che chiudeva i Giochi.
Per quanto riguarda le premiazioni, solo il primo classificato veniva considerato, in quantoil migliore, e superiore agli altri; probabilmente anche per questo motivo non esistevanocompetizioni a squadre, in quanto veniva esaltata l’individualità, il singolo. Inizialmente ilpremio consisteva in una corona d’ulivo, simbolo dell’immortalità che avvicinava l’atletaalla divinità. In seguito le varie città greche, a partire dal VI sec. a.C., cominciarono adincentivare le vittorie dei propri atleti con ricompense in denaro, come le 500 dracmevolute da Solone per i vincitori ateniesi ad Olimpia, o dei vitalizi, come nel caso di Efeso.Questi incentivi sono la prova di come il professionismo fosse presente anchenell’antichità.
Le gare si svolgevano in strutture diverse. Per quanto riguarda l’atletica, il teatro dellegesta degli atleti era lo stadio, che prende il nome da un’unità di misura, lo stàdion, per cuiera lungo circa 190m, 600 piedi greci. La pista era in terra battuta, delimitata a volte dauna soglia di pietra, che corrispondeva alla linea di partenza. Paralleli alla soglia vi era deifori, a 1,25m l’uno dall’altro, per l’inserimento di pali per la delimitazione delle corsie. Glispettatori sedevano sulle gradinate presenti sui lati lunghi dello stadio, mentre per i giudicivi era una speciale tribuna.
Le gare dei carri e di cavalli si svolgevano all’ippodromo, che stando alla testimonianza diPausania doveva essere uno spazio aperto di forma rettangolare contenente la pista per legare coi lati più corti a semicerchio. Le gare di Lotta, Pugilato e Pancrazio, avvenivanonella palestra, mentre il ginnasio era il luogo destinato alla preparazione delle gare,dunque per allenarsi. Le Olimpiadi ebbero una storia millenaria, iniziata, come detto, nel776 a.C., e terminata nel 392 d.C., con l’editto di Teodosio, che condannava e aboliva tuttele manifestazioni religiose pagane.
I Giochi Delfici o Pitici
Questa manifestazione si svolgeva a Delfi, località alle pendici del Parnaso, sede delsantuario di Apollo e del famoso oracolo. Sulla nascita dei giochi esistono diversetradizioni, come quella ricordata da Pausania (Viaggio in Grecia, II, 32, 2) che laattribuisce a Diomede, mitico eroe omerico, che avrebbe istituito gli agoni in onore diApollo, dio della musica. Infatti fino agli inizi del VI secolo a.C. vi si svolgevano solo agonimusicali per citaredi e si celebravano ogni 8 anni, che corrispondevano agli annidell’allontanamento del dio Apollo dopo l’uccisione del serpente Python, custodedell’oracolo. I citaredi si confrontavano sulla composizione di peana, canti lirici dal temaepico, in onore di Apollo. Una seconda tradizione sulla nascita dei Giochi è legataall’uccisione di Python, per cui i giochi venivano detti pitici. Infine secondo un’ulterioreversione, gli agoni vennero istituiti in seguito alla vittoria di Delfi su Crisa. Nel 582 a.C. lamanifestazione venne riorganizzata ad opera di Euriloco, furono introdotte le gare atletichee lo svolgimento ebbe cadenza quadriennale, nel terzo anno dell’Olimpiade, tra Agosto eSettembre. La nuova organizzazione riprendeva, in alcuni aspetti, il rituale olimpico, comela proclamazione di una tregua sacra nei territori circostanti e il bando, in tutta la Grecia,da parte di araldi. Il comitato organizzatore era composto da esponenti della Lega delleTermopili, e ogni città aveva 2 rappresentanti, uno politico, detto pulagòros, e quelloreligioso, lo ieròmnimon.
I Giochi iniziavano con sacrifici ad Apollo e all’eroe Eùdromos, cui seguiva la processione
lungo la Via Sacra, per portare i doni all’oracolo. Non si conosce bene in che modo sisvolgevano gli agoni, che dovevano durare da 4 a 7 giorni. Particolarmente importantierano, naturalmente, le gare musicali e dunque il premio più ambito era per il peanavincitore. Anche a Delfi vi erano gare ippiche, che si svolgevano nell’ippodromo situatonella valle di Crisa. Le gare di atletica, invece, si svolgevano nello stadio, costruito nel Vsec. a.C., situato nella parte più alta del Parnaso, che dominava tutta Delfi. Lo stadioaveva una pista di 178,35m e su questa distanza si misuravano gli atleti dello stadion; lastruttura, rivestita in marmo, poteva ospitare fino a 7000 spettatori. Il programma era ilmedesimo di Olimpia, con l’aggiunta del dìaulos e del dòlichos per ragazzi, inserite fra legare degli adulti. Il premio era una corona d’alloro della Valle di Tempe.
I Giochi istmici.
I Giochi Istmici si svolgevano nei pressi del santuario di Poseidone vicino a Corinto, neipressi dell’Istmo, fra Aprile e Maggio, ed avevano cadenza biennale, nel secondo e quartoanno dell’Olimpiade. Secondo il mito la nascita degli agoni era da attribuire a Poseidone,che contese in una gara ippica ad Elios il possesso del luogo. Inoltre esistevano duetradizioni, quella corinzia che è legata all’istituzione dei Giochi da parte del re Sisifo inonore di Melicerte, e quella ateniese secondo la quale era stato Teseo a istituire gli agoniper l’uccisione del ladrone Synis Pityocamtes. La manifestazione si svolgeva nello stadio,costruito nel VII-VI secolo a.C. e ristrutturato nel V secolo a.C., dotato di 17 corsie e lungo181,15m. I Giochi iniziavano, anche in questo caso, con la processione che, attraverso ilrecinto sacro, raggiungeva l’altare di Poseidone, dove si svolgevano sacrifici ed ilgiuramento di lealtà di atleti e giudici. Un secondo giuramento si faceva, successivamente,in un tempietto dedicato a Melicerte, dopo essere scesi nella cripta, al buio e con l’acquafino alle ginocchia. Il programma era quello olimpico, con le gare ippiche che eranoconsiderate le più importanti, ed era concluso da gare di regata. Il premio era una coronadi pino o di appio selvatico. Particolarmente bella doveva essere la cerimonia di chiusura,che si svolgeva di notte presso il tempietto di Melicerte.
I Giochi nemei.
I giochi nemei si celebravano prima nella Valle di Nemea, successivamente ad Argo, aLuglio con cadenza biennale, nel secondo e quarto anno dell’Olimpiade. Inizialmenteerano agoni locali, ma nel 573-572 a.C. vennero riorganizzati e divennero panellenici. Argoe Clone ne curavano e controllavano l’organizzazione. Secondo un mito furono i 7 eroidella spedizione contro Tebe ad istituirli, mentre una seconda tradizione attribuiva adEracle, vincitore sul leone nemeo, la loro istituzione. Il programma era quello canonicodelle Olimpiadi, tranne gli agoni per citaredi e trombettieri, inseriti in un secondo momento.Il premio, per il vincitore, era una corona di sedano fresco o di quercia e una palma.
Le Panatenee.
Le Panatenee erano le feste in onore di Atena poliade che si svolgevano ad Atene e sidistinguevano in “Piccole Panatenee”, annuali, e “Grandi Panatenee” con cadenzaquadriennale, nel terzo anno dell’Olimpiade. La tradizione attribuiva l’istituzione dei Giochial mitico re Eretteo, che aveva dedicato una statua lignea ad Atena dopo la vittoria sulgigante Asterio, da cui la festa delle Panatenee. Un’ulteriore mito assegnava la nascitadelle feste, e quindi dei giochi, a Teseo, quando riunì le città dell’Attica. Nel 566 a.C. lePanatenee, sotto l’arcontato di Ippocleide, vennero riorganizzate e si adeguarono alprogramma olimpico.
Le “Grandi Panatenee” iniziavano il 28 Ecatombeone,il giorno natale della città secondo il calendarioateniese, e duravano 9 giorni, concludendosi con lagrande processione lungo la Via Sacra finoall’Acropoli, dove veniva donato alla dea Atena ilsontuoso manto. Il programma degli agoni prevedeva3 giorni di gare musicali, 2 di gare atletiche, 2 dicorse ippiche; nel penultimo giorno si svolgevano ledanze pirriche e Lampadedromia, la corsa con letorce, nell’ultimo la processione. La Lampadedromiadava inizio alla pannuchìs, la festa religiosa che sisvolgeva tutta la notte. Le gare atletiche, cuipartecipavano solo atleti adulti, non ebbero maigrande importanza come negli altri agoni panellenici,ma la festa di Atene ebbe sempre un ruolo primario inambito panellenico. Il premio erano le famose anfore panatenaiche, ma è probabile cheesistessero premi in denaro, secondo una testimonianza di Plutarco. Le “PiccolePanatenee” erano annuali e prevedevano solo gare giovanili, la danza pirrica e altredanze, la evandrìa, competizione a squadre di giovani, e la Lampadedromia.
Le Heraia.
Le Heraia, festa in onore di Hera, erano l’unico esempio di manifestazione agonalefemminile. Queste si svolgevano ad Olimpia ogni 4 anni, come i Giochi, e avevano nellacorsa dello stàdion il loro fulcro rituale e agonale. Infatti 16 ragazze si misuravano nellacorsa di velocità, che rappresentava il passaggio veloce dall’adolescenza all’etàmatrimoniale, avendo come punto di riferimento Hera, moglie di Zeus ed esempio dibuona sposa. Anche in questo caso vi era un collegio di 16 giudici, composto da donne. Ilnumero 16 ricorre in quanto legato ai miti di fondazione degli agoni. Uno attribuiva lanascita del rito, propiziatorio di pace, alle 16 città dell’Elide alla morte di Damofonte, autoredi soprusi nei loro confronti. Un’altra versione assegnava la nascita del rito ad Ippodamia,che avrebbe riunito 16 ragazze di nobili famiglie dell’Elide per correre in onore di Hera eringraziarla per il matrimonio con Pelope.
La Maratona
La Maratona, corsa di lunga distanza che si svolge sui canonici 42,195 chilometri, è la piùsuggestiva e intensa gara dell’atletica moderna. Al giorno d'oggi chiunque conosce lamaratona a tal punto da potersi definire l’immagine stessa dell’atletica al pubblico dei nonaddetti ai lavori. Ormai ogni città, in Italia e nel mondo, ha la sua maratona enumerosissimi sono coloro i quali, pur non avendo mai fatto corsa, si avvicinano a questomondo grazie al potere d’attrazione che questa manifestazione trasmette. Ma come nascela Maratona? Per quale motivo prende questo nome che non riguarda la sua lunghezza,ma al contrario, si identifica a tal punto con la sua distanza canonica che Maratonasignifica 42,195 chilometri? Da cosa nasce, infine questa distanza? La storia dellaMaratona in quanto gara di corsa è un’idea del padre delle Olimpiadi moderne, Pierre deCoubertine. La prima Maratona olimpica venne disputata infatti ad Atene nel 1896 ed ilprimo vincitore fu il greco Spiridon Louis, che coprì la distanza fra Maratona ed Atene in2h58’50. Da quel momento la Maratona è diventata l’Atletica, per tutti.Conoscere la storiada cui trae origine la Maratona è fondamentale in quanto fa comprendere appieno il valoreche ha, in generale, ma anche il significato che assume non solo alla luce della storia maanche di tutti coloro che affrontano questa sfida e la portano a termine.
Corridori, particolare da anfora panatenaica afigure nere, VI sec. a.C. (Musée Vivenel,Compiegne)
Partiamo dunque dalla distanza. I 42,195 chilometri vennero canonizzati dalla IAAF nel1921, ma la prima volta che questa distanza fu quella ufficiale avvenne nei Giochi Olimpicidi Londra nel 1908, quando si consumò il dramma di Dorando Pietri. Infatti inquell’edizione si stabilì la partenza dalla residenza reale, il Castello di Windsor, e l’arrivodavanti al palco reale nello Stadio di White City, sobborgo di Londra: distanza 42,195chilometri. Ma a parte gli aneddoti sulla distanza canonica, la storia della Maratona èlegata alle vicende della storia greca antica, come le Olimpiadi d’altra parte, e di Atene inparticolare, per quello che avvenne alla fine dell’estate del 490 a.C., presso Maratona,villaggio posto nella piana costiere omonima, a circa 40 chilometri da Atene. Dunque laMaratona prende il nome di un piccolo villaggio greco. Qui avvenne la battaglia tra i Grecie i Persiani invasori. Per comprendere appieno il significato di questa battaglia e dellavittoria ateniese bisogna fare un piccolo accenno ai fatti, tramandatici da Erodoto (VI, 102-121).
I Persiani, barbari ovvero stranieri per i Greci, dopo aver conquistato nella loro marciad’invasione verso la Grecia la città di Eretria, si diressero verso Atene e si stanziarononella piana di Maratona, per preparare l’attacco. Gli Ateniesi, subito informati, si diresseroverso Maratona con un esercito di circa 11.000 uomini, da opporre ai 26.000 Persiani. Glistrateghi ateniesi, tra cui Milziade, prima di venire alle armi contro il nemico, decisero diinviare una richiesta di aiuto a Sparta, distante 240 chilometri. L’esercito ateniese eradotato di messi-corridori, gli emerodròmoi, e ne venne scelto il migliore, Filippide, che,stando ad Erodoto, giunse a Sparta in 2 giorni.
La scelta dell’emerodròmos fu obbligata, poichéc’era poco tempo ed il terreno da attraversare nonpermetteva a messi a cavallo di poter essere cosìrapidi. Gli Spartani accettarono di inviare aiuti, ma almomento del plenilunio, dunque successivamente.Filippide ripartì subito per Maratona ad annunciarela risposta spartana, e, anche se Erodoto non lospecifica, in altri 2 giorni coprì altri 240 chilometri.480 chilometri in 4 giorni!
La battaglia si svolse 12 Agosto (alcuni studiosiritengono il 12 Settembre) del 490 a.C., e l’esercitogreco, anche se in minoranza, riuscì ad avere lameglio, per una migliore tattica e soprattutto per il
migliore addestramento e armamento. Caddero sul campo 7000 Persiani e soli 192Ateniesi, ricordati con una tomba sulla cui stele sono incise le parole del poeta Simonide:«Gli Ateniesi, difensori degli Elleni, a Maratona distrussero le forze dei Medi, d'oro vestiti» .Appena ottenuta la vittoria lo stesso Filippide venne inviato ad Atene ad annunciarla al suopopolo. Giunto ai piedi dell’acropoli pronunciò la frase: «Kaìrete, nikomen», «Siate felici,abbiamo vinto», oppure semplicemente «Nenikèkamen», «Abbiamo vinto» e morì. Dopo ilplenilunio giunsero ad Atene 2000 Spartani. Pur arrivati troppo tardi per la battaglia, vollerolo stesso vedere i Persiani e si recarono appositamente a Maratona. Poi, elogiati gliAteniesi e la loro impresa, ritornarono a casa.
Quest’avvenimento mette chiaramente in risalto il grande patriottismo ateniese, tanto chelo storico J.F.C. Fuller ha scritto: «La vittoria diede ai Greci la fiducia nel loro destino:resistere per tre secoli durante i quali nacque la cultura occidentale». Ma non solo.Fondamentale appare la figura di Filippide, l’emerodròmos, che con la sua missioneassume statura storica ed etica. Ma la sua impresa riveste un significato esemplare pertutti coloro che affrontano la maratona preparandola giornalmente e affrontandola: la lorovittoria sta lì, nel portare a termine una fatica sovrumana, quella stessa fatica che l’eroe
Oplitodromoi, particolare da Anfora attica afigure nere, prima metà del Vi sec. a.C. (MuseoCivico Archeologico di Bologna)
ateniese superò annunciando ai suoi concittadini «Nenikèkamen».
Bibliografia generaleSommella A.M., Talano E., Cima M., Lo sport nel mondo antico. “Athla” e atleti nellaGrecia classica, Milano 1987 (Catalogo della Mostra).Yalouris N. (a cura di), The Olympic games in ancient Greece: ancient Olympia and theOlympic Games, Atene 1982.Pescante M., Mei P., Le antiche Olimpiadi, Milano 2003Miller S.G., Anciet greek athletics, Yale 2006