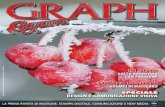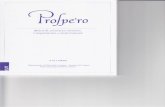“Contra Turcos. Alfonso d'Aragona e la retorica visiva della crociata” in G. Abbamonte et alter...
-
Upload
museodelprado -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of “Contra Turcos. Alfonso d'Aragona e la retorica visiva della crociata” in G. Abbamonte et alter...
Joan Molina Figueras
Contra Turcos. Alfonso d’Aragona e la retorica visiva della crociata*
Dall’inizio del Quattrocento l’avanzare dei Turchi Ottomani sui Bal-cani, nonché la loro minaccia di oltrepassare le porte di Costantinopoli, consumata poi nel 1453, destò un grande timore in tutto l’Occidente cri-stiano. Suonarono i tamburi di guerra e, un po’ alla volta, la maggioranza dei principi occidentali si fece avanti per condurre una grande crociata che scongiurasse tale minaccia. Alfonso d’Aragona fu uno di essi e, probabil-mente insieme a Filippo di Borgogna, può essere considerato il monarca che riuscì a suscitare una più grande speranza nella materializzazione di tale avventura militare.
Oggi sappiamo che i reali interessi di Alfonso nel progetto della crociata furono di carattere strategico e commerciale anziché religioso.1 Si trattava infatti di controllare i Balcani più che di difendere Costantinopoli; di otte-nere nuove fonti di finanziamento per progetti di ogni sorta tramite le tasse ecclesiastiche; di controllare infine le rotte commerciali del Mediterraneo seguite dai mercanti catalani e valenzani.2 Tuttavia, c’è da chiedersi se gli en-
* Vorrei ringraziare Jofre Albertí, Joana Barreto, Isa Cervelló, Philine Helas e Fran-cesco Senatore per i loro preziosi suggerimenti e informazioni. Questo studio s’inserisce nel progetto di ricerca “Artistas, patronos y público: Cataluña y el Mediterráneo (S. XI-XV)” – HAR2011/23015 – finanziato dal Ministerio de Ciencia e Innovación.
1. F. Cerone, La politica orientale di Alfonso d’Aragona, in «ASPN», 37 (1902), pp. 9-93, 380-456, 555-634, 774-852; 38 (1903), pp. 154-212; C. Marinescu, La politique orientale d’Alfonse V d’Aragon, roi de Naples (1416-1458), Barcelona 1994; A. Ryder, The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The Making of a Modern State, Oxford 1976; J. Vicens Vives Els Trastàmares (segle XV), Barcelona 1980; M. Navarro, Calixto III Borja y Alfonso el Magnánimo frente a la cruzada, Valencia 2003; D. Abulafia, Il mediterraneo all’epoca di Alfonso il Magnanimo, in Alfons el Magnànim de València a Nàpols, Valencia 2009, pp. 97-111.
2. Navarro, Calixto III, p. 103 e sgg.
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Joan Molina Figueras98
tusiastici proclami di Alfonso a favore della guerra santa fossero soltanto un pretesto per una politica di espansione mercantile. La risposta è decisamente negativa. Il timore di un’eventuale campagna turca sulla penisola italiana era fondato, come ben dimostrarono i fatti di Otranto (1480). D’altronde non va dimenticato che, oltre alla schietta retorica o propaganda, il sogno della sconfitta totale degli infedeli e della conquista di Gerusalemme costituì un elemento cardine nell’immaginario di molti monarchi medioevali, uno dei più notevoli dei quali fu indubbiamente Alfonso. Non a caso proclamò ripetutamente il suo diritto ad occupare il trono di Gerusalemme e, ancora, a governare un impero universale in qualità di erede degli Hohenstaufen e degli Angiò. Senz’altro, un sogno idealistico e purtroppo lontano.
Miti, propaganda, retorica sono termini indispensabili per capire la mise-en-scène attuata da Alfonso d’Aragona. Dall’inizio del suo re-gno, specialmente a partire dalla spedizione per la conquista di Napoli, l’entourage del monarca cominciò ad organizzare una delle campagne di legittimazione ed esaltazione aulica più straordinarie di tutto il Quat-trocento europeo. All’inizio, lo scopo fu quello di difendere il suo diritto a occupare il trono della Corona di Aragona e specialmente, il Regno di Napoli; più tardi, quello di disegnarne un’immagine quasi mitica che lo innalzasse in un piano superiore a qualunque altro principe contempo-raneo. Uomini di lettere, specialmente umanisti, artisti ed un variegato gruppo di apologeti di corte si impegnarono intensamente nella produ-zione di ogni sorta di oggetti culturali a carattere celebrativo destinati alle cerchie cortigiane del Regno di Napoli e di tutta l’Italia. Molti furono i motivi scelti per costruire un discorso retorico ed encomiastico ad ma-iorem gloriam di Alfonso: dalle sue virtù come principe alla glorifica-zione della sua stirpe, reale o mitica. Ma non v’è dubbio che il progetto della crociata contro i Turchi, nonché l’immagine di Alfonso come eletto condottiero, occupò un luogo predominante.
I primi testimoni della miticizzazione storiografica di Alfonso come campione della crociata risalgono agli anni Trenta. In quel periodo, ad esempio, avvenne la spedizione militare contro l’isola di Gerba (1432): una inconcludente scaramuccia organizzata per punire i pirati tunisini che attaccavano i navigli commerciali della Corona, presentata invece dagli apologeti di corte come una grande vittoria del cristianesimo sull’Islam. La sublimazione dell’episodio si osserva già nelle storie degli umanisti Barzizza e Facio ma, senza dubbio, il documento più esplicito a nostra disposizione è l’encomiastico poema Carmen de victoria Regis Aragonum
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Contra Turcos 99
contra barbaros composto da Antonio Canobbio, il quale, senza alcun pu-dore trasforma la sfortunata avventura nordafricana in gesta degne di riso-nanza universale.3
Ad ogni modo le manifestazioni letterarie più esplicite sull’argomen-to che c’interessa sono le orationes, exhortationes e le persuasiones con-tra Turcos, sorta di prediche umanistiche, scritte per la corte napoletana durante gli anni Cinquanta, cioè, poco prima o poco dopo la caduta di Costantinopoli. Tra i loro autori, troviamo i nomi di Niccolò Sagundino, Giannozzo Manetti, Poggio Bracciolini, Enea Silvio Piccolomini, Orazio Romano, Domenico Capranica o Matteo Zuppardo.4 Ricordiamo anche Flavio Biondo, autore di due dei testi più conosciuti e diffusi, la Oratio co-ram Serenissimo imperatore Frederico et Alphonso Aragonum rege e il De expeditione in Turchos;5 o Matteo Zuppardo, che nella sua opera Alfonseis attribuisce la vittoria cristiana di Belgrado sui Turchi (1456) alla stretta collaborazione fra Alfonso ed i suoi alleati Scanderberg e Unniadi.6
Considerate produzioni di carattere propagandistico, cresciute in seno alla corte, il principale obiettivo di tutti questi panegirici era quello di in-coraggiare e giustificare, mediante una serie di parallelismi classici, l’orga-nizzazione di una crociata contro i Turchi condotta da Alfonso d’Aragona. Perciò il monarca veniva presentato sotto l’immagine di un nuovo crociato benedetto dalla divinità per proseguire la strada aperta dagli eroi dell’anti-chità, come Scipione e Pompeo, e da quelli del Medioevo, come Goffredo di Bouillon. Una strada che mirava a Oriente e che aveva come proposito la sconfitta degli infedeli che vi si erano stabiliti, nonché la ripresa della Terra Santa. In tutte queste composizioni palpita il mito politico coltivato nella
3. A. Canobius, Carmen de victoria regis Aragonum contra barbaros, in G. Romano, Guiniforte Barzizza all’impresa di Gerba del 1432 e un poemetto inedito di Antonio Cano-bio sullo stesso avvenimento, in «Archivio Storico Siciliano», 17 (1892), pp. 1-27.
4. Cfr. G. Albanese, La storiografia umanistica e l’avanzata turca: dalla caduta di Constantinopoli alla conquista di Otranto, in La conquista turca di Otranto (1480) tra storia e mito, Atti del Convegno internazionale di studio, Otranto-Muro Leccese, 28-31 marzo 2007, a cura di H. Houben, I, Galatina 2008, pp. 319-352, a p. 325. Per Capranica, v. S. Sobrequés, Sobre el ideal de Cruzada en Alfonso V, in «Hispania», 12 (1952), pp. 240-241; su Manetti, P. Botley, Giannozzo Manetti, Alfonso of Aragon and Pompey the Great: a Crusading Document of 1455, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 67 (2004), pp. 129-156.
5. F. Biondo, Scritti inediti e rari, a cura di B. Nogara, Roma 1927, pp. 31-57 e 107-114.
6. M. Zuppardo, Alfonseis, a cura di G. Albanese, Palermo 1990.
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Joan Molina Figueras100
corte alfonsina: l’idea del principe perfetto, eroe cristiano oltreché colto umanista; ed ancor più, una subliminale celebrazione di Alfonso come mo-narca protettore degli storici, consapevole della loro capacità di trasmettere le sue gesta ai posteri.7
Vanno infine citati alcuni testi dove il monarca parla in prima per-sona con una serie di magniloquenti dichiarazioni pubbliche. È il caso del cartellone di sfida scritto nel 1453 in cui lo stesso Alfonso esortava il Gran Khan Maometto ad abbandonare Costantinopoli prima di tre anni, altrimenti avrebbe dovuto patire una terribile punizione. Incominciava il testo con un superbo «Alfonso, per la gràcia de Déu rey d’Aragó e ton destroidor».8 Più che come una fanfaronata, la maestosa dichiarazione va interpretata secondo le leggi della cavalleria. Si tratta di regole che stavano anche alla base del voto di crociata che il monarca pronunciò solennemente in una cerimonia celebrata nella Cattedrale di Napoli il giorno di Ognis-santi del 1455 alla quale partecipò una buona parte della nobiltà campana.9 Dopo essersi proclamato difensore della fede cristiana, avere espresso il suo dolore per la persecuzione sofferta dai cristiani da parte dei Turchi e avere segnalato che non aveva messo in atto prima tale impresa per il timore di essere accusato di superbia, Alfonso dichiarò che aveva deciso di prendere la croce della crociata dalle mani del patriarca di Alessandria e di dichiarare subito la guerra contro i Turchi. Notiamo che tutto ciò av-venne soltanto un anno dopo che Filippo di Borgogna aveva proclamato enfaticamente lo stesso proposito nel celebre Giuramento del Fagiano. Tale circostanza, forse non casuale, mostra la stretta concorrenza nata fra en-trambi per condurre questa specie di guerra propagandistica anteriormente alla programmata guerra santa. Infatti, narrano le cronache che messaggeri e re d’armi di Alfonso furono incaricati di diffondere il suo solenne voto di crociato nelle varie corti europee. Si occuparono cioè di proclamare, urbi et orbi, che egli era disposto a diventare la grande «speranza bianca» dell’immaginario cristiano dell’epoca.
Alfonso e i suoi cortigiani non solo furono consapevoli dell’importanza dei testi e delle parole nel processo di mitizzazione del monarca, ma sep-pero intravedere la potenzialità retorica che avevano certe immagini, come
7. F. Tateo, I miti della storiografia umanistica, Roma 1990, p. 142 e sgg. 8. Sobrequés, Sobre el ideal, p. 248.9. A. Beccadelli (Panormita), Dels fets e dits del gran rey Alfonso, Barcelona 1990,
pp. 290-295.
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Contra Turcos 101
le scenografie per cerimonie fino alle iconografie su supporti perenni. La corrispondenza fra parole ed immagini, l’interscambiabilità dei messaggi fra entrambi i mezzi di espressione e, soprattutto, la loro capacità di operare insieme per rafforzare un programma ideologico, sono aspetti da non dimen-ticare in un approccio più preciso dell’argomento da noi trattato.
Il 23 febbraio 1443 ebbe luogo la celebre entrata trionfale di Alfonso a Napoli, una fastosa e teatrale cerimonia con la quale si volle commemorare la conquista della città ma, soprattutto, sottolineare davanti ad un vasto pubblico, costituito da cortigiani, ambasciatori e rappresentanti di tutti i ceti cittadini, le straordinarie qualità del nuovo monarca (fig. 27). A questo scopo furono create diverse invenzioni scenografiche – alcune finanziate da mercanti fiorentini, altre da catalani – nelle quali si abbinò la rappresen-tazione di una serie di personificazioni delle virtù sacre e politiche tratte dagli specula principis umanistici ad altre con personaggi dell’antichità (Cesare) e vari simboli della cultura cavalleresca (siège perilous).10 Vorrei spostare la nostra attenzione in particolar modo verso il combattimento fra i cavallini e i Turchi che precedette la sfilata della grande Torre delle Quat-tro Virtù Reali e della divisa della Sedia Pericolosa. Secondo la descrizione del Panormita, queste allegorie erano interpretate da un gruppo di giovani catalani in sella a piccoli cavalli di cartapesta, armati con lo scudo arago-nese e la spada, che lottavano contro un gruppo di fanti Turchi, dalle teste mostruose e vestiti al modo persiano e siriano.11 La battaglia non poteva finire che con la sconfitta degli infedeli e chissà se, come accadeva nel ter-ritorio ispanico della Corona – dove questo tipo di rappresentazioni è do-cumentato dalla fine del XIV secolo –12 anche l’allegoria napoletana aveva
10. Per alcuni recenti approcci, v. G. Alisio et alii, Arte e politica tra Napoli e Firenze. Un cassone per il trionfo di Alfonso d’Aragona, Modena 2006; P. Helas, The Triumph of Alfonso d’Aragona in Naples 1443: from Living Images to Pictorical Representations, in The Triumph of Marriage: A Symposium on Renaissance Cassoni, in corso di stampa; J. Molina, Un trono in fiamme per il re. La metamorfosi cavalleresca di Alfonso il Magnanimo in L’umanesimo catalano e l’Italia. Cultura, storia e arte in corso di stampa.
11. A. Beccadelli (Panormita), Alphonsi regis triumphus, in De dictis et factis Al-phonsi Regis Aragonum libri quatuor, Basel 1538, p. 235. Nella solenne sfilata celebrata nel 1423 per celebrare la prima entrata di Alfonso a Napoli fu rappresentato uno spettacolo simile: una lotta fra angeli e un gruppo di Turchi intorno a un grande elefante di legno. H. Maxwell, Uno elefante grandissimo con lo castello di sopra: il trionfo aragonese del 1423, in «Archivio Storico Italiano», 553 (1992), pp. 847-875, a pp. 856-858.
12. F. Massip, De ritu social a espectacle del Poder: l’Entrada triomfal d’Alfons el Magnànim a Nàpols (1443), entre la tradició catalana i la innovació humanística, in La
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Joan Molina Figueras102
una fine ancor più drammatica con la presentazione delle teste dei Turchi trafitte da lunghe lance.13
Si potrebbe dire che la rappresentazione evocava in maniera gene-rica la lotta contro il nemico della fede cristiana, come spesso accadeva in molte delle manifestazioni di questo tipo nel territorio ispanico. Tutta-via disponiamo di un’informazione che ci permette di essere certi che in questo caso l’invenzione fu concepita per ottenere una maggior coerenza con le idee espresse nelle altre allegorie che l’accompagnavano. Si tratta del discorso pronunciato dalla personificazione della Magnanimità, una delle virtù che integrava l’allegoria della Torre Reale. Nella sua allocu-zione la dama esortava il re di Napoli ad intraprendere la lotta contro i Turchi, riprendendo così l’antica tradizione ispanica della Reconquista, garantendogli il successo di tale impresa e mostrandogli come esempio profetico i Turchi sconfitti dai cavalieri cristiani del suo esercito.14 Con tale discorso, dunque, Alfonso è presentato a tutti gli spettatori come un campione del cristianesimo nella lotta contro il Gran Turco. Una circo-stanza che invita, secondo quanto si è esposto, a situare l’encomiastico messaggio dell’allegoria visiva nella stessa linea dei panegirici scritti al-cuni anni dopo dagli apologeti di corte e a considerare quindi fino a che punto il programma dell’entrata, concepito poco dopo la conquista di Napoli, sia stato all’origine di alcuni testi posteriori, ovvero, a riflettere su come le immagini riuscirono a suscitare o stimolare una serie di opere letterarie anziché il contrario.
C’è da chiedersi se l’allegoria fosse stata concepita per esprimere i desideri di coloro che l’avevano finanziata, cioè, dei mercanti catalani. In-fatti, dagli studi di Philine Helas, risulta che le invenzioni dei mercanti fiorentini (con l’immagine di un Cesare sottomesso al fato) non solo servi-rono alla glorificazione di Alfonso, ma anche ad una fiera rivendicazione delle libertà della Repubblica toscana di fronte alle velleità imperialistiche
Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo, XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona, Napoli 1997, a cura di G. d’Agostino, G. Buffardi, 2 voll., Napoli 2000, p. 1867.
13. A. Duran i Sanpere, J. Sanabre, Llibre de Solemnitats de Barcelona, vol. 1, Bar-celona 1924, p. 331.
14. Beccadelli, Alphonsi regis triumphus, p. 236: «Magnanimitas regem hortabatur ad animi excellentiam, subinde demonstrans barbaros illos ab Hispanis victos fugatosque, ut intelligeret rex, siquando bellum suscepturus esset contra infideles et a Christi nomine abhorrentes, Hispano praesto esse ac procul dubio victores evasuros».
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Contra Turcos 103
del monarca aragonese.15 In un altro senso, ma in modo simile, si potrebbe pensare che con l’allegorica vittoria sui Turchi e la solenne proclamazione di Alfonso come crociato, i mercanti catalani dessero voce ad una delle loro maggiori aspirazioni: in questo caso, la difesa delle loro attività com-merciali con i porti orientali di fronte alle ingerenze ottomane e la sconfitta di qualunque concorrenza o minaccia ai navigli della Corona. Allo stesso modo è anche probabile che sia i fiorentini che i catalani vedessero nelle invenzioni scenografiche che finanziavano per l’entrata trionfale un’ottima occasione per trasmettere al monarca ed al pubblico in generale dei mes-saggi legati al loro sistema di valori e credenze.
Va chiarito però che i nemici rappresentati erano soltanto i Turchi Ottomani e non tutti i musulmani. Infatti, alcuni sudditi dei regni afri-cani, per esempio, svolsero un ruolo nella solenne entrata trionfale ben diverso da quello concesso agli Ottomani (fig. 28). Da una parte, la de-scrizione di Marino Jonata ci riferisce la partecipazione di due Etiopi che sfilarono a cavallo accompagnando il carro con la personificazio-ne di Cesare, forse con allusione al potere universale dell’imperatore.16 Dall’altra sappiamo che gli ambasciatori del re della Tunisia facevano parte del distinto corteo con cui si concludeva l’entrata e che, per la precisione, sfilarono fra il principe di Salerno e il Duca di Sessa.17 Era questa una dimostrazione di omaggio o di sottomissione al monarca ara-gonese? Per la loro situazione e rango mi sembra più plausibile la prima ipotesi. Sebbene all’inizio del suo governo Alfonso dirigesse diversi at-tacchi contro la Tunisia sta di fatto che a partire dagli anni Trenta preferì mettere in atto una strategia diplomatica per far divenire il Regno di Tunisia, così vicino al Regno di Napoli, un alleato strategico sia per la conquista del territorio italiano che per la crociata contro l’Impero Ottomano. Le ambascerie e i regali si susseguirono ininterrottamente,
15. P. Helas, Der Triumph von Alfonso d’Aragona 1443 in Neapel. �u den Darstellun-�u den Darstellun-gen herrscherlicher Einzüge zwischen Mittelalter und Renaissance, in Adventus-Studien. �um herrscherlichen Einzug in die Stadt, a cura di P. Johanek, A. Lampen, Köln-Weimar-Wien 2009, pp. 133-228.
16. «Et postea Ethyopi duo similer equitati», cit. in F. Ettari, El Giardeno di Mario Jo-nata Aragonese, in «Giornale napoletano di filosofia e lettere, scienze morali e politiche», 9 (1885), pp. 772-845.
17. G.M. Monti, Il trionfo di Alfonso I di Aragona a Napoli in una descrizione con-temporanea, in «Archivio scientifico del Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Bari», 6 (1931-1932), pp. 113-125, a p. 122.
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Joan Molina Figueras104
dimostrando fino a che punto le relazioni di Alfonso con i regni islamici fossero suscettibili di orientamenti opposti.
Grazie all’elenco documentario realizzato dall’erudito napoletano Ca-millo Minieri Riccio sappiamo che il trionfo vagheggiato sui Turchi, rap-presentato nell’entrata trionfale del 1443, fu ripetuto tutti gli anni nella processione commemorativa della presa della città. Infatti, ogni 2 giugno un’affollata comitiva presieduta dal re e dall’arcivescovo partiva dalla catte-drale, attraversava alcune delle vie principali della città partenopea e, dopo aver varcato la porta della città, si dirigeva verso la chiesa di Santa Maria della Pace, sita nel Campo Vecchio, dove venivano celebrati diversi giochi e un banchetto.18 Qui il quadro scenico rappresentato non era più la lotta fra Turchi e cristiani ma un’allegoria processionale che alludeva alla sconfitta o sottomissione alla quale erano destinati gli Ottomani secondo gli apologeti di corte. Così va interpretato il gruppo che apriva la processione, composto da otto uomini vestiti alla turca che portavano lo stendardo con la croce rossa di san Giorgio. Dietro di loro, sfilavano i 210 balestrieri della confraternita mi-litare sotto l’invocazione del santo cavaliere, poi, gli organizzatori dell’avve-nimento che con i ceri accesi proteggevano, alla stregua della milizia celeste, il re e tutte le autorità ecclesiastiche che partecipavano alla processione.
Notiamo dunque che l’evocazione della lotta contro gli Ottomani fu, mediante un modo di espressione più simbolico che narrativo, il solo quadro scenico della complessa entrata trionfale celebrata nel 1443 che si ripeté lungo tutto il governo di Alfonso. Acquisendo una ritualizzazione processionale, essa perse alcuni degli accenti presenti nel programma visi-vo originale disegnato dai mercanti catalani, ma allo stesso tempo assunse altri valori con cui si pretendeva affermare il potere militare e imperialisti-co del monarca. Infatti, la rappresentazione processionale non serviva più a trasmettere un messaggio di rivendicazione, ma diventava, fondamental-mente, un’espressione del prestigio di Alfonso come crociato.
Da Valencia, sicuramente la città iberica più amata da Alfonso, si pre-se in prestito il modello a cui si ispirò la fondazione della corporazione napoletana dedicata a san Giorgio. Infatti, dal 1371 esisteva nella città la suddetta confraternita del Centenar de la Ploma, un’istituzione sotto la
18. C. Minieri Riccio, Alcuni fatti di Alfonso I di Aragona, in «ASPN», 6 (1881), pp. 417-418 e, più in particolare, F. Senatore, La processione del 2 giugno nella Napoli arago-nese e la cappella di S. Maria della Pace in Campidoglio, in «Annali di storia moderna e contemporanea», 16 (2010), pp. 343-361.
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Contra Turcos 105
protezione del santo guerriero integrata da un gruppo di balestrieri al servi-zio del monarca.19 Come bene illustra la pala d’altare finanziata da questa corporazione (London, Victoria & Albert Museum), il culto di san Gior-gio era strettamente legato all’idea di guerra santa e, in particolare, alle crociate contro gli infedeli musulmani intraprese da secoli dai monarchi catalano-aragonesi.20 D’altronde, molte sono le notizie che mettono in ri-lievo la venerazione dei monarchi verso san Giorgio in qualità di patrono dinastico e protettore della crociata lungo tutto il basso Medioevo.21 In di-verse cronache reali viene descritta la miracolosa apparizione del cavaliere celeste agli eserciti catalano-aragonesi subito prima di alcune delle batta-glie più famose contro i musulmani: dalla difesa di Barcellona dall’attacco di Al-Mansur (986) fino agli scontri per la conquista di Maiorca (1232) e Valencia (1237). Sulla base di queste leggende Pietro il Cerimonioso (1336-1387) promosse l’istituzionalizzazione del culto mediante una serie di azioni, tra le quali, la strenua campagna per l’acquisizione delle reliquie del corpo del santo e la fondazione di un ordine di nobili e cavalieri, sotto il nome di Cavalieri di San Giorgio, a cui furono concesse le insegne del mantello di raso (drap) bianco e la croce rossa. Nel 1399 fu invece il figlio, Martino l’Umano, che non esitò ad affermare che «lo dit mossenyer Sant Jordi és cap, intercessor de la casada d’Aragó».22
Sulla strada intrapresa dai sui predecessori, Alfonso continuò a pro-muovere questo culto aulico. Come aveva già ordinato Pietro il Cerimo-nioso quasi un secolo prima, il segno della croce rossa contraddistingueva gli stendardi e l’abbigliamento dei soldati nelle campagne militari. Perfino Napoli fu conquistata nel 1442 sotto il segno di san Giorgio e san Michele. Inoltre, riecheggiando un’antica tradizione, il suo nome divenne l’urlo di guerra che incoraggiava i soldati prima della battaglia, come una sacra invocazione per ottenere la vittoria.23 Non c’è da stupirsi dunque se Alfon-
19. F. Sevillano, El Centenar de la Ploma de la ciutat de València, Barcelona 1966. 20. A. Serra, A. Serra, Ab recont de grans gestes. Sobre les imatges de la història i de la llegen-
da en la pintura gòtica de la Corona d’Aragó, in «Afers», 41 (2002), pp. 15-35, a p. 32. 21. R. d’Alós-Moner, R. d’Alós-Moner, Sant Jordi, patró de Catalunya, Barcelona 1926; J. Vincke, El
culte de Sant Jordi en terres catalanes durant l’Edat Mitjana com a expressió de les rela-cions entre l’Església i l’estat en aquella època, Barcelona 1933.
22. A. Rubió i Lluch, A. Rubió i Lluch, Diplomatari de l’Orient català (1301-1409), Barcelona 1947, doc. 655, p. 683.
23. Marqués de Santillana, La Comedieta de Ponza, a cura di M.P.A. Kerkhof, Madrid 1987, p. 172.
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Joan Molina Figueras106
so cercava anche di diffondere il suo culto nei vari ambienti della stessa Napoli, nuova capitale del suo regno di oltremare.24 Si trattava di un tenta-tivo innovativo in quanto san Giorgio godeva di scarsa fama nel pantheon agiografico della città partenopea. Infatti, malgrado gli sforzi del monarca, questa situazione non cambiò sostanzialmente e il suo culto continuò ad occupare un posto marginale nell’immaginario napoletano. Tuttavia sap-piamo che durante il regno di Alfonso si sviluppò una notevole campagna di promozione figurativa del santo cavaliere. Accanto alla chiesa di San-ta Maria della Pace, Alfonso fece costruire due cappelle dedicate ai santi protettori dei suoi eserciti, san Michele e san Giorgio.25 Quella dedicata a quest’ultimo fu eretta nella bocca del pozzo da dove erano usciti i primi soldati entrati nella città. Poco dopo, nel 1457, commissionò al pittore Pe-rinetto di Benevento diversi affreschi per la chiesa della Madonna, alcuni con le storie di san Giorgio e la principessa.26 Nulla rimane di tutto ciò e nemmeno della maggior parte degli oggetti di corte ornati con immagini o emblemi dedicati al santo cavaliere, da quelli di carattere rappresentativo fino ad altri di uso liturgico o devozionale.
Per fortuna disponiamo ancora di altre immagini sopravvissute al passare del tempo. È il caso delle illustrazioni che aprono le principali se-zioni liturgiche in alcuni manoscritti devozionali appartenuti ad Alfonso, come il Breviario di re Martino (Paris BnF, ms. Rothschild 2529, f. 444v) o uno dei suoi Libri d’Ore (Napoli BN, ms. I. B. 55, f. 214) (fig. 29). In entrambi i casi sono presenti iconografie tradizionali senza alcun partico-lare che segnali la volontà di venerare il santo cavaliere come campione della guerra santa. Ad ogni modo, mi sembra che l’idea della crociata fosse così forte nella corte napoletana che non occorreva un’esplicita allusione ad essa per rievocarla.
Invece, questo riferimento è del tutto palese in un’illustrazione pre-sente in un altro dei Libri di Ore di Alfonso (London, BL, ms. Add. 28962, f. 78) (fig. 30). La scena apre l’orazione Pro intrantibus bellum contra paganos, un’invocazione da recitare prima della battaglia contro i pagani
24. G. Vitale, G. Vitale, I santi del re: potere politico e pratiche devozionali nella Napoli angioi-na ed aragonese, in Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiorno medievale, a cura di G. Vitolo, Napoli 1999, pp. 93-128, a pp. 104-108; N. Jaspert, Santos al servicio de la Co-rona durante el reinado de Alfonso el Magnánimo (1419-1458), in La Corona d’Aragona, II, pp. 1839-1857, a p. 1847.
25. Minieri, Alcuni fatti, pp. 244-248; Vitale, I santi del re, pp. 112-114.26. Minieri, Alcuni fatti, p. 454.
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Contra Turcos 107
ispirata al salmo LXXVIII Deus, venerunt gentes in hereditatem tuam, in-terpretato come un riferimento velato alla riconquista cristiana di Gerusa-lemme.27 Prologo e sintesi visiva del testo, l’immagine citata rappresenta un re – da identificare con Alfonso perché porta le sue imprese personali, il libro ed il miglio – che mette in fuga la cavalleria musulmana. La composi-zione ricorda moltissimo quella rappresentata nella tavola del Centenar de la Ploma. Un parallelismo affatto fortuito in quanto l’adozione del modello utilizzato per evocare il trionfo di Giacomo I sui musulmani nella tavola del Centenar è ideale per prefigurare la vittoria di Alfonso sui Turchi e presentarlo come l’eroe della crociata. Ci troviamo, dunque, di fronte ad un consapevole “trasferimento” iconografico con il quale si pretese (e si ottenne) l’esaltazione maestosa di Alfonso di Aragona, reincarnazione del suo antenato e dello stesso san Giorgio.
Sebbene confinato agli ambienti cortigiani, il culto del santo cavaliere fu anche praticato intensamente dai successori di Alfonso. Ciò spiega perché nel 1480 il Pontano elaborò una composizione, compresa nel De laudibus divinis, il cui motivo principale è uno spettacolare trofeo di armi catturate ai Turchi che il duca di Calabria, il futuro Alfonso II, offre a san Giorgio in se-gno di gratitudine per la vittoria di Otranto.28 Insomma, un chiaro segno che, almeno nella cerchia della corte napoletana, la sua fama di santo protettore contro gli infedeli rimase intatta durante tutta la stagione aragonese.
Era l’anno 1353 quando Pietro il Cerimonioso ordinò che il cimiero degli scudi di armi reali venisse occupato dalla figura di una vipera alata che i documenti dell’epoca designano con il nome di vibra.29 L’insegna conquistò una notevole fortuna e diventò uno degli emblemi preferiti dei monarchi catalano-aragonesi (fig. 31). Più precisamente, sappiamo che Al-fonso il Magnanimo la ostentò in varie occasioni sul suo elmo durante vari tornei celebrati prima a Valencia e in seguito a Napoli.30 Ne ordinò anche
27. A. Villalba Davalos, La miniatura valenciana en los siglos XIV y XV, Valencia 1964, pp. 113-114; F. Español, El salterio y libro de horas de Alfonso el Magnánimo y el cardenal Joan de Casanova, in «Locus Amoenus», 6 (2002-2003), pp. 91-114, a pp. 107-109.
28. «Alfonsus Calabriae Dux Divo Georgio trophaeum erigit ob superatos ad Hydrun-«Alfonsus Calabriae Dux Divo Georgio trophaeum erigit ob superatos ad Hydrun-tem Turcos», cit. in Vitale, I santi del re, pp. 116-117.
29. J. Riera, J. Riera, Els heralds i les divises del rei Martí (1356), in «Paratge. Quaderns d’Estudis de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària», 14 (2002), pp. 41-61, a pp. 41 e 46-47.
30. Cfr. J.V. Garc�a Marsilla, Cfr. J.V. Garc�a Marsilla, La estética del poder. Arte y gastos suntuarios en la corte de Alfonso el Magnánimo (Valencia, 1425-1428), in La Corona d’Aragona, II, pp. 1705-1717, a p. 1709.
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Joan Molina Figueras108
la sua raffigurazione su una serie di oggetti e di edifici a lui particolarmente cari, dai libri della sua biblioteca ai rilievi scolpiti in diverse costruzioni (fig. 32). Altrettanto significativa ci sembra la sua presenza nel Real d’Or, una moneta coniata nel 1426 a Valencia (fig. 34).
Che sia frutto di confusione o di una certa vicinanza fra le due creature alate, sta di fatto che in diverse immagini realizzate durante il regno di Al-fonso la vibra appare rappresentata sotto la forma di un pipistrello (vesper-tilio). Una prova del possibile scambio fra le immagini delle due bestie si trova in una notizia del 1436 da cui si apprende che si dovrà rappresentare «la vibra o lo rat penat per obs de la tenda que’s fa de manament del senyor Rey».31 Anni dopo sarà il grande Pisanello a lasciarci delle bellissime testi-monianze figurative di come, col passar del tempo, la vibra si sia identifi-cata a tal punto con il pipistrello che prese perfino la sua stessa forma. Mi riferisco ai suoi affascinanti disegni di elmi e armature con le insegne reali, illustrazioni che ci offrono le tracce per provare a ricostruire l’immagine, veramente avvincente, di quell’Alfonso che partecipò ai tornei napoletani vestito con una luccicante armatura dei Missaglia coronata con il pipistrel-lo (fig. 33). D’altronde, in un poema del 1454 firmato da Denis Guinot, nel descrivere l’elmo di Alfonso, si parla della presenza di una creatura metà vipera, metà pipistrello. «Vi star un rey portant sobre.l cap timbre: vibra respant, de rat-penat les ales».32
Nel cercare una possibile spiegazione logica a questo processo di ibrida-zione-sostituzione conviene ricordare che il pipistrello fu uno dei simboli im-periali della casa Hohenstaufen e che già dalla fine del XIII secolo fu adottato come insegna da alcuni dei predecessori al trono di Alfonso.33 Fin dal primo momento venne fatta una lettura del tutto positiva di questa creatura dell’oscu-rità, in quanto secondo un’antica tradizione profetica di origine germanica, i monarchi portatori del vespertilio erano considerati i candidati ideali per governare un impero universale, quello che sarebbe sorto dopo lo sterminio di tutti i nemici della fede cristiana. Intriso di connotazioni millenaristiche, il
31. J. Sanchis Sivera, J. Sanchis Sivera, Pintores medievales en Valencia, in «Archivo de Arte Valen-ciano», 15 (1929), pp. 42-43.
32. M. de Riquer, M. de Riquer, Heràldica catalana des de l’any 1150 al 1550, Barcelona 1983, I, p. 24.
33. M. Aurell, M. Aurell, Messianisme royal de la couronne d’Aragon (14e-15e siècles) in «An-nales, Histoire, Sciences Sociales», 52/1 (1997), pp. 119-155, a p. 137 e sgg; Aurell, La fin du monde, l’Enfer et le roi, in «Revue Mabillon», 5 (1994), pp. 144-154; E. Duran, La imatge del rei Alfons, in La Corona d’Aragona, II, pp. 1401-1418, a p. 1402.
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Contra Turcos 109
simbolo della creatura alata offrì numerose letture possibili di grande valore propagandistico per tutti i monarchi che si identificassero in esso.
Nel caso d’Alfonso d’Aragona sappiamo che vi fu uno stretto legame fra l’emblema del vespertilio ed una politica (o sogno) di carattere imperiali-stico che significava lo sviluppo della guerra santa contro gli infedeli stabili-tisi sul versante orientale del Mediterraneo. Nei decenni precedenti la caduta di Costantinopoli, e nel contesto della ricerca di un salvatore universale del mondo cristiano, diverse tradizioni profetiche identificarono i primi monar-chi Trastamara con il vespertilio.34 Più precisamente, Alfonso era presentato come il vespertilio destructor Sarracenorum, un titolo con cui era già stato designato suo padre e il cui primo significato faceva riferimento alla sconfitta dei saraceni nella penisola ispanica.35 Aldilà di qualsiasi limite geografico Denis Guinot, nel suo poema profetico Obra figurativa, segnala che Alfonso è l’eletto per combattere i Turchi e diventare, per volontà divina, l’imperato-re universale: («perque Déu volia que fos de l’univers, monarca»).36
Un tono e un senso simili scaturiscono dalle profezie comprese in un manoscritto conservato a Carpentras, secondo Aurell, un vero e proprio repertorio del messianismo e della escatologia catalana. In uno dei testi di cui si compone, un componimento anonimo datato 1449, Alfonso e il figlio Ferrante sono presentati come due controfigure dell’Anticristo mistico, il personaggio apocalittico che, interpretato in chiave positiva, dovrà caccia-re via gli eretici dalla Chiesa e far fuori i nemici della fede cristiana. Alfon-so, si dice, sederà sul trono imperiale dopo una serie di campagne militari contro gli infedeli; Ferrante, da parte sua, sarà incaricato di intraprendere una profonda riforma della Chiesa e lo sterminio del resto dei musulmani.37 Il pipistrello diviene l’immagine simbolica citata spesso per sottolineare il potere soprannaturale e apocalittico che renderà possibile il successo di tali gesta. Alfonso, in particolare, viene evocato in varie occasioni sotto l’immagine del vespertilio che apre le sue ali immense sopra i propri do-mini, fino al lontano Oriente. Lo spirito di crociata, il desiderio di costruire un’allettante e retorica immagine del monarca aragonese che potesse con-correre con quella disegnata dal terribile e possente Gran Turco, animano
34. Aurell, Aurell, Messianisme royal, pp. 119-123.35. D. Barca, D. Barca, Alfonso il Magnanimo e la tradizione dell’immaginario profetico cata-
lano, in La Corona d’Aragona, II, pp. 1285-1286.36. Duran, Duran, La imatge del rei, p. 1410.37. Aurell, Aurell, Messianisme royal, pp.145-146.
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)
Joan Molina Figueras110
l’identificazione di Alfonso con l’animale del suo emblema personale. Una circostanza che si osserva anche chiaramente nell’oracolo valenzano «Sur-ge, vespertilio, surge», un enfatico richiamo al monarca aragonese affinché intraprenda la lotta contro gli Ottomani.38
Le immagini e i simboli legati alla crociata ci offrono la possibilità di arricchire un discorso che, finora, si è basato principalmente sullo studio delle fonti letterarie. Sebbene più sintetiche ed elementari dei testi, biso-gna riconoscere che determinate iconografie – come la rappresentazione scenica del combattimento fra Turchi e cristiani – dovettero risultare molto efficaci da una prospettiva psicologica allo scopo di lanciare un messag-gio, molto semplice e diretto, ad un vasto numero di spettatori. Inoltre, è ovvio che, viste nel loro insieme, le immagini evocavano alcune delle idee basilari del progetto di crociata condotto dal monarca: Alfonso era il gene-rale vittorioso destinato a sconfiggere i Turchi (ricordiamo l’invenzione dei cavalli cristiani contro gli Ottomani); il monarca godeva della protezione celeste di un riconosciuto miles Christi (come succede con la promozione di immagini dedicate a san Giorgio); infine, la sua missione era sacra e di portata universale (come ricorda il riferimento al pipistrello). A questo punto, chi poteva negare che Alfonso fosse il candidato ideale per condurre la crociata contro il Gran Turco, per diventare un potente imperatore dalle mire universalistiche? Le immagini, con tutte le loro limitazioni ma anche con tutto il loro fascino, finirono per definire e progettare decisamente i profili di uno degli “avatar” di Alfonso di Aragona, una delle personalità mitiche promosse dalla propaganda della sua corte napoletana.
38. Ibidem, p. 141.
La battaglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra parole e immagini. A cura di Giancarlo Abbamonte et al. (Roma, Viella, 2011)