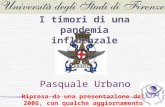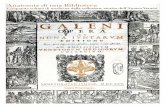UNA BATTAGLIA DI RETROGUARDIA
Transcript of UNA BATTAGLIA DI RETROGUARDIA
UNA BATTAGLIA DI RETROGUARDIA
LEDO STEFANINI, Università di Mantova-Pavia
1. LA VOCE DELLA RAGIONE
Al conte Monaldo Leopardi (Recanati, 1776 – ivi, 1847) toccò la non invidiabile ventura di passare alla
storia come padre insensibile e severo di un grande figlio. Ma questa è solo la vulgata diffusa nelle
scuole. In realtà, fu uomo di valore o, perlomeno, di vasta cultura e, a volergli trovare un ascendente
letterario, si potrebbe assimilare a don Chisciotte. Gli si farebbe torto, a volerlo credere discendente da
don Ferrante, poiché la sua biblioteca era ben più fornita di quella del personaggio del Manzoni. E,
soprattutto, utilizzata: Monaldo Leopardi fu infatti un serio studioso di storia, filosofia, economia e
diritto, studi a cui era stato indirizzato da un gesuita.
Il 1835 fu l’anno in cui Gregorio XVI tolse dall’Indice Dei Libri Proibiti le opere di Copernico, Keplero e
Galileo e possiamo immaginare che cos’avrà provato nella triste circostanza, il conte Monaldo. La
decisione di Gregorio XVI non fu affrettata; infatti erano trascorsi ormai 10 anni da che Laplace aveva
pubblicato il quinto volume della Mecanique céleste1
1 Laplace, Pierre Simon de (1825), Mécanique céleste, Vol. V, Imprimerie du Chapelet, Paris.
mentre l’ Exposition du système du monde2 era alla quinta edizione.
2 Laplace, Pierre Simon de (1796), Exposition du système du monde, Paris
Due opere con cui il grande matematico portava a perfezione la descrizione matematica del modello di
sistema solare che Newton aveva rozzamente esposto un secolo prima.
Rinserrato nella sua cittadina di provincia (triste ridotta culturale dell’ancien régime), il Leopardi,
combatté l’ultima battaglia contro il modernismo e contro Copernico. L’arma di cui si servì fu un
quindicinale da lui fondato nel 1832, di cui era quasi redattore unico, pur con l’aiuto della figlia Paolina.
Si chiamava La voce della ragione e venne chiuso d’autorità nel 1835, a causa delle sue posizioni troppo
conservatrici persino per la Curia. Nel suo ultimo anno di vita, la rivista pubblicò in sei puntate un lungo
pamphlet contro il modello che l’autore definisce copernicano, anche se, ai tempi, aveva ormai poco a che
fare con Copernico. Sulla rivista, il lavoro non è firmato che con le iniziali A.C., e neppure riporta il
nome dell’autore l’edizione che se ne fece a Genova due anni dopo (1837). Di quella edizione si sono
salvate poche copie, una delle quali porta, sul frontespizio, la scritta: «Donato a questa Casa dall’autore
Sig. Antonio Casanova Suggetto d.a Prov. Di Genova».
2. INSEGNAMENTI RICAVABILI DA UN TRATTATO ‘REAZIONARIO’
Il riferimento ideologico e culturale dell’autore non è uno scienziato, ma un filosofo torinese che,
al di là delle sue intenzioni, ha finito per divenire simbolo del conservatorismo: Joseph de Maistre
(1753 – 1821), le cui opere cita ripetutamente. Il titolo del libretto è
DUBBJ, DIFFICOLTÀ E RIFLESSIONI SULL’IPOTESI DEL MOTO DELLA TERRA E
SUL SISTEMA DELLE FORZE CENTRALI APPLICATE DA NEWTON E SUOI
SEGUACI ALLA SPIEGAZIONE DELLE ORBITE PLANETARIE ,
PROPOSTE DA UNA PERSONA, CHE AMA DI ESSERE ILLUMINATA ED
ISTRUITA.
Estratto dalla Voce della Ragione tom. 14 nuneri 80, 81, 82, 83, 84, e tom. 15 num. 85, ora
riprodotte tutte assieme riunite con correzioni, ed aggiunte.
Genova, tipografia di Giovanni Ferrando, 1837.
Nella Prefazione, l’autore non nasconde le finalità del suo lavoro:
« Io sospetto moltissimo, che questo impegno di pubblicare, come certo e dimostrato il moto
della terra, sia in varii scrittori l’effetto di un odio vatiniano contro la sacra Inquisizione, i
papi, e la Chiesa; l’effetto di un desiderio di spargere sugli Ecclesiastici il vergognoso
carattere d’ignoranti, fanatici, e persecutori della verità; quindi io sono di opinione, che se il
sacro Tribunale dell’ Inquisizione non avesse condannato il detto sistema, esso ormai
sarebbe andato in dimenticanza, o riposto nel numero delle favole; ma avendolo condannato
replicatamente, è cresciuto in tanti filosofi miscredenti il prurito di dichiararlo certo, e
dimostrato per far onta al Clero Cattolico, ai sommi Pontefici, e a tutta quanta la Chiesa. Se
questo mio sospetto sia fondato, o no, si potrà giudicare dai seguenti dubbii, che propongo
contro il detto sistema, non che contro di Newton circa le forze centrali applicate da esso alla
spiegazione delle orbite planetarie.»
Un’opera ideologica e di retroguardia già ai tempi della pubblicazione, sepolta sotto il prodigioso
sviluppo della meccanica celeste e dell’astrofisica, che ha fatto di questo opuscolo solo un triste residuo di
un paradigma scientifico ridotto a cascame storico. Tuttavia il confronto con le idee che Casanova
esprime non è vano esercizio di snobismo intellettuale: i problemi connessi con l’ammissione del moto
della Terra non sono così banali e la loro risoluzione, nell’ambito della fisica moderna, richiede notevoli
conoscenze di fisica e di astronomia.
Per questo ci siamo limitati a riportare solamente quattro dei quattordici dubbj del Casanova, conservando
la forma con cui l’autore li propone, limitandoci a sintetizzare un testo che, diversamente, sarebbe di
lettura eccessivamente pesante.
3. DUBBIO E DIFFICOLTÀ PRIMA CONTRO IL MOTO DELLA TERRA.
«La terra, secondo l’ipotesi copernicana, in 24 ore fa circa il suo asse, un circolo di rotazione
di 360 gradi, de’ quali il più grande è quello sotto l’equatore, perché contiene 60 miglia
italiane; quindi moltiplicando 60 per 360, ne risulta la somma di 21,600 miglia italiane, che
scorre la terra circa il suo asse nello spazio di ore 24 sotto l’equatore : in un’ora ne scorre
900, perché in 21,600, il 24 vi sta 900 volte: in un minuto primo ne percorre 15 perché in
900 il 60 vi sta 15 volte: in un minuto secondo fa un quarto di miglio, perché in 15 il 60 vi
sta una quarta parte»
Secondo i sostenitori del moto di rotazione della Terra, la velocità all’equatore sarebbe di 465 m/s; quindi, in
assenza della gravità, in un secondo, un corpo all’equatore percorrerebbe un segmento tangente alla
superficie terrestre lungo circa un quarto di miglio, allontanandosi dalla terra di circa 17 mm ( 7,5 linee).
Ma, dicono i sostenitori del modello di Newton, a causa della gravità, nello stesso tempo, il corpo cadrebbe
di 4,9 m (15 piedi) , che è molto maggiore dei 17 mm di allontanamento.
«Dunque i corpi liberi esistenti sulla superficie della terra non possono concepire alcuno
slancio rettilineo in vigor della rotazione diurna, perché questo slancio rettilineo viene
interamente distrutto dalla forza di attrazione, la quale è molto maggiore di quella che porta
i corpi ad allontanarsi dalla periferia per il solo spazio di linee sette e mezza.».
A questo argomento si può rispondere che le due forze – quella di gravità di 15 piedi e quella di projezione di
1425 piedi (un quarto di miglio) – non hanno la stessa direzione e quindi la loro risultante non è
perpendicolare alla terra. Pertanto, una sferetta appoggiata su un piano orizzontale dovrebbe rotolare verso
est, se fosse vero che la terra ruota. A maggior ragione si dovrebbe muovere l’aria che, per la maggiore
altezza, è soggetta una forza di projezione maggiore « … e perciò si dovrebbe continuamente sentire un
turbine di vento dall’occaso all’oriente capace di abbattere uomini, bestie, alberi, edifizj ec.: ma ciò non
succede; dunque sembra una chimera il moto rotatorio della terra.»
Ne vale far ricorso all’esperienza ideale descritta nella Giornata Seconda del Dialogo di Galilei in cui i
posteri vogliono riconoscere l’enunciazione del Principio di Relatività:
«Né si dica che il navigante cammina liberamente e con eguale facilità dentro la nave per
qual verso gli piace, come che ad un tempo stesso questa lo trasporti o per la medesima o per
l’opposta direzione, giacché passa una grandissima differenza fra questo caso e il primo: in
fatti l’esperienza, e le leggi della meccanica insegnano, che un corpo il quale si muova
lentamente , e in linea sensibilmente orizzontale non produce negli altri corpi liberi situati su
di esso, veruna tendenza allo slancio rettilineo, ma che la produce bensì un corpo mosso
velocemente con moto di rotazione: ora il moto della nave è un moto lentissimo in paragone
di quel della terra, è sensibilmente orizzontale e retto, ed insensibilmente curvo, e quindi non
può produrre nei corpi che sono in essa nave veruna tendenza verso prora, ovvero verso
poppa; perciò questi corpi restano affatto indifferenti … ».
Sui corpi liberi sulla superficie della terra deve agire continuamente una forza tale da conservare loro uno
slancio di un quarto di miglio al secondo. Pertanto l’analogia con il caso descritto da Galilei non può
sussistere.
4. DUBBIO SECONDO
«Secondo l’ipotesi Copernicana tutta la nostra atmosfera ha in se stessa fin dall’origine
l’impressione del moto rotatorio unitamente alla terra, dalla quale essendo alta miglia 50,
deve per conseguenza descrivere, nel tempo stesso, un circolo maggiore di quello, che la
superficie terrestre, giacché secondo le leggi meccaniche, quanto le parti sono più o meno
lontane dall’asse di rotazione, formano nell’aggirarsi, archi più o meno grandi, e la velocità
delle parti più lontane dall’asse, sta a quella delle parti più vicine, come gli archi formati
dalle prime, a quelli formati dalle seconde; quindi trovandosi spesso alti da terra due o tre
miglia corpi pesanti, come per esempio grandini, aereoliti ec., questi in un minuto secondo
devono concepire un moto di rotazione, ossia velocità maggiore di quella di un quarto di
miglio, che concepiscono i corpi attaccati ed incastrati sulla superficie terrestre. Ciò posto,
la meccanica e l’esperienza insegnano che ogni moto rotatorio tende ad estrudere le parti
rotanti, cioè scagliarle lontane dal centro del moto: così se un secchiello con acqua dentro e
pendente da una corda, facciasi girare dintorno alla mano, ed al braccio con impeto
sufficiente, l’acqua non cascherà fuori del vaso, anzi colui che la mena in giro, sentirà
sempre, che il vaso tira la corda, e fa forza per allontanarsi dal braccio; in tal modo per
quanto il chierichetto faccia andar alte le ondulazioni dell’incensiere, non per questo se ne
sparpaglian le bragie; l’acqua e le bragie son ritenute a quel moto dalla forza di rotazione,
che distrugge l’azione della gravità, in virtù della quale, ognun vede, che in certe situazioni
cadrebbero a terra, se non vi fosse quel moto, che ostasse …»
La velocità degli strati superiori dell’atmosfera ( alla quota di 50 miglia, ovvero di 92 km) dovrebbero
viaggiare a velocità superiore a quella del suolo, poiché
dove indica la velocità angolare della Terra e d la distanza dal suo asse. Ma la forza centripeta,
necessaria a mantenere i corpi su una traiettoria circolare è proporzionale al quadrato della velocità:
Nel contempo, all’aumentare dalla distanza dal centro della Terra, la forza di gravità diminuisce in
ragione inversa al quadrato della distanza:
dove g0 indica il campo gravitazionale terrestre a livello del mare e g lo stesso alla distanza d al centro
della Terra. Pertanto, all’aumentare della distanza dall’asse di rotazione terrestre, aumenta la forza
centripeta necessaria a mantenere quella distanza, mentre l’attrazione gravitazionale diminuisce. Ne segue
che i corpi che stanno in alto, come la grandine, a causa del moto di rotazione, dovrebbero fare come
l’acqua nel vaso che ruota, cioè dovrebbero rimanere in alto. Ma questo non accade: quindi la terra non
ruota intorno al proprio asse. Inoltre, ammesso che un corpo cada da tale altezza, sarebbe animato da una
grande velocità in direzione est ( 470 m/s) che dovrebbe conservare, perché la forza di gravità agisce in
senso perpendicolare a tale velocità. Pertanto, al termine della caduta, questi corpi si dovrebbero trovare
grandemente spostati verso est, rispetto all’inizio.
«In simil guisa i corpi che trovansi alti da terra non tentano d’ innalzarsi viemmaggiormente,
ma invece tendono subito a discendere in forza della gravitazione verso la terra lor centro:
ora in questa loro discesa, se fosse vera l’ipotesi Copernicana, dovrebbero essere tirati da due
forze, cioè come 15 della forza di gravità perpendicolare alla terra, e come mille e più dalla
forza di slancio rettilineo prodotta necessariamente dal supposto moto di rotazione; queste
due forze, come ognun vede, sono congiunte ad angolo retto, e la maggiore di esse sarebbe
quella di projezione, ossia slancio rettilineo; per conseguenza dovrebbero più ubbidire a
questa, che a quella di gravità, giusta le leggi del parallelogramma, i di cui lati esprimono le
forze, e quindi mai potrebbero i detti corpi ricadere nel medesimo punto, da cui sono partiti,
ma bensì molto più in là verso oriente: questo però non segue, giacché noi vediamo, che tutti
corpi lanciati in aria verticalmente, ricadono nel medesimo punto, da cui sono partiti; dunque
non hanno alcuno slancio rettilineo, e quindi neppure il moto di rotazione da cui è
inseparabile il moto di slancio rettilineo dei corpi liberi esistenti nell’aria […]. Dunque
sembra assurda la Copernicana ipotesi del moto diurno della terra.»
5. DUBBIO QUARTO
«Se la terra si movesse intorno al sole, e formasse circa di esso ogni anno una ellissi, ciò
nascerebbe, secondo la teoria di Newton adottata dai moderni Copernicani, dalle due forze
centripeta, e projettile. […] Questa attrazione del sole, e della luna unita assieme colla quale
vengono i corpi liberi esistenti sulla superficie terrestre tirati all’insù, deve essere molto grande e
sensibile, perché secondo i Copernicani, e Newtoniani, la stessa riesce a sollevare enormi masse di
acqua, ed a produrre la marea, ossia il flusso e riflusso del mare in ogni giorno. Inoltre se giusta i
medesimi filosofi la sola attrazione del sole unita alla forza proiettile riesce a far muovere intorno a
sé in forma ellittica la terra, la quale precipiterebbe in esso malgrado l’enorme lontananza, che vi è
fra l’uno e l’altra, quando nel medesimo tempo non fosse spinta dalla forza di projezione, ne
siegue, che anche ai corpi liberi esistenti sulla periferia della terra, deve il sole comunicare un egual
grado di propensione a cadere in esso, giacchè questa propensione, non ha veruna dipendenza dalla
maggiore o minore grandezza, ma bensì è uguale tanto nelle grandi, quanto nelle piccole masse, e
sì le une che le altre ricevono dalla gravitazione un egual grado di velocità. E siccome se il sole
tira a se la terra, la deve tirare con una forza proporzionata alla sua enorme massa secondo tutte le
leggi della Fisica, la quale massa superando di gran lunga quella della terra esige necessariamente,
che la di lei forza centripeta, anche nella lontananza di 81 milioni e mezzo di miglia italiane sia di
486 piedi parigini, e 9 pollici nel primo minuto secondo, come si dimostrerà in appresso; così ne
segue, che in tale ipotesi i corpi liberi esistenti sulla superficie terrestre sarebbero essi pure tirati
all’insù dal sole con 486 piedi, e 9 pollici di forza, e che quindi sarebbero molto di più attratti dal
sole, che dalla terra, la di cui forza centripeta, come è noto, è di soli 15 piedi nel primo minuto
secondo.»
Il raggio della Terra è
Il raggio del Sole è
Pertanto
Il rapporto dei volumi è quindi
e tale sarà anche il rapporto delle masse. Poiché l’intensità del campo gravitazionale sulla superficie di un
corpo sferico è proporzionale alla massa, sarà
dove g indica l’intensità del campo sulla superficie terrestre e g0S l’analoga sulla superficie del Sole. Pertanto
Ma la terra gravita ad una distanza di 81,5 milioni di miglia italiane ( 1,505 X 1011
m) ovvero a 215
semidiametri solari; e poiché l’intensità del campo è inversamente proporzionale al quadrato della distanza,
alla distanza della Terra tale intensità si riduce a
E se g è di 15 piedi parigini,
che non coincide esattamente con i 486 piedi parigini e 9 pollici ottenuti dall’autore. La discrepanza ha
origine dalla diversa stima del rapporto dei volumi del Sole e della Terra.
Ma anche prescindendo dal valore reale del campo gravitazionale solare, questo dovrebbe comporsi
con il campo terrestre. Pertanto nel punto G della Terra in cui il Sole è allo zenit, i due campi sono
opposti; mentre nel punto N, in cui il Sole è al nadir, i campi sono concordi.
Se ne conclude che il campo gravitazionale risultante in N è maggiore che in G, ovvero che il peso
dei corpi posti sulla superficie della Terra dovrebbe essere maggiore di notte che di giorno. Tale
variazione dell’intensità del campo gravitazionale locale si renderebbe visibile sulla frequenza delle
oscillazioni di un pendolo che, com’è noto, è proporzionale all’intensità del campo:
Com’è noto, l’orbita della Terra, nel riferimento solare, è ellittica, con un’eccentricità
Il rapporto fra la distanza in afelio ( fra il 3 e il 7 luglio) e quella in perielio ( ai primi di gennaio) è
SOLE G N
Il campo gravitazionale solare è quindi maggiore in gennaio che in luglio e il rapporto delle due
intensità è uguale al quadrato del rapporto delle distanze. Pertanto
dove gp indica l’intensità del campo in perielio e ga l’analoga in afelio, con una differenza del 7%
circa, che dovrebbe essere rilevabile mediante il pendolo.
«Un professore di astronomia ha preteso di sciogliere questo quarto dubbio di sopra esposto, con
l’asserire sull’autorità di Newton, che l’aumento, e la diminuzione di peso, e di oscillazioni, che
l’attrazione luni-solare produce ne’ corpi terrestri sta al loro peso, ed oscillazioni naturali, come
uno sta a due milioni trentaduemila ottocentonovanta, il qual ragguaglio produce un’attrazione
luni-solare di una nonagesimo quarta parte di punto, in cifra 1/94, cioè quasi: 0; e che perciò non
possono essere sensibili i cambiamenti di peso, e di oscillazioni cagionati nei corpi terrestri dalla
attrazione luni-solare; e che quindi è senza forza quanto di sopra si è obbiettato. Soggiunge, che
quest’attrazione luni-solare, sebbene sommamente piccola, può nondimeno, secondo i calcoli assai
semplici del Newton, sollevar le acque del mare a dieci, o dodici piedi, e produrre la marea, e che
ciò deriva dalla somma mobilità dell’acqua, e dalla sua inerzia, per cui conserva la concepita
velocità. […]»
Ma, quand’anche l’intensità del campo gravitazionale sulla superficie del Sole fosse uguale a quella
terrestre, cioè di 15 piedi nel primo minuto secondo, alla distanza di 215 raggi solari, sarebbe
Un risultato ben superiore a
di punto.
È noto che tra la forza centripeta F, il raggio dell’orbita circolare R e la velocità angolare sussiste la
relazione
S
dove m indica la massa del corpo orbitante. Da questa viene che
avendo indicato con T il periodo di rivoluzione. Da qui si cava
Se in questa inseriamo per g il valore ipotizzato
essendo , si ottiene infine
equivalenti a 65 mila miglia italiane circa.
Oppure, se si assumono 93 milioni di miglia geometriche ( 1,5 X 1011
m) per la distanza R e per
di punto, cioè
, inserendo questi valori nella stessa, si ottiene
pari a circa 35 anni e 2 mesi. «Il che quanto sia insussistente ognuno il conosce a prima vista.»
«Al contrario, se la terra si aggira intorno al sole in forma ellittica quasi circolare, come pretendono i
Copernicani», la sua accelerazione centripeta è
che è anche il valore locale dell’intensità del campo gravitazionale solare. Sarebbe legittimo anche dire
che il suo valore è 3 mm ovvero 13,3 punti.
S T
T’ H
In effetti, con riferimento alla figura,
rappresenterebbe quello che sarebbe lo spostamento rettilineo nell’unità di tempo. Ne seguirebbe che
Questa sarebbe l’entità della caduta della Terra verso il Sole, per ogni unità di tempo, come dicevamo.
Questo non può essere, perché un’intensità di campo di soli 3 mm, ovvero 13,3 punti, non sarebbe
proporzionale alla massa del Sole che è 1,3 X 106 volte quella della Terra. Ricordiamo che questa
produce un campo di 15 piedi, ovvero di 21, 6 X 103 punti. In altri termini, il campo solare, pari a
, si aggiunge al campo terrestre che sappiamo essere
, cioè 1600 volte maggiore.
«[…] dunque se un corpo in tempo di oscura notte pesa p. e. come 21,600, in tempo di giorno
dovrebbe pesare come 21,600, meno 11 o 13, perché in tempo di giorno l’attrazione solare opposta
diametralmente a quella della terra dovrebbe distruggere 11 o 13 punti di attrazione terrestre.
Parimente se un pendolo facesse in tempo di notte 21,600 oscillazioni nello spazio di ore sei, in
vece in tempo di giorno ne dovrebbe fare molte di meno; ma ciò non succede: dunque ec. ».
6. DUBBIO DECIMO
«Un’altra prova dell’annuo moto della terra, i Copernicani la ricavano dalle osservazioni fatte da
Roemero e Bradley verso la fine del secolo XVII, scoprirono eglino che trovandosi Giove in
congiunzione col sole, gli ecclissi del suo primo satellite aveano luogo ora più tardi, ora più presto,
e che ciò non può provenire, se non perché la terra col suo annuo moto ora è più vicina a Giove, ed
ora n’è più lontana: quando n’è più vicina i detti ecclissi si vedono più presto, e quando n’è più
lontana si vedono più tardi di 40 minuti; dunque secondo queste osservazioni la terra si muove
intorno al sole.»
La spiegazione dei ritardi delle eclissi dei satelliti di Giove è tradizionalmente la seguente. Facciamo
riferimento al più interno (Io) che ha un periodo T =1,769 giorni. A percorrere l’intera orbita impiega
quindi circa 210 di questi periodi. Per ognuno di essi, la Terra percorre sulla sua orbita un arco di 1,74°
ovvero 0,03 rad, avvicinandosi o allontanandosi progressivamente da Giove.
Il pianeta si può quindi assimilare ad un emettitore di segnali con periodo costante che vengono ricevuti
dall’osservatore terrestre con ritardo variabile. Tale ritardo, rispetto al momento dell’emissione ( l’istante
in cui Io emerge da dietro il pianeta) è
dove R è il raggio dell’orbita terrestre, D l’analogo per Giove, c la velocità della luce ed n il tempo
trascorso dal momento della opposizione Giove – Sole, misurato in periodi di Io.
«A questo argomento si risponde in primo luogo, che queste osservazioni sono molto incerte, come
attestano i celebri astronomi Cassini Domenico, Cassini Giacomo, Maraldi, Manfredi Eustachio, ed
altri accademici di Parigi.[…] Si risponde in secondo luogo, che la successiva propagazione della
luce è molto dubbiosa, perché dall’ammetterla ne deriverebbero delle conseguenze che sembrano
paradossi: infatti in astro il più vicino non può non avere una distanza da tetrra di circa venti bilioni
di miglia italiane, come argomentano i Copernicani mediante il supposto moto annuo terrestre,
unitamente alla mancanza dell’annua parallasse, che da quello dovrebbe nascere; dunque se la luce
propagasi successivamente e viene dal sole a noi, nello spazio di 493 secondi, come pretendono gli
stessi Copernicani, e la distanza del sole dalla terra è di 81 milioni e mezzo di miglia italiane, per
venire a noi dalla distanza di 20 bilioni di miglia saranno necessarii circa anni 4; per le stelle
distanti cento bilioni bisogneranno anni 20, per quelle lontane mille bilioni, ci vorranno anni 200,
per quelle che distano diecimila bilioni, anni 2,000, per quelle lontane cento mila bilioni, anni
20,000, per quelle distanti un trilione, anni 200,000 e per quelle lontane dieci trilioni, saranno
necessarii due milioni di anni: perciò né Adamo, né tutti i suoi discendenti avrebbero mai potuto
vedere le stesse spettanti alle ultime quattro classi; ma ciò sarebbe un solennissimo paradosso, anzi
un assurdo: dunque ec. […] Si risponde in terzo luogo, che se dalla maggiore o minor vicinanza
G
S
T
della terra a Giove ne risultasse un’anticipazione o ritardo degli eclissi del suo primo satellite, come
pretendono i Copernicani, quest’anticipazione o ritardo dovrebbe altresì seguire allorquando Giove
è nell’afelio, e poi nel perielio, giacché fra questi due punti vi è una distanza di circa 900 milioni di
miglia; ma non si osserva alcun’anticipazione, o ritardo fra questi due punti, come assicura il
celebre astronomo Maraldi; dunque ec.»
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’atteggiamento del lettore moderno che si trova di fronte a queste pagine è quello del sorriso di
compatimento, nei confronti di uno studioso che si sforza di difendere l’indifendibile ed è fatalmente
destinato alla sconfitta e alla rimozione dalla memoria. Le sue argomentazioni coincidono
sostanzialmente con quelle di messer Ludovico delle Colombe che, nella Firenze di Galileo, fu
riferimento di un gruppo di letterati animosamente ostili al modello copernicano. Il suo opuscolo
Contro il moto della Terra, circolò manoscritto per Firenze, ma che si può leggere nel volume III
dell’Edizione Nazionale delle Opere di Galileo Galilei, raccoglie obiezioni assai ben fondate contro
l’idea di una Terra in rotazione. La differenza rispetto a quelle di Casanova è che queste ultime
tengono conto delle scoperte effettuate nell’ultimo secolo – come l’aberrazione stellare, le anomalie
nei periodi dei satelliti di Giove, la piccolezza delle parallassi stellari - e le corrobora con
argomentazioni quantitative. Ma le obiezioni e i dubbi avanzati dai due autori ( separati da due secoli)
sono della stessa natura, cioè dettate da un assunto a priori: che valga la fisica aristotelica. Tutte le
argomentazioni che i due autori sviluppano consistono nella descrizione dei fenomeni che si
dovrebbero osservare - se la fisica dello stagirita dovesse descrivere correttamente la realtà fisica – e
nella constatazione che questi non si osservano: ergo la Terra è immobile. Non bisogna nascondersi
che la posizione dei favorevoli al modello newtoniano non era più munita di quella di coloro che
erano rimasti legati al modello tradizionale. L’interpretazione dei moti planetari sulla base del
modello delle forze centrali aveva un costo altissimo sul piano del rigore scientifico di ispirazione
baconiana: l’introduzione di una misteriosa forza di gravità sulla quale lo stesso Newton si era
rifiutato di formulare ipotesi e che molti – e fra questi Descartes e Leibniz – rifiutavano come
‘proprietà occulta’. Casanova, in una lunga nota a piè di pagina, non esita ad associare quella che
oggi, con Feynman, chiamiamo “stravaganza della natura”, ad una stravaganza degli scienziati, e non
ha esitazioni a riprendere un sospetto introdotto da Biot nella sua biografia di Newton.3
3 Biot, Jean-Baptiste (1822), Biographie universelle ancienne et moderne : histoire par ordre alphabétique de
la vie publique et privée de tous les hommes , Tome 31 ( NE-OL), Paris, Michaud .
«Si noti che questo Newton tanto lodato e sublimato eccessivamente dai filosofi è caduto in errori
assai grossolani, ed assurdi: esso non ammette il mistero della SS.Trinità, è su questo punto
sociniano, e nel tempo stesso confessa di esser persuaso della rivelazione, il che fa calci e pugni.
Nei suoi commentarj sull’Apocalisse scaglia contro il Papa e la Chiesa Romana tutte quelle
chimere, e bestemmie, che sogliono vomitare alcuni furiosi Protestanti, e che ributtano chiunque ha
un qualche principio di onestà. Nella suddetta sua opera Principj matematici di filosofia naturale
dice questo solennissimo paradosso, cioè che forse non vi è un pollice di materia in tutto l’universo.
[…]. I frequenti assurdi e vaneggiamenti , che si osservano nei grandi matematici, come p.e. in
Newton, Leibnizio, Volfio, Ticone, Keplero, Maupertuis (vedi tutti questi articoli nel dizionario
biografico del Feller, edizione francese dell’anno 1835) hanno fatto credere, che questa scienza
della matematica abbracciata con eccessivo zelo, ed assiduità pregiudica non solo le qualità
brillanti, ma ancora le qualità solide dello spirito umano, e che lo studio troppo ostinato dei punti,
delle linee, e dei numeri debilita in qualche modo la nozione delle cose medesime, delle loro
essenze, dei loro diversi rapporti, e delle loro proprietà fisiche e morali, il che ha fatto nascere quel
proverbio, il quale dice, che allor quando lo spirito di un Geometra esce da un angolo, è quasi
sempre ottuso, motteggio, che Pascal, e Scaligero hanno trovato giusto.»
Non si può evitare di osservare che il Galileo del ‘Dialogo sopra i due massimi sistemi’(1632) non è così
diverso dal Casanova del 1835. Ambedue ricorrono a tutti gli strumenti che le loro conoscenze di fisica e
astronomia gli forniscono per difendere una posizione intellettuale che non è difendibile sul piano
strettamente scientifico. In ambedue gli scritti – prescindendo dal loro valore scientifico – la retorica
letteraria gioca un ruolo rilevante4
, in ambedue la finalità ultima è la difesa di un’idea di fronte ad un
pubblico di ipotetici lettori.
4 Battistini, Andrea (2000), Galileo e i Gesuiti. Miti letterari e retorica della scienza, Vita e Pensiero, Milano.
Né si può evitare un’altra osservazione, più banale, ma non scontata e riguarda quanti, tra coloro
che oggi sanno ( o credono di sapere) che la Terra è in moto, sarebbero in grado di ribattere alle
argomentazioni e alle riserve avanzate dal Casanova sul giornale del codino padre di Leopardi. Una
lettura attenta dei dubbj animosamente proposti dall’autore rischierebbe di mettere in crisi molti non
ben ferrati in questa materia e di rivelare quanto poco scientifiche siano le fondamenta sulle quali si
sostengono alcune ovvie certezze scientifiche. Noi le abbiamo riportate cercando di rimanere fedeli
alla lettera e allo spirito, con il rispetto che si deve a tutti coloro che combattono l’ultima battaglia,
nella ubbidendo all’imperativo di attenersi alle proprie convinzioni.
APPENDICE 1:
SULLE UNITÀ DI MISURA
1) UNITÀ DI LUNGHEZZA
1 miglio italiano = 5700 piedi parigini = 1847 m
1 miglio geometrico = 5000 piedi parigini = 1620 m
1 piede parigino = 32,4 cm
1 pollice = 1/12 piede = 2,7 cm
1 linea = 2, 25 mm
1 punto = 0,225 mm
2) UNITÀ DI CAMPO GRAVITAZIONALE
L’accelerazione gravitazionale ( ovvero l’intensità del campo) viene misurata con la lunghezza del tratto
percorso nel primo secondo di caduta. Pertanto
APPENDICE 2:
SULLE VARIAZIONI DEI PERIODI DEI SATELLITI DI GIOVE
Il pianeta si può assimilare ad un faro che emette segnali ottici con un periodo di 1,769 giorni, chje
vengono raccolti con un ritardo che dipende dalla distanza dell’osservatore. Tale ritardo, rispetto al
momento dell’emissione ( l’istante in cui Io emerge da dietro il pianeta) è
dove R è il raggio dell’orbita terrestre, D l’analogo per Giove, c la velocità della luce ed n il tempo
trascorso dal momento della opposizione Giove – Sole, misurato in periodi di Io.
La variazione del periodo del satellite misurata da Terra è quindi
cui si può dare la forma
o anche
La rappresentazione grafica di questa variazione nel corso dell’anno è riportata in figura.