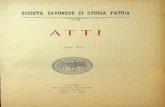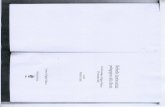"Adele" di Federigo Tozzi: Storia di una nevrosi
Transcript of "Adele" di Federigo Tozzi: Storia di una nevrosi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
CORSO DI LAUREA IN LETTERE
Dissertazione finale
ADELE DI FEDERIGO TOZZI: STORIA DI UNA NEVROSI
Relatore
Prof. Beatrice Manetti
Candidata: Sara Marzana
Anno accademico 2014/2015
2
Indice
Introduzione p. 3
1. La logica dell’inconscio in una realtà frammentata
1. Storia editoriale e genetica p. 6
2. Una grinza nell’infinito p. 11
3. Frammento e romanzo p. 20
2. Malattia e cura della coscienza tozziana
1. Una volontà alterata da leggi invisibili p. 25
2. L’autobiografismo «en travesti» p. 32
3. Storia di una nevrosi p. 35
4. James e la cultura scientifica di Tozzi p. 45
3
Introduzione
Adele è un romanzo in frammenti di Federigo Tozzi, pubblicato postumo nel 1979
da Vallecchi, a cura di Glauco Tozzi, il figlio dell’autore. L’opera è il primo tentativo
dello scrittore senese di avvicinarsi alla misura romanzesca, abbandonato, secondo la
critica, per dedicare maggiore attenzione al più avvincente intreccio di Con gli occhi
chiusi, il romanzo pubblicato nel 1919.
La protagonista di Adele è una giovane donna afflitta da una dichiarata isteria, che
non si riconosce nella realtà circostante ed è incapace di intrattenere rapporti
armonici con gli altri. La sua vita procede inesorabile, mentre Adele tenta invano di
raccapezzarsi nel «sogno insopportabile» dal quale non si può svegliare, fino a
quando la solitudine e l’incolmabile vuoto non la condurranno al suicidio: nessuno se
ne accorgerà fino alla mattina seguente. L’analisi di questo romanzo è stata svolta
nell’ottica del fondamentale binomio Tozzi-James, ovvero alla luce dell’influenza
che il lavoro di William James, filosofo e psicologo americano, ha esercitato
sull’opera di Federigo Tozzi. L’autore lesse le opere di James sin dal 1904, e rimasto
affascinato dalle nuove scoperte psicologiche sul flusso di coscienza, la volontà
inibita e il misticismo dei casi eccentrici di psicopatologia religiosa, decise di
riportarne le sfumature tra le vite disperate dei suoi personaggi.
Le opere di James, tra cui i Principii di psicologia, Le varie forme della coscienza
religiosa e La volontà di credere, si rivelano dunque essenziali alla comprensione
dell’enigmatica opera tozziana, in particolare della protagonista di Adele: vittima
della sua corrente interiore continuamente in bilico tra presa di coscienza e ricaduta
patologica, uno dei personaggi più jamesianamente connotati.
Il mio intento è stato dunque ricostruire il quadro di questo romanzo in frammenti,
ponendo un’attenzione particolare al confronto tra l’opera di William James e
l’impianto narrativo di Adele, sulla scorta delle indicazioni fornite dallo studio di
Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia. Il primo capitolo è dedicato
alla ricostruzione della storia genetica ed editoriale di Adele, alla cui stesura lo
4
scrittore senese si è dedicato nel primo periodo della sua produzione letteraria, tra il
1908 e il 1914, più precisamente tra il 1912 e il 1913, preservandone soltanto un
abbozzo. Glauco Tozzi, il figlio dello scrittore, ha curato l’opera rilegandone i
frammenti sparsi e riorganizzandone la struttura, operando sia secondo le indicazioni
lasciate da Tozzi sia sulla base di alcune scelte personali, come ho mostrato nel
primo paragrafo. L’intreccio di questo romanzo in frammenti si svolge attorno alle
vicende dei genitori della protagonista, Domenico e Zaira, la domestica Caterina e il
giovane Fabio, del quale Adele si innamora senza la possibilità di poter veramente
amare, vittima di una realtà in cui ogni scopo di vita è assente. Adele è appunto la
storia di una volontà alterata: Tozzi vi restituisce l’immagine di un’anima incapace di
dispiegarsi nella corrente della vita, descritta nel secondo paragrafo. Negli anni di
produzione giovanile, durante i quali l’autore ha diretto il periodico «La Torre», la
scrittura di Tozzi è stata molto influenzata dalla poetica vociana del frammento, che
ritroviamo negli aforismi di Barche capovolte. Nel terzo paragrafo si ipotizza che
l’influenza di James sia già presente in Barche capovolte, dove Tozzi si propone di
seguire attraverso la scrittura i movimenti dell’anima e l’inarrestabile flusso di
coscienza, con l’intenzione di non imporre un controllo razionale sulla materia
psicologica.
Dopo l’infatuazione per il frammentismo vociano, Tozzi dichiara la necessità di
superarlo per approdare al genere romanzesco; egli non vede nel frammentismo un
fine, ma un mezzo per aprirsi ad altro, un’inevitabile sosta. L’intento dello scrittore
senese non consiste unicamente nel recupero di un genere letterario ma nella scelta di
svuotarlo dall’interno, rinnovando decisamente la forma del racconto e lo stesso
flusso narrativo. Adele dunque, al contempo insieme di frammenti e romanzo
compiuto, è il primo tentativo tozziano di avvicinarsi al genere del romanzo, dove
l’autobiografismo dell’autore incontra l’interesse culturale.
Ho iniziato il secondo capitolo, che si addentra più analiticamente nella cultura
psicologica di Tozzi, con la descrizione di Adele, che presenta molti degli elementi
distintivi studiati da James nell’analisi di casi patologici: è un personaggio iper-
inibito, «incapace di fare ciò che non potrà mai fare»; è inoltre un caso di
5
psicopatologia religiosa, continuamente colto da «esaltazioni mistiche». È dunque
evidente l’intento tozziano di attribuire ad Adele le anomalie psichiche studiate dallo
psicologo americano narrando la storia di un personaggio femminile: l’autore ha di
fatto scelto una donna non solo per raccontare ma anche per raccontarsi, proponendo
nel testo un forte conflitto tra la protagonista e suo padre, che ricalca quello vissuto
dall’autore stesso. Ho descritto altre componenti autobiografiche che Tozzi
riconduce ad Adele nel paragrafo L’autobiografismo «en travesti»: il misticismo, la
passione per la letteratura e la malattia agli occhi che colpì lo scrittore senese nel
1904. Tuttavia il filo conduttore di questo romanzo è l’isteria della protagonista: nel
paragrafo Storia di una nevrosi sono indagate principali caratteristiche della
patologia isterica, così come sono state individuate e descritte dagli psicologi
francesi Théodule Ribot e Pierre Janet e successivamente da Freud, per fare luce
sugli aspetti più dolorosi della malattia che affligge Adele.
Nell’ultimo paragrafo, ho ricostruito in che modo lo scrittore venne a contatto con
le opere di James, l’entusiasmo che queste suscitarono in lui, insieme alla volontà di
approfondire maggiormente le sue conoscenze tramite gli studi di Ribot, Janet e
Freud. Dal punto di vista tozziano, leggere le recenti opere riguardanti la malattia
nervosa e i meccanismi dell’inconscio, significava non solo coltivarsi e migliorare la
propria cultura in materia ma anche curare se stesso, indagare nell’intimo della
propria anima tormentata. Da questa matrice psicologica sono nati i personaggi
“folli” dei romanzi di Tozzi, vittime di una visione disperata della vita: la stessa che
non ha mai abbandonato l’autore.
6
1. La logica dell’inconscio in una realtà frammentata
1.1 Storia editoriale e genetica
Adele è un abbozzo di romanzo di Federigo Tozzi, pubblicato postumo dal figlio
Glauco nel 1979 per Vallecchi. Il testo è curato dal figlio dell’autore, Glauco Tozzi,
con un’introduzione di Carlo Cassola. La genesi del romanzo, risalente al periodo
1908-1914, si colloca nel “sessennio di Castagneto”, secondo la suddivisione
effettuata dalla critica per definire i due periodi di produzione di Federigo Tozzi, e
più probabilmente tra il 1912 e il 1913.
In ogni caso c’è per Adele un preciso riferimento alla data a quo,
quanto meno per una importante parte del lavoro: in una
interessante lettera dell’autore alla moglie, scritta a lapis da
Civitavecchia, col timbro postale dell’1-VI-09, tuttora inedita,
descrivendo il suo viaggio in bicicletta da Siena verso Roma,
l’autore le diceva, tra l’altro: “Ho passato con le barche due fiumi,
perché mancavano i ponti”.1
Proprio nelle ultime pagine del romanzo, leggiamo che l’avvocato Belcolori, in
compagnia del figlio Fabio, durante il viaggio in macchina da Siena verso Roma,
attraversando l’Aurelia, supera il fiume Ombrone passando «sopra un chiatta».
Dacché non si è a conoscenza di altri viaggi in cui lo scrittore, dirigendosi verso
Roma, abbia avuto occasione di attraversare l’Aurelia, tranne quello citato, pare
evidente che questa vicenda sia stata narrata in Adele successivamente al giugno
1909. Inoltre, la breve durata delle descrizioni romane esclude, per quanto concerne
il contenuto, una data posteriore al 1914, giacché il trasferimento definitivo a Roma
permise allo scrittore di dilungarsi in rappresentazioni della città maggiormente
esaustive e minuziose.
Sono presenti inoltre alcuni riferimenti all’epoca di Novale, la raccolta di lettere
1 Glauco Tozzi, postfazione, in Federigo Tozzi, Adele, Vallecchi, Firenze 1979, p. 85.
7
che Federigo Tozzi scrisse alla fidanzata Emma, pubblicata cinque anni dopo la
morte dell’autore, nel 1925, che confermano la precocità di Adele rispetto alle opere
successive; ad esempio il nesso tra la descrizione della protagonista che mangia sola
nella casa dei suoi genitori con ciò che l’autore racconta di se stesso alla fidanzata
Emma. Ancora più evidenti sono i legami con quello che diventerà l’intreccio di Con
gli occhi chiusi, i quali portano ad ipotizzare che prima di proiettare se stesso nel
testo sopra citato, Federigo Tozzi tentò di esprimersi in Adele. Secondo l’ipotesi del
curatore, il tentativo fu abbandonato quando l’autore identificò nelle vicende di
Pietro e Ghisola, protagonisti di Con gli occhi chiusi, una trama più avvincente
rispetto alle vicissitudini di Adele e Fabio.
Nel contempo, Tozzi era fermamente convinto che molte pagine di Adele fossero
altamente significative, da salvare dunque, anche singolarmente. Il curatore racconta,
infatti, come queste non furono distrutte né cancellate; anzi lo scrittore le racchiuse
tra grosse righe a matita rossa e verde, attribuendo buona parte dei brani così salvati
un numero, sempre a matita rossa o verde.
Va subito aggiunto che questa numerazione, che non copre dunque
neanche tutti i brani “salvati”, cioè non cancellati nelle pagine superstiti,
dà alcuna idea su ciò che l’autore intendesse fare dei brani così numerati.
Si ha anzi la certezza che le cifre siano state messe non per costituire un
nuovo ordine, ma solo per contraddistinguere i più notevoli tra i passi del
romanzo che dovevano scampare.2
La numerazione inizia al principio del manoscritto con il numero 9, ma come
spiega il curatore non siamo a conoscenza del motivo, e prosegue di brano in brano,
fino al 18 compreso, ordinatamente. Troviamo in seguito uno dei molti frammenti
“salvati” privi di numero, che si suppone fosse il primo ma che non è compreso nel
testo. Dopo il brano numero 18 troviamo il brano numero 2, seguito dai numeri 3, 4,
5, 6, 7 e dal numero 8, attribuito alla chiusa del romanzo. A lato dell’ordine sopra
descritto, il curatore indica per ogni episodio numerato le parole iniziali e quelle
finali.
2 Ivi, p. 89.
8
Glauco Tozzi prosegue ipotizzando che l’unica spiegazione di questa numerazione
consista nell’interpretazione già accennata: iniziando da dove ha collocato il
supposto numero 1, seguito dal numero 2, l’autore ha inteso esclusivamente
discernere, in vista di una qualsiasi diversa collocazione futura, i brani da salvare
fino alla fine; e dopo la chiusa, contrassegnata dal numero 8, ha ricominciato dal
principio del testo a contrassegnare altri brani con i numeri compresi tra il 9 e il 18.
Una riprova ancora che l’autore non intendeva arrivare ad un preciso
intreccio diverso, è data, indirettamente, da certe modifiche che
evidenziano come, non ostante tutto, egli intendesse ulteriormente
operare sempre nell’ambito dell’intreccio originario.3
La più importante di queste modifiche interviene nella descrizione della malattia e
dei funerali di un personaggio che prima era Zaira, la madre di Adele, e in seguito,
nella correzione successiva, diventa la nonna della protagonista. La variazione era
probabilmente funzionale al mantenimento fino al termine della vicenda del
contrasto tra Adele e la madre, che l’autore però non ha più avuto occasione di far
ricomparire.
Glauco Tozzi ricorda ancora che su una specie di copertina, costituita da un
leggero doppio foglio e contenente varie indicazioni a matita rossa e blu, spicca
l’annotazione autografa «Frammenti», preceduta da un’altra, di mano di Emma, che
recita: «Primo abbozzo di romanzo». Accanto vi è il titolo Adele, probabilmente
autografo. Infine Emma ha annotato per sé, sempre su tale copertina: «Cavati dei
brani», intendendo così ricordarsi di aver eseguito una copia a macchina di alcuni
estratti, della quale tuttavia non vi è più traccia.
Il testo che rimane, raccolto nella stessa copertina, è costituito da pagine
dattiloscritte con numerazione autografa a lapis, che procede fino alla pagina 158,
dove finisce il romanzo. Di queste pagine dattiloscritte ne restano soltanto 76 e
presentano numerose “correzioni” successive per “tagli”, le quali si distinguono
chiaramente dalle precedenti cancellature per “normale correzione”. Sono dunque in
3 Ivi, p. 90.
9
tutto 82 le pagine mancanti, in base alla numerazione originaria, rimosse in varie
parti del testo e segnalate dai curatori. Glauco Tozzi specifica che alle 76 pagine
dattiloscritte superstiti sono state ancora aggiunte altre 9 cartelle manoscritte, che si
frappongono tra i brani “salvati”, nonostante l’autore non le avesse comprese nella
sua numerazione. In conclusione, le pagine contenute nel testo sono in tutto 85 oltre
la copertina, circa la metà del materiale originario.
Durante il lavoro di edizione, Glauco Tozzi si è reso conto che, pur essendo
necessario distinguere nettamente i brani che l’autore intendeva salvare,
naturalmente nel loro ordine originario, fosse altrettanto importante riportare tra
parentesi quadre i passi che nelle pagine dattiloscritte superstiti risultano soppressi
per “taglio”.
Di più: il curatore ha poi ritenuto, d’accordo con l’editore, che ai fini
della conoscenza del metodo di lavoro dell’autore, fosse utile perfino
riprodurre anche brani cancellati entro il contesto “salvato” dall’autore:
qui facilmente riconoscibili, anche questi, perché anche essi stampati tra
parentesi quadre. […] Se ne può dedurre che, per il suo intento artistico,
il singolo frammento non vale se lo scrittore non è convinto che esso sia
anche parte necessaria del tutto.4
Per la stessa ragione, specifica il curatore, in quattro note sono state ricostruite
alcune scene come apparivano prima della modifica apportata dall’autore: quella
delle percosse dei genitori di Adele, la prima descrizione del giardino della famiglia
Belcolori, la scena che segue l’uccisione del cane Toppa e il suicidio di Adele.
Non ostante questo, è sembrato pur sempre necessario inserire dove era
opportuno, in carattere corsivo e in corpo minore, alcuni collegamenti e
chiarimenti che il curatore, dopo aver più volte riletto il tutto, era in
grado di dare per agevolare una comprensione più immediata possibile
della trama.5
La seconda edizione di Adele, che risale al 1993, è curata nuovamente da Glauco
4 Ivi, p. 94. 5 Ivi, p. 95.
10
Tozzi ed è pubblicata da Vallecchi insieme a Paolo, un poema in prosa scritto da
Federigo Tozzi nel 1908. L’opera non presenta modifiche rispetto alla prima
edizione. Nella sua introduzione, Marco Marchi sostiene che queste due opere
giovanili, Paolo e Adele, nella loro precocità rappresentino scritti non meramente
preparatori, ma artisticamente validi in se stessi; tutt’altro che “minori” e dotati
ambedue di punte espressive in cui l’autore è al meglio di se stesso. I due testi sono
accumunati da una forte componente autobiografica: Adele sarebbe dunque l’alter
ego femminile di Tozzi, che nello stesso periodo si proietta anche in Paolo.
Anche se i personaggi di Tozzi “non sono altro che fenomeni di
superficie, sotto ai quali scorre un magma comune”, ciò non toglie che
l’autore “senta l’autoritratto in veste femminile come il più consono
all’esplorazione degli istinti”. 6
Il femminile è percepito da Tozzi come «una forza primigenia potentissima,
anteriore alla cultura dell’uomo». 7 Tozzi sceglie dunque Adele per addentrarsi nella
realtà del profondo con una sensibilità diversa, quella femminile, attraverso la quale
è possibile instaurare un contatto differente con le cose. Ciò che colpisce
maggiormente in Adele è la presenza di un forte conflitto tra il maschile e il
femminile, tra un padre e una figlia che seppur vicini, colpiti dalla stessa disgrazia (la
morte della nonna), non riescono a trovarsi, a riconoscersi nel loro legame
sentimentale. Questo contrasto, che emerge sin dalle prime pagine del romanzo, non
si risolve mai, fino alla morte della protagonista. Si tratta dello stesso contrasto che
attanaglia la vita dell’autore, della stessa impotenza che Federigo Tozzi sente nei
confronti del padre, un uomo autoritario, concreto e violento. È interessante notare
come lo scrittore abbia deciso di analizzare il suo più grande conflitto interiore
presentando innanzitutto nel romanzo un personaggio femminile, quindi una figlia, e
secondariamente introducendo un rapporto così minato e irrecuperabile come quello
tra Adele e il padre.
6 Marco Marchi, introduzione a Federigo Tozzi, Paolo. Adele, Vallecchi, Firenze 1993, p. 23. 7 Ibidem.
11
È quasi una necessità per la ricerca che lo scrittore ha iniziato passare
attraverso la donna, colei che abita nel seno della natura con minori
problematismi allontananti e paure del maschio, essa stessa generatrice,
continuatrice e tramite dell’opera voluta, sua complice e sua potenziale
antagonista.8
1.2 Una grinza nell’infinito
«Un romanzo è una cosa che si racconta, e l’atto di raccontare non è altro che
mettere in evidenza le strutture portanti, o almeno quelle che si rivelano come tali al
lettore»9, sostiene Luigi Baldacci. Adele è il racconto di una giovane donna isterica,
la quale vive rapporti conflittuali con se stessa, con i propri genitori e con l’ambiente
circostante. Si tratta di un romanzo frammentato, pieno di parentesi quadre, pagine
eliminate, scarti narrativi e conseguenti riprese.
La storia, ambientata a Siena, inizia con l’introduzione del personaggio di Adele,
figlia del dottor Freschi. Durante la descrizione del ritorno a casa della giovane,
sull’impallidire del giorno, comincia la sua analisi psicologica: «Tutta la sua vita le
sembrava limitata dall’indomani; tutta la sua impazienza era impigliata come da un
divieto fatale. Le pareva che la morte fosse prossima, sopra le colline di Siena, così
alta»10. Adele si avvia verso casa e allo stesso tempo indugia, poi si affretta, teme di
essere inseguita, si ferma per riprendere fiato. È una passeggiata serale per le vie
della sua città, un cammino acustico, animato di suoni e gorgoglii d’acqua.
Attraverso una nota frammentaria dell’incipit, è reso noto che il racconto inizia nel
mese di settembre. Viene poi presentato il padre di Adele, Vincenzo, un medico che
non gode di nessuna stima da parte dei colleghi. Egli è insensibile nei riguardi dei
malati, incomprensibile agli occhi degli altri; soltanto il tono di voce collerico lo
contraddistingue. Adele ricorda, quando contro la volontà del padre, aveva deciso di
8 Ivi, p. 24. 9 Luigi Baldacci, Tozzi moderno, Einaudi, Torino 1993, p. 4. 10 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 5.
12
trasferirsi a Firenze:
E tutta Firenze acquistò per lei una delizia imparagonabile. Il suo cielo
profondo sopra i marmi luccicanti, i suoi piani verdi, dove si distingue
bene la bianchezza dei pioppi sottili, e le sue colline furono amati da lei
insaziabilmente.11
Di ritorno a Siena, la protagonista vive in conflitto con i suoi genitori, soffre di
manie di persecuzione, al punto da pensare che essi, d’accordo con la domestica,
vogliano avvelenarle il vino. Quando la giovane, rientrata a casa, si rivolge alla
domestica chiedendole se abbia riferito ai genitori dei suoi sospetti riguardo alle loro
intenzioni di avvelenarla, la donna non risponde. Adele diviene violenta e scuotendo
per la manica la donna le grida: «L’ho detto perché lo sapessero!». Quindi comincia
a mangiare riflettendo su cose profonde e mistiche e cadendo in un abisso di
disperazione proprio nel momento in cui le pare di accostarsi sempre di più al
concetto che desidera avere della divinità.
Secondo gli studi di Marco Marchi e Luigi Baldacci, confermati dai dati estratti
dai registri del prestito della Biblioteca Comunale di Siena, la lettura delle Varie
forme della coscienza religiosa di William James, risalente al 1902, ha influenzato
notevolmente la composizione tozziana di testi come Paolo e Adele, fortemente
connotati dal connubio tra misticismo e psicologia. Nella sua opera, James pone le
basi per una rivisitazione in chiave psicologica dell’esperienza religiosa, secondo una
prospettiva per cui i termini delle fede religiosa sono definiti dell’individuo stesso:
più precisamente dalla sua profonda esigenza di trovare un punto di riferimento
alternativo dinanzi a un futuro che appare indecifrabile. Nei casi eccentrici di
psicopatologia religiosa, come quello del personaggio di Adele, questa esigenza è
ancora più accentuata: «La religiosità di Adele è una jamesiana religiosità morbid-
minded, ovvero il termine specifico con il quale il filosofo e psicologo americano
William James definì i casi eccentrici di psicopatologia religiosa»12.
Il padre accusa la giovane d’essersi disonorata tornando a casa; la madre, per
11 Ivi, p. 11. 12 Marco Marchi, introduzione a Federigo Tozzi, Paolo. Adele, cit., p. 25.
13
quattro mesi, tutte le mattine s’inginocchia dinanzi alla statua di un santo, e
compiendo ripetutamente questa devozione riesce a trovare un po’ di pace, riuscendo
così a ignorare la condotta della figlia. Adele d’altro canto non trova in nessun libro
cattolico una preghiera degna della sua divina soavità e bellezza: «Soltanto le ultime
cantiche di Dante potevano esprimere tale paradiso e tale verità eterna» 13 . Nel
frattempo giunge un periodo di quiete famigliare, durante il quale, nonostante la
giovane Adele non si occupi di nulla né porti alcun contributo alla vita domestica, la
sua soggettività è tollerata da entrambi i genitori. La tranquillità del focolare non si
protrae a lungo, l’isteria di Adele peggiora, le voci che continua a sentire aggravano
il suo stato d’animo e le recano sofferenza. Pertanto la protagonista non riesce più a
trovare un accordo con i genitori e, travolta dallo sconforto, rinuncia a uscire di casa.
Una cupa disperazione la invase, ma tutti credevano ch’ella fosse per
divenire idiota. Non poteva pregare se in chiesa fosse stata anche un’altra
persona qualunque; ella riusciva e vi tornava, finché non avesse potuto
inginocchiarsi da sola.14
Adele è perseguitata dal dolore. Tutto procede tranquillamente intorno a lei, fuori
di lei, senza di lei. Non c’è alcuna interazione attiva fra l’ambiente circostante e il
suo patimento.
Il padre giunge a casa con un medico pronto a visitare Zaira, la madre di Adele,
che nel frattempo si è ammalata, il quale annuncia che la donna sia colpita da febbri
infettive; non appena Caterina esce per comprare le medicine necessarie, Adele si
sente nuovamente bene, prende in mano alcune rose di carta e provando una
sensazione di calore ricorda il giorno del suo compleanno «così bianco di sole». La
protagonista avverte tutte le sensazioni di quel momento così puro, rimpiangendo
quel tempo colmo di affetto. Adele ritorna alla sua infanzia, si lascia trasportare da
questo salto nella memoria e una volta accortasi di ciò, si sente umiliata, addolorata.
Presto la delusione si trasforma in odio «contro quelle cose, che sono ancora intatte e
13 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 15. 14 Ivi, p. 17.
14
non possono curarsi di lei; che le sembrano brutte e false»15.
L’improvviso ingresso di Adele nel mondo dell’infanzia, dove gli spettri
della memoria si materializzano e traumi profondi mostrano le loro reali
origini, rievoca chiaramente il meccanismo di una seduta ipnotica
freudiana durante la quale i segni di un passato infantile rimosso
riemergono repentinamente dalla dimensione inconscia per mostrare
nette distorsioni al limite della patologia.16
Il racconto torna al tema della morte della nonna, che prima della correzione
autografa vedeva protagonista la madre (uccisa dal tifo). Durante il funerale,
Vincenzo e Adele proseguono in una carrozza chiusa, tuttavia la giovane non vede
l’ora di andarsene, non potendo sopportare la vista del padre che si aggira intorno
alla cassa mentre gli amici lo consolano.
Il rapporto tra la giovane e il padre migliora nettamente dopo la morte della
nonna. Egli accetta pienamente la figlia in virtù del suo bisogno emotivo, e Adele si
sente di nuovo libera, «come se le cose, intatte e spirituali, tornassero a lei»17. La
protagonista sente di dover distruggere qualunque oggetto legato alla nonna e
rifiutando ogni aiuto inscatola tutti gli abiti e i ritagli di stoffa. Al semplice tocco,
avverte che nessuna di quelle cose le appartiene.
Il padre, assicuratosi che non trascurava l’andamento della famiglia, la
lasciò fare; quantunque si acuisse in lui il desiderio di viversene da solo.
Le loro relazioni superficiali divennero di un’ottima cordialità, che
permetteva alle loro indoli così opposte una reciproca sopportabilità.18
Adele si ritrova a pregare soltanto la domenica. Lentamente scompare in lei ogni
sintomo di quell’esaltazione mistica procurata dalla malattia isterica. Così la giovane
trascorre i suoi giorni, tra serenità e inquietudine, reminiscenze e realtà, perdendosi e
ritrovandosi per poi perdersi ancora una volta; è colta da un forte senso d’inutilità, da
15 Ivi, p. 22. 16 Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, Olschki, Firenze 1999, p. 119. 17 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 26. 18 Ibidem.
15
una marcata estraneità verso tutto ciò che la circonda.
Come illustra Salomon Resnik a proposito della storia del termine isteria,
Sigmund Freud aveva analizzato i fenomeni di regressione, nella nevrosi e nella
psicosi, come risposte di un io infantile che, posto davanti a una situazione difficile
da affrontare, si rifugia nel passato: in questo caso regredire equivale a tornare in
un’epoca della propria vita personale in cui ci si sentiva protetti: «Il soggetto in stato
di regressione riprende il suo ruolo di bambino che cerca un luogo, nella propria
“storia” e topografia corporale, dove poter essere protetto dall’impatto della vita
presente»19.
Caterina dedica alla giovane tutte le attenzioni, la circonda di affetto e prevede per
lei un matrimonio con un giovane ricco. Adele, diffidente, contesta la sua
affermazione. Attraverso il racconto della modesta storia di Caterina, l’autore
rappresenta maggiormente il personaggio, che si rivela alquanto segnato dai propri
trascorsi ma incapace di confrontarsi con le proprie emozioni, con le proprie
mancanze, di risolversi. La domestica era una volta sposata con il contadino Martino,
il quale un giorno, recandosi al bosco di Lecceto per prendere della legna, conobbe
un boscaiolo vecchio e curvo, di nome Fiorenzo. Durante la conversazione, entrambi
realizzarono di essere più vicini di quanto credessero: Fiorenzo si rivelò, infatti,
essere il padre di Caterina. Egli aveva avuto da giovane un rapporto con la bella
Maria di Rienzo, la madre della donna, una vecchia contadina morta da parecchi
anni. Martino invitò Fiorenzo al podere, regalandogli l’opportunità di rivedere la
figlia. In seguito lo comunicò alla moglie, la quale provò vergogna e nello stesso
tempo contentezza, non essendo mai venuta a conoscenza di chi fosse il suo vero
padre. Dieci anni dopo tutte le persone vicine a Caterina erano morte. «Una volta,
Adele le chiese: - Pensi mai tu alla tua mamma? - Chi è morto non c’è più»20, è la
risposta della domestica.
Dopo tre pagine mancanti compare la famiglia Belcolori, residente in una vasta
tenuta un po’ fatiscente, non lontano dalla famiglia della protagonista. Fabio, il figlio
19 Salomon Resnik, Isteria, in Enciclopedia, Einaudi, Torino 1979, vol. VII, p. 1025. 20 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 39.
16
dell’avvocato Belcolori, incontrando Adele per la prima volta, se ne innamora:
«L’innamorarsi, molte volte abbatte, ma può anche procurare un senso di ebrietà
piacevole e gaudiosa che esalta l’anima, e la rende come un istrumento capace di far
vibrare l’infinito. E non è possibile contenersi»21.
Fabio è un ragazzo introverso, taciturno, a tratti insofferente e molto sensibile.
Soltanto dopo aver conosciuto Adele ogni cosa diventa incantevole per lui, vede il
mondo intero attraverso la sua figura, ma teme che questa bellezza possa sfuggirgli
da un momento all’altro. Egli comprende il perché di quell’inquietudine che
accompagnava le sue giornate prima di allora e si rammarica di aver incontrato Adele
così tardi. La protagonista invece, dopo aver rivisto Fabio, sente la sua vita
sdoppiarsi, a causa del fenomeno della paramnesia, un disturbo della memoria che si
esprime con il ricordo di momenti non vissuti o situati erroneamente nel tempo.
Onde credette la vita sdoppiata a modo di un raggio e della sua
rifrazione. Come se le sue sensazioni continuassero ad avere un’esistenza
propria, fuori dello spirito; eterne, appunto perché prodotte da lui. Allora
si chiese se dopo la morte, le proprie sensazioni sopravvivessero.22
Durante un temporale, nel corso del quale sente di dover morire da un momento
all’altro, Adele è sopraffatta dall’inquietudine e prega che termini presto. Quando il
sole torna splendere la giovane incontra Fabio, i due rimangono talmente folgorati da
non riuscire a parlare l’uno con l’altra, e due ore dopo la fanciulla riceve un mazzo di
fiori, sentendosi felice come non era mai stata. Adele è innamorata, impaziente,
euforica, ma si chiede quanto durerà. Il personaggio è psichicamente frantumato,
scisso, quindi iper-ricettivo.
Ma un’altra volta, la sua giovinezza le apparve lontana e inafferrabile.
Comprese allora che la sua esistenza era limitata da molte leggi invisibili,
che non si sarebbero piegate giammai. Come la pietra che è infissa nel
suo luogo, come la nuvola che si sperde, ella doveva adattarsi a quello
che le avrebbero preparato. La vita era così immensa che ella non aveva
più la voglia né il coraggio di guardarla. E tutta questa vita era
21 Ivi, p. 44. 22 Ivi, p. 45.
17
indifferente per quello che ne provava.23
Quelle «invisibili leggi» da cui è afflitta e che dominano su di lei non le
permetteranno mai di abitare la vita nella sua interezza; saranno sempre il
campanello d’allarme per una realtà da cui non può che fuggire, perché percepita
come sconfinata e destabilizzante. Baldacci scrive che
Adele è già, come saranno molti altri romanzi di Tozzi, la storia di una
nevrosi, dell’estraneità dell’uomo di fronte al mondo e alle cose. La
protagonista avverte che non c’è più una relazione storica, cioè
logicamente temporale, tra se stessa e gli oggetti che la circondano, e a
questo rilievo corrisponde un’illuminazione dolorosa.24
Adele è prigioniera della sua solitudine, avverte la mancanza di qualcuno che si
occupi di lei, è indotta a vivere un’esistenza limitante dove l’innocenza e l’autenticità
hanno già lasciato spazio alla polvere della vecchiezza: «Tutto le produceva
stanchezza»25.
In un brano la cui prima parte è tra quelle in seguito cancellate, troviamo Adele
intenta a osservare i segatori dalla sua loggia. Per la prima volta la protagonista sente
la sua esistenza collegarsi con tutto ciò che vede intorno a sé; in quel momento si
chiede cosa gli altri pensino di lei. L’incontro successivo tra Adele e Fabio avviene
mentre lei sta innaffiando le piante in giardino e accortasi che il ragazzo la sta
spiando si vergogna di continuare. I due cominciano a parlarsi e a ridere, ad
avvicinarsi l’uno all’altro intanto che il sole splende: «Nelle mani di lei cadde tutta la
luce. Ed essi si baciarono cento volte, nel desiderio ancora puro e intatto»26:
In Adele, come era già avvenuto in Paolo, l’erotico e il religioso sono le
due facce della stessa medaglia, con la conseguente intercambiabilità dei
patrimoni linguistici e simbolici che si è avuto modo di notare. Il sole che
riscalda ed illumina (e spesso brucia e abbacina) è il simbolo paterno
della divinità, ma è anche l’annuncio dell’eros; il connubio mistico è
23 Ivi, p. 54. 24 Luigi Baldacci, Tozzi moderno, cit., p. 66. 25 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 55. 26 Ivi, p. 65.
18
intriso di sensualismo, così come la voluttà è vissuta nei termini della
devozione. 27
Dopo uno spazio bianco, ci informa Glauco, segue la storia dei contadini
dell’avvocato Belcolori, i quali dopo la mietitura uccidono il loro cane perché non
mangi l’uva che sta per maturare. L’episodio è molto crudele. La motivazione non
regge. Essi dibattono sull’uso dell’arma e infine decidono di legare la bestia a un
albero di fico; il cane, abituato ai maltrattamenti, non riesce però a comprendere il
perché di quella piccola corda che gli stringe il collo e diviene triste.
Nel mondo primitivo di Tozzi non ci sono differenze fra le diverse
creature, fra uomini e bestie. È un mondo originario, creaturale, appunto.
Tutte hanno la stessa dignità data dal dolore di vivere, e conoscono la
stessa miseria. Il cane diventa triste come Adele: perché non capisce
niente.28
Dopo due colpi di fucile sparati dal giovane contadino, Toppa è ancora vivo;
continua a guardare negli occhi il suo assassino e tenta ancora di alzarsi, ma senza
pietà il vecchio lo colpisce sul capo con quattro colpi di vanga e l’animale muore.
Nel capitolo successivo l’avvocato Belcolori si trova costretto a recarsi Roma per
lavoro e decide di portare con sé il figlio Fabio, il quale, colto di sprovvista, non
trova il tempo di avvertire Adele. Il giovane si avvia verso casa dell’amata e le
annuncia il suo viaggio di lavoro. I due cominciano un dialogo amoroso in cui
espongono i propri sentimenti e si regalano certezze inverosimili prima della
partenza.
Fabio subisce il rapporto con il padre, non vorrebbe accompagnarlo ma
nonostante ciò non si oppone, non riesce a prendere alcuna posizione. Spera soltanto
che questo disagio possa miracolosamente terminare e non sa quando. Egli soffre di
psicastenia, alla quale è ricondotta la sua sensazione di impotenza psichica.
Il padre gli disse: - Che cosa hai? Tu non sei venuto volentieri. Egli cercò
27 Marco Marchi, Ipotesi e documenti, Marietti, Genova 1993, p. 31. 28 Romano Luperini, Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, le opere, Laterza, Roma 1995, p. 102.
19
di sorridere e di scusarsi; ma l’oppressione era immensa come quel sole
infocato. Egli ripensava ad Adele, ripeteva tutto quel che le aveva detto;
ed il suo dispiacere di non averla vicino era tale che egli si disperava e se
ne struggeva. Sarebbe tornato in dietro, subito, se avesse potuto.29
Guardando il mare, Fabio vede Adele. È consapevole della realtà ma si lascia
trasportare dall’allucinazione; è travolto dal suo male. L’avvocato Belcolori decide di
tornare a Siena la sera stessa e il figlio si ritrova colto da un senso di impotenza
fortissimo: «Ogni scopo di vita era assente, disperso non si sa dove e per sempre»30.
Dopo un ultimo spazio bianco, il racconto torna ad Adele. La giovane, sconvolta a
seguito dell’ultima conversazione con Fabio, sembra stimolata da un’esaltazione
mistica in cui le pare di sentire in tutto il suo ardore la benedizione della vita. Il
giorno dopo, invece, Adele è impaurita, pensa che egli non tornerà; ne conclude che
il fuoco di quell’amore si sia già spento e decide che Fabio non la rivedrà più.
Gli iper-inibiti rappresentati da Tozzi non sono destinati ad alcun cambiamento; è
loro preclusa ogni forma di redenzione perché la loro volontà è incapace di credere.
Adele è di nuovo raggiunta da un’irragionevole disperazione, sente che nulla più le
appartiene, soprattutto ciò che potrebbe renderla felice: Fabio, l’amore, il bene; ogni
cosa accade al di fuori di lei.
Tozzi ricavò senza dubbio dalla pagina di James l’immagine della mente
malata che avverte il peso insostenibile della vita, “la soma del male”, ma
se per lo psicologo americano i mali “sono la chiave” migliore al
significato dell’esistenza […] la sola cosa che ci può aprire gli occhi
sugli abissi più profondi della verità”, questo è vero per Tozzi solo in
parte, allorché, per seguire fino in fondo la parabola dell’esperienza
mistica di Adele, siamo costretti a vederla ‘chiudere gli occhi’ sul mondo
e sulla vita, perché essa aveva finalmente compreso “che tutto andava per
conto proprio, al di fuori di lei”.31
Così Adele prende la rivoltella, chiude ogni imposta per guadagnarsi una
completa solitudine, e si uccide. Sino al sorgere del nuovo giorno nessuno se ne
29 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 75. 30 Ivi, p.78. 31 Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. 174.
20
accorge.
La morte per Adele non è la realizzazione di un sogno, come per Paolo,
ma il segno di un’avvenuta, insopportabile, dissociazione fra io e mondo.
Le cause della morte non vengono lasciate nel vago, ma assumono la
forma del suicidio visto come esito conclusivo di una “patologia”.32
1.3 Frammento e romanzo
La vita di Tozzi è interamente dedicata alla scrittura: «stando alla sua stessa
poetica, è appunto in essa che deve risolversi la fortissima istanza morale»33 Tra le
due fasi della sua ricerca, ovvero il periodo senese, che dura sino al 1914, e il periodo
romano, che inizia nel 1914 e termina con sua la morte, nel 1920, non vi è una
rottura ma un’evoluzione, scrive Luperini. Si tratta tuttavia di due periodi
caratterizzati da differenze notevoli: il primo è contraddistinto dalla direzione del
periodico «La Torre», mentre il secondo trova la sua più importante manifestazione
nel lavoro al «Messaggero della domenica», dove Tozzi è immerso in un mondo
culturale più ampio, circondato da personalità di rilievo nazionale e internazionale.
La rivista fiorentina «La Voce», protagonista del dibattito intellettuale dalla fine
del 1908, con il tempo mostra un’attenzione sempre più vasta ai problemi della
produzione di testi creativi:
Questa letteratura sperimentava inediti modi espressivi, spesso si poneva
in un’ottica d’avanguardia parallela a quella del futurismo rifiutandone
però il culto ossessivo della modernità. La letteratura più
specificatamente definibile come «vociana» si avvolge in un’inquieta e
sofferta indagine nelle pieghe dell’io e dei suoi difficili rapporti con il
mondo.34
La scrittura di Tozzi è inizialmente molto influenzata dalla poetica vociana del
frammento, dove le vibrazioni del sentimento e la ricerca formale procedono di pari
passo, oltrepassando nel lirismo e nella brevità dei componimenti i confini tra prosa e
32 Romano Luperini, Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, le opere, cit., p. 102. 33 Ivi, p. 47. 34 Guido Ferroni, L’esperienza letteraria in Italia, Einaudi scuola, Milano 2006, p. 411.
21
poesia. Negli aforismi di Barche capovolte, elaborati nel biennio 1910-11, ritroviamo
la poetica giovanile dello scrittore, dedicata all’esplorazione dell’anima come essa si
rivela abitualmente, senza alcun criterio di valutazione. In nessun altro autore del
Novecento vi è un rapporto così intimo tra letteratura e psicologia. Secondo Delia
Garofano, parlare di “Tozzi aforista”, a rigore di termini, vuol dire parlare di Tozzi
come autore di un solo libro, Barche capovolte. È lo scrittore stesso ad attribuire a
questa sua raccolta di prose brevi, sospese tra misticismo lirico ed autoindagine
psicologico-intimistica, la definizione di “aforismi”, che egli riserverà ad altri suoi
testi di carattere frammentario quali Bestie, Cose e Persone. È pur vero, continua
Delia Garofano, che Tozzi in un’altra circostanza allude agli aforismi di Barche
capovolte anche come a un «libro di psicologia» o come ai propri «principi morali»,
evidenziando per primo la difficoltà di ricondurre a un genere preciso la propria
opera, come hanno concordemente dimostrato gli studi più recenti dedicati
all’argomento35. In questo testo l’autore si propone di permettere che l’anima si
mostri autonomamente, fuggendo da ogni condizionamento del proprio io:
Lasciate sempre che l’anima svolga energicamente le proprie funzioni.
Molte volte sorvoliamo uno stato mentale, che è interessante. Onde,
dopo, ricerchiamo invano riacquistarlo. L’anima vuol spendere bene il
suo tempo, ed è come le nuvole che continuamente cambiano la loro
forma. Quando state per raffigurare qualche cosa, l’anima si avanza con
un altro aspetto.36
Si crea un contrasto tra la levità dell’anima e la volontà di seguirla
affannosamente attraverso la scrittura, aderendovi in maniera spontanea, senza
opporsi al suo libero flusso. Questo corpo a corpo con l’anima per carpirne i segreti
può risolversi unicamente nell’aforisma o nell’appunto lirico, cioè nel frammento,
scrive Luperini. Questa è la linea della produzione giovanile in prosa, da Barche
capovolte a Bestie.37
A questo periodo di formazione nel clima vociano segue una presa di distanza;
35 Delia Garofano, Tozzi aforista, in «Moderna», a. IV, n. 2, 2002, p. 187. 36 Federigo Tozzi, Paolo. Barche capovolte, Empiria, Roma 2007, p. 94. 37 Romano Luperini, Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, le opere, cit., p. 81.
22
come ricorda Fernando Marchiori, «egli si scaglierà dalle colonne della Torre contro
la rivista fiorentina puntando invece sul binomio sincerità-provincia e opponendosi
alla falsità di una letteratura malata, lontana dalla verità della vita 38 . Nel
frammentismo Tozzi non vede un fine ma un mezzo per aprirsi ad altro, ad un nuovo
che magari «già esiste fin dai primi secoli della nostra civiltà»39, come dichiara in un
articolo del 1918:
I così detti frammenti lirici, onde sono gremite le riviste e ormai anche i
giornali, sarebbero un segno miserevole se appunto non servissero a una
sosta; di cui non si poteva fare a meno. Ma se essi hanno un valore quasi
statico ed elementare, è evidente che danno anche tempo ad altri scrittori
d’arrivare, con una lentezza di ferita che si rimargina, a produrre con una
decisiva e accettabile lealtà che non si preoccupa delle inezie.40
Tozzi non metterà da parte il suo progetto aforistico durante il periodo romano ma
non a caso sceglierà di rinunciare alla pubblicazione dei frammenti di Cose e
Persone; egli continua a dedicarsi alla componente lirico-soggettiva della sua arte,
seguendo attraverso la scrittura la mobilità dell’anima con l’intenzione di trasporla
nel romanzo e nella novella. Secondo lo scrittore senese il frammentismo ha
rappresentato una sosta, all’interno della tradizione, di cui non si poteva fare a meno.
È necessario però superarlo:
Occorrerà recuperare dal passato la tradizione del genere per calare però
in essa il rinnovamento, tornare alla narratività – con la sua durata, la sua
interna articolazione, i suoi snodi – ma nello stesso tempo inventare un
nuovo tipo di narrazione, fondata sulla ricerca psicologica e sulla fedeltà
ai movimenti minimi dell’anima. Da un lato, quindi, dovrà esserci
l’invenzione dei personaggi e di situazioni che riflettano una determinata
“realtà umana e sociale”; dall’altro sarà necessario il rifiuto di una
narrativa basata prevalentemente sul racconto, a favore di una narrazione
capace di cogliere i “misteriosi atti nostri” e di creare “più moderne unità
38 Fernando Marchiori, Apparizione e transito: le bestie senza favola di Tozzi, in Federigo Tozzi,
Bestie, Manni, Lecce 2000, p. 71. 39 Ibidem. 40 Ibidem (la citazione è tratta da Federigo Tozzi, Realtà di ieri e di oggi, Amadeus, Montebelluna,
1989, p. 40).
23
psicologiche”. Questo progetto, volto non a restaurare il passato ma a
dotare l’Italia di una narrativa moderna di tipo nuovo, è il contributo
storicamente più rilevante che Tozzi, come critico e come elaboratore di
una poetica personale, abbia apportato alla narrativa
primonovecentesca.41
Per la prima volta con Adele, Tozzi cerca di superare il frammento avvicinandosi
alla misura romanzesca, scrivendo quello che resterà soltanto un abbozzo di
romanzo. L’evoluzione consiste non solo nel recupero di un genere letterario, ma
nella scelta di svuotarlo dall’interno, in modo da rinnovare decisamente la forma del
racconto e lo stesso flusso narrativo.42 Non è più necessario preoccuparsi dell’ordine
logico del discorso e delle esigenze della trama, perché secondo la prospettiva
tozziana la scrittura ha il compito di restituire immediatamente la corrente delle
sensazioni che attraversano la vita umana «in una qualunque porzione di realtà
guardata»43.
In Adele, sembra che l’autore abbia in mente una precisa storia da raccontare ma
non sappia dove collocare ogni singolo frammento di ciò che risiede nella sua
immaginazione:
Questa combinazione fra allucinazione e senso della realtà non è casuale.
L’abbandono alla logica dell’inconscio avviene pur sempre in presenza di
un progetto consapevole e del principio di realtà. La stretta correlazione
fra psicologia e forma viene assunta all’interno di un progetto, diventa
strategia di scrittura che, lasciando vuoti di significato e ampi varchi al
non-detto e al non-spiegato, abbandona il lettore in uno stato di leggera
ma costante vertigine.44
È proprio la vertigine a guidare la lettura di un romanzo che appare come un
collage, composto in parte dai brani “salvati” dall’autore e in parte da quelli non
compresi nella sua scelta, che Glauco Tozzi ha introdotto per rendere più agevole la
comprensione della trama. Procede inesorabile un continuo alternarsi di stati d’animo
41 Cfr. Romano Luperini, Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, le opere, cit., p. 73. 42 Ivi, p. 83. 43 Ivi, p.87. 44 Ivi, p. 44.
24
e descrizioni, dove non è possibile soffermarsi; sembra quasi che Tozzi non voglia
concedere al lettore il diritto di comprendere ciò che accade nella storia, perché lui
stesso non lo comprende, o per meglio dire non lo domina.
Nel testo è particolarmente evidente ciò che Tozzi intende comunicare scrivendo
in Come leggo io che il «lettore ideale» non si lascia dominare dalla lettura: come
l’autore, egli deve dedicarsi alla profondità e non allo svolgimento dell’azione. «La
sua strategia di lettura non deve basarsi sulla successione lineare del racconto, bensì
sulla interruzione, sulla sospensione, sul ritorno all’indietro, sul salto in avanti45».
Strategia di lettura e strategia di scrittura si fondono dunque, costituendo un impianto
narrativo ancora più enigmatico in quanto frutto di continue doppie scelte:
dell’autore e del curatore. Insieme di frammenti e romanzo compiuto al tempo stesso,
Adele è il primo tentativo tozziano di consegnarsi in un’opera che ne racconti gli
studi, le letture, le ossessioni, i traumi. Si tratta di un esperimento che io considero
riuscito, perché dalle pagine di questo testo emerge tutta la realtà che Tozzi voleva
restituire: tagliente, frantumata, per niente consolatoria. L’impressione è che Tozzi
non scriva né per il lettore né per se stesso, per la vita piuttosto: per rendere omaggio
alla sua crudeltà, negarne l’importanza, acclamarla e intanto colpirla con urgenza, la
stessa di chi continua a cercare la forma più consona per narrare la storia dei suoi
personaggi. La ricerca di una forma narrativa che coniughi la durata romanzesca con
la frammentazione della coscienza moderna per rendere traducibili «i misteriosi atti
nostri» è il problema principale dell’intero percorso creativo di Federigo Tozzi, che
nel 1919, tracciando una sorta di bilancio del proprio lavoro, scriveva:
Molte volte mi sono domandato se nei nostri scritti, con i quali
esprimiamo più fervidamente il pensiero, non sentiamo che le parole
adoperate non hanno più con noi un’aderenza assoluta […]. A me sembra
che tutte le nostre parole, specie quelle più significative abbiano un non
so che di vieto che non vuole adattarsi allo sforzo che noi domandiamo.
C’è da sospettare che esse ci costringano ad un’angustia, da cui ci
vogliamo liberare a tutti i costi.46
45 Ivi, p. 90 46 Federigo Tozzi, Rerum fide, in «Il Messaggero della domenica», 19 gennaio 1919, citato in Delia
Garofano, Tozzi aforista, cit., p. 198.
25
2. Malattia e cura della coscienza tozziana
2.1 Una volontà alterata da leggi invisibili
Adele è la storia di una pazza47, scrive Luigi Baldacci. La protagonista di questo
romanzo è appunto una donna afflitta da numerose nevrosi, di cui Tozzi racconta la
storia avvalendosi della propria cultura di carattere scientifico-psicologico, in
particolare delle opere del filosofo e psicologo americano William James.
La parola nevrosi, assieme a nevrosismo, viene divulgata in Italia probabilmente
da Paolo Mantegazza, che la reputa «parola nuova, perché serve ad esprimere una
cosa che non esisteva, od era così rara da non fermar l’attenzione degli osservatori».
In verità la malattia nervosa era nota sin dalla fine del Seicento: si reputava fosse una
sofferenza della mente che coinvolgeva tutto il corpo, provocando agitazione e moto
continuo, anche del volto48. Secondo l’opinione comune, questa patologia affliggeva
in particolare le donne, che proprio per la loro costituzione delicata sono più portate
degli uomini all’agitazione nervosa e alla malattia mentale 49 . Tra i sintomi era
annoverato un «aumento della sensibilità, della immaginazione, della affettibilità,
della locomotilità, che caratterizza certi individui, ai quali per causa appunto di
siffatta suscettibilità si attribuisce il temperamento nervoso»50.
Adele è notoriamente uno dei personaggi tozziani dallo spessore psicopatologico
più marcato, un prodotto letterario che prende ispirazione dalle più importanti opere
jamesiane: Principii di psicologia pubblicato nel 1890, Le varie forme della
coscienza religiosa del 1902 e La volontà di credere del 1897. Il ritratto della
protagonista di questo romanzo in frammenti corrisponde alla figura di una giovane
donna che fatica a sopportare il peso della sua esistenza, non si riconosce in nessun
riflesso della realtà circostante, è un soggetto che infinitamente cerca quello che
47 Luigi Baldacci, Tozzi moderno, cit., p. 60. 48 Cfr. Anna Panicali, Del secolo «nevrosico», in «Critica letteraria», n. 1, 2005, p. 89 (la citazione da
Mantegazza è tratta da Il secolo nevrosico, Barbèra, Firenze 1887, p. 8). 49 Cfr. G.L. Mosse, L’immagine dell’uomo, Einaudi, Torino 1997, p. 80. 50 Cfr. Anna Panicali, Del secolo «nevrosico», cit., p. 91 (la citazione è tratta dal Dizionario
compendiato delle scienze mediche, Antonelli, Venezia 1829, p. 281).
26
disperatamente non trova. Un personaggio disperato dunque, che nessuno poteva
descrivere meglio di Tozzi, il quale come commenta Baldacci, «aveva una visione
disperata della vita. Penso anche che sia stato il primo scrittore italiano che senza
volere, sia stato esistenzialista»51. Senza volere appunto, perché la vita di Adele,
come la sua morte, non hanno alcun significato; trovarne uno sarebbe l’ennesima
allucinazione del lettore, che continuamente interrotto e lentamente frantumato dalle
stesse parole con cui viene descritta la triste storia della protagonista, non può che
abdicare al senso. Lasciarsi trasportare da Adele significa aderire alla sua follia
isterica, l’unico elemento per capire il puzzle tozziano di cui possediamo i
frammenti.
Lo scrittore senese, quindi, senza avere alle spalle specifici studi
scientifici, lesse le opere di James, forse, in parte, influenzato dalla
cultura fiorentina del tempo, forse per aggiungere un tassello alla sua
formazione culturale e forse anche per rispondere ad un’esigenza
personale, per appagare un’ansia di certezze, quella stessa ansia che, pur
diversamente gestita ed affrontata, è in fondo l’elemento motore di tutti i
suoi personaggi, delle sue bestie.52
Dallo psicologo americano, Tozzi eredita un concetto fondamentale, tale da
decidere le sorti di quasi tutti i suoi personaggi successivi: quello di volontà inibita.
Adele può innamorarsi ma non può amare, riesce a lasciare i genitori cercando
un’indipendenza che non troverà mai, per ritrovarsi al punto di partenza, di nuovo a
casa. Si rivela fin dall’inizio un soggetto iper-inibito: cammina veloce temendo di
essere inseguita e dopo poco si ferma per riprendere fiato; tuttavia Tozzi non le
permette di prendere fiato dalla sua incapacità di vivere, dalla sua isteria, dal
sentimento di morte che la insegue:
Le pareva che la morte fosse prossima, sopra le colline già oscure di
Siena, così alta. La morte che aveva ucciso anche la luna apparsa tra due
nuvolette su tra le cime dei cipressi, tra gli inviluppi dei roghi, tra gli
51 Luigi Baldacci, Tozzi moderno, cit., p. 111. 52 Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit. p. 55.
27
stecchi degli alberi senza foglie, tra i pioppi troppo bianchi che non
potevano difenderla, e qualche angolo di vigna.53
La giovane Adele, vittima dei suoi «impulsi impotenti», conosce stati di quiete
spesso piacevoli, ma ben presto ricade nell’abisso della sua immobilità.
Nell’alternanza di sforzi vani e dolorose frustrazioni si svolge, o meglio tenta di
farlo, l’azione manchevole delle creature inibite di Tozzi, tragicamente coscienti
della propria impotenza e, con essa, dell’immenso dramma della vita 54 . È
un’impotenza che per Adele diventa delirio, come quando «Non le è più possibile
pensare: sembra che a lei si sostituisca un’altra anima. E si abbandona. Tutto quel
ch’ella avrebbe bisogno di dire le sembra così strano e inutile che invece di
rispondere fa una risata»55.
Negli Studi sull’isteria del 1895, Freud aveva scoperto come l’Io si costruisca
delle difese per non vivere una rappresentazione intollerabile, che respinge e dissocia
affettivamente56. È lo stesso meccanismo di cui è vittima la protagonista quando si
sente attraversata da un sentimento più forte della sua capacità di vivere, poiché
«Tutte queste immagini luminose le restano nella mente, abbagliandola, bruciando
ancora come fiamme»57. Ciò nonostante, Adele non è una paziente, è un personaggio
di Tozzi; i suoi conflitti, le sue dissociazioni, le sue risate isteriche non sono e non
devono essere curabili, rimangono manifestazioni affascinanti e profonde dell’analisi
di una coscienza alla quale Tozzi non concede alcuna redenzione, solo «la crudele
verità del suo tartaro pregiudizio di dimostrare a se stesso e agli altri che non c’è via
d’uscita da una penosa e allucinante condizione umana»58.
L’autore senese non condivide l’ottimismo di James: come rimedio al doloroso
stato di una «volontà ostruita, lo psicologo americano propone l’antidoto della
«volontà di credere»59, ovvero la credenza che in ogni momento della nostra vita vi
53 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 5. 54 Cfr., Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, p. 135. 55 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 29. 56 Cfr. Salomon Resnik, Isteria, cit., p. 1020. 57 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 29. 58 Massimo Lippi, Federigo Tozzi: La nostalgia del vero, in «Moderna», a. IV, n. 2, 2002, p. 255. 59 Cfr. Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. 136.
28
siano delle cose che realmente si decidono in essa e che «non si tratti semplicemente
del monotono tintinnio di una catena i cui anelli furono fabbricati nelle età
primordiali»60.
Il pensiero di James, autore di un’intera opera dedicata alla Volontà di
credere, filosofo disposto a riabilitare il libero arbitrio umano anche a
costo di disprezzarne l’esistenza, non poteva in questo senso funzionare
per l’opera tozziana drasticamente refrattaria a qualsiasi forma di
approccio ottimistico alla vita. Ancora una volta, dunque, seguendo
un’ottica e una visione del mondo tutte personali, Tozzi sceglie e censura
le pagine scientifiche di William James, estromettendole con
straordinaria facilità da un complesso discorso teorico, spesso destinato
ad approdare altrove.61
Tanto è vero che Adele non sentirà «l’intera sensazione della realtà» 62 , per
riempirsi di essa e farne parte integralmente, come soggetto attivo, ma lascerà che il
suicidio ponga fine alle sue sofferenze, allontanandosi da un mondo che mai le aveva
dato importanza. «La vita reale, che non aveva bisogno di lei, era divenuta come un
sogno insopportabile».63 La realtà di Adele prende la sembianza di un incubo a tre
dimensioni: lei, la sua isteria, i suoi genitori. Il rapporto della protagonista con la
madre e il padre, che fin dall’inizio appare compromesso, continuerà a peggiorare,
mentre l’atmosfera in casa diventerà insopportabile. Si tratta di legami tanto
disgregati e frammentati quanto i brani di questo romanzo, afflitti da
un’incomunicabilità quasi insuperabile, che conosce rarissimi momenti di quiete. I
genitori di Adele sono in collera con lei a causa del suo trasferimento a Firenze, che
avviene contro la volontà del padre; dal capoluogo toscano la protagonista torna
trovando una desolante accoglienza che suscita in lei manie di persecuzione:
60 Cfr. ivi, p. 136 (la citazione è tratta da William James, Principii di psicologia, traduzione italiana
con aggiunte e note di Giulio Cesare Ferrari, diretta e riveduta da Augusto Tamburini, Società
Editrice Libraria, Milano 2005, pp. 809-810). 61 Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. 137. 62 Cfr. ivi, p. 136 (la citazione è tratta da William James, Principii di psicologia, cit., pp. 809-810). 63 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 18.
29
L’indomani disse: - Questo vino è avvelenato! La serva si tacque. – Tu
credi che io non me ne avveda! Ma dillo anche a loro. Se seguitano così,
griderò dalla finestra che vogliono avvelenarmi. La serva richiuse l’uscio.
Ed ella pensò: «Perché non mi ha risposto? Vuol dire che è vero quel che
penso io. Dovrei essere folle se io sbagliassi». E si accasciò nella sua
poltrona. Ma dentro di sé vantavasi di quel tempo trascorso a Firenze, e
decise di non parlare più a nessuno di quei di casa.64
La madre di Adele, una figura non altrettanto presente quanto quella del padre ma
comunque percepibile nel suo conflitto con la protagonista («Bastava che vedesse la
madre per divenire furibonda»65), è ugualmente contraria alla condotta della figlia; la
donna si affida alla preghiera e alla devozione religiosa per rendersi indifferente al
comportamento di Adele. Vi è un punto d’incontro, forse l’unico nel testo, dove
madre e figlia entrano in relazione, perché sono entrambe donne di fede. Eppure,
Adele si rivela nuovamente eccentrica: Tozzi non le risparmia le numerose
«esaltazioni mistiche» 66 favorite dalla malattia isterica, ed essa jamesianamente
partecipa, sostiene Martina Martini, ad una dimensione religiosa in cui la concezione
di Dio è consapevolmente personale:
Sentiva le sue vene come aperte da uno sforzo; ed era indignata. Poi
penso: «Dio mi conduce dove vuole; ma essi non conoscono il mio Dio».
E cominciò a mangiare riflettendo a cose profonde e mistiche. Le pareva,
in questo abisso di disperazione, accostarsi sempre di più al concetto che
ella voleva avere della divinità. 67
Si entra quindi nel mondo della soggettività, dove tutti gli uomini differiscono tra
loro, e l’intensità del loro credo religioso si rafforza in funzione delle proprie
esigenze personali68. Si tratta a mio avviso di una religione paradossalmente umana,
poiché di ogni uomo sono le debolezze, le contraddizioni, le speranze; è umano voler
credere, anche se la protagonista di questo romanzo supererà tale concezione
64 Ivi, p. 12. 65 Ivi, p. 15. 66 Ivi, p. 27. 67 Ivi, p. 14. 68 Cfr. Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. 157.
30
precipitando nel buio: «Sia che cerchi l’amore sia che cerchi Dio, il personaggio
tozziano si risolverà costantemente in un personaggio di tipo tragico»69. Stipulando
un fondamentale compromesso tra spiritualismo ed esistenzialismo, poiché «i
migliori seguaci del metodo critico non confondono mai il problema esistenziale con
quello spirituale», si entra appunto in una dimensione soggettiva, in cui le linee della
fede religiosa sono decretate dall’individuo, ovvero dalla sua innata esigenza,
amplificata nei casi eccentrici di esasperazione patologica, di crearsi un punto di
riferimento rassicurante in alternativa ai grandi quesiti posti da un futuro
indecifrabile70. Adele fa parte delle «morbid minds», il termine con il quale William
James definisce i casi eccentrici di psicopatologia religiosa che affollano il vasto
panorama delle tipologie umane presenti tra le pagine tozziane71.
La chiesa le pareva quasi un deserto silenzioso, di cui la Madonna di
Giovanni avesse avuto bisogno. E le pareva che la divinità la incitasse a
perseverare, finché anche ella non fosse creduta sacra. Le pareva che
qualcuno avesse dovuto esclamare, scorgendola: «Questa donna era
attesa da noi! Lasciamola predicare! Non udite come predica? Predica,
dunque, predica!» E le sue parole erano udite dovunque avesse voluto.
Tutte le città si volgevano a lei, che rispondeva: «Aspettate. Vedrete
quale sono io. Vi farò il più grande miracolo che io vi possa fare». E si
sbalordiva accasciandosi, con un dolore insistente dentro la testa; un
dolore che la perseguitava perché doveva simbolizzare qualche cosa. 72
Il destino di Adele, prima di risolversi in un esito tragico, incontra quello di un
altro personaggio, altrettanto malato, di cui la protagonista s’innamora. Si tratta di
Fabio, il figlio dell’avvocato Belcolori: un ragazzo introverso, molto sensibile,
affetto da psicastenia. Il loro amore è struggente, conosce momenti di grande
romanticismo, Tozzi ne regala un’immagine più spirituale che carnale. Appare però
evidente che Fabio e Adele non sono due innamorati come tanti altri, poiché
entrambi afflitti da una patologia psichica. Nel brano in cui il figlio dell’avvocato
69 Marco Marchi, Ipotesi e documenti, cit., p. 28. 70 Cfr. Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. 159. 71 Cfr. ivi, p. 168. 72 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 17.
31
Belcolori si trova costretto ad accompagnare il padre durante un viaggio di lavoro a
Roma, lo scrittore senese, più che altrove, ricorre una cultura psicologica
sapientemente bilanciata tra James e Janet, riuscendo a descrivere con precisione i
sintomi di una patologica condizione inibitoria.73
Fabio non avrebbe voluto accompagnare il babbo, ma egli era in quello
stato d’animo passivo che lascia scorrere gli avvenimenti, subendoli con
disagio, ma senza alcuna iniziativa di opposizione. Soltanto si aspetta che
questo malessere, quasi volontario, abbia termine presto a costo di
qualsiasi cosa; ma si assomiglia a chi non ha più la forza di risalire onde
costantemente è disceso; e quel che occorre si aspetta che capiti,
soffrendo molto intanto. […] Tale indolenza dolorosa è un fenomeno di
psicastenia. Ma ecco che dopo i primi chilometri, i suoi sentimenti
ebbero il sopravvento sì che egli provò una reazione emozionale.74
Fabio ripensa ad Adele e si dispera perché non può averla vicino, mentre la
giovane, temendo di non vederlo più tornare, rinnega il suo stesso sentimento: i due
amanti non si rivedranno più. Il loro è un amore fatale che non avrà seguito, perché
la protagonista morirà:
«Perché doveva morire? Perché tutte le cose andavano in una lontananza
che non le apparteneva più?». Tutte le ombre della vita la chiusero nella
loro vanità e la eccitarono a compiere quello che la sua volontà alterata
aveva parecchie volte considerato come un adempimento finale. Fabio
era lontano come tutte le altre cose belle, le quali erano chiuse in un
ritmo a cui ella non poteva partecipare; tutta la vita era in un ritmo
estraneo a lei. Bisognava dunque trovare una vita differente!75
Francesca Sanvitale scrive che con Tozzi scompare l’assoluta conoscenza del
mondo da parte dell’autore: sembra infatti che i suoi personaggi a volte inventino se
stessi, seguendo in maniera autonoma le loro pulsioni. Essi si trasformano, agiscono,
muoiono e intanto conducono l’autore e i lettori non a spiegare l’enigma ma
unicamente a prendere atto della sua presenza.
73 Cfr. Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. 140. 74 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 72. 75 Ivi, p. 81.
32
L’enigma, infatti, non è conoscibile, né l’autore può credere di tenere e
muovere i fili delle marionette, di essere il loro dominatore perché è il
primo a non sapere, a non conoscere, a non credere nella propria
lungimiranza narrativa e psichica. Non crede più al suo potere. Ed è per
questo che Tozzi ha indicato molte strade della modernità.76
2.3 L’autobiografismo «en travesti»
Come dubitare che Adele sia lo stesso Federigo Tozzi? La novità di
Tozzi è proprio questo autobiografismo en travesti. […] Tozzi rifiuta
l’oggettivazione del personaggio, e tutte le volte che egli deve scendere
nel profondo di una figura femminile, vi trasferisce se stesso.77
Secondo Luigi Baldacci, e dello stesso avviso sono tutti i critici di Tozzi, Adele
non è che l’alter ego dello scrittore: una figura femminile la cui psiche
profondamente turbata rappresenta il rifugio dell’anima tozziana. La pazzia della
protagonista nasce però da un sentimento critico dell’autore: è l’annuncio del fallito
tentativo di uscire da se medesimo che egli aveva immaginato possibile in Novale,
scrivendo in una lettera del 1907: «ho desiderato spesso divenire uno stocco di
granoturco»78. In Adele, per uscire fuori di sé, Tozzi diventa una donna e lo fa nel
modo più insolente, continuando ad attribuire alla protagonista una sensibilità e
un’impronta culturale sociologicamente impossibili, come ad esempio il riferimento
alla lettura del Paradiso dantesco79: «Soltanto le ultime cantiche di Dante potevano
esprimere tale paradiso e tale verità eterna. Ne aveva una adorazione così sincera che
cominciò ad esserne fanatica».80
L’indizio più esplicito dell’autobiografismo di Adele è il rapporto della
protagonista con il padre, riflesso di quello tra lo scrittore e Ghigo del Sasso, nel
quale la rivolta del figlio, come scrive Luperini, sembra assumere l’aspetto della
trasgressione piuttosto che quello della radicale rottura e della ribellione drastica e
76 Francesca Sanvitale, Federigo Tozzi: La rivolta psichica del personaggio e altre divagazioni, in
«Moderna», a. IV, n. 2, 2002, p. 239. 77 Luigi Baldacci, Tozzi moderno, cit., p.50. 78 La citazione è tratta da Federigo Tozzi, Novale, p. 158. 79 Cfr. Luigi Baldacci, Tozzi moderno, cit., p. 60. 80 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 15.
33
definitiva81. In Adele, la protagonista si trasferisce a Firenze contro la volontà del
padre, trasgredendo quindi alle regole da lui imposte, ma anche la sua partenza non
assume le forme di un vero distacco dalla dipendenza emotiva e dall’autorità paterna:
tornerà di fatto a Siena per vivere nuovamente a casa dei genitori. Adele porta
insomma la stessa croce dell’autore, il suo conflitto con il padre riflette quello di
Tozzi e Ghigo, che termina, e mai completamente, soltanto con la morte di
quest’ultimo. Così, prima di riportarlo brutalmente tra le pagine di Con gli occhi
chiusi attraverso la figura di Pietro Rosi, Tozzi lo impone a un soggetto femminile
afflitto da patologia isterica. Marco Marchi scrive che
Se Tozzi fa di se stesso il personaggio di Adele prima di calarsi nel Pietro
di Con gli occhi chiusi (ma è interessante che qui Tozzi sia anche lo
psicastenico Fabio, il giovane che Adele vorrebbe amare) è
sostanzialmente per andare più a fondo nella comprensione delle regole
che il suo Dio ha imposto a lui e all’universo. O meglio: perché il
nichilismo appurato nei rapporti con il padre sia davvero assoluto.82
Qualora l’autore voglia approfondire le regole che Dio gli ha imposto, o invece si
proietti nel personaggio di Adele perché la donna, colei che abita nel seno della
natura, è più lontana dalla problematicità e dalle paure del maschio83, ciò che appare
indiscutibile è che le risorse personali a cui Tozzi attinge implichino una complessa
strategia di distanziamento che gli permette di creare storie, personaggi e modalità
narrative diversi: di essere Paolo e Adele, come pure Pietro Rosi e Leopoldo Gradi,
protagonista dei Ricordi di un impiegato, e molti altri ancora84.
Adele ha pertanto realizzato di essere «dimenticata come una cosa inutile e a
posta», di non essere veduta e neppure udita, nel suo urlo disperato, nella sua ricerca
di senso, e compiendo un atto escatologico vince la sua solitudine con la morte. Si
tratta di un passaggio obbligato per eseguire la vendetta paterna e accedere alla
totalità di quella «vita differente». Dal padre Adele ha imparato a chiudere gli occhi
81 Cfr. Romano Luperini, Le immagini, le idee, le opere, cit., p. 5. 82 Marco Marchi, Ipotesi e documenti, cit., p. 29. 83 Cfr. ivi, p. 29. 84 Cfr. Marco Marchi, introduzione a Paolo. Adele, cit., p. 9.
34
per attendere un calcio o un pugno in testa; chiudere gli occhi per sempre, per lei, è
anche un infantile chiudere gli occhi per non essere vista. E tuttavia le ossessioni di
Adele, la sua frequentazione degli istinti portata al diapason di una «disperazione
folle», trovano al suicidio una motivazione lucidissima: «Essa soltanto aveva dato
importanza a se stessa»85.
Il potere del padre coincide, per Tozzi, con quello di Dio, e ad esso si possono
contrapporre soltanto la lettura e la scrittura: «leggere per esistere, scrivere per
esistere»86. Allo stesso modo per Adele, plasmata secondo le stesse inclinazioni del
suo autore, «Soltanto le ultime cantiche di Dante potevano esprimere tale paradiso e
tale verità eterna»87. Lo scrittore senese, pur non dominando i suoi romanzi, echeggia
in ogni angolo della realtà rappresentata; nelle pagine finali si accosta anche a Fabio,
il giovane psicastenico innamorato della protagonista.
Nel 1904, Federigo Tozzi è colpito da una malattia agli occhi che lo costringe per
alcuni mesi all’oscurità e all’isolamento, caratterizzato unicamente dai continui
contrasti con il padre. Da questa lunga notte, sofferta anche dal punto di vista
intellettuale, Tozzi esce profondamente cambiato e inizia a dare ascolto ad un
fermento religioso interiore. Durante questi mesi frequenta assiduamente la
Biblioteca Comunale di Siena, imbattendosi nelle Varie forme della coscienza
religiosa di William James, come confermano le date delle richieste di prestito.88
Il dramma di Tozzi diventerà quello di Adele, la cui segregazione in casa è
aggravata dalla sopravvenuta malattia agli occhi, come ricorda Glauco Tozzi in una
nota. Adele non desidera che la madre le tenga compagnia in questo difficile
momento, si lascia trasportare dalle sue esaltazioni mistiche, e ciò che più la
tormenta è che tutto proceda inesorabile senza di lei: «Ma intorno a lei, la vita si
svolgeva con lo stesso vigore tranquillo. La natura rigogliosa non si preoccupava di
quel volto dimagrito e bianco e de’ suoi occhi coperti dalle grosse bende»89.
85 Cfr. Id., Ipotesi e documenti, cit., p. 32. 86 Marco Marchi, Leggere ed esistere. Ancora sulla cultura di Tozzi, p. 142. 87 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 16. 88 Cfr. Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, p. 188. 89 Federigo Tozzi, Adele, cit., p.19.
35
Debenedetti, che disponeva di un numero di testi tozziani assai inferiore rispetto a
quello a cui possiamo attingere oggi, ricorda Baldacci, pensava che solo attraverso
l’autobiografia, cioè la rappresentazione della propria nevrosi, Tozzi sia diventato il
grande scrittore che conosciamo:
Naturalmente un’autobiografia per simboli, come in Paolo, Adele,
Ricordi di un impiegato, Con gli occhi chiusi, Bestie, Cose, Persone.
Un’autobiografia che non aveva il compito di fare chiarezza. Anzi il
contrario: fissare in punti oscuri, non razionalizzabili in termini di
superficie, la presenza di verità sommerse, che fossero avvistate ma non
descritte dal segno letterario.90
Adele è dunque un’altra figlia disperata, un’altra figura mutilata, per cui «ogni
scopo di vita era assente», uno dei tanti personaggi-figli di Tozzi, che prima di essere
padre dei suoi romanzi, ne è soprattutto figlio. «Perché fare i figliuoli crocifissi?»,
scrive Tozzi a Emma in una lettera di Novale, il 20 ottobre 190791. Al crescere
dell’universalità di un quesito, aumenta il nostro tormento nel trovarvi una risposta.
2.3 Storia di una nevrosi
In una recensione a Cose e persone del 1982, Luigi Baldacci scriveva: «Adele è
già, come saranno molti altri romanzi di Tozzi, la storia di una nevrosi,
dell’estraneità dell’uomo di fronte al mondo e alle cose» 92 . Tozzi sceglie di
raccontare la malattia nervosa presentando un soggetto femminile che ne subisce le
fatali conseguenze; si tratta di una decisione che potrebbe avere rilevanza storica se
Adele non fosse il primo di una lunga lista di personaggi folli messi in scena
dall’autore.
Nel diciannovesimo secolo, infatti, si pensava che la nevrosi colpisse soprattutto
la donna, giacché trovava origine da uno squilibrio del sentire, da un eccesso di
sensibilità:
90 Luigi Baldacci, Tozzi moderno, cit., p. 86. 91 Cfr. Marco Marchi, Ipotesi e documenti, cit., p. 36. 92 Cfr. Luigi Baldacci, Tozzi moderno, cit., p. 66.
36
Immagino che tutti più o meno conoscano le bizzarrie di carattere delle
donne nervose. Tutti i loro sentimenti sono portati all’eccesso. L’evento
più insignificante può scatenarne l’entusiasmo o la disperazione. Nessuno
come loro piange con tanta facilità. Sembra addirittura che esse
possiedano la chiave delle lacrime. 93
La protagonista del romanzo tozziano corrisponde alla suddetta descrizione:
«Tutte le cose tristi e penose, quantunque lontane, assumevano un’importanza
patologica in lei, influendo nel suo carattere» 94 . Per una società fondata
sull’equilibrio e sul buon senso come quella ottocentesca, che guardava con sospetto
ogni forma di eccesso, i «nervi a pezzi» erano una seria minaccia, in quanto simbolo
di mancanza di freno e misura, commenta Anna Panicali. Non è una coincidenza che
il medico si avviasse a diventare un giudice della moralità. Verso la metà
dell’Ottocento i disturbi nervosi vengono messi in rapporto con la decadenza dei
costumi e si parla di degenerazione 95 . Bénédict Morel, nel Trattato delle
degenerazioni fisiche, intellettuali e morali del 1857, dichiara il suo sconcerto di
fronte al costante progredire in Europa non soltanto della pazzia ma di tutte le
condizioni anormali, in relazione diretta con l’esistenza del male fisico e morale nella
società. Di conseguenza, rappresentare la donna moderna equivale a restituire di essa
l’immagine data dagli studi della scienza positiva ottocentesca, per cui «il mistero
spirituale si concretizza in vibrazioni nervose, inafferrabili stati d’animo,
incongruenze e stranezze», ad esplorare un universo estraneo, la psiche femminile,
cimentandosi nel «tradurre in linguaggio comunicativo la sua incomunicabilità»96.
Tozzi sceglie dunque una strada difficile, si potrebbe dire azzardata, se non si
conoscesse la vastità delle sue letture scientifico-psicologiche, da cui ha preso
ispirazione per narrare non solo la storia di Adele ma quella di moltissimi personaggi
che portano il peso di un’esistenza malata, che non conosce logica ma soltanto
93 La citazione è tratta da Charles Robert Richet, Le indemoniate del nostro tempo, in S. Ferrari,
Psicologia come romanzo, Alinea, Firenze 1987, p. 136. 94 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 80. 95 Cfr. Anna Panicali, Del secolo “nevrosico”, cit., pp. 92-93. 96 Cfr. ivi, p. 101 (la citazione è tratta da Carlo A. Madrignani, Teresa, «povera pazza», in Luigi
Capuana, Tortura, Sellerio, Palermo 1992, pp. 52-57).
37
sensazioni: «Ciascuno ha in sé un mondo, che è indeterminabile. Ciò che ne
mostrano i raccoglimenti o le improvvise realizzazioni è una piccola cosa, rispetto
alla parte destinata a rimanere sepolta per sviluppare quel che soltanto diviene
superficie visibile»97, recita Intorno all’anima, un aforisma di Barche capovolte.
La conoscenza cui Tozzi e la sua scrittura si affidano partecipa dunque,
fin dagli inizi, con i suoi bagagli di intuizione e di certificabili notizie,
alle ipotesi noetiche avanzate dalla civiltà moderna: a quelle,
principalmente, insoddisfatte degli esiti del razionalismo, schierate dalla
parte dei sentimenti e degli istinti e comunque interessate al rilevamento
di una loro ineludibile presenza. Anima e psiche finiscono per Tozzi con
il confondersi.98
È dagli aforismi di Barche capovolte, quello che Tozzi confessa essere un
«piccolo libro di psicologia», che prende inizio la storia della vocazione psicologica
dell’autore, fortemente condizionata dalle letture di James. Baldacci ha perciò intuito
la modernità dello scrittore senese, accogliendo con entusiasmo gli studi di Marco
Marchi grazie ai quali oggi si può ricostruire con sicurezza il quadro della cultura
psicologico-scientifica di Tozzi, in cui è assolutamente centrale il rapporto Tozzi-
James. Di fatto, soltanto in base alle scoperte di Marchi all’interno dell’archivio
tozziano di Castagneto, la critica ha potuto tramutare le precedenti opinioni in
dimostrabili certezze.99
Martina Martina scrive che tali appigli scientifici (l’opera di James, ma è
necessario citare anche quella di Pierre Janet, Jean-Martin Charcot e Sigmund
Freud), sono diventati per l’autore l’unico mezzo attraverso il quale egli è riuscito ad
esprimere il proprio disagio, ad esorcizzare la propria pazzia che, priva del supporto
di un’analisi psicologica, sarebbe rimasta inespressa, condannata al silenzio di
un’interiorità inibita e indecifrabile. Il suo desiderio di conoscenza lo porterà a
superare i limiti della sua sofferta patologia, spingendolo a cercare risposte culturali
al proprio dramma. Non è un caso, continua Martina Martini, se la guarigione di
97 Federigo Tozzi, Paolo. Barche capovolte, Empiria, Roma 2007, p. 130. 98 Marco Marchi, introduzione a Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p.
XVI. 99 Cfr. ivi, p. 11.
38
Tozzi, o meglio la presa di coscienza del suo stato interiore, coincide con un
intenzionale ritorno in Biblioteca, come lo scrittore rivela alla fidanzata Emma in una
lettera di Novale:
Ho studiato assai in biblioteca, e sono quasi a raggiungere il nuovo
mondo, che sentivo muoversi dentro di me. Vorrei che tu credessi come
io a qualche cosa di nuovo che io porterò nel pensiero. Leggendo, ora mi
tornano tutte le sensazioni, che prima si perdevano in tutto il male che era
penetrato fino alle ossa della mia anima.100
«Tozzi non ha altra esperienza che di se stesso; cioè dei propri traumi; ma
dovendo illuminare quei traumi propri, deve per forza rappresentare gli altri», scrive
Baldacci101. In Adele, Tozzi assume le sembianze di una giovane isterica, che con la
stessa intensità avverte gli istinti di vita e di morte, senza riuscire a scinderli, a
prenderne il necessario distacco. Vi è una follia dunque, che minaccia costantemente
la pagina tozziana e i suoi protagonisti, quella che alcuni hanno voluto attribuire
personalmente all’autore, altri unicamente al personaggio, ma che necessita piuttosto
di essere riconosciuta all’insegna di una reciproca interrelazione di biografia e
letteratura, patologia e cultura scientifica102.
Il personaggio di Adele recita il dramma dell’impotenza, degli sforzi della volontà
che non hanno seguito, delle vane speranze che faticano a trasformarsi in
soddisfacenti realtà. In questo senso è centrale il pensiero di Alberto Moravia, di cui
Baldacci ricorda le parole in Tozzi moderno: «Tozzi è fisiologico perché sente la vita
come dolore del corpo prim’ancora che dell’anima»103. Sofferenza dunque ma anche
squilibrio; fra gli studiosi dell’isteria, Thomas Syndenham considera la malattia
appunto come l’espressione di una mancanza di equilibrio tra la mente e il corpo104.
La minaccia che Adele percepisce nella porzione di realtà all’interno della quale si
sente imprigionata è sempre un insieme di stati mentali e sensazioni corporee che
100 La citazione è tratta da Novale, p. 80. 101 Luigi Baldacci, Tozzi moderno, cit., p. 38. 102 Cfr. ivi, p. 64. 103 Ivi, p. 78. 104 Salomon Resnik, Isteria, cit., p. 1012.
39
non si accordano mai:
Adele si indugiava al sole, provando quelle debolezze repentine che
sembrano soffocanti; ma le ombre erano ancora piene di brividi freddi. Si
accarezzò tutte le braccia; poi salì di corsa in casa, a mangiare quel che
era avanzato del pranzo. […] Non può andare a letto senza assicurarsi
che la gabbia dei canarini è stata attaccata dentro il salotto; ma non vuole
che l’oda Caterina, che sonnecchia aspettando il padrone. Rientra in
camera, provando un benessere profondo che ha atteso da tanto tempo. Si
guarda a lungo nello specchio, non preoccupandosi se alcuni ricordi
smuovono il suo pudore ma trepida, senza sapere il perché, ed entra
piangendo sotto le coltri. Ma il suo pianto è delizioso e inebriante, è
come se disciogliesse una cosa amara; è uno di quei pianti che
somigliano alla voluttà. Le pare di far bene così. Poi ha il bisogno di
trarre giù le coperte e di restare con le ginocchia in alto, piegate, e con le
mani accanto ai fianchi.105
I ricordi smuovono Adele: una volta, due volte, infinite volte, perché Tozzi la
condanna a condurre un’esistenza schiava di essi, che addolorano, umiliano,
provocando una «repugnanza violenta». È vano per la protagonista il tentativo di
dimenticare, per trovare infine pace nell’oblio: la coscienza del passato, afferma
Martina Martini, interviene ad inibire ogni sforzo di fuggirne gli indesiderati effetti
che trapassano eternamente la soglia del tempo. «Sono i ricordi a proibire di far
tabula rasa del passato negativo per illudersi di ricominciare una vita migliore, quei
fantasmi imprevisti ed improvvisi che costantemente minacciano e limitano lo
slancio dell’esistenza umana»106.
Per curare gli individui affetti da isteria, scrive Salomon Resnik, l’approccio di
Freud si fonda proprio sulla memoria contro il processo di rimozione. Il paziente
isterico presenta difficoltà nel ricordare, eppure soffre di reminiscenze, come già era
stato notato da Moebius, Strumpell e Janet. Non si tratta solo di risvegliare il ricordo
del malato in questione, significa anche «dare parola» all’affettività, trasformare la
sua amnesia in storia vissuta. L’atto del «ricordare» presuppone una distinzione: la
riproduzione può essere isolata e depersonalizzata, e in questo caso si tratta di un atto
105 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 27. 106 Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. 113.
40
sans affectivité; al contrario, se ricordare appare doloroso, fatto «col cuore», il gesto
è compiuto avec affectivité107.
Il personaggio tozziano, comincia a ricordare, senza l’aiuto di un vero e proprio
analista, bensì per mano di un abile scrittore armato di studi psicologici: è così che
l’autore riporta in superficie l’affettività della protagonista. Quando Zaira, la mamma
di Adele è colta da febbri infettive, Adele si sente «come una cosa inutile e a posta»,
quasi dimenticata dai suoi affetti più cari, e inizia a ripercorrere il piacevole passato
mentre osserva gli oggetti attorno a sé:
E riprovò il sapore dei molti confetti mangiati, e rivide tutti gli abiti delle
invitate che si stringevano intorno a lei, ricordandosi di una vecchia che
emanava un odore forte di canfora e di spigo. Ritrovò, dunque, di quel
tempo un affetto intenso; di cui aveva un’acredine d’invidia. […] Allora
ella ebbe una di quelle mattinate, quando tutta la vita sembra lieve come
un sogno solitario. Anche una foglia tenue che sia rimasta in cima agli
stecchi di un albero fa piacere. I canarini mangiavano molto. Ella li
guardò e sorrise. Poi entrò in un altro salotto, non ricordandosi più di
nulla.108
Dalla denuncia di un senso di impotenza di fronte al flusso associativo dei ricordi,
al tentativo di indagare scientificamente le origini più profonde del meccanismo
mnemonico, afferma Martina Martini, lo scarto è assai breve: Federigo Tozzi, sulla
scorta della teoria psicologica di James, non si lascia intimorire dalle zone oscure e
indefinibili a cui conduce l’indagine sulla psiche umana, ma si lascia affascinare da
una dimensione in cui il meccanismo della rimozione giustifica le molteplici e
improvvise «rispondenze simboliche» che occupano il mondo dei ricordi109.
È opportuno notare, che la parola «inconscio», appare già nel 1895, nei freudiani
Studi sull’isteria. Pierre Janet, il neurologo francese direttore del laboratorio di
psicologia patologica della Salpétriere, utilizzava in quegli anni il termine
«subconscio» (sous la conscience), adottato per breve tempo anche da Freud e
107 Cfr. Salomon Resnik, Isteria, cit., p. 1018. 108 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 21. 109 Cfr. Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. 114.
41
sostituito successivamente con quello più appropriato di «inconscio» 110 .
Continuamente tormentata da paure inconsce, Adele durante la malattia della madre
è afflitta dal ricordo di un passato che non potrà più tornare, di un’infanzia perduta
per sempre:
Ma in quest’altro salotto, ecco la poltrona rossa della nonna, ed ecco la
sua fotografia incorniciata, che non ha niente a che fare con l’immagine
interiore che si produce in lei; ecco che le stoviglie fiorite che si
adoprano soltanto nei giorni solenni. Ed ella pensa: «Sono tornata
bambina mamma! Verrò a scaldarmi nel tuo letto, quantunque i miei
piedi ghiacci ti faranno andare in collera» […] Poi Adele si accorge di
questo trasporto nel passato, addolorandosi e umiliandosi. La porta della
madre è lì da vero, ma ella vi passa innanzi in punta di piedi, e si
allontana.111
Pierre Janet aveva parlato, scrive ancora Resnik, della «doppia coscienza» delle
isteriche e della loro sofferenza a livello della memoria: l’isterica soffre di
reminiscenze, è assalita dal suo passato, legata a certi fatti della sua biografia
personale che non può associare in modo adeguato. La rimozione di un fatto
importante, di una situazione traumatica, prevede l’ingresso di immagini molto varie
che si riallacciano allo stesso avvenimento; corrisponde spesso a un’amnesia a livello
di pensiero, legata a un dato evento che a sua volta nasconde un fatto coscientemente
rinnegato: è un «ricordo di copertura», secondo Freud. «Ma la cosa più curiosa
dell’isterico, per ritornare alla dissociazione, è che il corpo può esprimere,
separandosi dalla coscienza, certe situazioni nascoste ad essa»112. Le gambe di Adele
infatti, si allontanano silenziosamente dalla porta della camera della madre, perché
pur inebriandosi del ricordo di un’infanzia felice, la protagonista inconsciamente sa
di non averne vissuta una. Ha sostituito un ricordo doloroso rimosso con
un’immagine accettabile, ma non a caso si sente umiliata, addolorata. Il suo non è un
passato felice e tornare bambina non le regalerebbe mai la spensieratezza che non
trova nel presente. Sono numerose le battaglie perse contro i fantasmi del passato che
110 Cfr. Salomon Resnik, Isteria, cit., p. 1018. 111 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 22. 112 Salomon Resnik, Isteria, cit., p. 1023.
42
propone la pagina tozziana, ma l’effetto più incisivo è ottenuto come sempre quando
un delirio muta repentinamente in un’espressione patologica che ne amplifica gli
echi, come succede ad Adele:
Così passano i suoi giorni; ed ella, intanto, si fa capace di guardare quel
che avviene intorno a lei. Si ricorda di quando, bambina, pensava: «O
sole, voglio venire a trovarti!» E temeva di non riuscirvi mai, perché il
sole dubitava che ella avesse ridetto ad altrui quale sarebbe stato il suo
orgoglio giocondo. Ed ella gli prometteva sempre di stare zitta! E quando
esso era tramontato sotto, ella abbassava gli occhi e le pareva di essere
triste e inutile, così inutile come ora.113
Secondo Marchi, si tratta di un ricordo di separazione: «la pena resistente che
Adele ha di se stessa è la pena della distanza»114 dalla dimensione passata e da quella
presente, in cui la protagonista non riesce a trovare una collocazione, un qualunque
angolo di spazio reale in cui «raccapezzarsi». Tozzi ci suggerisce la soluzione
dell’enigma di Adele, o meglio ci lascia intravedere una possibilità di salvezza, che
tuttavia non concede alla protagonista: «Ci sarebbe stato da pensare ad altro, ma ella
non ne era capace»115.
Comprese allora che la sua esistenza era limitata da molte leggi invisibili,
che non si sarebbero piegate giammai. Come la pietra che è infissa nel
suo luogo, come la nuvola che si sperde, ella doveva adattarsi a quello
che le avrebbero preparato. La vita era così immensa che ella non aveva
più la voglia né il coraggio di guardarla. E tutta questa vita era
indifferente per quello che ne provava.116
Neppure l’amore riesce a destare la protagonista dalla sua follia isterica, anzi, ne
aumenta l’intensità fino a renderla inerme: quando l’amato Fabio le comunica di
dover partire per un viaggio di lavoro, Adele riesce a mantenere un certo controllo,
pur perdendosi nei meandri della malinconia romantica, ma resta comunque
113 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 30. 114 Marco Marchi, Ipotesi e documenti, cit., p. 32. 115 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 61. 116 Ivi, p. 54.
43
sconvolta dal colloquio con il giovane. «Ebbe paura che Fabio non tornasse più; le
pareva già lungo tempo di non vederlo che ella si stupì di pensare a lui come a una
persona da cui potesse attendere qualche cosa117». È ancora Resnik a fornire una
spiegazione essenziale dell’eterno ritorno in cui è immersa la protagonista:
Nell’isteria, comunque, l’Io si sottrae alla sofferenza di un Io pulsionale
condannato al dispiacere o a un piacere «troncato». La rimozione, come
nelle altre nevrosi, consiste nel respingere l’angoscia e il dolore sino al
punto di fissazione predeterminato. Ma la componente narcisistica dell’Io
non accetta lo scacco, né la frustrazione di un piacere irraggiungibile, né
la perdita del proprio prestigio nei confronti di un Io ideale. L’isterico
cerca il suo oggetto ideale, il suo ideale dell’Io, dove il suo Io ideale
possa realizzarsi. Quest’ultima nozione, che in Freud anticipa quella di
Super-io, corrisponde ad un’immagine idealizzata del padre.118
Quando la pagina tozziana si addentra nei meandri dell’anima, scrive Martina
Martini, in essa scopre che «molte delle sue determinazioni, anche quelle che
sembrano improvvise, hanno le radici nei recessi del passato».119 La sensazione di
Adele che la conduce a pensare di essere invisibile, dimenticata, come una cosa
inutile, come un oggetto che si non si percepisce nella stanza, un mobile da sempre
presente nell’arredamento che mai sia stato riconosciuto come parte integrante
dell’arredo, è un’idea costante che tormenta la sua esistenza e trascinerà la
protagonista verso il suicidio. «Secondo Janet, le “idee fisse”, nell’isteria, rivelano
una persistenza della domanda o di certe preoccupazioni psichiche o somatiche»120.
Adele si affligge ma nessuno se ne avvede: il padre, la madre, Caterina, Fabio, non
sono che scie lontane dalla bufera patologica nella quale è immersa la protagonista,
la quale non è provvista di remi per navigare nella tempesta della propria anima.
Come «l’utero errante», anche l’isterico trova difficilmente il proprio
spazio e la propria ragione d’essere nel corpo sociale. A livello nevrotico
come a livello psicotico, egli arriva a strutturare il proprio mondo isterico
117 Ivi, p. 79. 118 Salomon Resnik, Isteria, cit., p. 1026. 119 Federigo Tozzi, Paolo. Barche capovolte, cit., p. 117. 120 Salomon Resnik, Isteria, cit., p. 1026.
44
e a destrutturare e decomporre il mondo storico, il mondo della realtà.121
Fondamentale per lo studio di questa patologia diventa l’analisi della dimensione
onirica del soggetto isterico. La ricerca di Freud sull’isteria si collega a quelle
sull’inconscio e sul sogno; gli stati oniroidi dell’isteria, infatti, sono dei veri sogni
psico- e socio-drammatizzati che caratterizzano certi stati deliranti di personalità
isteriche con tendenza alla dissociazione schizoide. Non c’è da meravigliarsi dunque,
commenta Luperini, se nell’opera tozziana l’allucinazione e il sogno non sono solo
temi specifici, ma una sorta di condizione permanente. Onirismo e visionarietà sono
momenti essenziali dell’arte tozziana, la rappresentazione dell’interiorità profonda di
chi vive «con gli occhi chiusi» realizza l’effetto di un’incessante visione disturbata
del mondo.122 L’isteria notturna di Adele né è un esempio:
Poi il sonno la prende. I suoi sogni sono rapidi e pieni di emozioni. Uno è
tale che la desta. Allora di male voglia, poi che il sonno le pende sopra,
guarda il chiarore violento della luna piena. Sembra che i raggi abbiano
da dirle qualche cosa. Ma ella vorrebbe rispondere: «Dormite anche voi».
E si riaddormenta, mentre tutti i suoi sogni le fanno la stessa impressione
inspiegabile dei raggi.123
In un continuo alternarsi di sonno e veglia, per soffermarsi talvolta nell’arco di un
dormiveglia semicosciente, continua a svolgersi all’interno dell’opera di Tozzi il
jamesiano flusso dei pensieri, delle immagini e delle sensazioni, dando origine a esiti
certamente fra i più originali che la nostra letteratura primonovecentesca possa
vantare124. Tozzi si dimostra dunque analista visionario dei suoi torbidi romanzi,
individuo malato avido di cultura psicologico-scientifica, ma è prima di tutto un
uomo ha che dedicato l’intera vita alla scrittura, consapevole della propria modernità:
«In altre parole, Tozzi era capace di essere uno, nessuno, centomila; e noi dobbiamo
121 Ivi, p. 1029. 122 Romano Luperini, Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, le opere, cit., p. 36. 123 Federigo Tozzi, Adele, cit., p. 28. 124 Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. 99.
45
vedere in lui prima il grande scrittore e poi il grande malato»125.
2.4 William James e la cultura scientifica di Tozzi
Negli ultimi anni, le prospettive critiche intorno all’opera di Federigo Tozzi hanno
subito un mutamento di rotta, soprattutto grazie alla pubblicazione di vari inediti e in
particolare di Adele, che ha costituito un punto di partenza fondamentale per
un’analisi ancora più profonda della cultura tozziana. Confermata la straordinaria
modernità dell’arte di Tozzi, ad essa si aggiunge la definitiva consapevolezza che
l’autore «non procedeva rabdomaticamente, come per lungo tempo si era creduto, ma
si abbeverava a fonti scientifiche ben precise, a quelle stesse fonti e a quella stessa
cultura scientifica alla quale si era ispirato l’inventore della psicanalisi»126.
La narrativa tozziana accoglie ed elabora in un singolare sistema creativo più linee
convergenti: la tradizione degli antichi scrittori toscani, l’afflato religioso dei mistici
senesi e una moderna sensibilità psicologica, che pone l’accento sulla patologia
nevrotica, trasferita dall’autore in una prosa che procede per giustapposizioni di
sensazioni ed immagini, fino a cogliere attimo per attimo il senso profondo e oscuro
dei «misteriosi atti» che governano l’esistenza. L’opera dello scrittore senese, letta
in questa chiave, rappresenta una delle più affascinanti e fortunate anomalie che
aprono il Novecento italiano alle influenze della cultura europea ed extraeuropea127.
Così, mentre Adele sfoglia petali di rosa, l’autore sfoglia libri: gli stessi che lo
aiutano a scrutare negli abissi della propria anima, a vedersi sotto una nuova luce, a
indagarsi scientificamente e umanamente, creando personaggi dichiaratamente malati
sulla scorta delle opere di William James.
Secondo Martina Martini, la cui posizione è condivisa da Marco Marchi, è Tozzi
stesso a parlarci del suo jamesismo, ora nascondendolo nella psicologia dei suoi
personaggi, ora facendone il filo rosso del suo aforistico «libro di psicologia» o
ancora esibendone la terminologia scientifica.
125 Luigi Baldacci, Tozzi moderno, cit., p. 42. 126 Giorgio Luti, presentazione di Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. IX. 127 Ibidem.
46
E chi se non Tozzi stesso – fin dal «primo tempo» di Novale, e cioè dal
lontanissimo 1902, ha ormai trasformato la conoscenza di James in
scrittura, in una testimoniabile prassi quotidiana? «Potrei riportare a mio
comodo – comunica Tozzi alla sconosciuta Annalena, alias Emma
Palagi, nella lettera del 13 dicembre 1902 – una infinità di documenti
psicologici, che io ho la buona abitudine di fermare, ogni giorno, su la
carta quello che è passato nella mia anima».128
La produzione dello psicologo americano comprende soprattutto studi di matrice
scientifica più che veri e propri trattati di filosofia: James coltiva questa disciplina
privatamente e con gli amici del Metaphysical Club da lui fondato, nell’ambito del
quale ha origine il pragmatismo americano. Egli possiede uno spirito inquieto ed
insaziabile, costantemente alla ricerca di un «ideale di vita»: studia dapprima chimica
ad Harvard, successivamente segue corsi di anatomia e fisiologia e infine si laurea in
medicina alla Harvard Medical School, ma non eserciterà la professione.
Ancora non riusciva a cogliere la sua vocazione autentica: mentre la
filosofia gli appariva come qualcosa che avrebbe potuto incrementare
quella che lui stesso definiva la sua «malattia interiore», e cioè la
tendenza a perdersi in se stesso ed a staccarsi dal reale, d’altra parte
intuiva che c’era un modo di accostarsi anche positivamente al problema
dell’esperienza umana, al di là di ogni caduta metafisica o ipocondriaca,
attraverso gli studi di psicologia sperimentale che stavano portando
avanti i ricercatori tedeschi. Fu così che, nella primavera del 1867,
William James arrivò in Germania con l’obiettivo di studiare fisiologia
del sistema nervoso, fermandosi in particolare a Dresda, Berlino e
Heidelberg per vedere come Helmholtz e Wundt riuscissero a studiare
scientificamente gli stati di coscienza, registrandone le implicazioni con
le evoluzioni del sistema nervoso.129
Ancora una volta il dato biografico è prevalente: James stesso è stato per molto
tempo affetto da sindromi di carattere psicosomatico, crisi di ansia e istinti suicidi;
mentre il padre e i due fratelli maggiori erano per di più soggetti a disturbi nevrotici,
di cui lo psicologo durante gli anni dell’adolescenza ha avuto modo di osservare gli
128 Marco Marchi, introduzione a Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p.
XXI. 129 Ivi, p. 19.
47
effetti, scanditi dai ripetuti attacchi isterici della sorella Alice. James, dopo aver fatto
tesoro del tempo passato nelle università tedesche, in cui stava nascendo la «nuova
psicologia», decide di tornare ad Harvard, dove insegnerà fisiologia, allestendo poco
dopo un piccolo laboratorio di psicologia sperimentale e contribuendo in questo
modo a promuovere in America, l’idea che la psicologia dovesse essere prima di
tutto liberata da qualsiasi implicazione metafisica. L’autore dei Principii di
psicologia comprende ben presto che è necessario procedere verso direzioni mai
esplorate dallo sperimentalismo, al quale riconosce tuttavia i notevoli contributi alla
ricerca positiva ed il merito indiscutibile di aver liberato la psicologia dai limiti dello
spiritualismo130:
James capì allora che era necessario connettere la realtà psicologica
direttamente all’esperienza, recuperando così tutte quelle forme di
pensiero collocabili al di fuori della sfera strettamente scientifica ma
altrettanto determinanti nel contesto della storia umana. In questa
direzione la psicologia jamesiana arrivò ad occuparsi anche del pensiero
religioso, etico, poetico, sentimentale e finalistico, tutte esperienze che
avevano alla base una concezione personale del vivere, secondo
quell’ottica soggettiva da sempre invisa ai seguaci della scienza.131
Fino a quando Marco Marchi, attraverso le sue ricerche nell’archivio tozziano di
Castagneto, ha portato alla luce tutti i tasselli delle letture di Tozzi, pochi avevano
riconosciuto nel lavoro dello scrittore senese le incidenze di una ben determinata
cultura scientifica e in particolare dell’opera dello psicologo americano. In una
lettera di Novale del 13 dicembre 1902, Tozzi scrive alla fidanzata Emma: «Stasera,
per esempio, sono più disposto ad esporre un’analisi psicologica, che a cercare fiori
in immagini e fantasmi. Ciò dipende dal fatto che tutto il giorno ho letto un libro
dello psicologo americano James, ossia Gl’ideali della vita»132. Tozzi quindi appare
già, come scriverà Giuliotti, «scavare, nella tristezza della vita, a grande
130 Cfr. ivi, p. 19. 131 Ivi, p. 21. 132 Federigo Tozzi, Novale, in Opere, a cura di Glauco Tozzi, Vallecchi, Firenze 1984, VI, p. 25.
48
profondità»133. È ancora tra pagine di Novale che ritroviamo l’appassionata dedizione
con la quale lo scrittore senese si è avvicinato all’opera di William James, in
particolare nella lettera del 29 settembre 1907:
Stamani ho potuto trovare da comprare la mia psicologia a tre lire,
mensili. E ne sono contento per quanto potrò leggerla e la leggerò.
Adesso desidero tanto per precauzione come per un tuo adornamento
intellettuale, che il libro sia tagliato da te e stia nelle tue mani. Col solo
patto che sia toccato soltanto dalle tue mani, e veduto soltanto da’ tuoi
occhi.134
La presenza, nell’archivio di Castagneto, dei Principii di psicologia ha permesso a
Marco Marchi di decifrare l’interesse psicologico che Tozzi rivela in Novale; mentre
le ricerche di Loredana Anderson hanno chiarito il motivo per cui l’autore abbia
deciso di acquistare l’imponente opera di James, dopo averla presa in prestito alla
Biblioteca Comunale di Siena per ben quattro volte nell’arco di un anno e mezzo135.
Pagando a rate la sua cultura del profondo, Tozzi ha incontrato le tre grandi opere di
James: Gli ideali della vita, Le varie forme della coscienza religiosa, in cui è
rintracciabile la prospettiva psicologica jamesiana più innovativa, che condurrà il
personaggio di Adele alle sue frequenti esaltazioni mistiche, e i Principii di
psicologia.
Nel 1905 James partecipò tra l’altro al Congresso Internazionale di Psicologia,
che si svolse in Italia, e in quella occasione ebbe effettivi contatti con l’ambiente
culturale del tempo. Le parole di Giovanni Papini, che esprimono l’ammirazione con
cui i componenti del gruppo pragmatista fiorentino guardavano al proprio maestro,
sono utili a ricomporre il quadro della fortuna di William James in Italia:
Tutti quelli che cercano, tutti quelli che danno la maggior parte di sé allo
studio dell’anima, della conoscenza, della fede, hanno avuto fra le mani i
libri di William James – conclude infatti Papini – sanno che egli, dopo
avere dato il più originale libro di psicologia che abbiano gli
133 Marco Marchi, Ipotesi e documenti, cit., p. 57. 134 Ivi, p. 166. 135 Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. 13.
49
anglosassoni, è passato ai problemi più generali, si è affacciato alla
metafisica, è penetrato nel mondo misterioso delle credenze religiose, ha
restaurato […] quel vecchio metodo inglese di riflessione e di ricerca che
oggi si chiama pragmatismo.136
Tozzi non è un pragmatista. Tuttavia è uno scrittore avido di cultura psicologica,
di quei mondi recentemente esplorati dai più importanti indagatori dell’inconscio. Lo
scrittore senese era perfettamente consapevole della portata innovativa dell’opera di
James. Lo psicologo americano, ponendo l’accento sul «flusso di coscienza», aveva
individuato alla perfezione il fulcro della speculazione psicologica, meglio di quanto
non avessero fatto i suoi seguaci e ammiratori italiani, e si soffermava su argomenti
che trascendevano la concezione pragmatista in senso stretto, per offrire nuovi e
stimolanti spunti di riflessione su termini come «inibizione», «sforzo di volontà»,
«stati di eccitamento morboso», finendo per invadere un terreno dal fascino
inesauribile come quello della conversione religiosa e della «fede psicologicamente
motivata»137. Si tratta di concetti che appassionano il giovane Tozzi, il quale, a
seguito delle letture jamesiane, inibirà la volontà di Adele e quella di molti altri
personaggi successivi, la renderà impotente di fronte ai loro stati di esaltazione
mistica, ossessionata dall’idea di non appartenere al qui ed ora.
James non esitava a segnalare nei suoi lavori la sostanziale novità degli studi di
Pierre Janet relativi a casi di isteria, psicastenia e sdoppiamento di coscienza. In
questo fortunata triangolazione Tozzi-James-Janet ritroviamo le linee deliranti del
personaggio di Adele e dello psicastenico Fabio:
Quando Tozzi scriverà Adele, didatticamente, con un a capo un po’
goffo, ci terrà a caratterizzare la infrangibile soggezione di Fabio alla
volontà del padre e la sua protratta dipendenza, sentenziando con un
linguaggio tecnico da manuale che «Tale indolenza dolorosa è un
fenomeno di psicastenia», così come Adele, prima, ha percepito da
povera malata coincidenze di situazione «per il fenomeno della
paramnesia».138
136 Cfr. ivi, p. 31 (la citazione è tratta da Giovanni Papini, prefazione a William James, Saggi
pragmatisti, Carabba, Lanciano 1910, p.7). 137 Cfr. Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. 35. 138 Marco Marchi, Ipotesi e documenti, cit., p. 59.
50
Una volta dimostrato come il pensiero di James abbia influenzato apertamente e in
modo non trascurabile l’opera di Federigo Tozzi, il binomio Tozzi-James può offrire
ancora numerosi spunti per indagare sulla cultura scientifica dell’autore. Sono
numerosi gli stimoli culturali che hanno permesso allo scrittore senese di ampliare la
propria cultura psicologica e di trasferirla conseguentemente tra le pagine dei suoi
romanzi139. L’aspetto più interessante di questa mediazione culturale transoceanica si
rivela in un singolare gioco di richiami e rinvii filosofici e letterari gestiti dall’autore
con estrema competenza:
Mentre dunque i Principii di psicologia, l’opera jamesiana più tecnica e
specialistica, divennero il facile veicolo dei nomi più rappresentativi
della cultura scientifico-psicologica del tempo, da Janet a Freud, in opere
come Gli ideali della vita e Le varie forme della coscienza religiosa, nate
dalla raccolta di conferenze rivolte ad un pubblico di giovani allievi, i
nomi di Tolstoj, Whitman, Sant’Agostino, D’Annunzio, costituivano quel
coinvolgente sostrato letterario che doveva facilitare all’inesperto
uditorio l’approccio con la materia psicologica.140
Non si può affermare con assoluta certezza che Tozzi abbia letto Tolstoj,
Whitman, Sant’Agostino e D’Annunzio grazie alle pagine di James, ma non si può
ignorare che il pragmatista americano fornì al giovane Tozzi una chiave
interpretativa di alcuni autori e delle loro opere, e più precisamente l’analisi
psicologica del loro pensiero. In questa prospettiva la categoria di cultura in base alla
quale la critica contemporanea propone il moderno ritratto di Federigo Tozzi
acquisisce un valore ancor più significativo nell’accezione di cultura consapevole e
attiva, capace di unire la tradizione letteraria europea con le più aggiornate intuizioni
della psichiatria, le pagine antiche dei mistici senesi con le complesse teorie della
nuova scienza psicologica.
Le letture di Tozzi sono straordinariamente varie: da Ribot a Freud, da Janet a
Emerson, passando appunto per Whitman, Tolstoj, Caterina da Siena, Bergson,
139 Cfr. Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, p. 245. 140 Ivi, p. 246.
51
Pirandello, D’Annunzio, Leopardi, Nietzsche, Dante141. Théodule Ribot, professore
alla Sorbona e titolare della cattedra di psicologia sperimentale al Collège de France,
nonché direttore della rivista «Revue philosophique», è un nome che compare più
volte all’interno dei Principii di psicologia di James. Ribot aveva appunto indagato
sui più importanti meccanismi psicologici e sulla loro patologia:
Qui le nozioni di degenerazione e di ereditarietà tirate in ballo ad ogni
occasione come argomenti onnipotenti per la spiegazione delle
manifestazioni patologiche più disparate subiscono ulteriori contraccolpi.
[…] Tuttavia per Ribot alcune fobie si spiegano tramite la memoria
affettiva, che opera per associazione, di avvenimenti della vita passata, e
persino con un fatto dell’infanzia «di cui non si è serbato il ricordo».142
Nei capitoli dedicati alla coscienza dell’io e alla memoria, James cita lo psicologo
francese, richiamandosi al suo pensiero e illuminandone alcuni tra gli aspetti più
moderni: i concetti di sub-personalità incosciente, la dinamica della memoria
affettiva e il residuo emotivo latente. Tra le opere citate da James nei Principii e
nelle Varie forme della coscienza religiosa, troviamo Les maladies de la mémorie,
Les maladies de la personalité e la Psychologie des sentiments, tutte presenti
nell’interno dell’archivio tozziano di Castagneto.
Sulle stesse pagine jamesiane, Tozzi incontra il neurologo Pierre Janet, direttore
del laboratorio di psicologia patologica della Salpêtriere e titolare dal 1902 della
cattedra di psicologia sperimentale appartenuta in precedenza a Ribot. Dobbiamo agli
studi janettiani sull’automatismo psicologico e sulla nevrosi la collocazione di
fenomeni come l’isteria e la schizofrenia nella sfera delle patologie mentali e non più
in quella dell’ereditarietà biologica. I casi curati da Janet servono a James come
pratico riscontro delle sue considerazioni teoriche: egli citerà pagine intere
dell’Automatisme psychologique, opera janettiana del 1889, all’interno dei Principii.
Nel novembre del 1911 è Tozzi a citare Pierre Janet, in una cartolina
141 Cfr. ibidem. 142 Marco Marchi, Ipotesi e documenti, cit., p. 63.
52
indirizzata a Giuliotti in cui incarica l’amico di una ricerca bibliografica
che gli sta a cuore: «Quando capiterai a Firenze, bada se il Gonnelli ti sa
dire chi è l’editore di questo libro Janet – Le mentalità isteriche, ma
forse, c’è soltanto l’edizione francese; che sarebbe migliore»: L’état
mental des hystériques, appunto; e l’isteria è da tempo argomento per
romanzieri […] La vita delle isteriche ha tutti gli attributi del romanzo
anche per Janet […] che Tozzi ha cominciato a conoscere con ampiezza
tra le pagine dei jamesiani Principii di psicologia.143
In Adele le tracce di Janet sono molto evidenti: la protagonista è un’isterica;
Fabio, l’uomo che Adele non è riuscita ad amare, è uno psicastenico. Così Tozzi,
dopo aver letto le pubblicazioni del neurologo francese, ha introdotto nei frammenti
di questo romanzo i termini scientifici della sintomatologia nevrotica, che si
accostano alla definizione jamesiana del personaggio di Adele come «morbid
minded»144.
Il ritrovamento, nella biblioteca tozziana, di alcune pagine firmata da Freud in un
volume dal titolo emblematico Vita sessuale e malattie nervose, del 1911, abbina
inoltre il nome di Tozzi a quello del fondatore della psicanalisi, soprattutto per
quanto riguarda lo studio dei sintomi isterici e nevrastenici come fenomeni derivanti
da un conflitto tra la coscienza del malato e le sue tendenze istintive o complessi di
idee e di ricordi dotati di una forte tonalità affettiva145. Tra le letture di Federigo
Tozzi, nel 1905, troviamo anche Il carattere e la vita di Emerson: anche in questo
caso, l’ipotesi è quella di una mediazione culturale dell’opera jamesiana, dal
momento che il nome del filosofo, poeta e saggista statunitense compare in tutte e tre
le opere di James consultate dallo scrittore senese. Emerson, dipinto nell’opera di
James come grande indagatore dell’inconscio, ha sicuramente attirato la curiosità
dello scrittore dei «misteriosi atti nostri». Tuttavia Tozzi, ancora una volta, rifiuterà
l’ottimismo di Emerson, condiviso invece da James, il quale negli Ideali della vita
cita le parole del poeta:
143 Ibidem. 144 Cfr. Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., pp. 247-250. 145 Cfr. Marco Marchi, Ipotesi e documenti, cit., p. 67.
53
«Traversando un luogo comunissimo – sono parole di Emerson – con i
pattini da neve al crepuscolo, sotto un cielo di piombo, senza avere nei
miei pensieri alcuna causa speciale di essere allegro, mi sono dato ad un
pazzo riso. Sono lieto del mio cantuccio intorno al fuoco». La vita merita
sempre di essere vissuta, solo che si abbiano le sensibilità
corrispondenti.146
Per Tozzi, invece, le dolci sensazioni rappresentate dalle immagini floreali non
riescono a perdurare, se non nella fugace e disperata difesa di una consapevole
illusione: «Perché vuoi dirmi che la primavera non è venuta? Io vedo dovunque i
fiori. Che m’importa se tu mi dici che non ci sono? Vedi io li colgo anche per te»147.
Martina Martini fa però notare che nell’interpretazione jamesiana dell’ottimismo di
Emerson è presente un’evidente connotazione patologica, una moderna chiave di
lettura a sfondo psicopatologico che Tozzi aveva subito captato «e che anzi sarebbe
diventata per lo scrittore senese il prezioso éscamotage per accogliere una visione del
mondo e della vita altrimenti troppo ottimistica per poter trovare una qualsiasi forma
di conciliazione con la disperazione del suo universo “bestiale”»148.
L’invito dunque è a leggere Tozzi attraverso James ma non a vedere James,
sempre e solo James, nell’opera di Tozzi. L’autore dei «misteriosi atti nostri» ha
voluto che ogni lettura influenzasse la sua anima come un fiore da cogliere per
impreziosire il proprio giardino; ha coltivato le sue ossessioni, si è preso cura dei
suoi traumi, nella consapevolezza di potersi definire attraverso qualunque dettaglio
del suo percorso di vita. Tozzi stesso ha confidato ad Emma in una lettera del 14
marzo 1908: «Tutto è stato per me un passare tra la vita per giungere a completare la
mia anima»149.
146 Cfr. Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit. p. 254 (la citazione è tratta da
William James, Gli ideali della vita, traduzione dall’inglese del dottor Giulio Cesare Ferrari, Bocca,
Torino 1906, p.59). 147 Federigo Tozzi, Paolo. Barche capovolte, cit., p. 83. 148 Cfr. Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, cit., p. 255. 149 Federigo Tozzi, Novale, cit., p. 225.
54
Bibliografia
Opere di Federigo Tozzi citate nella tesi
Adele. Frammenti di un romanzo, a cura di Glauco Tozzi, Vallecchi, Firenze 1979.
Cose e persone. Inediti e altre prose, Vallecchi, Firenze 1981.
Opere, Romanzi, Prose, Novelle, Saggi, a cura di Marco Marchi, Mondadori, Milano
1987.
Paolo. Adele, Vallecchi, Firenze 1995.
Ricordi di un giovane impiegato, Cadmo, Perugia 1999.
Paolo. Barche capovolte, Empiria, Roma 2007.
Bestie, Manni, Lecce 2009.
Con gli occhi chiusi, Mondadori, Milano 2012.
Bibliografia critica
Salomon Resnik, Isteria, in Enciclopedia, Einaudi, Torino 1979, vol. VII, pp. 1009-
1031.
Luigi Baldacci, Tozzi moderno, Einaudi, Torino 1993.
Marco Marchi, Ipotesi e documenti, Marietti, Genova 1993.
Romano Luperini, Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, le opere, Laterza, Roma
1995.
Martina Martini, Tozzi e James. Letteratura e psicologia, Olschki, Firenze 1999.
Laura Nay, Fantasmi del corpo fantasmi della mente, Edizioni dell’Orso,
Alessandria 1999.
Christopher Bollas, Isteria, Cortina, Milano 2001.
Riccardo Castellana, Il punto su Tozzi: 1990-2000, in «Moderna», a. III, n. 1, 2001,
pp. 97-115.
Delia Garofano, Tozzi aforista, in «Moderna», a. IV, n. 2, 2002, pp. 187-206.
Massimo Lippi, Federigo Tozzi. La nostalgia del vero, ivi, pp. 249-260.
55
Marco Marchi, Leggere ed esistere. Ancora sulla cultura di Tozzi, ivi, pp. 129-143.
Francesca Sanvitale, Federigo Tozzi. La rivolta psichica del personaggio e altre
divagazioni, ivi, pp. 239-243.
Sigmund Freud, Studi sull’isteria, in Opere, vol. 1, Studi sull’isteria e altri scritti
(1886-1895), Bollati Boringhieri, Torino 2003.
Anna Panicali, Del secolo “nevrosico”, in «Critica letteraria», a. XXXIII, fasc. I, n.
126, 2005, pp. 89-107.