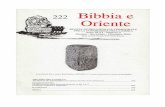Indice - Dipartimento di Studi linguistici e culturali
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Indice - Dipartimento di Studi linguistici e culturali
IndiceL’Ateneo e la Facoltà di Lettere e Filosofia ........................................................... 9
Lettere e Filosofia a Modena: contenuti e percorsi innovativi per lo studio di
Lingue e Cultura ..................................................................................................... 9
Offerta formativa .................................................................................................. 10
Indirizzi utili e date da ricordare ........................................................................... 10
Per le immatricolazioni ......................................................................................... 11
Selezione dei candidati ........................................................................................ 12
Servizi per gli studenti .......................................................................................... 12
Mobilità internazionale ......................................................................................... 13
Tirocinio ............................................................................................................... 13
Corso di lingua e cultura italiana per studenti stranieri ......................................... 13
Organizzazione didattica ...................................................................................... 14
Regolamentazione della frequenza ...................................................................... 14
Calendario Lezioni a.a. 2007/08 .......................................................................... 15
Sessioni di laurea a.a. 2006/07 ............................................................................ 15
Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura ..................................... 16
La Biblioteca Umanistica ..................................................................................... 17 Risorse disponibili (a luglio 2007) ........................................................................ 17
Servizi offerti ....................................................................................................... 17
Servizi online ........................................................................................................ 17
Apertura ............................................................................................................... 17
Personale addetto ................................................................................................ 17
Lingue e Culture Europee ................................................................................... 18 Gli obiettivi ........................................................................................................... 18
Articolazione del corso ......................................................................................... 18
Prova finale .......................................................................................................... 19
Passaggio da un corso di laurea ad un altro ........................................................ 20
Sbocchi professionali .......................................................................................... 20
Propedeuticità ...................................................................................................... 20
Scienze della Cultura .......................................................................................... 21
1
Gli obiettivi ........................................................................................................... 21
Articolazione del corso ......................................................................................... 21
Prova finale .......................................................................................................... 22
Attività strutturate ................................................................................................. 22
Passaggio da un corso di laurea ad un altro ........................................................ 22
Gli sbocchi professionali ...................................................................................... 23
Propedeuticità ...................................................................................................... 23
Lauree magistrali ................................................................................................. 24 Laurea Magistrale in Analisi dei Conflitti, delle Ideologie e della Politica nel Mondo
Contemporaneo .................................................................................................. 24
Laurea magistrale in Comunicazione nell’impresa e nelle organizzazioni
internazionali ........................................................................................................ 25
Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione di Attività Culturali ...................... 25
Laurea Magistrale in Teoria e metodologia della ricerca antropologica sulla
contemporaneità ................................................................................................. 26
Notizie generali sull’Ateneo ................................................................................. 28 Gli organi dell’Ateneo ........................................................................................... 28
Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario ...................................... 29
Ufficio orientamento allo studio universitario ........................................................ 30
Programmi annuali a.a. 2007-2008 ..................................................................... 31
Lingue e Culture Europee – I anno ..................................................................... 31 Antropologia Culturale .......................................................................................... 31
Informatica per le scienze umane - Modulo A+B .................................................. 31
Laboratorio di lingua italiana e abilità di studio ..................................................... 33
Letteratura italiana contemporanea ...................................................................... 35
Lingua Francese .................................................................................................. 36
Lingua Inglese A-L ............................................................................................... 37
Lingua Inglese M-Z .............................................................................................. 39
Lingua spagnola ................................................................................................... 40
Lingua tedesca ..................................................................................................... 41
Linguistica generale e applicata ........................................................................... 43
Linguistica Italiana ................................................................................................ 44
Sistemi sociali e culture della comunicazione ...................................................... 46
2
Storia dell’Europa contemporanea A-L ................................................................ 48
Storia dell’Europa contemporanea M-Z ................................................................ 48
Lingue e Culture Europee – II anno .................................................................... 50 Diritto dell’Unione Europea .................................................................................. 50
Informatica per le scienze umane - Modulo C ...................................................... 50
Istituzioni di Economia ed Economia dell’integrazione europea (M-Z) ................. 51
Istituzioni di Economia ed Economia dell’integrazione europea (A-L) .................. 51
Seminario di Lingua Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Inglese .................. 52
Lingua, cultura ed istituzioni dei paesi di lingua inglese ...................................... 53
Lingua, cultura ed istituzioni dei paesi di lingua spagnola ................................... 54
Lingua, cultura ed istituzioni dei paesi di lingua tedesca ...................................... 55
Lingua, Cultura e Istituzioni dei paesi di lingua francese ...................................... 56
Seminario di Culture nazionali e relazioni economiche tra paesi ........................ 57
Seminario di Letteratura inglese .......................................................................... 58
Seminario di Letteratura inglese .......................................................................... 59
Seminario di Lingua, Cultura e Istituzioni dei paesi di lingua spagnola ............... 60
Seminario di storia economica A .......................................................................... 61
Seminario di storia economica B .......................................................................... 61
Seminario di traduzione lingua inglese ................................................................. 61
Seminario di traduzione lingua inglese ................................................................ 63
Seminario di letteratura tedesca .......................................................................... 63
Seminario linguistica francese B .......................................................................... 64
Sistemi giuridici comparati ................................................................................... 65
Terza Lingua Tedesco ........................................................................................ 66
Terza Lingua Francese ........................................................................................ 67
Terza lingua spagnolo .......................................................................................... 68
Traduzione Lingua Francese .............................................................................. 68
Traduzione lingua spagnola ................................................................................. 69
Traduzione lingua tedesca .................................................................................. 70
Seminario sulle teorie della traduzione ............................................................... 72
Lingue e Culture Europee – III anno ................................................................... 73 Diritto commerciale comunitario ........................................................................... 73
Etnologia .............................................................................................................. 74
3
Linguistica francese ............................................................................................. 76
Linguistica inglese ................................................................................................ 77
Linguistica spagnola ............................................................................................. 80
Linguistica Tedesca ............................................................................................. 80
Marketing internazionale ...................................................................................... 81
Mediazione scritta e orale francese - italiano ....................................................... 82
Mediazione scritta e orale inglese-italiano ........................................................... 84
Mediazione scritta e orale tedesco-italiano .......................................................... 85
Mediazione scritta e orale spagnolo-italiano ........................................................ 86
Seminario di Linguistica Inglese ........................................................................... 86
Seminario di Linguistica Inglese ........................................................................... 88
Seminario di Linguistica Inglese ........................................................................... 89
Seminario di Linguistica Inglese ........................................................................... 90
Seminario di Linguistica Inglese ........................................................................... 91
Seminario di Linguistica Francese ....................................................................... 93
Seminario linguistica spagnola ............................................................................. 94
Seminario linguistica spagnola ............................................................................ 94
Seminario di linguistica tedesca ........................................................................... 94
Semiotica della comunicazione ............................................................................ 95
Sociologia dei processi culturali ........................................................................... 96
Scienze della Cultura – I anno ............................................................................ 97 Antropologia Culturale .......................................................................................... 97
Informatica per le Scienze Umane ....................................................................... 98
Letteratura italiana ............................................................................................. 100
Lingua Francese ................................................................................................ 102
Lingua Inglese .................................................................................................... 102
Lingua Spagnola ................................................................................................ 103
Sistemi sociali e culture della comunicazione .................................................... 105
Storia Moderna .................................................................................................. 106
Scienze della Cultura – II anno ......................................................................... 109 Etnologia ............................................................................................................ 109
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese ....................................... 112
Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Francese ................................. 113
4
Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Spagnola ................................. 113
Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Tedesca .................................. 114
Sociologia dei Processi Culturali ........................................................................ 114
Storia Contemporanea ....................................................................................... 115
Seminario A ....................................................................................................... 117
Seminario B ....................................................................................................... 118
Storia della filosofia (6 crediti) ............................................................................ 120
Storia della filosofia (10 crediti) .......................................................................... 120
Storia delle religioni ............................................................................................ 121
Scienze della Cultura – III anno ........................................................................ 123 Antropologia Sociale .......................................................................................... 123
Culture dei paesi islamici ................................................................................... 124
Filosofia del linguaggio ....................................................................................... 125
Fondamenti di linguistica e sociolinguistica ........................................................ 127
Geografia culturale ............................................................................................. 128
Laboratorio filosofico interdisciplinare ................................................................ 129
Modulo di cultura spagnola ................................................................................ 130
Lingua araba ...................................................................................................... 131
Lingua Spagnola e Culture Ispanofone .............................................................. 132
Lingua tedesca e culture germaniche ................................................................ 134
Storia dell’Europa ............................................................................................... 134
Storia dell’Islâm .................................................................................................. 136
Teoria e metodi del dialogo e della mediazione ................................................. 137
Laurea magistrale in Analisi dei Conflitti, delle Ideologie e della Politica del
Mondo Contemporaneo .................................................................................... 139 Culture dei paesi islamici contemporanei ........................................................... 139
Demografia ........................................................................................................ 139
Metodologia della ricerca storica ........................................................................ 141
Religioni e conflitti .............................................................................................. 142
Scienza, tecnologia e ambiente ......................................................................... 143
Storia dei conflitti politico religiosi nell’Europa moderna ..................................... 144
Storia delle dottrine politiche .............................................................................. 145
Storia dei paesi europei e delle relazioni internazionali ...................................... 146
5
Storia della scienza e della tecnica in età moderna e contemporanea ............... 147
Storia sociale del mondo contemporaneo .......................................................... 148
Teorie della pace e della guerra ......................................................................... 150
Laurea magistrale in Comunicazione nell'Impresa e nelle Organizzazione
Internazionali ..................................................................................................... 152 Comunicazione d’azienda .................................................................................. 152
Comunicazione interculturale e Varietà della lingua – Lingua tedesca ............... 153
Comunicazione interculturale e Varietà della lingua – Lingua spagnola ............. 154
Comunicazione interculturale e Varietà della lingua – Lingua francese ............. 155
Comunicazione interculturale e Varietà della lingua – Lingua inglese ................ 157
Comunicazione professionale scritta in italiano ................................................. 159
Comunicazione Web per le Organizzazioni (CWO) ........................................... 162
Corso di formazione per gli utenti della Biblioteca Umanistica ........................... 163
Diritto delle organizzazioni internazionali ........................................................... 165
Diritto privato comparato – Diritto ed economia delle organizzazioni private ..... 165
Economia applicata e Processi di Internazionalizzazione delle Imprese ............ 167
Geografia economico-politica e del Turismo ...................................................... 168
Mediazione e Trattativa – Lingua francese ......................................................... 170
Mediazione e Trattativa – Lingua inglese ........................................................... 172
Mediazione e Trattativa – Lingua spagnola ........................................................ 174
Mediazione e trattativa - Lingua tedesca ............................................................ 175
Organizzazione delle Aziende e delle Amministrazioni ...................................... 176
Teoria e metodi del dialogo e della mediazione ................................................. 177
Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione di Attività Culturali .................. 180 Analisi dei generi comunicativi – Lingua francese .............................................. 180
Analisi di tipi e generi comunicativi – Lingua inglese .......................................... 181
Analisi di tipi e generi comunicativi – Italiano ..................................................... 183
Analisi dei generi e tipi testuali e Modulo di comunicazione interculturale – Lingua
Spagnola ............................................................................................................ 185
Analisi dei generi comunicativi - lingua tedesca ................................................. 185
Comunicazione Interculturale – Lingua francese ............................................... 186
Comunicazione interculturale – Lingua inglese .................................................. 187
Comunicazione interculturale - lingua tedesca ................................................... 188
6
Diritto delle Istituzioni culturali ............................................................................ 189
Economia della cultura ....................................................................................... 190
Geografia del turismo ......................................................................................... 191
Laboratorio/Modulo di scrittura in italiano ........................................................... 192
Laboratorio di Progettazione Web e Multimediale (LPW) ................................... 193
Laboratorio di strumenti e metodologia di analisi dei mercati culturali ............... 194
Letteratura francese ........................................................................................... 195
Letteratura Inglese ............................................................................................. 196
Letteratura spagnola .......................................................................................... 197
Letteratura tedesca ............................................................................................ 198
Mediazione e trattativa – Francese .................................................................... 199
Mediazione e Trattativa - Inglese ....................................................................... 201
Mediazione e trattativa – Spagnolo .................................................................... 203
Mediazione e trattativa - Tedesco ...................................................................... 204
Testi di riferimento .............................................................................................. 205
Seminario di museologia .................................................................................... 206
Seminario orientativo di Storia dell’arte .............................................................. 207
Sistemi di Elaborazione dell’Informazione (SEI) ................................................ 208
Tecnologie di Internet ed Editoria multimediale (TIEM) ...................................... 209
Teoria e Metodi della Progettazione Culturale ................................................... 211
Laurea Magistrale in Teoria e Metodologia della Ricerca Antropologica sulla
Contemporaneità ............................................................................................... 213 Antropologia delle religioni ................................................................................. 213
Antropologia Economica .................................................................................... 213
Antropologia Politica .......................................................................................... 214
Antropologia delle società complesse ................................................................ 217
Culture dei Paesi islamici contemporanei .......................................................... 217
Demografia ........................................................................................................ 218
Etnografia ........................................................................................................... 219
Etnolinguistica .................................................................................................... 221
Etnologia delle culture mediterranee ................................................................. 222
Filosofia morale .................................................................................................. 222
Sociologia dei conflitti interculturali .................................................................... 223
7
Sociologia delle relazioni interculturali ............................................................... 225
Modalità d’esame ............................................................................................... 226
Storia delle dottrine politiche .............................................................................. 227
Storia della filosofia (Teorie della pace e della guerra) ...................................... 229
Storia delle teorie antropologiche ....................................................................... 230
Teoria e metodi del dialogo e della mediazione ................................................. 231
8
L’Ateneo e la Facoltà di Lettere e FilosofiaLettere e Filosofia a Modena: contenuti e percorsi innovativi per lo studio di Lingue e Cultura La sede della Facoltà di Lettere e Filosofia si trova nel comparto di Sant’Eufemia, che fu assegnato all'università a seguito dell’unifi-cazione d’Italia, dopo essere stato in uso come Caserma ed Economato militare del Ducato Estense.
La Facoltà di Lettere e Filosofia è nata nel 1999 sulla base di un progetto innovativo e interdisciplinare e risponde all’esigenza di creare nuove figure professionali, più ade-guate ad una società in rapida e continua trasformazione che tende a divenire multilin-gue e multiculturale. I corsi offerti coniugano dinamicamente e proficuamente lo studio e l’approfondimento di alcune delle grandi lin-gue di cultura, europee ed extraeuropee, con le tematiche socio-politiche ed economi-co giuridiche oggi più urgenti e rilevanti, per raggiungere una comprensione allargata ma anche operativa delle società contempora-nee.
Gli obiettivi formativi dei due corsi di lau-rea che fanno capo alla Facoltà di Lettere e Filosofia corrispondono al raggiungimento di professionalità oggi richieste dai settori della comunicazione internazionale e della media-zione interculturale.
Gli sbocchi professionali previsti per i lau-reati riguardano, tra gli altri, i servizi e le isti-tuzioni culturali così come l’editoria, le im-prese e le attività commerciali e turistiche, l’intermediazione tra culture europee ed ex-traeuropee, la formazione di operatori che collaborano a progetti di sviluppo in contesti multietnici e multiculturali.A partire dall’anno accademico 2001/2002 i corsi di laurea sono organizzati, in ottempe-ranza alle direttive comunitarie, in un primo triennio finalizzato al conseguimento del di-ploma di laurea e in un secondo biennio di
approfondimento al termine del quale si con-segue una laurea ‘magistrale’. Per quanto ri-guarda il primo triennio (Lauree di base), la Facoltà fornisce il titolo di studio sia per la classe delle lauree in Scienze della Media-zione Linguistica, sia per la classe delle lau-ree in Lingue e Culture Moderne e offre quindi la possibilità di differenziare e caratte-rizzare le esigenze formative individuali se-condo due diversi percorsi di base a scelta dello studente:● Corso di Laurea in Lingue e Culture Eu-
ropee.● Corso di Laurea in Scienze della Cultu-
ra.
Dopo i primi tre anni è possibile consegui-re una Laurea Magistrale in:
● Progettazione e Gestione di Attività Cul-turali.
● Comunicazione nell’Impresa e nelle Or-ganizzazioni Internazionali.
● Teoria e Metodologia della Ricerca An-tropologica sulla Contemporaneità.
● Analisi dei Conflitti, delle Ideologie e della Politica nel Mondo Contempora-neo.
9
Offerta formativa Tutti i corsi di laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia sono caratterizzati da una didattica innovativa e multidisciplinare. Oltre alle lezioni frontali svolte in aule attrezzate con moderni sussidi sono previste forme di-verse di interazione fra docenti e studenti, che hanno come fine quello di promuovere il processo di apprendimento, stimolando l’as-sunzione di responsabilità da parte dei discenti:● contatto continuo con collaboratori ed
esperti di madre lingua: grazie a classi formate da gruppi ristretti di studenti, che assicurano una più completa pre-parazione linguistica. I collaboratori di madre lingua accompagnano gli stu-denti nel loro percorso di apprendi-mento per tutte le lingue insegnate;
● laboratori e seminari interattivi: per fa-vorire la massima partecipazione degli studenti al dialogo formativo;
● conferenze e seminari: di scienziati, docenti ed esperti stranieri e italiani anche in collaborazione con prestigiosi Enti culturali;
● attività di auto-apprendimento linguisti-co assistito: condotte individualmente oppure in gruppo con la supervisione di un tutor linguistico, che fornisce ai discenti indicazioni finalizzate a miglio-rare la conoscenza delle proprie abilità e dei propri fabbisogni linguistici;
● sessioni di approfondimento: in spazi attrezzati con le più avanzate tecnolo-gie, dove possibile accedere diretta-mente a materiali multimediali disponi-bili on- e off-line;
● lezioni per via telematica con esperti e docenti di altre università;
● apertura verso le realtà che ci circon-dano: grazie alla connessione in rete e alla possibilità di disporre di una casel-la di posta elettronica, si favorisce non solo lo scambio di messaggi ma anche lo spunto per l’analisi e lo studio di for-me di comunicazione diverse da quelle tradizionali;
● certificazioni linguistiche: per il ricono-scimento a livello internazionale delle competenze linguistiche acquisite nelle varie lingue;
● internazionalizzazione delle proprie esperienze: grazie ai rapporti con Or-
ganizzazioni ed Associazioni che ope-rano in campo internazionale e trans-nazionale e agli scambi con Università straniere è possibile trascorrere periodi di studio all’estero;
● contatti sistematici con il mondo del la-voro: stage e tirocini, guidati da tutor scientifici ed organizzativi, presso aziende e istituzioni che operano in ambito nazionale ed internazionale; orientamento sistematico al lavoro grazie ad un ufficio apposito presso la Facoltà; opportunità di training sul campo;
● corsi di preparazione per il conseguimento della patente europea per computer (ECDL).
Il Corso di Laurea in Lingue e Culture Europee e il Corso di Laurea in Scienze della Cultura hanno una durata triennale e prevedono l’acquisizione di 180 crediti da parte degli studenti, pari complessivamente a 4.500 ore di attività, tra didattica in aula e studio individuale. In particolare, valgono le seguenti regole generali:● per ciascun insegnamento, per il
laboratorio di informatica e per il laboratorio i strumenti e abilità i studio, un credito (CFU) equivale a 10 ore di didattica e 15 ore di attività di studio individuale;
● per le cosiddette “attività strutturate” (seminari ed altre attività con tutor), un credito equivale a 5 ore di didattica e 20 ore di attività di studio individuale;
● i crediti assegnati agli insegnamenti delle lingue prevedono 100 ore di esercitazione pratica con esperti di madrelingua, 60 ore di didattica forma-le/teorica e 90 ore di attività di studio individuale;
la valutazione dell’apprendimento prevede lo svolgimento di prove scritte e/o orali in itine-re e/o alla fine del corso.
Indirizzi utili e date da ricordareSegreteria Studenti – via Università, 4 – te-lefono 059/2056404 - fax. 059/2056422 e-mail: s [email protected]
La Segreteria Studenti riceve nelle se-guenti giornate: LUNEDÌ e MERCOLEDÌ ore 15.00-17.00; MARTEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ ore 11.00–13.30.
Consulenza telefonica da LUNEDÌ a VENERDÌ ore 9.30-11.00.
10
● Iscrizioni ad anni superiori al primo: entro il 28 settembre 2007.
● Iscrizioni in ritardo ad anni superiori al primo per gravi e giustificati motivi: non oltre il 31 dicembre 2007 (previo paga-mento di Euro 51,65 di mora).
● Iscrizioni fuori corso (pagamento I rata) entro il 31 dicembre 2007 (senza addebito di mora).
● Iscrizione come “ripetente”: entro il 28 settembre 2007.
● Trasferimenti da altre Facoltà o Uni-versità: - a Cdl ad accesso libero (triennale o magistrale 19 ottobre 2007) – ad accesso programmato secondo i bandi.
● Pagamento 1a rata tasse: all’atto dell’i-scrizione.
● Pagamento 2a rata tasse (anche per i fuori corso): entro il 30 aprile 2008.
● Presentazione piano di studi individua-le: sino al 31 dicembre 2007 (in marca da bollo da euro 14,62).
Attenzione: il ritardato pagamento dei ratei di tasse e contributi comporta il pagamento di una sovrattassa.
Per le immatricolazioniUfficio Immatricolazioni:Via Università, 4 - Tel. 059/2056416 – fax. 059/2056422 Lunedì, mercoledì .9.00 –13.30 e 15.00-17.00 Martedì, giovedì, vener-dì 9.00-13.30 e-mail: [email protected]
Per informazioni è attivo il Call Center im-matricolazioni al numero verde 800 42 52 00, servizio gratuito con operatore, che fun-ziona dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00.Sono previsti 200 posti per il Corso di Lau-rea In Lingue e Culture Europee. I posti disponibili nel Corso di Laurea in Scienze della Cultura sono assegnati in ordine di iscrizione. L’accesso al Corso di Laurea in Lingue e Culture Europee è, invece, subordinato all’esito di una prova di ammis-sione. Tutte le informazioni relative alla pro-va di ammissione e all’accesso programma-to ai due corsi di laurea sono stabilite di anno in anno dal bando di ammissione che viene pubblicato nel mese di giugno e reso disponibile sul sito della Facoltà: http://www.lettere.unimore.it.
Si ricorda inoltre che è possibile pre-im-matricolarsi ai corsi di laurea ad accesso
programmato della Facoltà di Lettere e Filo-sofia seguendo tutte le indicazioni riportate sulla pagina web dell'Università a: http://www.casa.unimore.it, alla voce: ‘Offerta Formativa – Immatricolazioni e Iscrizioni’, oppure attraverso le torrette dislocate in vari punti della città:● Segreterie Studenti, via Universalità, 4● Segreterie Studenti - Campus
Universitario,via Campi, 213/b (Dipartimento di Matematica).
● Ufficio Orientamento allo Studio Universitario, Via Campi, 309.
● Facoltà di Economia, viale Berengario, 51.
● Policlinico, c/o Portineria Universitaria, Largo del Pozzo, 71.
Per effettuare l’operazione è necessario conoscere il proprio codice fiscale e i dati relativi all’esame di stato.
Al termine dell’operazione, i moduli emes-si dalla torretta o i compilati sul sito web, permetteranno di ottenere la ricevuta/domanda di partecipazione alla prova di ammissione al corso prescelto e il modulo per effettuare il versamento del previsto contributo per spese e bollo. Gli studenti dovranno presentarsi alla prova di ammissione con un documento di identità valido, con la ricevuta/domanda di partecipazione alla prova di ammissione e con la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo per spese e bollo.
Sono ammessi a sostenere la prova di ammissione i titolari di diploma di maturità ri-lasciato da Istituti di istruzione secondaria, di durata quinquennale, oppure di durata qua-driennale con superamento del corso an-nuale integrativo. In caso di possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, i candi-dati dovranno rivolgersi direttamente alla Segreteria Studenti, presso la quale potrà essere effettuata la pre-iscrizione.
Sono previsti 200 posti per il Corso di Lau-rea in Lingue e Culture Europee, riservati a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, oltre ad un massimo di n. 10 posti, ri-servati a studenti extracomunitari non sog-giornanti in Italia. L’1% dei posti disponibili per ciascun Corso di Laurea riservato ai portatori di handicap.
Ai sensi dell’art. 39, comma 5, del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286, “ è comunque consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,
11
agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ov-vero di permesso di soggiorno per lavoro su-bordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanita-rio, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di ti-tolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente”.
I candidati di cittadinanza straniera in pos-sesso di un titolo di studio conseguito all’estero, per poter accedere alle selezioni devono superare preventivamente una prova di conoscenza della lingua italiana, che si svolgerà il giorno 4 settembre 2006 alle ore 11,00 presso il Centro Linguistico di Ateneo, in Corso Vittorio Emanuele, 59.
Selezione dei candidatiL’accesso al Corso di Studio in LCE è
subordinato all’esito di una prova scritta di ammissione che prevede domande a scelta multipla su:● una lingua straniera a scelta tra:
inglese/francese/tedesco/spagnolo;● comprensione di un testo su tematiche
culturali;● capacità logico-linguistiche.In caso di parità del punteggio complessi-
vo, si procede secondo l’ordine alfabetico a decorrere da una lettera estratta dalla commissione esaminatrice prima della prova. La prova di ammissione avrà luogo se i candidati che si presenteranno risulteranno essere in numero superiore ai posti disponibili; in caso contrario i candidati presenti potranno immatricolarsi senza aver sostenuto alcuna prova.
Servizi per gli studentiSostegni alla didattica
Gli studenti possono utilizzare il Laborato-rio Informatico, dotato di 24 postazioni PC, situato presso il Centro Linguistico di Ate-neo, in Corso Vittorio Emanuele, 59. Altre postazioni PC sono disponibili presso la sede della Facoltà di Lettere e Filosofia in Largo Sant’Eufemia, 19 (sala multimediale), dove è inoltre disponibile un’aula informatica dotata di 20 postazioni PC per workshop e lezioni organizzate.
Presso il Centro Linguistico è attiva anche una sala di “auto-apprendimento” (SELF-
ACCESS POINT) aperta dal lunedì al venerdì, dove gli studenti possono trovare materiali e strumenti per lo studio autonomo delle lingue e preparare gli esami. È prevista l’assistenza di un adviser che distribuisce materiali, consiglia percorsi di apprendimen-to e cerca di fornire una risposta ai dubbi e ai quesiti posti dagli studenti.
La Facoltà si avvale inoltre dell’operato di un coordinatore didattico che coordina le attività relative ai diversi insegnamenti ed è disponibile per fornire assistenza agli studenti.
Servizi interattiviGli studenti possono usufruire di alcuni dei
servizi normalmente forniti dalle segreterie studenti, collegandosi alla pagina web: http://www.esse3.casa.unimo.it/ (se non è richiesta alcuna stampa), oppure utilizzando le torrette dislocate in vari punti della città.
Per avvalersi dei servizi interattivi è ne-cessaria la tessera magnetica e la password (alias: PIN) che vengono rilasciate dalle se-greterie studenti.
I servizi che si possono ottenere includo-no:● emissione di certificati;● controllo della propria carriera scolasti-
ca (esami sostenuti, pagamento delle tasse, ecc.);
● inoltro della domanda di laurea.
Posta elettronica per gli studentiL’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia mette a disposizione di ogni studente una casella di posta elettronica presso il proprio server: http:// mail.unimore.it .
L’indirizzo di posta elettronica di ogni stu-dente è dato dal numero della tessera ma-gnetica (scritto di seguito, senza spazi)@unimore.it, mentre la password si ot-tiene interrogando i servizi interattivi.
Le informazioni sull’utilizzo della posta elettronica sono consultabili alla pagina: http://mail.unimore.it.
WebÈ consigliabile consultare i siti:http://www.unimore.it ehttp://www.lettere.unimore.it per avere ac-
12
cesso alle informazioni generali sull’Ateneo e sulla Facoltà di Lettere e Filosofia. In parti-colare, sul sito web della Facoltà sono di-sponibili i programmi dei corsi, gli orari delle lezioni e del ricevimento dei docenti, le date degli appelli, eventuali variazioni e altro ancora.
Liste di distribuzioneTramite le liste di distribuzione che riuni-
scono gli studenti a seconda dei corsi di laurea e degli anni di corso, i docenti posso-no inviare, in modo mirato, messaggi di posta elettronica ai propri iscritti.
Pertanto, è opportuno che gli studenti con-trollino regolarmente la propria casella di posta elettronica dell'università.
Si può accedere alle liste di distribuzione da: http://dbstudenti.unimore.it solamente dall’interno della rete universitaria, fatta ec-cezione per il Centro Linguistico. È inoltre possibile utilizzare il servizio dbstudenti per risalire ad un indirizzo di posta elettronica, partendo dai dati anagrafici.
NewsgroupDa http://news.unimore.it si accede ai
gruppi di discussione dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Esistono gruppi di discussione generali (ad esempio dove ven-gono fornite informazioni sull’uso della mail) e altri di carattere più specifico, organizzati a seconda della Facoltà di appartenenza. Per accedere al gruppo di discussione della Facoltà di Lettere e Filosofia vengono utiliz-zati lo username e la password della posta elettronica.
Iscrizione agli appelliDal sito web della Facoltà di Lettere:
http://www.lettere.unimore.it è possibile iscri-versi agli appelli degli esami e ai corsi a nu-mero chiuso (seminari di Letteratura Italiana e Corsi di Informatica). Per potersi iscrivere agli appelli è richiesta l’autenticazione tramite le credenziali della posta elettronica.
È possibile iscriversi fino a due giorno prima per gli appelli orali e fino a cinque giorni prima per gli scritti.
Mobilità internazionaleLa Facoltà di Lettere e Filosofia ha siglato
accordi bilaterali di collaborazione nell’ambito del progetto SOCRATES/ERASMUS con numerose e prestigiose università europee, che rendono possibili soggiorni all’estero di durata varia-bile, da parte di un consistente numero di studenti.
TirocinioNell’ambito dei nuovi ordinamenti, la
Facoltà di Lettere e Filosofia si è attivata per avviare accordi con enti e organizzazioni del mondo del lavoro per favorire i tirocini dei propri studenti e delle proprie studentesse. I tirocini vengono coordinati dal delegato di Facoltà per l’orientamento al lavoro, supervi-sionati da un tutor scientifico e gestiti da un tutor organizzativo.
Corso di lingua e cultura italiana per studenti stranieri
Il Corso, attivato presso il Centro Linguisti-co di Ateneo dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, si propone di sviluppare le competenze linguistiche degli studenti stranieri per facilitare il loro inseri-mento nella vita quotidiana e nel contesto accademico italiano. Responsabile scientifi-co del Corso è la Prof.ssa Cecilia Robustelli (docente di Linguistica italiana della Facoltà di Lettere e Filosofia).
I tre livelli di insegnamento (principiante, intermedio e avanzato) prevedono l’acquisi-zione di strutture linguistiche, e il consolida-mento e l’approfondimento del lessico. All’inizio di ogni semestre viene effettuato un test d’ingresso scritto e orale, obbligatorio per tutti i partecipanti, volto a stabilire il livel-lo di conoscenza della lingua italiana al fine dell’inserimento al livello appropriato.
Il corso è diviso in due semestri:● I semestre: ottobre-novembre
/dicembre (la data di inizio varia a se-conda delle Facoltà);
● II semestre: marzo/maggio.Calendario I semestre● Entro la metà di settembre: test
d’ingresso.● Nella terza settimana di settembre:
inizio lezioni.Per ogni semestre sono previsti moduli di
60 ore, di cui 50 ore di lezione frontale e 10 ore di incontri culturali.
Ogni lezione prevede la trattazione di
13
argomenti grammaticali e/o sintattici e l’assegnazione di esercizi da svolgere a casa, individualmente o in gruppi, per consolidare e verificare le conoscenze e per stimolare la riflessione personale sulla lingua. L’approccio didattico fortemente comunicativo ed è previsto l’uso di materiale integrativo del libro di testo per l’arricchimento della lezione. Sono incoraggiate le attività di apprendimento autonomo degli studenti: una apposita sala con materiali cartacei e multimediali aperta dal lunedì al venerdì, su prenotazione. Il docente è a disposizione per fornire chiarimenti e verificare i progressi ottenuti.
Per tutti i partecipanti sono previste due settimane intensive all’inizio di ogni corso (tre incontri settimanali di tre ore ciascuno). Le lezioni proseguono poi con due incontri settimanali di due ore ciascuno. La frequen-za è obbligatoria soprattutto se il partecipan-te desidera ricevere l’attestato di partecipa-zione con i relativi crediti formativi1.
Le competenze acquisite sono valutate alla fine di ogni semestre mediante un esame finale costituito da una parte scritta (verifica delle nozioni di grammatica, sintassi e lessico e della capacità di comprensione e produzione scritta), e da una parte orale (verifica del grado di capacità comunicativa a livello orale).
L’iscrizione è gratuita ed è aperta a:● Studenti dei programmi
Socrates/Erasmus e Leonardo.● Dottorandi, Ricercatori e Docenti
stranieri.● Studenti stranieri regolarmente iscritti
a un corso di Laurea presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia.
Per l’iscrizione al corso: scarica il modulo di iscrizione http://www.cla.unimore.it/corsi/corsi_italiano/ModIT.pdf, da compilare in tutte le sue parti e da rispedire al responsabile del corso Dott.ssa Maria Rosaria Tosco.
Si raccomanda di rispettare le date di sca-denza per l’invio del modulo:● I semestre 30 agosto.● II semestre 29 novembre
Calendario II semestre.● Entro la terza settimana di febbraio:
1 Il Centro Linguistico di Ateneo ha avviato le procedure necessarie per diventare sede di esame CILS – Certificazione di Italiano come Lingua straniera, in collaborazione con l'Università per Stranieri di Siena.
test d’ingresso.● Prima settimana di marzo: inizio
lezioni.Le date del test di ingresso e dell’inizio
delle lezioni per il primo e secondo semestre sono pubblicate sul sito del Centro Linguisti-co di Ateneo: http://www.cla.unimo.it.
Gli studenti interessati hanno la possibilità di partecipare al progetto “TANDEM”, aperto a tutte le Facoltà e coordinato dal Centro Linguistico di Ateneo. Per ulteriori informa-zioni contattare via e-mail la responsabile organizzativa del Corso: Dott.ssa Maria Rosaria Tosco: [email protected]
Organizzazione didatticaLe lezioni e gli esami si svolgono secondo ilcalendario universitario tradizionale.
Periodi di lezioni● I semestre: dal 1 ottobre 2007 al 14
dicembre 2007 (recupero lezioni dal 17/12 al 21/12).
● II semestre: dal 25 febbraio 2008 al 19 marzo 2008 e dal 31 marzo al 16 maggio 2008 (recupero lezioni dal 19/05 al 23/05).
Esami● Dal 7 gennaio al 22 febbraio 2008
(sessione straordinaria a.a. 2006/2007 e sessione invernale a.a. 2007/2008): una prova scritta e due appelli orali per le lingue, tre appelli per le altre materie;
● dal 3 giugno al 31 luglio 2008 (ses-sione estiva a.a. 2007/2008): una prova scritta e tre appelli orali per le lingue, tre appelli per le altre materie;
● dal 1 settembre al 26 settembre 2008 (sessione autunnale a.a. 2007/2008): una prova scritta e un appello orale per le lingue, un appello per le altre materie.
Regolamentazione della frequenza
La frequenza delle lezioni è un diritto degli studenti, che deve essere garantito con op-portune decisioni organizzative, atte a evita-re sovrapposizioni di insegnamenti frequen-tati dai medesimi studenti e a rendere co-munque possibile la frequenza a tutti gli iscritti.
14
La frequenza alle lezioni è normalmente presupposta, in quanto permette di acquisire in modo guidato orientamenti fondamentali che permettono di raggiungere nei tempi previsti gli obiettivi formativi proposti e di-chiarati per l’insegnamento. In casi motivati,lo studente può chiedere, all’inizio del corso, di essere dispensato dalla fre-quenza, concordando un programma per non-frequentanti con i singoli docenti.
Ricordando che, ai sensi della riforma dell'Università a (decreto del 3 novembre 1999, n. 509), ciascun credito acquisito equivale a 25 ore di lavoro complessivo dello studente, nell’assegnare il carico di la-voro a coloro che non frequentano, si do-vranno far recuperare le ore di frequenza mancata, con ore di studio. A tale proposito, si ritiene comunque che le ore di frequenza siano più significative rispetto alle ore di studio individuale, in relazione al consegui-mento degli obiettivi formativi. Si avvertono pertanto gli studenti che un numero di ore di studio individuale pari al numero di ore non frequentate potrebbe non compensare com-pletamente l’orientamento fornito dal docen-te a lezione. Di conseguenza, il carico effet-tivo di studio individuale dei non frequentanti potrebbe superare quello cumulato dai fre-quentanti tra ore di frequenza e ore di studio individuale, essendo questi ultimi facilitati nello studio dall’aver goduto del diritto di es-sere a lezione. Gli studenti non-frequentanti dovranno essere identificati, in assenza di autodichiarazione, attraverso opportune for-me di rilevazione delle frequenze in aula, se-condo una quota di presenza stabilita e di-chiarata nel programma dal docente, in base alle caratteristiche attribuite alla frequenza stessa.
Calendario Lezioni a.a. 2007/08I PERIODO dal 1/10/2007 al 14/12/2007 Lezioni;dal 7/1/2008 al 22/02/2008 Esami.
II PERIODOdal 25/2/2008 al 19/3/2008 Lezioni,dal 31/3/08 al 16/5/2008 Lezioni,dal 3/6/2008 al 31/7/2008 Esami,dal 1/9/2008 al 26/9/2008 Esami .
Il primo periodo prevede undici settimane
di lezione (più una settimana di recupero lezioni).
Il secondo periodo prevede dieci settima-ne e mezzo di lezione (più una settimana di recupero lezioni).
Sessioni di laurea a.a. 2006/07
18-19 luglio 2007;
24 –25 -26 ottobre 2007;
18 – 19 dicembre 2007;
20 – 21 febbraio 2008;
17 – 18 marzo 2008.
15
Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura
Il Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura si caratterizza per la sua in-terdisciplinarità, intendendo i termini ‘lin-guaggio’ e ‘cultura’ nel senso più ampio pos-sibile. Promuove ricerche e iniziative in capo linguistico,sociologico, antropologico, storico, filosofico, letterario e artistico, ma si apre anche ad aree come l’economia e il di-ritto, favorendo soprattutto il dialogo fra spe-cialisti di discipline diverse e l’elaborazione di progetti comuni. È aperto a tutte le istanze e sollecitazioni che possano venire dalla so-cietà civile e dalla realtà sociale. Fra i campi di ricerca privilegiati: la comunicazione scientifica, i problemi della società multicul-turale, l’analisi dei conflitti nel mondo con-temporaneo.
Nell’anno accademico 2003/2004 il Dipar-timento proponeva due dottorati di ricerca della durata di tre anni. Entrambi i dottorati nascono da un progetto spiccatamente inter-disciplinare e coinvolgono tutte le aree disci-plinari del Dipartimento. Il dottorato in Antropologia e Storia del Mon-do Moderno e Contemporaneo intende for-mare studiosi capaci di analizzare le forme del conflitto e del consenso da diverse ango-lazioni: politica, sociale, ideologica, cultura-le, retorico-comunicativa. In particolare approfondisce due tematiche fondamentali:● forme e rappresentazioni del conflitto e
del consenso;● cittadinanza e comunicazione
interculturale.Il dottorato in Lingue e Culture Comparate
pone l’accento sul contatto tra lingue e culture diverse, che caratterizza la nostra società, tanto a livello nazionale, quanto nel quadro europeo e internazionale. I due diversi percorsi formativi individuati prevedo-no:● problemi di interpretazione della te-
stualità (retorica, traduzione e studi culturali comparati);
● varietà delle lingue e dei testi (linguisti-ca dei corpora, analisi delle varietà storico-geografiche delle lingue ogget-to di indagine e analisi dei generi te-stuali in specifiche situazioni d’uso, scritte e parlate).
Dall’anno accademico 2004/2005 i due dottorati sono stati unificati in un unico dotto-rato, mantenendo, tuttavia, i due indirizzi (Antropologia e Storia del Mondo Moderno e Contemporaneo, e Lingue e Culture Compa-rate) con gli stessi contenuti. Gli indirizzi sa-ranno attivati ad anni alterni.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla sig.ra Barbara Viaro, Segretario del Dipartimento, tel. 059 2055952; fax 059 2055933 il mercoledì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
16
La Biblioteca UmanisticaLa Biblioteca Umanistica di Ateneo
(http://www.biblioumanistica.unimore.it), fondata nel 2002, è la Biblioteca specialistica di riferimento per gli utenti della Facoltà di Lettere e Filosofia e per tutti gli ambiti di studio e ricerca del Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura.
È collocata presso la sede della Facoltà stessa, al pianoterra dell’edificio sito in Largo S. Eufemia 19, e utilizza attualmente locali in parziale condivisione con la Bibliote-ca del Dipartimento di Scienze della Terra.La Biblioteca Umanistica, insieme alle altre Biblioteche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, aderisce al Sistema Bibliote-cario di Ateneo (http://www.sba.unimore.it/) e persegue in primo luogo la finalità istituzio-nale di dare supporto alle attività di didattica e di ricerca svolte all’interno della Facoltà di Lettere e Filosofia e del Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura. La Biblioteca Umanistica si propone inoltre di essere un punto di riferimento peculiare a favore di tutto l’Ateneo e dell’utenza esterna per le proprie specificità disciplinari di carat-tere umanistico, con una forte propensione e specializzazione verso le culture e le aree linguistiche europee ed extra-europee.
Risorse disponibili (a luglio 2007)
La Biblioteca possiede attualmente più di 4600 libri, acquisiti per la didattica e la ricer-ca ed è abbonata a 127 periodici disponibili in forma cartacea: 73 di queste riviste e dei relativi archivi di arretrati sono consultabili online. Inoltre sono utilizzabili, attraverso il sito web dello SBA, 6 banche dati bibliografi-che specialistiche.
Le principali risorse elencate si riferiscono ai seguenti ambiti disciplinari: Anglistica, Arabistica, Francesistica, Germanistica, Ispanistica, Italianistica, Scienze demoet-noantropologiche, Scienze filosofiche, Scienze geografiche, Scienze giuridiche, Scienze glottologico-linguistiche, Scienze sociologiche e Scienze storiche.
Servizi offerti I servizi fondamentali garantiti dalla
Biblioteca Umanistica sono il prestito dei libri secondo il regolamento disponibile in Biblioteca, la fornitura di articoli di riviste in altre biblioteche (document delivery) e corsi di formazione per l'utilizzo delle risorse bibliografiche.. Gli utenti potranno ottenere informazioni bibliografiche generali e aiuti per ricerche e consulenze specifiche (reference di base e specialistico). Per foto-copie è possibile utilizzare l’apparecchiatura in apposito spazio.
Servizi onlineUna specifica attenzione viene dedicata
all’accesso alle risorse bibliografiche elettro-niche consultabili sia nei locali della Biblioteca e del Laboratorio informatico (15 postazioni informatiche dotate di stampante in rete) sia da tutti i computers dell’Ateneo, sia da accesso remoto (VPN, Virtual Private Network).Si segnalano in particolare il catalogo del Si-stema Bibliotecario di Ateneo (http://sebinaweb.cedoc.mo.it/SebinaOpac/Opac) e quello dei periodici e delle banche dati online (http://www.sba.unimore.it/).
AperturaLa Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì: 8.30-13.00/14.00-17.30.
Personale addetto● Coordinatore di Biblioteca: Gianluca
Tosetto (e-mail: [email protected]) Tel. 059 2055987 - Fax 059 20555937.
● Bibliotecari: Cinzia Rebecchi (e-mail: [email protected]) Tel. 059 2055920 - Fax 059 2055937; Ombretta Malavasi (e-mail [email protected] Tel. 059 2055915 - Fax 059 20555937.
● Il Comitato di gestione della Biblioteca è costituito da: Prof. Augusto Carli (Direttore scientifico), Prof. Giancarlo Gagliardelli, Prof. Gualtiero Harrison, Dr. Gianluca Tosetto, Sig.ra Cinzia Rebecchi, Sig.na Giulia Tomasetto (rappresentante studenti).
17
Lingue e Culture Europee Il Corso di Laurea in Lingue e Culture Europee, che si attiva nella classe di Lauree in Scienze della Mediazione Linguistica, coniuga in modo innovativo l’approfondimento di diverse lingue e culture con conoscenze socioeconomiche e giuridiche. Le competenze acquisite permetteranno ai laureati, in considerazione delle molteplici sfaccettature della propria formazione, di ricoprire un ruolo di primo piano nell’ambito delle pubbliche relazioni per le imprese e le istituzioni e della mediazione interlinguistica e culturale.
Gli obiettiviLa Laurea in Lingue e Culture Europee
permette di:● utilizzare le lingue straniere in modo
corretto, ma soprattutto adeguato alla complessità a delle situazioni, grazie ad una conoscenza approfondita della cultura, della storia, della società e delle istituzioni dei paesi che utilizzano queste lingue;
● acquisire un’adeguata preparazione generale in campo economico-giuridi-co con particolare riferimento alle or-ganizzazioni sociali e ai rapporti con il mondo europeo ed extra-europeo;
● acquisire gli strumenti teorici e pratici per la comunicazione e la gestione dell’informazione in ambito internazio-nale, avvalendosi delle tecnologie più avanzate;
● sviluppare una maggiore consapevolezza delle differenze inter-culturali (a livello generale e locale) fra le lingue oggetto di studio e la propria.
Articolazione del corsoPrimo anno
Il primo anno è finalizzato al consolida-mento delle competenze di base nelle lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spa-gnolo) e all’acquisizione di ulteriori cono-scenze relative a discipline di ambito socio-antropologico, storico, linguistico e letterario quali: Linguistica Applicata, Linguistica Italiana, Sociologia, Antropologia Culturale, Storia Contemporanea e dell’Europa, Lette-
ratura Italiana Contemporanea. Si prevede inoltre la frequenza di due Laboratori di Informatica e di un Laboratorio di Strumenti e Abilità di Studio.
Insegnamenti CFULingua Inglese 10Lingua Francese/Tedesca/Spagnola 10
Linguistica Applicata 6Linguistica Italiana 6Sistemi sociali e culture della comunicazione /Antropologia Culturale
6
Storia Contemporanea + Storia dell'Europa 8
Letteratura Italiana Contemporanea 8Informatica Umanistica 4Laboratorio di Strumenti e Abilità di Studio 2
Totale crediti: 60
Secondo annoViene consolidata la formazione di base,
con la prosecuzione dello studio delle lingue-culture straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo), e la frequenza di un la-boratorio di informatica. Vengono offerti in-segnamenti di tipo giuridico (Sistemi Giuridici Comparati e Diritto delle Comunità Europee) ed economico (Istituzioni di Economia ed Economia dell’Integrazione Europea).
Allo stesso tempo vengono proposte op-portunità a di orientamento e professionalizzazione grazie ad insegna-menti e seminari opzionali: la terza lingua o l’applicazione delle due lingue studiate alla traduzione; la cultura e le istituzioni dei paesi delle lingue scelte; le letterature delle lingue straniere; seminari di area giuridico-economica.
Insegnamenti CFULingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Inglese
10
Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Francese/ Tedesca/ Spa-
10
18
Insegnamenti CFUgnola Nozioni Giuridiche Fondamentali 4Diritto delle Comunità Europee 4Istituzioni di Economia + Economia dell’Integrazione Europea
8
Opzione tra:● Terza lingua● Corso Traduzione Prima
Lingua+ Seminario Traduzione Seconda Lingua
10
Seminario a scelta tra:● Lingua, cultura e istituzioni
della lingua straniera● Letteratura della lingua
straniera(francese, inglese, americana,spagnola, tedesca)
4
Seminario a scelta tra:● Comunicazione d’azienda● Culture nazionali e relazioni
economiche tra paesi● Diritto comparato della tra-
dizione occidentale
4
Laboratorio di Informatica 2A scelta 4Totale crediti: 60
Terzo annoOltre agli insegnamenti delle due lingue
straniere scelte come principali (inglese e francese/tedesco/spagnolo), il terzo anno propone tre curricula specifici:
1. pubbliche relazioni per le imprese e le istituzioni;
2. operatore culturale;3. mediazione inter-linguistica.Questi tre diversi curricula sono rispettiva-
mente caratterizzati da: un approfondimento di contenuti economico-aziendali; un affian-camento dei suddetti contenuti a tematiche di tipo comunicativo; percorsi operativi sulla traduzione scritta e orale in campo economi-co-aziendale.
Per tutti i curricula, una parte rilevante dei crediti sarà assegnata ad attività da svolger-si in modo operativo attraverso laboratori e comunque in gruppi di lavoro. Per quanto possibile, saranno incoraggiati i periodi di studio all’estero (progetti Socrates) e gli sta-ges presso aziende e istituzioni che operano all’interno dell’UE.
Insegnamenti CFULinguistica Inglese 8+4Linguistica Francese/Tedesca/Spagnola
8+4
Totale crediti: 24
Tabella 1: Insegnamenti comuni ai tre curricula al terzo anno.
Prova finaleLa prova finale prevede:● la verifica delle conoscenze linguisti-
che in base ai criteri del Common European Framework of Reference (4 CFU);
● l’elaborazione di un testo a carattere accademico-professionale (6 CFU), con opzione tra:– relazione sul tirocinio;– elaborati scritti redatti sotto la gui-
da di un docente della Facoltà (in forma di progetto unico o in forma cumulativa);– progetto di traduzione.
Totale crediti: 10.
Insegnamenti CFU
Marketing Internazionale 8
Diritto commerciale comunitario 4
A scelta 8
Tirocinio/Altri laboratori 6
Totale crediti: 26
Tabella 2: Curriculum di pubbliche relazioni per le imprese e le istituzioni.
Insegnamenti CFU
Marketing 4
Opzione tra:● Semiotica della Comunica-
zione● Etnologia● Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi
4+4
A scelta 8
Tirocinio/Altri laboratori 6
19
Insegnamenti CFUTotale crediti: 26
Tabella 3: Curriculum per operatore culturale.
Insegnamenti CFUMediazione Scritta e Orale Inglese-Italiano (Laboratori)
4
Mediazione Scritta e Orale Tedesco/Francese/Spagnolo- Italia-no(Laboratori)
4
Opzione tra: ● Marketing● Marketing Internazionale● Diritto Commerciale Comunita-
rio● Semiotica della comunicazione
4
A scelta 8Tirocinio/Altri laboratori 6Totale crediti: 26
Tabella 4: Curriculum di mediazione interlinguistica.
Passaggio da un corso di laurea ad un altro
Per informazioni sul passaggio da un corso di laurea ad un altro, rivolgersi alla Segreteria Studenti, in Corso Canalgrande, 45 Modena.
Sbocchi professionali Il corso di Laurea in Lingue e Culture
Europee propone una formazione per attività professionali che possono essere svolte nel quadro dei rapporti Italia - UE presso:● imprese industriali e di servizi a
dimensione internazionale, nell’ambito dei rapporti commerciali, del marketing e delle pubbliche relazioni;
● amministrazioni pubbliche che intrattengono rapporti con amministrazioni, enti e istituzioni di altri paesi europei o con cittadini di paesi europei ed extra-europei;
● istituzioni pubbliche o private (istituzioni culturali e istituti di credito) nei loro rapporti con altre istituzioni dell’UE;
● l’editoria e le istituzioni culturali, le imprese e le attività commerciali e turistiche.
L'attività didattica pratica può essere svol-ta in parte anche presso enti esterni all'Università a (pubbliche amministrazioni, imprese singole o associate, organismi culturali nazionali ed internazionali), sia in Italia sia in altri paesi europei. Ciò permette di porre le basi per un eventuale futuro inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
PropedeuticitàVi è propedeuticità fra le annualità della
stessa lingua straniera. Pertanto non può essere sostenuto l’esame di un'annualità successiva prima che sia stato superato l’esame dell’annualità precedente.
È consigliato sostenere gli esami di insegnamenti della stessa area disciplinare secondo l’ordine in cui sono impartiti.
20
Scienze della Cultura Il Corso di Laurea in Scienze della Cultura fa parte della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Modena e Reggio Emilia ed inserito nella Classe di Lauree in Lingue e culture moderne. Questo nuovo corso di laurea si propone di formare laureati in un’area innovativa di sviluppo scientifico e professionale, legata alle più recenti trasfor-mazioni della società contemporanea, che richiedono nuovi rapporti tra le comunità locali (nazionali, regionali, ecc.) e una società che ha ormai dimensioni mondiali.
Gli obiettiviIl Corso di laurea in Scienze della cultura
permette di qualificare la laurea nella classe delle Lingue e Culture Moderne, fornendo in specifico:● conoscenze sui fondamenti storici, an-
tropologici e sociologici delle culture e delle società contemporanee;
● competenze linguistiche per la comuni-cazione interculturale, in particolare in tre lingue di ampio uso nell’intermedia-zione tra le diverse culture;
● conoscenze sul contesto sociale e cul-turale dei paesi in cui si parlano queste lingue, con particolare riferimento ad ambiti extraeuropei;
● competenze nella comunicazione in-terculturale e nell’analisi e gestione dei processi dell’immigrazione e della coo-perazione internazionale;
● competenze nella costruzione e nella divulgazione multimediale di progetti inerenti le diverse aree della comuni-cazione interculturale.
Il titolo di studio fornito dal Corso di Laurea coniuga quindi la competenza acquisita nelle lingue con una competenza ampia ed articolata nel trattare i fenomeni culturali ed interculturali, accrescendo così il valore della laurea sul mercato e per le proprie competenze personali.
Articolazione del corsoPrimo anno
Insegnamenti di base in due lingue stra-niere (inglese, francese/spagnolo) larga-mente utilizzate nella comunicazione inter-culturale con paesi extraeuropei, fondamenti
sociologici, antropologici e storici delle forme culturali e dei processi sociali e culturali, preparazione di base nella lingua e letteratu-ra italiana in vista di un’analisi comparata tra culture. Laboratorio di informatica applicato alle tematiche culturali e interculturali.
Insegnamenti CFUAntropologia Culturale 10Letteratura Italiana 6Lingua Inglese 10Sistemi Sociali e Culture della Co-municazione
10
Storia Moderna 10Informatica per le scienze umane 4Opzione tra: Lingua francese/spagnola/tedesca
10
Totale crediti: 60
Secondo annoConsolidamento delle conoscenze lingui-
stiche e studio della cultura e delle istituzioni dei paesi delle lingue scelte. Orientamento degli studi sociologici e antropologici dei processi culturali, approfondimento dei fon-damenti storici e culturali della modernità e della contemporaneità e delle relazioni inter-culturali.
Insegnamenti CFUEtnologia 10Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Inglese
10
Sociologia dei Processi Culturali 6Storia Contemporanea* 10Storia della Filosofia* 10Storia delle Religioni* 10Opzione tra: Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Spagnola Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Francese Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Tedesca
10
Totale crediti: 62* Gli studenti debbono scegliere tre insegnamenti da 10 crediti e uno da 6 tra
21
Etnologia, Storia Contemporanea, Storia della Filosofia e Storia delle Religioni.
Terzo annoDifferenziazione nei due curricula previsti
dal Corso di laurea (Mediazione Interculturale e Analisi dei Sistemi Culturali e Socio-Economici). I due curricula creano profili professionali che integrano la forma-zione di base del primo biennio, innestando-si in un percorso di carattere multidisciplina-re che si completa attraverso studi sull’uso del linguaggio in contesti multiculturali. Inoltre,viene introdotto lo studio di una terza lingua (a scelta tra arabo, francese e spagnolo), sempre di massima rilevanza nella comunicazione interculturale, insieme alla cultura dei paesi in cui essa viene parlata.
Insegnamenti CFU
Filosofia del linguaggio 6Sociolinguistica 6Opzione tra:Lingua Araba, Storia dell’Islam e Cultura Spagnola/Lingua Araba, Storia dell’Islam e Cultura Francese/Lingua Araba, Storia dell’Islam e Cultura Tedesca/Storia dell’Islam, Lingua Francese e Culture Francofone/Storia dell’Islam, Lingua Spagnola e Culture Ispanofone/Storia dell’Islam, Lingua Tedesca e Culture Germaniche/Lingua Francese, Culture Francofone e Culture dei Paesi Islamici/Lingua Spagnola, Culture Ispanofone e Culture dei Paesi Islamici/Lingua Tedesca, Culture Germaniche e Culture dei Paesi Islamici
12
Curriculum a scelta tra:Mediazione interculturale (2 esami a scelta tra:)Antropologia SocialeEtnologia delle Culture MediterraneeFilosofia MoraleSociologia delle Relazioni InteretnicheTeoria e Metodi della Pianificazione
12
Insegnamenti CFU
SocialeAnalisi dei sistemi culturali e socio-economici (2 esami a scelta tra:)Economia dello SviluppoGeografia CulturaleStoria della Scienza e della Tecnica nell’Età Moderna e ContemporaneaStoria del Cristianesimo in Età Moderna e ContemporaneaStoria dell’EuropaA scelta dello studente 10Opzione tra:TirocinioCertificato di conoscenza linguistica (livello C1 Common European Framework of Reference) Attività strutturate (formazione di competenze di ricerca)
6
Prova finale 6Totale crediti: 58
Prova finaleLa prova finale ha un valore di 6 crediti,
pari a 150 ore di attività di studio dello stu-dente o della studentessa. La prova finale consiste in una relazione scritta, che viene valutata da una commissione composta da cinque docenti, titolari di insegnamenti nel quadro della Facoltà, uno dei quali funge da tutor. Oltre ad essere direttamente collegata all’insegnamento del tutor, la prova finale può essere collegata anche al tirocinio op-pure ad attività strutturate previste in sostitu-zione del tirocinio.
Attività strutturateCon il termine ATTIVITA' STRUTTURATE
(6 crediti nel terzo anno) si fa riferimento ad: attività di studio, ricerca, laboratorio o semi-nario, in base alle indicazioni del docente del corso corrispondente, oppure al docente scelto come tutore per la prova finale .
Passaggio da un corso di laurea ad un altroPer informazioni sul passaggio da un corso di laurea ad un altro, rivolgersi alla Segreteria Studenti, in Corso Canalgrande, 45 – Modena.
22
Gli sbocchi professionaliIl Corso di laurea in Scienze della Cultura
si prefigge di formare le competenze per svolgere attività professionali nel quadro di:● organizzazioni internazionali che for-
mulano progetti di cooperazione e svi-luppo tra paesi a diverso grado di mo-dernizzazione;
● imprese che operano in contesti multi-culturali, sia in Occidente, sia in paesi in via di sviluppo;
● delegazioni politiche internazionali, come rappresentanze diplomatiche e consolari;
● servizi locali per l’immigrazione e le re-lazioni multietniche, nelle aree dell’U-nione Europea ad alto tasso di immi-grazione extracomunitaria;
● istituzioni educative in contesti multiet-nici, con particolare riferimento alla programmazione e alla costruzione di interventi di educazione interculturale;
● servizi e istituzioni culturali nella pubblica amministrazione, nella cooperazione e nel privato (biblioteche, archivi,
● centri ed uffici che organizzano eventi culturali, spettacoli, attività artistiche, ecc.);
● turismo interculturale, sia nelle aree europee che extraeuropee.
Gli sbocchi professionali vengono favoriti dai tirocini, organizzati dalla Facoltà in collaborazione con Enti culturali, Organizzazioni Non Governative per la cooperazione internazionale, Società e Associazioni che si occupano di comunicazione interculturale.
PropedeuticitàVi è propedeuticità fra le annualità della
stessa lingua straniera. Pertanto non può essere sostenuto l’esame di un'annualità successiva prima che sia stato superato l’esame dell'annualità precedente. È consi-gliato sostenere gli esami di insegnamenti della stessa area disciplinare secondo l’ordi-ne in cui sono impartiti.
23
Lauree magistraliLa Facoltà di Lettere e Filosofia ha attivato
quattro Lauree Magistrali per arricchire competenze e professionalità già acquisite durante il percorso di laurea di base:
● Analisi dei Conflitti, delle Ideologie e della Politica nel Mondo Contemporaneo.
● Comunicazione nell’Impresa e nelle Organizzazioni Internazionali.
● Progettazione e Gestione di Attività Culturali.
● Teoria e Metodologia della Ricerca Antropologica sulla Contemporaneità.
Laurea Magistrale in Analisi dei Conflitti, delle Ideologie e della Politica nel Mondo Contemporaneo
Obiettivi formativiIl corso intende fornire competenze avan-
zate sui metodi della ricerca storica, addestrando all’uso critico delle fonti archivistiche e bibliografiche secondo le tecniche di analisi più aggiornate.
L’obiettivo primario formare studiosi capa-ci di intervenire criticamente e con contributi originali nello studio dei problemi del mondo contemporaneo, muovendosi in una pro-spettiva ampia che consente di collegare le dinamiche sociali, gli eventi politici, l’evolu-zione delle istituzioni politiche, le trasforma-zioni economiche, i mutamenti intellettuali, scientifici, ideologici e della mentalità.
A tale scopo, gli studenti dovrebbero con-seguire conoscenze approfondite sui princi-pali movimenti culturali e sulle principali cor-renti del pensiero politico, sociale, filosofico, economico, artistico del Novecento, non solo europeo.
Inoltre, gli studenti dovranno dimostrare la padronanza di due lingue dell’Unione Europea e potersi quindi inserire nel contesto della ricerca internazionale.
Al fine di sviluppare capacità di collegamento fra gli aspetti politici, economi-ci, sociali dell’età contemporanea e la storia
delle idee (intesa in senso ampio), l'attività di ricerca si concentrerà su quattro grandi nuclei tematici, affrontati in una prospettiva mondiale:
1. Stato, istituzioni politiche e conflitti nell’età contemporanea. L’evoluzione dell’idea di Stato nella cultura del XIX e del XX secolo in rapporto alle mutazioni dei grandi quadri di riferimento. Le trasformazioni degli assetti istituzionali e politici prima e dopo i grandi conflitti europei e mondiali. Le varie forme di conflittualità interne ai singoli Stati riconducibili alla dialettica svi-luppo/sottosviluppo propria dell’età con-temporanea.
2. Scienza, tecnica e ideologia. Gli sviluppi della scienza e della tecnica saranno esaminati in relazione ai principali movimenti culturali dell’Ottocento e del Novecento, ai dibattiti sulla modernità e la modernizzazione, sui problemi ambientali, sulla globalizzazione e sul rapporto tra scienza e società.
3. Mito e sacro. I paradossi del Novecento: la secolarizzazione, l’affermazione del pensiero laico e la crescita dell’ateismo, accanto all’espandersi dell’irrazionalismo e del misticismo nel pensiero filosofico. Religiosità, politica, religione civile, ideologie totalitarie. La diaspora del sacro ed il ritorno del religioso negli ultimi decenni del secolo. I fondamentalismi ed i conflitti religiosi. Le nuove forme della religione: le sette e l’universo del new age.
4. Analisi dei conflitti ideologici, sociali e politici nell’età contemporanea. Conflitti politici e sociali nel XIX e XX secolo. Prima guerra mondiale come frattura epocale all’interno delle vicende contemporanee, all’origine degli eventi che separano gli anni compresi tra le due guerre. Sorgere di utopie millenaristiche. Nuove forme di organizzazione del consenso e di repressione del dissenso. Affermarsi dei totalitarismi, crisi economica mondiale, persecuzione e stermini. Nuove nevralgiche situazioni di crisi politico-sociali e nuovi focolai di tensione “calda”
24
e “fredda” dopo il secondo conflitto mondiale.
Sbocchi professionaliI laureati potranno svolgere attività di pro-
gettazione e gestione organizzativa di carattere culturale e di ricerca. In particolare potranno inserirsi:● progettazione e gestione organizzativa
negli istituti di cultura e nelle società e cooperative culturali;
● ricerca storiografica nei centri di studi e ricerca privati e pubblici, negli istituti culturali e nelle società e cooperative culturali;
● progettazione e gestione organizzativa nel campo dell’editoria e della diffusio-ne dell’informazione e della cultura storica contemporanea;
● responsabilità nella pubblica ammini-strazione e nelle organizzazioni inter-nazionali nel campo della cooperazio-ne e dello sviluppo che richiedano spe-cifiche competenze nell’analisi delle di-verse forme della conflittualità (politica, sociale, ideologica, religiosa, etnica) nella realtà contemporanea.
Laurea magistrale in Comunicazione nell’impresa e nelle organizzazioni internazionali
La laurea magistrale in “Comunicazione nell’Impresa e nelle Organizzazioni Internazionali” intende fornire competenze avanzate e strumenti metodologici necessari a gestire i diversi ambiti della comunicazione internazionale in imprese e organizzazioni che operano sia sul contesto regionale che quello sovranazionale.
Basandosi sull’imprescindibile nesso tra conoscenze giuridiche, socio-economiche e padronanza linguistica, il corso si propone di creare professionalità flessibili in un mercato del lavoro in continua trasformazione. Obiettivo fondamentale del corso è quello di fornire allo studente capacità di progettazione, organizzazione e conduzione di attività di comunicazione inter-culturale con particolare riferimento a incontri multilaterali tra istituzioni governative e/o imprese con sedi in diversi paesi. Esso ore:
● acquisizione di conoscenze avanzate per l’interpretazione delle trasformazioni sociali, geo-politiche e economiche nei diversi paesi e aree geografiche;
● indirizzi di formazione nei campi giuri-dico, economico, amministrativo e politico indispensabile all’accompagna-mento di negoziazioni multilaterali sia nel settore pubblico che quello privato;
● acquisizione di tecniche specifiche in informatica, pubblicità, comunicazione multimediale.
I laureati potranno esercitare funzioni di responsabilità:● in imprese operanti a livello
multinazionale;● in istituzioni locali, nazionali e
internazionali preposte allo sviluppo della cooperazione internazionale.
Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione di Attività Culturali
La Laurea Magistrale in “Progettazione e gestione di attività culturali” costituisce, per contenuti, finalità e metodologia d’insegnamento, un programma formativo ad alto livello che si accompagna e completa la preparazione conseguita durante il percorso di laurea di primo livello, arricchendone in maniera più specifica l’approfondimento. Per queste sue caratteristiche si presenta come un’offerta formativa unica nel suo genere.
Obiettivi formativiL’obiettivo prioritario della Laurea Magi-
strale, dunque, quello di fornire competenze avanzate e strumenti critico-metodologici volti ad offrire, in una prospettiva internazio-nale, una visione d’insieme dei fenomeni scientifico-culturali e dell’imprenditoria che di essi si avvale, permettendo al tempo stesso agli specializzati di conoscere a fondo i pro-blemi e gli scenari di un ambito culturale specifico.
Coniugando conoscenze linguistiche approfondite ad elevate competenze profes-sionali in campo culturale, oltre a una valida preparazione giuridico-economica, il corso di studi intende formare figure specializzate in grado di rispondere alle sfide di un mercato del lavoro, anche in questo settore, in conti-
25
nua trasformazione.Ciò consentirà di inserirsi con un bagaglio
adeguato in tutte quelle organizzazioni ed istituzioni, sia pubbliche che private, che promuovono la progettazione e gestione di attività culturali.
Sbocchi professionaliI laureati potranno svolgere attività di pro-
gettazione, mediazione, e gestione di attivi-tà` a culturali in una prospettiva di globaliz-zazione dei mercati culturali. I particolare potranno inserirsi:● nelle istituzioni governative competen-
ti(settori del turismo, della cultura,dei beni culturali e ambientali e dello svi-luppo locale) centrali e decentrate;
● nell’industria culturale e negli istituti di cultura (produzione di strumenti edito-riali tradizionali e multimediali);
● in strutture preposte alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità locali e nazionali;
● in strutture preposte alla valutazione e progettazione di politiche e strategie finalizzate alla attrazione dei flussi turistici;
● in servizi di gestione e sviluppo nei settori: spettacoli dal vivo (performing arts), beni culturali ed ambientali, co-municazione di massa (televisione, cinema, editoria), ecc;
● in strutture preposte all’organizzazione di spettacoli ed esposizioni;
● in imprese pubbliche e private, Orga-nizzazioni Non Governative, Associa-zioni di rappresentanza, nonché pres-so gli uffici dell’Unione Europea e dell’ONU.
Laurea Magistrale in Teoria e metodologia della ricerca antropologica sulla contemporaneità
Il corso di laurea in “Teoria e Metodologia della Ricerca Antropologica sulla Contempo-raneità” è dedicato alla formazione di ricer-catori in campo antropologico ed etnologico, con particolare riferimento ai temi dell’antro-pologia della contemporaneità.
Esso nasce dalla necessità di costruire un
approccio scientifico qualificato per l’analisi delle nuove realtà culturali che caratterizza-no la nostra epoca, determinatesi in seguito ad un sempre più intenso contatto culturale che si concretizza nei fenomeni migratori, nella trasmissione delle informazioni a livello mondiale, nella diffusione delle tecnologie e nell’internazionalizzazione dei mercati eco-nomici.
Queste dinamiche culturali mondiali crea-no processi sia di convergenza che di diver-genza, di omogeneizzazione e diversifica-zione culturale. Il variegato universo delle differenze culturali richiede, per essere inter-pretato e compreso, l’apporto di una pro-spettiva teorica e metodologica quale quella offerta dalle discipline demoetnoantropologi-che, che con la loro riflessione e con le loro ricerche hanno posto da più di un secolo al centro dei loro interessi l’analisi culturale, sviluppando specifici modelli interpretativi, specifiche metodologie e tecniche di ricerca.
A tal proposito, il curriculum della laurea magistrale permette di:● acquisire una conoscenza avanzata
delle discipline demoetno-antropologi-che, relativamente, oltre che ai pre-supposti teorici ed epistemologici delle discipline stesse, alle dinamiche culturali e ai processi identitari, alla co-stituzione delle identità collettive, ai fe-nomeni di ibridazione culturale, conta-minazione, deterritorializzazione, loca-lismo, all’insorgenza di atteggiamenti entrocentrici e di fenomeni di xenofo-bia e razzismo;
● acquisire competenze nell’uso del me-todo etnografico per l’analisi antropo-logica;
● acquisire una formazione complemen-tare a quella antropologica nelle disci-pline sociologiche attente allo studio dei fenomeni interculturali, dell’analisi comparata delle culture e dell’analisi applicata nei contesti organizzativi e associativi di interazione culturale;
● acquisire una conoscenza delle scien-ze storiche, linguistiche e filosofiche che fondano l’analisi delle diversità e delle convergenze culturali;
● acquisire conoscenze approfondite della cultura materiale e delle tradizio-ni verbali, iconiche e musicali che co-stituiscono il patrimonio folcloristico dell’area socioculturale del Mediterraneo;
26
● acquisire conoscenze approfondite sulle realtà sociali e culturali dell’Africa, in particolare sui fenomeni e sulle dinamiche di lungo periodo situabili prima e dopo la spartizione coloniale;
● acquisire consapevolezza critica sui concetti e sulle categorie della tradi-zione culturale africanista;
● acquisire competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’in-formazione;
● essere in grado di utilizzare fluente-mente, in forma scritta e orale, una lin-gua dell’Unione Europea, oltre all’ita-liano e, in via opzionale, una seconda lingua tra quelle più utilizzate nel pa-norama mondiale.
27
Notizie generali sull’AteneoL’Ateneo Modenese ebbe inizio nell’anno
1175 con la chiamata di Pillio da Medicina che impresse nuovo vigore a quella scuola di Diritto che ha costituito il primo nucleo dell’Ateneo stesso.
Dall’a.a. 1998/99, l’Ateneo ha adottato un nuovo modello organizzativo a “rete di sedi” ed ha assunto la denominazione di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. (D.R.del 8.6.98, n 35 e pubblicato sulla G.U. Del 2.7.98, n152).
Gli organi dell’AteneoGli organi dell’Ateneo di Modena e Reggio
Emilia sono di governo, consultivi e di con-trollo (come previsto dallo Statuto approvato con Decreto del Rettore il 14.4.94, n 24 e pubblicato sulla G.U. del 26.4.1994, n95 Serie Generale).
Gli organi di governo dell’Università sono il Rettore, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico. Sono organi consultivi con poteri di proposta la Consulta d’Ateneo, il Consiglio degli studenti ed il Consiglio del personale tecnico-amministra-tivo. Organo di controllo il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Rettore viene eletto fra i professori straordinari ed ordinari dell'Università e dura in carica per un triennio accademico; presie-de il Consiglio d’Amministrazione, il Senato Accademico e la Consulta d’Ateneo, ne coordina l'attività e dà esecuzione alle ri-spettive deliberazioni; egli inoltre cura l’osservanza delle norme dell’ordinamento universitario ed esercita l'autorità disciplinare.
Il Senato Accademico è un organo collegiale con compiti di programmazione per lo sviluppo dell’Ateneo e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca; suddivide fra le facoltà i posti di personale docente e ricercatore assegnati all’Ateneo; stabilisce annualmente il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea e di diploma.
Il Consiglio d’Amministrazione è un
organo collegiale che dura in carica per un
triennio accademico; sovrintende alla gestio-ne economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo. Ne fanno parte anche i rappresentanti eletti dagli studenti dell’Ateneo.
La Consulta d’Ateneo, composta di otto membri nominati dal Rettore, ha poteri di proposta in merito allo sviluppo e all’organizzazione dell’Ateneo.
Il Consiglio degli studenti, composto da diciotto membri elettivi e dai cinque rappresentanti degli studenti nel consiglio d’amministrazione, dura in carica due anni ed ha funzioni consultive su ogni proposta che riguardi in modo preminente gli studenti.
Il Consiglio del personale tecnico- am-ministrativo è un organo collegiale che dura in carica tre anni: formula proposte ed esprime pareri su quanto attiene al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.
Il Collegio dei revisori dei conti, che dura in carica tre anni, è un organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Università.
Gli Organi di governo della Facoltà sono il Preside, il Consiglio di Facoltà ed i Consigli di Corso di Laurea.
Il Preside viene elettro fra i professori straordinari ed ordinari della Facoltà e dura in carica un triennio accademico. Il Preside presiede il Consiglio di Facoltà, notifica le deliberazioni al rettore, partecipa alle sedute del senato accademico, vigila sulla disciplina scolastica.
Il Consiglio di Facoltà è un organo colle-giale del quale fa parte anche una rappre-sentanza degli studenti della Facoltà; prov-vede alla chiamata dei professori universita-ri, alla distribuzione dei compiti e del carico didattico, propone modifiche all’ordinamento didattico.
I Consigli dei Corsi di Laurea sono organi collegiali dei quali fanno parte anche rappre-sentanze elette dagli studenti; hanno il com-pito di provvedere all’organizzazione della didattica ed all’approvazione dei piani di stu-dio. Sono presieduti da un presidente che dura in carica tre anni accademici.
28
Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario
L’Azienda Regionale per il diritto allo stu-dio universitario (Arestud) e l'Università hanno da tempo stretto una importante collaborazione in materia di diritto allo studio. Il sistema di aiuto agli studenti universitari ha l’obiettivo di facilitare il cammino verso la laurea degli studenti meno abbienti e più meritevoli. In particolare, viene predisposto un ‘Bando Be-nefici’ annuale, disponibile dal 25 giugno 2007 presso l'Ufficio Benefici, le torrette, le segreterie studenti e l’Informastudenti (consultabile al sito www.arestud.unimore.it) (e-mail: [email protected])
Gli studenti interessati, in possesso congiunto di specifici requisiti di merito e di condizioni economiche della famiglia, posso-no ottenere una borsa di studio, il cui importo viene differenziato anche in base alla condizione di studente ‘fuori sede’, ‘pen-dolare’ e ‘residente’.
I benefici erogati dall’Azienda sono: Borse di studio Esonero dal pagamento della tassa re-
gionale Servizio abitativo Servizio di ristorazione Contributi per la partecipazione a
programmi di mobilità internazionale Contributi per il trasporto urbano Collaborazioni studentesche retribuite● Posti alloggio.● Servizio di ristorazione presso mense
convenzionate.
Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO BENEFICI STUDENTI
Sede di ModenaVia Vignolese, 671/1- Campus Universitario 41100 ModenaTel. 059413751 - 059413702Fax. 059413755 - 059413750e-mail: [email protected]
Sede di Reggio EmiliaVia Mazzini, 6 – 4° piano42100 Reggio EmiliaTel. 0522406333Fax. 0522540498
e-mail: [email protected]: dal 25 giugno al 28 settembre 2007: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9.00 - 12.30 e martedì 9.00-12.30 e 15.00-17.00. Dal 1 ottobre 2007 al 24 giugno 2008: martedì, giovedì, venerdì 9.30-13.00.
Chiusura dal 24 al 28 dicembre 2007.
Servizio abitativo● Studenti che si iscrivono al primo
anno: 25 agosto 2006.● Studenti iscritti ad anni successivi al
primo: 11 agosto 2006.
Principali scadenze:
Servizio abitativo Studenti che si iscrivono al primo
anno: 24 agosto 2007. Studenti iscritti ad anni successivi al
primo: 10 agosto 2007.
Tutti gli altri benefici Studenti iscritti al primo anno: 27
settembre 2007. Studenti iscritti ad anni successivi al
primo: 20 settembre 2007
Contribuzione differenziata di tasse e contributi universitari (riduzione pagamento 2^ rata)Per tutti gli studenti: 6 novembre 2007
Interventi personalizzati per studenti diversamente abili6 novembre 2007
AttenzioneGli studenti che presentano domanda bene-fici ed hanno i requisiti per l’idoneità alla borsa di studio sono tenuti a pagare, ai fini dell’iscrizione, solo la tassa regionale per il diritto allo studio che sarà rimborsata sulla base delle graduatorie di idoneità alla borsa di studio del 13 novembre 2007. In caso di non idoneità alla borsa di studio, gli studenti dovranno pagare anche la prima rata delle tasse universitarie entro il 1° febbraio 2008, con applicazione di mora per ritardato pagamento. La mora non sarà applicata agli studenti fuori corso non idonei che regolarizzeranno il pagamento entro il 2 gennaio 2008.
29
Ufficio orientamento allo studio universitario
L’Ufficio Orientamento allo Studio Universitario gestisce servizi e promuove attività di orientamento alla scelta del corso di studi e di aiuto alla persona nel momento della transizione dalla scuola all’università e durante il percorso degli studi universitari.
Corso Canalgrande, 64 – 41100 ModenaTel. 0592057091 – 0592057092Fax 0592056465e-mail: [email protected]
Viale Allegri, 15 – 42100 Reggio EmiliaTel. 0522522011 Fax 0522522199mail: [email protected]
Informastudenti
È il servizio che ti aiuta a:● cercare ed elaborare le informazioni sui
contenuti dell’offerta formativa;● informarti sulle iniziative di
orientamento: importanti occasioni per confrontarti con docenti, studenti ed operatori del servizio orientamento;
● prenotare un colloquio con il Consulente di Orientamento o con il Referente accogliente studenti diversamente abili;
● conoscere a) le modalità di iscrizione ai corsi, le agevolazioni legate al diritto allo studio, le modalità di accesso ed immatricolazione degli studenti stranieri, i trasferimenti ed i passaggi di corso, il riconoscimento dei crediti, ecc. b) l’organizzazione didattica dei corsi (calendario lezioni, frequenza, calendario appelli, ecc.; c) le attività per il tempo libero;
● consultare e ritirare il materiale informativo: “GO! Guida all’Orientamento”, bandi dei corsi a numero programmato, ecc.
Via Università, 4 – 41100 ModenaTel. 0592057095 Fax 0592056422e-mail: [email protected]
Viale Allegri, 15 – 42100 Reggio EmiliaTel. 0522522010 Fax 0522522199
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico:lunedì e mercoledì : 15.00-17.00; martedì, giovedì e venerdì: 09,30 – 13.30chiusura 24 dicembre ’07 – 4 gennaio ‘08
Consulente d’Orientamento
Se ti trovi in difficoltà nello scegliere il Corso di Studio a cui iscriverti, puoi prenotare uno o più colloqui con il Consulente d’Orientamento che ti aiuta a chiarire i tuoi dubbi e a riflettere sui tuoi interessi, sulle tue attitudini ed aspirazioni, per individuare, insieme a te, il percorso universitario più coerente con le tue aspettative. Al Consulente possono rivolgersi, inoltre, tutti gli studenti dell’Università che si trovino in difficoltà nel proseguire il percorso di studio intrapreso. I colloqui sono gratuiti e si svolgono presso le sedi dell’Ufficio Orientamento. Puoi accedere al servizio fissando l’appuntamento direttamente con il Consulente o presso lo Sportello Informastudenti.
Corso Canalgrande, 64 – 41100 ModenaTel. 0592057092 Fax 05920564mail: [email protected]
Viale Allegri, 15 – 42100 Reggio EmiliaTel. 0522522020 Fax 0522522199e-mail: [email protected]
Referente Accogliente
Il referente accogliente per gli studenti diversamente abili, affiancato da altre figure presenti nell’Ateneo, ti aiuta nella scelta del Corso di Studio tenendo conto delle tue abilità, dei tuoi interessi e delle competenze che hai acquisito nella scuola media superiore.
Via Vignolese, 671 – 41100 ModenaTel. 059 413716 – Fax 059 413755Viale Allegri, 15 – 42100 Reggio EmiliaTel. 0522522020 - 0522522199e-mail: [email protected]
30
Programmi annuali a.a. 2007-2008
Lingue e Culture Europee – I annoAntropologia Culturale
Prof. Stefano Boni CFU 6 – 60 ore
Mutuato da Scienze della Cultura
Informatica per le scienze umane - Modulo A+B Prof.ssa Laura Ascari CFU 4 – 20 ore Obiettivi formativiIl Corso intende dotare gli/le studenti/esse di conoscenze e competenze informatiche di base in linea con il curriculum proposto per la disciplina di Informatica Umanistica la quale, sebbe-ne non abbia ancora raggiunto formalmente lo statuto di disciplina autonoma, nondimeno è da anni oggetto di studi e ricerche specifiche sia in Italia sia all'estero dove è comunemente nota con la denominazione Computer and the Humanities. L’obiettivo del corso è dotare gli studenti di strumenti e metodi che consentano loro di rappor-tarsi alle nuove tecnologie non semplicemente come utenti passivi ma come interlocutori attivi in grado di cogliere la trasversalità di alcuni strumenti metodologici comuni alle discipline lin-guistiche e informatiche ed essere consapevoli del contributo che l’umanista può apportare al dialogo tra strutture, rappresentazioni e contenuti nell’ICT. Prerequisiti Nessuno Programma del corsoL’informazione Il concetto di informazione e la teoria della comunicazione. Intersezioni: il teorema di Shan-non e Weaver e lo schema della comunicazione di Jackobson. Il concetto di codice o linguag-gio. La rappresentazione digitale dell’informazione. Il concetto di algoritmo. Concetti di multime-dialità, interattività e ipermedia. Il software Tipi di software; fasi di sviluppo del software; sistema operativo; sistema operativo GUI e non-GUI, software applicativo. La filosofia opensource. Reti informatiche concetto di LAN e WAN. Profili utente, domini e amministrazione del sistema. Concetti di use-rid, password, dominio, rete. Gestire il sistema File- directory- file system. L’organizzazione delle informazioni in memoria. Il pathname. Il for-mato dei file. Compatibilità tra sistemi e applicativi, portabilità dei file di testo. Conversioni di formato. Compressione e decompressione file. Comunicare con la rete: gestione e trasferi-mento documenti estesi ed integrati: gli attachment, il sistema FTP, Telnet.Il sistema Windows Gestione e organizzazione di documenti nel sistema. Le impostazioni del pannello di control-
31
lo, gli strumenti di utilità del sistema. I testi La codifica del testo: i codici utilizzati, la rappresentazione dei caratteri: i font. Font scalari e bitmap. Gli elaboratori di testo Word e Acrobat Writer. Word Formattare un documento secondo le caratteristiche desiderate. Saper gestire in un docu-mento: note a piè di pagina, intestazione e piè di pagina, tabelle, colonne, bordi e sfondo, im-magini, grafici, tabelle Excel, indici e sommario; segnalibro e collegamenti ipertestuali interni ed esterni; punti elenco. Stile personalizzato. Saper utilizzare i modelli. Saper utilizzare gli strumenti di controllo ortografico e grammaticale nonché impostare la scrittura e il controllo in altre lingue. Saper utilizzare il Thesaurus. Saper consultare le statistiche relative al documen-to. Saper impostare combinazione tasti per fonemi lingue altre. Stampa del documento e ge-stione della stampa. Stampa unione. Pratica: L’elaboratore di testo per scrivere una tesina. rappresentare organigrammi, flow-chart, socio-grammi o mappe concettuali. impostare un articolo giornalistico correlato di immagini o grafici. Redigere annunci e inviti. Inviare un attestato di partecipazione a n. nominativi creare una struttura ipertestuale per la leggibilità trasversale di un documento esteso Costruire un layout grafico-testualeAUTOAPPRENDIMENTO Concetti di Base dell’ Information Technology I concetti di Hardware, Software e Information Technology. Tipi di computer e loro utilizzo. Classi di computer e loro applicazioni in termini di costi e velo-cità di elaborazione. Componenti di base di un Personal Computer e loro funzionamento: Scheda madre, CPU, bus, memorie e periferiche. Periferiche di Input/Output: tipologie e funzionalità. Porte di accesso al sistema: porte seriali, parallele, USB. Dispositivi di memoria: memoria di massa, memoria veloce, capacità della memoria. L’orga-nizzazione delle informazioni in memoria: il File System. Il computer nell’applicazione dome-stica: il computer nelle applicazioni d’ufficio, nell’industria, nei servizi, nel commercio e nell’i-struzione: benefici e applicazioni. Il computer nella vita quotidiana: usi tipici. IT e società. Il concetto di Società dell’Informazione e sue implicazioni. Il computer sul lavoro: rispetto delle norme ergonomiche e precauzioni di sicurezza. Sicurezza, diritto d’autore e aspetti giuridici: la sicurezza dei dati, Copyright, Privacy. Virus informatici.Corso B- secondo semestreUsabilità e accessibilità degli strumenti informatici: il concetto di usabilità per gli strumenti, usabilità dei contenuti, ergonomia ed ergonomia cognitiva. L’iniziativa WAI della Pubblica am-ministrazione. La scrittura per il Web: stile e contenuti. Scrivere per chi? Il mito dell’utente medio e il punto di vista dell’utente: tra mediazione linguistica e mediazione interculturale. Digital divide: il ruolo delle tecnologie nei paesi in via di sviluppo.Stili di navigazione e tipologie di utenti Web: searcher, strollers serendipers. Navigazione ca-tegoriale e prototipica. Information overload -censire, catalogare e valutare è possibile?Strategie di ricerca avanzata, i concetti di discovery e retrieval.Motori di ricerca. Metamotori di ricerca. L’utilizzo degli operatori logici, l’analisi della pertinen-za e la selezione delle informazioni. Criteri di valutazione delle fonti: paratesti, riferimenti bibliografici, copyright. Criteri di autenti-cazione della qualità del testo.Reti e società: cyberspazio e realtà virtuale. Il cyberspazio come spazio sociale: le comunità on line, comunità di pratica, comunità di apprendimento. Strumenti e ambienti: piattaforme web-based per la condivisione di materiali. Chat Forum, Blog, un nuovo modo di comunicare.Elementi tecnici:L’utilizzo del browser. Navigazione, bookmarks, impostazione personalizzate. Salvare il risul-tato di una ricerca in diversi formati.
32
Introduzione alle reti. Le reti locali. Internet e il WWW, concetti di URL, HTML, Account, pas-sword, userid, ISP, ADSL, dominio, host. La struttura della rete. Il trasferimento delle informa-zioni. Il protocollo TCP/IP.L’utilizzo della e-mail:mailer e mailbox, mailing list e gestione della posta. Il sistema store and forward. Gestione dello Spam .I virus informatici.Opac Metaopac. Strumenti di presentazione: Power Point.
Testi di riferimentoParte teorica
● F. Ciotti, G. Roncaglia, Il mondo digitale, Ed. Laterza,2000● Dispense fornite a lezione durante il corso● Risorse di rete e materiali digitali le cui indicazioni verranno fornite durante il Corso
verranno resi disponibili all’indirizzo www.lettere.unimo.it/pub accessi autenticati nel-la cartella Informatica Umanistica.
Parte pratica
● S. Rubini, Elaborazione testi, Ed. APOGEO● S. Rubini. Strumenti di Presentazione, Ed. APOGEO
Approfondimenti – facoltativo● Pekka Himanen, L’etica hacker, Feltrinelli, 2003● Carrada, Scrivere per Internet, Lupetti, 2000● Carla Basili, la biblioteca in rete, Bibliografica
Frequenza Per la parte A frequenza consigliata, per la parte B si intenda come frequenza la partecipa-zione allo spazio condiviso dedicato (bscw) al quale occorre iscriversi tramite apposita lista sul sito Web di Facoltà lasciando nome cognome ed indirizzo e-mail di Facoltà. ([email protected]) Programma per i non frequentantiCome per frequentanti Modalità d’esameModulo A: prova pratica; Modulo B: prova orale. Valutazione Idoneità. Valutazione dell’esito di una prova pratica a conclusione del modulo A; valutazione orale a conclusione del modulo B.
Laboratorio di lingua italiana e abilità di studio
Prof. Domenico ProiettiCFU 4 – 32 ore
Obiettivi formativiFornire agli studenti le nozioni scientifiche e tecnico-operative per la comprensione, l’analisi e la schematizzazione di testi (in particolare dei testi di studio), avviandoli alla redazione di testi argomentativi e saggi brevi, anche in prospettiva della stesura della dissertazione di laurea (specialistica).
Prerequisiti Nessuno
33
Programma del corsoIl corso sarà costituito da lezioni ed esercitazioni sul modo di leggere, riassumere e schema-tizzare testi di tipo saggistico e manualistico (abilità di lettura) e sul modo di stendere brevi saggi, relazioni, dissertazioni, ecc. (abilità di scrittura). Tali attività saranno affiancate e inte-grate da una serie di lezioni ed esercitazioni sulle strutture generali della lingua italiana, allo scopo di rinforzare le conoscenze di base nel campo della morfosintassi, dell’ortografia e del-la punteggiatura, e di fornire le cognizioni elementari sulla dimensione testuale della lingua e la tipologia dei testi. Alla parte teorica, in ogni incontro, seguirà una parte di esercitazione su testi forniti dal docente (inseriti anche nello spazio condiviso nel sito Internet di facoltà) e/o su materiali prodotti dagli studenti. Le 30 ore di corso sono così divise:
1) 8 ore sulla lettura e le connesse operazioni di scrittura (glossa, parafrasi, riassunto, schematizzazione, riscrittura, scheda/recensione di testi);
2) 10 ore sulla struttura del verbo e della frase, sulla tipologia dei testi (in partic. sui testi manualistici, su testi saggistici e giornalistico-informativi), su altri aspetti del sistema linguistico e sugli usi della punteggiatura: in questa parte del corso le “informazioni” e i “rafforzamenti” di linguistica prenderanno spunto dalle pratiche di lettura e scrittu-ra già svolte nel Corso di laurea di base e dalle carenze emerse nell’esame della produzione scritta degli studenti;
3) 10 ore: elaborazione di testi originali degli studenti;4) 2 ore prova scritta finale del Laboratorio/Modulo.
Testi di riferimento● F. Sabatini, L’“italiano dell’uso medio”: una realtà tra le varietà linguistiche italiane, in
Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart, a cura di G. Holtus – E. Radtke, Tübingen, Narr, 1985, pp. 154-184;
● F. Sabatini, Lingua e comunicazione, in Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua ita-liana. Guida all’uso del Dizionario, Milano, Rizzoli-Larousse, 2003, pp. 5-30 e 42-47;
● F. Sabatini, Lettera sulla grammatica, in «La Cruscaper voi», 2004;● B. Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, Bari, Laterza, 2003.
N.B.: dei testi di Sabatini è stata depositata, a cura del docente, fotocopia presso l’Ufficio In-formazioni della Facoltà
FrequenzaIl Laboratorio/Modulo ha carattere pratico-applicativo, pertanto la frequenza è obbligatoria: saranno considerati frequentanti gli studenti che avranno partecipato ad almeno 11 dei 15 in-contri in cui il Laboratorio/Modulo è articolato.
Programma per i non frequentantiAgli studenti che non possono frequentare il corso è richiesto, oltre alla preparazione di quan-to indicato nel Programma per i frequentanti, lo studio dei seguenti testi:
● P. D’Achille, L’italiano contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2006, capp. 7 (Sintassi, pp. 155-175) e 9 (Le varietà scritte, pp. 203-223);
● F. Sabatini, Il traduttore e la dimensione testuale dell’italiano, in «Rivista di psicolin-guistica applicata», I (2001), pp. 111-132 (fotocopie fornite dal docente: in distribu-zione presso l’Ufficio Informazioni in Facoltà).
Modalità d’esameper i frequentanti: scritto e orale; per i non frequentanti: orale.
ValutazionePer lo scritto: correttezza e adeguatezza dell’elaborato alle richieste formulate nella traccia; Per l’orale: grado di conoscenza, comprensione e capacità di esposizione-rielaborazione dei
34
testi indicati nel programma.
Letteratura italiana contemporanea
Prof.Franco Nasi – Prof. Duccio TongiorgiCFU 8 – 60 ore
Obiettivi formativiCapacità di contestualizzare i movimenti culturali e le poetiche più rilevanti del Novecento. Conoscenza critica di alcuni dei maggiori poeti italiani del Novecento. Comprensione di un te-sto poetico nei suoi elementi tecnici, strutturali e stilistici. Capacità di analizzare il rapporto re-torica-ideologia-linguaggio nel testo letterario e nelle sue riscritture e traduzioni. Conoscenza delle principali linee del dibattito contemporaneo sulla definizione del canone letterario.
Prerequisiti Conoscenza generale della storia della letteratura italiana come da programma della scuola media superiore. Gli studenti stranieri che non hanno frequentato le scuole superiori in Italia sono pregati di incontrare il docente per concordare modalità di recupero individualizzato.
Programma del corsoPoesia italiana del Novecento Il corso sarà articolato in tre sezioni.
1) Poetica, canone e traduzione: una propedeutica alla poesia (18 ore - prof. Franco Nasi).
2) l rinnovamento del linguaggio poetico tra Otto e Novecento. Lettura di Myricae di Giovanni Pascoli, dell’Antologia dei poeti futuristi, di Il porto sepolto di Giuseppe Ungaretti (22 ore - prof. Duccio Tongiorgi) e di Ossi di Seppia di Eugenio Montale (6 ore - prof. Franco Nasi)
3) La poesia italiana dopo il 1960 ( 14 ore - prof. Franco Nasi)
Testi di riferimentoPer la prima sezione: una dispensa verrà messa a disposizione degli studenti presso l’Ufficio Informazioni della Facoltà o in rete, nel sito web della facoltà (materiali condivisi). Gli studenti dovranno inoltre studiare
● F. NASI, Poetiche in transito, Milano, Medusa, 2004. Per la seconda sezione:
G. PASCOLI, Myricae (si consiglia la lettura di G. PASCOLI, Myricae, introduzione di P. V. Mengaldo, note di Franco Melotti, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli [BUR], 1997) e il saggio di G. Contini, Il linguaggio di Pascoli, in Idem, Varianti e altra lingui-stica, Torino, Einaudi, 1970, pp. 219-45.
G. UNGARETTI, Il porto sepolto, a cura di C. Ossola, Venezia, Marsilio, 2001 (stu-diare anche l’introduzione del curatore).
Da F.T. MARINETTI, Teoria e invenzione futurista, a cura di Luciano De Maria, Mila-no, Mondadori, 1968 (o edizioni successive): Fondazione e Manifesto del Futurismo (pp. 7-14) e il Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp. 46-54). Si studi anche C. SALARIS, Storia del futurismo. Libri, giornali, manifesti, Roma, 1985 (o ediz. suc-cessive), pp. 13-87 (capitolo: Gli anni eroici).
E. MONTALE, Ossi di Seppia, a cura di P. Cataldi e F. D’Amely, Milano, Mondadori, 2003 (studiare anche il saggio di P.V. Mengaldo pubblicato nel volume, oppure R. Luperini, Storia di Montale, Bari, Laterza, 1999, capitolo II).
Per la terza sezione: E. TESTA, Dopo la lirica. Poeti Italiani 1960-2000, Einaudi, Torino, 2005 (in-
troduzione di E. Testa, e le parti relative ai poeti analizzati a lezione)
FrequenzaPer poter sostenere l’esame come frequentante è necessario aver seguito con ragionevole
35
continuità le lezioni (70 % di presenze).
Programma per i non frequentantiGli studenti che non potranno frequentare le lezioni dovranno studiare i seguenti testi: Per la prima sezione:
M. Onofri, Il canone letterario, Bari, Laterza, 2001 A scelta uno dei seguenti:
Bertoni, La poesia. Come si legge e come si scrive, Bologna, Il Mulino, 2006; H. M. Enzensberger, A. Berardinelli, Che noia la poesia, Torino, Einaudi, 2006; L. ANCESCHI, Che cosa è la poesia?, Bologna, Clueb, 1998.
Per la seconda sezione, oltre a tutti i testi indicati nel programma per i frequentanti relativi alla poesia di Pascoli, Ungaretti, Futuristi e Montale, a scelta una delle seguenti antologie:
P.V. Mengaldo (a cura di) Poeti Italiani del Novecento, Milano, Mondadori,1978 N. Lorenzini (a cura di) Poesia del Novecento Italiano, Dalle Avanguardie storiche
alla seconda guerra mondiale, Roma, Carocci, 2002. Dell’antologia scelta lo studente dovrà leggere l’introduzione e le parti relative ai seguenti au-tori: Govoni, Palazzeschi, Gozzano, Sbarbaro, Campana, Saba, Betocchi, Quasimodo, Pen-na, Gatto, Caproni, Bertolucci, Luzi.
Per la terza sezione, oltre all’introduzione di Testa, indicata nel programma per frequentanti, gli studenti sono tenuti a leggere le parti antologizzate realtive ai seguenti poeti: Sereni, Zan-zotto, Sanguineti, Rosselli, Baldini, Conte, Cavalli, Valduga, Magrelli.
Modalità d’esameEsame orale
Lingua Francese
Prof. Claudio CostantiniCFU 10 – 60 ore
Obiettivi formativiLo studente sarà guidato verso l'acquisizione di buone competenze interpretative ed espressi-ve in lingua francese. Attraverso la realizzazione di progressi nelle sue conoscenze linguisti-che e culturali, graduati in relazione al livello di partenza ma tendenti ad uno standard qualita-tivo elevato, dovrà giungere a disporre degli strumenti necessari per identificare ed enunciare i concetti presenti in testi di tipologie e ambiti diversi, per esprimere una riflessione sui mecca-nismi che determinano l'efficacia del testo, per parafrasarne e commentarne il contenuto e il messaggio. Nello stesso tempo avrà modo di apprendere (o di consolidare) gli elementi fon-damentali della lingua francese sul piano fonetico, grammaticale e lessicale, nonché di svilup-pare gradualmente la capacità di organizzazione di un discorso, orale e scritto, avente le ca-ratteristiche della chiarezza, della correttezza e dell'efficacia. Le modalità e gli obiettivi del corso sono concepiti in funzione di una più ampia finalizzazione, propria del Corso di Laurea. Essi mirano alla formazione di futuri laureati in grado sia di orien-tarsi con sicurezza nella complessità di un mondo professionale sempre più basato su inter-scambi fra Stati, che dotati di caratteristiche intellettuali e critiche tali da permettere loro di svolgere le diverse mansioni in spirito di autonomia e responsabilità.
Prerequisiti Il corso si rivolge sia a studenti che già conoscono almeno le basi della lingua francese che ai principianti, per i quali si raccomanda comunque una partecipazione particolarmente attiva e costante, tesa a raggiungere in tempi accettabili un livello di competenze sufficiente.
Programma del corso
36
Progressivo approccio alle diverse realtà della struttura della lingua francese. Studio di testi argomentativi, narrativi, descrittivi, teatrali e poetici appartenenti ad ambiti diversi e tali da sti-molare l'esigenza di interpretare correttamente il messaggio in relazione anche ai procedi-menti espressivi e al contesto socio-culturale, in una prospettiva sincronica e diacronica.Lettura e analisi di testi integrali. Attività di presa di appunti, di produzione orale guidata e li-bera, di sintesi e commento scritto. Il Corso ufficiale, di 60 ore, procede in parallelo con attività di lettorato incentrate sullo studio progressivo e metodico di fonetica, grammatica e lessico, i cui risultati partecipano a determi-nare la valutazione complessiva dello studente.
Testi di riferimento ``Dossier'' elaborato dallo studente contenente appunti, testi forniti direttamente dal
docente, documenti oggetto di ricerca autonoma. Lettura di opere integrali (almeno tre) in lingua originale scelte tra quelle proposte dal
docente, una delle quali corredata da audio-cassetta per attività orali. H. Walter, Le français dans tous les sens, Paris, Le Livre de Poche, 1988. L. Schena, Outils de grammaire, Napoli-Milano, Morano Editore, 1993. Dizionari bilingue e monolingue.
FrequenzaLa partecipazione alle lezioni non è da intendersi come mero assolvimento di un obbligo for-male, ma risulterà essenziale in vista delle finalità formative del corso e del tipo di verifica pre-visto. Sarà comunque cura del docente predisporre piani di studio alternativi con gli studenti impossibilitati a frequentare, tenendo conto delle singole realtà e nel rispetto degli obiettivi co-muni.
Programma per i non frequentantiRicerche autonome sui materiali in programma. Contattare il docente.
Modalità d’esameLo sviluppo delle lezioni metterà gli studenti in condizione di elaborare, attraverso sistemati-che prese di appunti e attività su testi e contenuti proposti, un “dossier” personale contenente l'arsenale di strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il docente avrà cura di sollecitare la partecipazione e sarà disponibile per costanti messe a fuoco delle esi-genze e dei risultati conseguiti. La prova scritta, il cui superamento è indispensabile per acce-dere all’orale, verterà sul programma del lettorato e su quello del corso ufficiale. La prova ora-le verterà sui testi e materiali vari comunicati dal docente e la cui lista è depositata in copiste-ria.
ValutazioneSaranno misurate e valutate le abilità e le conoscenze acquisite in relazione agli obiettivi. Possibilità di incontri preparatori di controllo parziale e in itinere delle competenze sviluppate.
Lingua Inglese A-L
Prof. Giancarlo Gagliardelli CFU 10 – 60 ore
Obiettivi formativi Il corso intende condurre all’acquisizione di strumenti teorici e metodologici per l’analisi de-scrittiva della lingua inglese. Oggetto di studio saranno i sotto-sistemi: fonologico (in particola-re la divaricazione fra il sistema dei suoni della lingua inglese e quello della loro rappresenta-zione grafica), morfologico, sintattico, semantico-lessicale, nonché il confronto costante con quelli dell’italiano e di altre lingue moderne. L’allenamento alla riflessione rigorosa sui ‘fatti di lingua’, dovrebbe agevolare il raggiungimento di un ragionevole livello di consapevolezza lin-
37
guistica.
PrerequisitiLa frequenza, nella scuola superiore, di un corso aggiornato di grammatica descrittiva dell’in-glese.
Programma del corsoFonetica e Fonologia: La scelta dello standard inglese - Lo standard italiano - Foni, Fonemi, Allòfoni - Gli alfabeti fonetici - Cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato fonatorio - Vocali e Consonanti - I fonemi dell'italiano - I fonemi dell'inglese - I due sistemi a confronto - Studio dei singoli fonemi segmentali - Fonemi soprasegmentali: accento, ritmo, intonazione.Grammatica dell'enunciato: Invariante vs. Effetti del senso. Tense e Time - La nozione verbo - Presente e Preterito - Invariante e usi di 0/S/D - L'operatore TO - Modalizzazione, modalità, modali. Modalità assertiva, interrogativa, negativa, ingiuntiva, riassertiva, epistemica, deonti-ca, dinamica - Riasserzione vs. enfasi - L'operatore DO - L'Aspetto verbale: imperfettivo, per-fettivo, perfetto - Il Perfetto inglese: di risultato, di esperienza, di persistenza, di "passato re-cente" - BE e la caratterizzazione del Soggetto - Invariante e usi di BE +ING - HAVE e la lo-calizzazione del Predicato - Invariante e usi di HAVE +EN - L'espressione della futurità in inglese - La diàtesi passiva.Grammatica del nome: La nozione nome - Determinanti - Quantificatori - Pro-forme - Relazio-ni fra nomi: NN, N's N, N of N - Altri operatori notevoli.Grammatica dell'enunciato complesso: Coordinazione – Subordinazione.
Testi di riferimento G. Gagliardelli, The words of an Economist, Pitagora, Bologna, 1997. G. Gagliardelli, Elementi di grammatica enunciativa della lingua inglese, CLUEB,
1999. G. Gagliardelli, Avviamento allo studio dei fenomeni prosodici dell’inglese. Accento
Ritmo Intonazione, Pitagora, Bologna, 2004.
Testi di cui è consigliata la lettura o la consultazione: A.L. & G. Lepschy, La lingua Italiana: storia, varietà dell’uso, grammatica, Bompiani,
Milano M. Maiden, & C.Robustelli, A Reference Grammar of Modern Italian, Arnold, Londra. L. Serianni, Grammatica Italiana, Utet Libreria, Torino
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è normalmente presupposta, in quanto permette di acquisire in modo guidato orientamenti fondamentali che permettono di raggiungere nei tempi previsti gli obiettivi formativi proposti e dichiarati per l’insegnamento. In casi motivati, lo studente può chiedere, all’inizio del corso, di essere dispensato dalla frequenza concordando un program-ma per non-frequentanti con i docenti. Si considerano frequentanti gli studenti che seguono almeno il 75% delle lezioni.
Modalità d’esameL’esame finale consta in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta, sotto forma di test di completamento di frasi, di cloze procedures, di quesiti a scelta multipla, ecc., avrà come oggetto gli argomenti trattati dai docenti nelle lezioni frontali e dai collaboratori linguistici nel corso dei lettorati. La prova orale, che si sostiene con il docente di cui si sono frequentate le lezioni, verte sul programma svolto da quest’ultimo.
ValutazioneE’ ammesso a sostenere la prova orale chi ha superato la prova scritta riportando un voto di almeno diciotto/30. Il voto meritato nella prova orale fa media col voto della prova scritta e co-stituisce il voto finale che in sede d’esame sarà riportato nel processo verbale e nel libretto dello studente.
38
Lingua Inglese M-Z
Prof.ssa Franca Poppi CFU 10 – 60 ore
Obiettivi formativi Il corso intende condurre all’acquisizione di strumenti teorici e metodologici per l’analisi de-scrittiva della lingua inglese. Oggetto di studio saranno i sotto-sistemi: fonologico (in particola-re la divaricazione fra il sistema dei suoni della lingua inglese e quello della loro rappresenta-zione grafica), morfologico, sintattico, semantico-lessicale, nonché il confronto costante con quelli dell’italiano e di altre lingue moderne. L’allenamento alla riflessione rigorosa sui ‘fatti di lingua’, dovrebbe agevolare il raggiungimento di un ragionevole livello di consapevolezza lin-guistica. PrerequisitiLa frequenza, nella scuola superiore, di un corso aggiornato di grammatica descrittiva dell’in-glese.
Programma del corsoFonetica e Fonologia: La scelta dello standard inglese - Lo standard italiano - Foni, Fonemi, Allòfoni - Gli alfabeti fonetici - Cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato fonatorio - Vocali e Consonanti - I fonemi dell'italiano - I fonemi dell'inglese - I due sistemi a confronto - Studio dei singoli fonemi segmentali - Fonemi soprasegmentali: accento, ritmo, intonazione.Grammatica dell'enunciato: InvarianteVs. Effetti del senso. Tense e Time - La nozione verbo - Presente e Preterito - Invariante e usi di 0/S/D - L'operatore TO - Modalizzazione, modalità, modali. Modalità assertiva, interrogativa, negativa, ingiuntiva, riassertiva, epistemica, deonti-ca, dinamica - Riasserzione vs. enfasi - L'operatore DO - L'Aspetto verbale: imperfettivo, per-fettivo, perfetto - Il Perfetto inglese: di risultato, di esperienza, di persistenza, di "passato re-cente" - BE e la caratterizzazione del Soggetto - Invariante e usi di BE +ING - HAVE e la lo-calizzazione del Predicato - Invariante e usi di HAVE +EN - L'espressione della futurità in inglese - La diàtesi passiva.Grammatica del nome: La nozione nome - Determinanti - Quantificatori - Pro-forme - Relazio-ni fra nomi: NN, N's N, N of N - Altri operatori notevoli.Grammatica dell'enunciato complesso: Coordinazione – Subordinazione.
Testi di riferimento G. Gagliardelli, The words of an Economist, Pitagora, Bologna, 1997. G. G. Gagliardelli, Elementi di grammatica enunciativa della lingua inglese, CLUEB,
1999. G. Gagliardelli, Avviamento allo studio dei fenomeni prosodici dell’inglese. Accento
Ritmo Intonazione, Pitagora, Bologna, 2004.
Testi di cui è consigliata la lettura o la consultazione: A.L. & G. Lepschy, La lingua Italiana: storia, varietà dell’uso, grammatica, Bompiani,
Milano M. Maiden, & C.Robustelli, A Reference Grammar of Modern Italian, Arnold, Londra. L. Serianni, Grammatica Italiana, Utet Libreria, Torino
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è normalmente presupposta, in quanto permette di acquisire in modo guidato orientamenti fondamentali che permettono di raggiungere nei tempi previsti gli obiettivi formativi proposti e dichiarati per l’insegnamento. In casi motivati, lo studente può chiedere, all’inizio del corso, di essere dispensato dalla frequenza concordando un program-ma per non-frequentanti con i docenti. Si considerano frequentanti gli studenti che seguono almeno il 75% delle lezioni.
39
Modalità d’esameL’esame finale consta in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta, sotto forma di test di completamento di frasi, di cloze procedures, di quesiti a scelta multipla, ecc., avrà come oggetto gli argomenti trattati dai docenti nelle lezioni frontali e dai collaboratori linguistici nel corso dei lettorati. La prova orale, che si sostiene con il docente di cui si sono frequentate le lezioni, verte sul programma svolto da quest’ultimo.
ValutazioneE’ ammesso a sostenere la prova orale chi ha superato la prova scritta riportando un voto di almeno diciotto/30. Il voto meritato nella prova orale fa media col voto della prova scritta e co-stituisce il voto finale che in sede d’esame sarà riportato nel processo verbale e nel libretto dello studente.
Lingua spagnola
Prof.ssa Silvia BettiCFU 10 – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso di Lingua Spagnola intende portare gli studenti alla conoscenza di alcuni degli aspetti fondamentali della lingua e della cultura spagnola e ispanoamericana.
PrerequisitiNessuno
Programma del corsoLingua spagnolaIl corso di Lingua Spagnola, annuale, si propone di introdurre gli studenti alla lingua e cultura spagnola. Mediante lezioni frontali si fornirà una panoramica della lingua spagnola attraverso lineamenti storici e le aree di diffusione della lingua (spagnolo peninsulare e spagnolo d’Ame-rica). Si parlerà delle altre lingue ufficiali della Spagna (catalano, basco, galiziano), dello spa-gnolo negli Stati Uniti e del fenomeno dello spanglish.In sintonia con gli obiettivi dei due corsi di laurea a cui si rivolge (Lingue e Culture Europee e Scienze della Cultura) questo corso presterà attenzione contemporaneamente agli aspetti lin-guistici, culturali e storici propri dei due corsi di laurea, in modo da preparare lo studente ad affrontare il secondo anno di spagnolo, in cui tali aspetti verranno approfonditi.
Lingua spagnola – parte linguistica (LETTORATO)Si consiglia agli studenti di frequentare le lezioni di lettorato tenute dalle Docenti di lingua ma-dre, lezioni che intendono fornire e consolidare le strutture morfosintattiche e comunicative di base, attraverso lo sviluppo delle quattro macroabilità (comprensione orale e scritta ed espressione orale e scritta).Testi di riferimento
● Alatorre, Antonio, Los 1001 años de la lengua española, Madrid, FCE, 2003.● Berschin, H.-Fernández-Sevilla, J.-Felixberger, J., La lingua spagnola- Diffusio-
ne, storia, struttura, Taravacci, P. (ed. it.), Firenze, Le Lettere, 1999.● Betti, Silvia, Apuntes sobre el español de ayer y de hoy, Modena, Il Fiorino,
2006, 2^edizione.● Canepari, Luciano, Introduzione alla fonetica,Torino, Piccola Biblioteca Einaudi,
1979, pp. 268 – 277.● Fontanella de Weinberg, M.Beatriz, El español de América, Madrid, MAPFRE,
1993 (2°edizione). ● Grijelmo, Álex, La seducción de las palabras, Madrid, Taurus, 2004.
40
● Henríquez Ureña, Pedro, Storia della cultura nell’America Spagnola, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1961 (2°edizione).
● Lodares, Juan R., El paraíso políglota, Madrid, Taurus, 2000.● Lodares, Juan R., Gente de Cervantes, historia humana del idioma español,
Madrid, Taurus, 2001.● Nooteboom, Cees, Verso Santiago. Itinerari spagnoli, Milano, Feltrinelli, 2001.● Quesada Marco, Sebastián, España siglo XXI, Madrid, Edelsa, 2004.● Siguan, Miquel, España plurilingüe, Madrid, Alianza Editorial Universidad, 1992. ● Todorov, Tzvetan, La conquista dell’America. Il problema dell’”altro”, Torino, Ei-
naudi, 1992.
Testi di riferimento - LETTORATOI titoli dei testi in uso durante il lettorato saranno comunicati dalle docenti il primo giorno di le-zione.
*Eventuali modifiche e/o integrazioni al programma presentato saranno comunicate agli stu-denti durante le lezioni.
DIZIONARI consigliati● AA.VV., Clave, diccionario de uso del español actual, SM, Madrid, ultima edizione;
MONOLINGUE● AA.VV., Gran diccionario de la lengua española, Madrid, SGEL, ultima edizione;
MONOLINGUE● ALVO RIGUAL - GIORDANO, Diccionario italiano (italiano-español; español- italia-
no), Barcellona, Herder, ultima edizione;Diccionario Salamanca de la lengua española, Santillana, Madrid 1996; MONOLINGUE
● Tam, Laura, Dizionario spagnolo-italiano, italiano-spagnolo, Milano, Hoepli, ultima edizione.
FrequenzaLa regolare frequenza alle lezioni è normalmente presupposta per tutti gli studenti.
Programma per i non frequentantiNel caso di motivati impedimenti, gli studenti sono pregati di presentarsi ad un ricevimento con la docente per concordare un programma alternativo.
Modalità d’esameL’esame prevede una prova scritta in lingua ed una prova orale in lingua sui temi affrontati durante il lettorato da sostenere con i Collaboratori linguistici; superate queste due prove, in ogni loro parte (es. esercizio a, b, c, ecc.), si accede all’esame orale di Lingua Spagnola che consiste in un colloquio con la docente del corso principale. Per il primo anno la lingua veicolare è l’italiano, ma gli studenti che lo vorranno, potranno utilizzare lo spagnolo (o espor-re in lingua parti del programma a scelta).
ValutazioneLa valutazione finale del corso principale sarà su tutto il materiale fornito dalla docente duran-te i semestri (appunti del corso e materiale distribuito nel corso delle lezioni) e terrà conto del lavoro svolto durante i lettorati (eventuali verifiche intermedie scritte e orali da sostenere du-rante i semestri con i Collaboratori linguistici) e delle prove finali in lingua.
Lingua tedesca
Prof. Ernst KretschmerCFU 10 – 60 ore
41
Obiettivi formativiIl corso è inteso a introdurre gli studenti alla lingua e alla cultura tedesca. L’aspetto linguistico più importante è quello di preparare gli studenti a una lettura “autonoma” di un testo, ossia a una strategia di lettura che prende in considerazione la molteplicità dei fattori linguistici, storici e situativi che determinano la comprensione di un testo. Si parte dal presupposto che l’auto-nomia del lettore è strettamente legata alla sua consapevolezza linguistica. Un’attenzione particolare sarà data allo sviluppo della competenza “inferenziale” del lettore che riguarda le dimensioni “intra-linguale”, “inter-linguale” ed “extra-linguale” (Carton 1971). La dimensione “inter-linguale” della competenza inferenziale sarà trattata non solo sotto l’aspetto delle comu-nanze tra tedesco e italiano, che risalgono in gran parte alle loro radici indoeuropee e latine, ma anche sotto l’aspetto della comunità delle lingue europee (Wandruszka 1990).
Prerequisiti Conoscenze di base della lingua tedesca.
Programma del corsoLa scelta dei testi su cui si baseranno le riflessioni linguistiche segue anche l’obiettivo di intro-durre, nello stesso tempo, alla cultura tedesca. Si parte dai tre obiettivi per una nazione tede-sca – “Einigkeit und Recht und Freiheit” –, formulati da Hoffmann von Fallersleben nel 1841, quando una tale nazione ancora non esisteva, per arrivare alla Costituzione della Repubblica Federale del 1949, nata per escludere per sempre la ripetizione degli orrori del nazismo: “Die Würde des Menschen ist unantastbar.”
Testi di riferimentoIl corso si articola in 30 unità didattiche, ognuna dedicata ad un argomento linguistico-cultura-le, che prevedono, oltre alle lezioni in classe: a) un modulo di esercizi scritti, e b) la lettura di brani complementari, aderenti ai temi trattati in classe. Ai testi e ai moduli si accede attraver-so il server della Facoltà. Si consigliano inoltre:
Blasco Ferrer, Eduardo (1999), Italiano e tedesco. Un confronto linguistico. Torino: Paravia.
Gellert, Anne (2000), Großer Lernwortschatz, Ismaning: Hueber. Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (2001), Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für
den Ausländerunterricht, Berlin, München: Langenscheidt. Jaager Grassi, Gisela (2006), Grammatica tedesca. Manuale di morfologia ed ele-
menti di sintassi, Milano: Hoepli. Lübke, Diethard (1998), Wortschatz Deutsch. Deutsch-Italienisch, Ismaning: Hue-
ber. Saibene, Maria Grazia (2002), Grammatica descrittiva della lingua tedesca, Roma:
Carocci.
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è normalmente presupposta. In casi motivati, lo studente può chie-dere, all’inizio del corso, di essere dispensato dalla frequenza concordando un programma per non-frequentanti con il docente. Si considerano frequentanti gli studenti che seguono al-meno il 75% delle lezioni.
Modalità d’esameScritto e orale
ValutazioneCon prova finale
42
Linguistica generale e applicata
Prof.ssa Emilia CalaresuCFU 6 – 60 ore
Metodi didattici Le lezioni saranno di tipo frontale, ma all'interno del corso sono previste anche attività di con-fronto e di esercitazione collettiva.
Obiettivi formativiL'attività didattico-formativa del corso ha come obiettivi principali: 1) lo sviluppo della consa-pevolezza linguistica degli studenti, ovvero la capacità di ragionare sulla lingua e di affinare la propria consapevolezza su forme e funzioni linguistiche (sia per quanto riguarda la propria lin-gua madre che quelle in fase di apprendimento); 2) lo sviluppo di competenze disciplinari specifiche, ovvero: a) apprendimento del linguaggio proprio della disciplina di studio; b) cono-scenza dei meccanismi di funzionamento del linguaggio in generale e di lingue specifiche; c) acquisizione degli strumenti necessari alla descrizione e all'analisi critica della comunicazione verbale.
Prerequisiti Si presuppone che gli studenti iscritti all'università abbiano già le competenze grammaticali normalmente previste dai programmi scolastici sia della scuola dell'obbligo che della scuola superiore, ovvero la capacità di distinguere le diverse categorie grammaticali di una frase (nome, verbo, preposizioni, ecc.) e le sue parti logiche (soggetto, predicato, ecc.) ed essere dunque in grado di svolgere sia l'analisi grammaticale che l'analisi logica di frasi semplici e complesse. Si tratta di competenze di base da cui il percorso universitario intrapreso e, in par-ticolare, il corso di Linguistica generale e applicata non può prescindere.Agli studenti che, per qualsiasi ragione, non si sentissero sicuri o adeguatamente preparati su queste competenze di base si consiglia la rilettura attenta di un manuale di grammatica italia-na delle scuole superiori e lo svolgimento delle relative esercitazioni (o, per gli studenti stra-nieri, del manuale di grammatica della propria lingua nativa impiegato nelle scuole superiori). Un’ottima grammatica di riferimento per la lingua italiana è comunque il volume Grammatica Italiana. Italiano comune e lingua letteraria di Luca Serianni (con la collaborazione di Alberto Castelvecchi), editore UTET, Torino, 1989 e successive edizioni.
Programma del corsoParte generale e introduttiva: Fondamenti di linguistica generale e presupposti per lo studio scientifico del linguaggio e delle lingue; indagine linguistica ai diversi livelli della lingua (da quello fonetico a quello testuale) in prospettiva pragmatica. Parte applicativa e monografica: la variazione legata alle diverse modalità scritte o parlate: Rapporti tra oralità e scrittura, e specificità linguistico-testuali di scritto e parlato. Tecniche di rilevazione di testi parlati. Analisi di testi scritti e parlati.
Testi di riferimento
Per i frequentanti: Giorgio Graffi & Sergio Scalise, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica,
Bologna, Il Mulino, 2002 (e successive edizioni); Carla Bazzanella, Le facce del parlare, Firenze, La Nuova Italia, 1994 (e successive
edizioni); Cecilia Andorno, Che cos’è la pragmatica linguistica, Roma, Carocci, 2005; Il capitolo "Parlare e scrivere", tratto dal volume di: Andrea Bernardelli e Roberto Pel-
lerey, Il parlato e lo scritto, Milano, Bompiani, 1999 (pp. 53-93).
Ulteriori indicazioni bibliografiche per gli approfondimenti di tematiche specifiche verranno date nel corso delle lezioni.
43
Gli studenti stranieri in Erasmus sono pregati di contattare la docente prima del corso, o co-munque almeno nelle prime settimane di frequenza del corso.
Programma per i non frequentantiSono richiesti gli stessi testi dei frequentanti più l'integrazione con il seguente eserciziario di autoverifica:
Silvia Luraghi e Anna M. Thornton, Linguistica generale: esercitazioni e autoverifica, Roma Carocci, 2004 (e successive edizioni).
Gli studenti non frequentanti o a tempo parziale, prima di presentarsi all'esame, devono met-tersi in contatto per tempo con la docente (o andando direttamente al ricevimento studenti o prendendo con lei un appuntamento via mail: [email protected]). Trattandosi infatti di un corso che prevede specifiche attività applicative (vedi sotto la parte per il superamento del-l'esame) è necessario che i non frequentanti vadano a fare il punto della loro preparazione con la docente PRIMA dell'esame.Gli studenti, sia frequentanti che non frequentanti, potranno concordare con la docente la pre-sentazione di lavori individuali di tipo applicativo (come ad es., raccolta e analisi di testi scritti o parlati di vario tipo) - o comunque programmi individuali di diverso tipo purché direttamente concordati per tempo con la docente.
Modalità di esameProva finale di tipo orale
ValutazionePer il superamento dell'esame gli studenti dovranno mostrare di essere in grado di:
a. esporre e discutere in maniera appropriata le tematiche oggetto del corso, utilizzan-do la terminologia adeguata;
b. avere almeno un minimo di consapevolezza bibliografica sulle tematiche trattate (ov-vero saper indicare almeno i principali autori che si sono occupati dei principali argo-menti oggetto del corso).
c. esemplificare in maniera autonoma e pertinente i diversi fenomeni linguistici trattati; d. fare collegamenti pertinenti; e. effettuare trascrizioni fonetiche e fonologiche di singole parole o gruppi di parole; f. analizzare enunciati o testi sia dal punto di vista della struttura morfosintattica che
dal punto di vista testuale e funzionale; g. Non saranno ammessi allo svolgimento dell'esame gli studenti con programma in-
completo.
Linguistica Italiana
Prof.ssa Cecilia RobustelliCFU 6 – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di sviluppare negli studenti una competenza linguistica di base per quanto riguarda la lingua italiana attraverso la conoscenza delle sue strutture, delle sue varietà e del-la sua storia, nonché una competenza metalinguistica che permetta di elaborare riflessioni sulla lingua stessa, e una competenza comunicativa che assicuri l’utilizzo della lingua nel ri-spetto dei criteri di accettabilità e adeguatezza contestuale.
Prerequisiti Buona conoscenza della grammatica della lingua italiana, della letteratura italiana e della sto-ria italiana dall'epoca romana a oggi
44
Programma del corsoIl corso, della durata di 60 ore di lezione frontale, si articola in tre sezioni dedicate a seguenti argomenti:
1. conoscenze di base necessarie per l’analisi delle strutture dell’italiano contempora-neo e delle sue variazioni diatopiche, diastratiche, diafasiche e diamesiche.
2. rapido profilo di storia della lingua italiana, componente indispensabile della nostra lingua a causa della sua lunga diacronia, con lettura e commento linguistico di alcuni brani tratti da grammatiche del Cinquecento e del Seicento
3. nozioni di base di linguistica testuale e esame di alcune tipologie di testi riscontrabili nell’uso contemporaneo dell’italiano.
Programma dettagliato
Presentazione del corso e della bibliografia. I vari tipi di grammatica: storica, descrittiva, di riferimento, per stranieri. Le varietà del
repertorio. Le lingue d’Europa. Lingue europee di uso colto. Raccomandazioni di Bad Homburg. La politica linguistica italiana. L’italiano come gamma di varietà. Il concetto di conti-
nuum linguistico. Le parlate alloglotte. Diglossia e bilinguismo. Dialettologia italiana. La carta dei dialetti italiani. Le linee La Spezia-Rimini e Roma-
Ancona. Alcune isoglosse. Il gergo. Il linguaggio giovanile. Le lingue speciali: settoriali e specialistiche. L’italiano di oggi: il concetto di standard e ‘l’italiano dell’uso medio’. Elementi di fonetica, fonologia, morfologia, sintassi. Introduzione alla storia della lingua italiana. Stabilità e instabilità nei caratteri originari
dell’italiano. Latino classico, latino volgare, e latino circa romançum. Prime testimonianze volgari. La nascita delle lingue romanze. Mutamenti vocalici e consonantici dal latino al vol-
gare. Dalla sinteticità latina all’analiticità romanza. Lettura e commento di alcuni testi volgari contenuti in Sabatini (1999a) Mutamenti morfologici dal latino al volgare. Il sistema verbale. Caratteristiche sintatti-
che del volgare. La scuola siciliana. Il dolce stil novo. Dante e il il De Vulgari Eloquentia. La nascita della lingua poetica. Petrarca. Il modello linguistico fiorentino. Italiano antico e moderno a confronto: dieci caratteri divergenti. Il Quattrocento e l’Umanesimo. La ‘questione della lingua’ nel ‘500. La nascita della lingua scientifica nel ‘600. Le grandi lingue europee a confronto. Italiano e francese nel ‘700. L’Ottocento e il purismo. L’idea di una lingua nazionale. La politica linguistica dopo l’Unità d’Italia. Manzoni e Ascoli. Il ‘900. I mezzi di comunicazione di massa e la diffusione dell’italiano. L’italiano della comunicazione telematica: e-mail, sms, pagine web. Linguistica testuale: nozioni di coerenza e coesione. Il ‘patto comunicativo’: testi rigidi/espliciti vs testi elastici/impliciti. Conclusione del corso, con chiarimenti agli studenti su argomenti a richiesta.
Testi di riferimento M. Dardano, Nuovo manualetto di Linguistica Italiana, Zanichelli, Bologna, 2005. C. Marazzini, La lingua italiana, Il Mulino, Bologna, 2002 (capitoli V-XIII compresi). C. Robustelli, Grammatici italiani del Cinquecento e del Seicento, Mucchi Editore,
Modena, 2006
45
F. Sabatini, 1985. “L’italiano dell’uso medio: una realtà tra le varietà linguistiche ita-liane”, in Holtus G., Radtke E. (curr.), 1985, Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart, Gunter Narr Verlag, Tübingen, pp. 155-183.
F. Sabatini, 1997. L’italiano: dalla letteratura alla nazione, presso l’Accademia della Crusca , Firenze, 29 pp.
F. Sabatini, 1999a. “Origini linguistiche e letterarie d’Italia”, estratto da Storia genera-le della Letteratura italiana, a cura di Nino Borsellino e Walter Pedullà, Motta Edit., pp. 239-270.
F. Sabatini, 1999. “Rigidità-esplicitezza vs elasticità-implicitezza: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi”, in Sabatini F., Skytte G., 1999, Linguistica te-stuale comparativa, Et. Rom. 42, Mus. Tusculanum Press, Copenhagen, pp. 141-172.
FrequenzaE' richiesta la frequenza
Programma per non frequentantiGli studenti non frequentanti dovranno informare la docente all’inizio del corso della loro im - possibilità a frequentare, presentandosi al ricevimento, e concordare un piano alternativo.
Il piano alternativo per i non frequentanti è rappresentato da un carico effettivo di studio indivi-duale superiore a quello cumulato dai frequentanti tra ore di frequenza e ore di studio indivi-duale, essendo questi ultimi facilitati nello studio dall’aver usufruito dell’acquisizione guidata di cui sopra. Pertanto al programma per frequentanti sopra riportato viene aggiunto un testo da concordare in un incontro fra docente e studente.
Modalità d’esameOrale
Sistemi sociali e culture della comunicazione
Prof. Claudio BaraldiCFU 6 – 60 ore
Obiettivi formativiFornire la conoscenza (a) dei concetti fondamentali per la descrizione e la spiegazione dei processi interni alla società, con particolare riferimento alle relazioni che intercorrono tra pro-cessi globali e processi locali e (b) dei fondamenti epistemologici e metodologici degli studi sociologici. Per questo scopo, il corso introduce all’analisi della comunicazione e delle produ-zioni culturali nella comunicazione, permettendo di acquisire capacità di studio critico dei ma-teriali sociologici. In particolare, si focalizza sui concetti diversità delle forme culturali e di co-municazione interculturale, nel quadro della società contemporanea.
PrerequisitiNessuno
Programma del corsoIl programma intende porre le basi per una comprensione generale dei rapporti tra società e culture, considerando in particolare le dinamiche societarie mondiali nel loro intreccio con quelle delle società europee.Il corso introduce anzitutto alcuni concetti fondamentali: comunicazione, individui e comunica-zione, forme e contesti di comunicazione, società, cambiamento socioculturale, cultura e for-me culturali, forme della comunicazione interculturale, significato sociale delle diversità (con diversi esempi specifici). In seguito, esso propone l’analisi delle diverse forme di società e di differenziazione interna alla società, con particolari approfondimenti sulle caratteristiche fon-
46
damentali delle società contemporanee. Su questo sfondo, sarà proposta un’analisi dei rap-porti tra società e culture e della comunicazione interculturale, con un’attenzione particolare per il tema della diversità e delle sue varie espressioni.Il metodo didattico del corso consiste nell’alternanza di fasi di spiegazione a fasi di discussio-ne, basata su stimoli verbali, scritti e visivi forniti dal docente. Attraverso questa metodologia, si intende far scaturire i significati sociologici dall’esperienza diretta delle studentesse e degli studenti, mostrando come la sociologia si occupi di problemi concreti, di diretta esperienza, ma anche come la riflessione teorica su tale esperienza sia essenziale per comprendere i processi sociali e per utilizzare questa comprensione nelle professioni fornite dalla laurea.
Testi di riferimentoFrequentantiFrequentanti sono considerati coloro che raggiungono il 75% delle frequenze alle lezioni. Il programma di esame per i frequentanti prevede un testo fondamentale, che sarà utilizzato e commentato durante le lezioni, e un precorso ulteriore a scelta tra due, che approfondiscono le tematiche affrontate a lezione. 1. C. Baraldi, Comunicazione interculturale e diversità, Carocci, Roma.
2. Percorso a scelta tra 2.1, 2.2, 2.3.2.1 La personalizzazione nella cultura di origine europea.
Harry G. Frankfurt, Le ragioni dell’amore, Donzelli, Roma Anthony Giddens, La trasformazione dell’intimità, il Mulino, Bologna
2.2 La società multiculturale. Enzo Colombo, Le società multiculturali, Carocci, Roma Ian. Nederveen Pieterse, Melange globale, Carocci, Roma
2.3 La mediazione interculturale Ida Castiglioni, La comunicazione interculturale, Carocci, Roma Giovanna Ceccatelli Gurrieri, Mediare culture, Carocci Roma
Frequenza In base alla normativa stabilita dalla Facoltà, coloro che si dichiarano non frequentanti o che comunque non raggiungono la quota del 75% delle frequenze delle lezioni, dovranno portare un programma aggiuntivo.
Programma per i non frequentantiIl programma per non frequentanti equipara il monte ore trascorso a lezione dai frequentanti (equivalenti a 60 ore di frequenza). Il programma è il seguente:Testi obbligatori:
Claudio Baraldi, Comunicazione interculturale e diversità, Carocci, Roma. Ida Castiglioni, La comunicazione interculturale, Carocci, Roma Giovanna Ceccatelli Gurrieri, Mediare culture, Carocci Roma Enzo Colombo, Le società multiculturali, Carocci, Roma
In aggiunta, un testo a scelta tra i seguenti: Harry G. Frankfurt, Le ragioni dell’amore, Donzelli, Roma Anthony Giddens, La trasformazione dell’intimità, il Mulino, Bologna Ian. Nederveen Pieterse, Melange globale, Carocci, Roma
Modalità d’esame Per l’esame finale, sono disponibili due opzioni: 1) esame soltanto orale; 2) esame in due par-ti, scritta e orale. In entrambi i casi, la valutazione ha lo scopo di verificare la conoscenza dei contenuti dei testi studiati e le capacità critiche acquisite grazie allo studio.
47
Storia dell’Europa contemporanea A-L
Prof. Lorenzo BertucelliCFU 8 – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di offrire agli studenti la possibilità di collocare criticamente nel tempo l’in-sieme delle conoscenze storiografiche relative all’Europa del XIX e XX secolo. In particolare il corso muove dall’analisi delle rivoluzioni borghesi della seconda metà dell’Ottocento, si con-centra sui processi di modernizzazione economica, politica e sociale del continente. Un’atten-zione specifica viene assegnata alle grandi cesure rappresentate dai due conflitti mondiali, alla profonda crisi politico-sociale tra le due guerre e alle grandi trasformazioni del secondo dopoguerra (welfare state, consumi di massa), approfondendo i casi nazionali più significativi, le relazioni internazionali e lo sviluppo delle organizzazioni sopranazionali.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso dedica una particolare attenzione ai seguenti aspetti:
1. Il periodo 1860-1918 viene analizzato sia dal punto di vista delle vicende politico-isti-tuzionali dei principali paesi europei (la politica dell’equilibrio in Europa, le questioni nazionali, i movimenti politici), sia da quello dell’evoluzione del sistema economico internazionale: la diffusione del processo di industrializzazione, l’imperialismo nella sua dimensione politica ed economica
2. Per gli anni tra le due guerre sono trattate analiticamente le questioni economiche e sociali e i loro riflessi sull’evoluzione politica europea e mondiale. I tentativi di rico-struzione dell’economia internazionale negli anni ’20, la grande depressione, le di-verse soluzioni alla crisi: liberale, fascista, socialista
3. A partire dalla seconda guerra mondiale il corso si sofferma sulle eredità del conflit-to, analizza le ragioni del declino dell’eurocentrismo, della comparsa di diverse vie alla modernizzazione e della nascita di due blocchi politico-ideologici contrapposti fino al crollo dell’Unione Sovietica nel 1991
Testi di riferimentoLa bibliografia sarà indicata all’inizio delle lezioni
FrequenzaE’ richiesta la frequenza nella misura almeno del 75% di presenza alle lezioni
Programma per i non frequentantiPer i non frequentanti saranno indicate ulteriori letture
Modalità d’esameColloquio finale orale
Storia dell’Europa contemporanea M-Z
Prof. Fabio Degli EspostiCFU 8 – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di offrire agli studenti la possibilità di collocare criticamente nel tempo l’in-sieme delle conoscenze storiografiche relative all’Europa del XIX e XX secolo. In particolare il corso muove dall’analisi delle rivoluzioni borghesi della seconda metà dell’Ottocento, si con-centra sui processi di modernizzazione economica, politica e sociale del continente. Un’atten-zione specifica viene assegnata alle grandi cesure rappresentate dai due conflitti mondiali,
48
alla profonda crisi politico-sociale tra le due guerre e alle grandi trasformazioni del secondo dopoguerra (welfare state, consumi di massa), approfondendo i casi nazionali più significativi, le relazioni internazionali e lo sviluppo delle organizzazioni sopranazionali.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso dedica una particolare attenzione ai seguenti aspetti:
1. Il periodo 1860-1918 viene analizzato sia dal punto di vista delle vicende politico-isti-tuzionali dei principali paesi europei (la politica dell’equilibrio in Europa, le questioni nazionali, i movimenti politici), sia da quello dell’evoluzione del sistema economico internazionale: la diffusione del processo di industrializzazione, l’imperialismo nella sua dimensione politica ed economica
2. Per gli anni tra le due guerre sono trattate analiticamente le questioni economiche e sociali e i loro riflessi sull’evoluzione politica europea e mondiale. I tentativi di rico-struzione dell’economia internazionale negli anni ’20, la grande depressione, le di-verse soluzioni alla crisi: liberale, fascista, socialista.
3. A partire dalla seconda guerra mondiale il corso si sofferma sulle eredità del conflit-to, analizza le ragioni del declino dell’eurocentrismo, della comparsa di diverse vie alla modernizzazione e della nascita di due blocchi politico-ideologici contrapposti fino al crollo dell’Unione Sovietica nel 199
Testi di riferimentoLa bibliografia sarà indicata all’inizio delle lezioni
FrequenzaE’ richiesta la frequenza nella misura almeno del 75% di presenza alle lezioni
Programma per i non frequentantiPer i non frequentanti saranno indicate ulteriori letture
Modalità d’esameColloquio finale orale
49
Lingue e Culture Europee – II anno
Diritto dell’Unione Europea
Prof.ssa Ivana PalandriCFU 4 – 30 ore
Obiettivi formativiIl corso si prefigge lo scopo di far conoscere l’Unione Europea nei suoi aspetti giuridico-istitu-zionali, mediante lo studio delle istituzioni preposte al suo funzionamento, gli atti che queste possono adottare e l’incidenza che il diritto comunitario comporta per gli ordinamenti naziona-li.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoNascita ed evoluzione dell’Unione europea – Le istituzioni dell’Unione Europea – Le fonti del diritto comunitario – La tutela giurisdizionale – Rapporti tra ordinamento comunitario e ordina-mento interno – Il regime linguistico delle istituzioni comunitarie
Testi di riferimentoPer gli studenti frequentanti sarà messa a disposizione una dispensa da parte del docente. La dispensa è reperibile presso la Portineria della Facoltà.
FrequenzaLa frequenza al corso non è obbligatoria. Per essere comunque considerati frequentanti è ne-cessario aver seguito almeno il 75% delle lezioni.
Programma per i non frequentanti
Il programma per i non frequentanti è lo stesso degli studenti frequentanti, esclusa la parte re-lativa al regime linguistico delle istituzioni comunitarie.Il testo per gli studenti non frequentanti è il seguente: Giorgio Gaja, Introduzione al diritto co-munitario, Bari, Laterza, ultima edizione (escluso il capitolo VIII).
Modalità d’esamePer gli studenti frequentanti è prevista una prova intermedia scritta (tre domande aperte sulle prime tre parti della dispensa); mentre la valutazione finale consisterà nella discussione di un caso giurisprudenziale riguardante tutti gli argomenti trattati durante il corso. I tre casi giuri-sprudenziali oggetto della discussione saranno indicati dal docente.
Per gli studenti non frequentanti l’esame consisterà in una prova scritta (tre domande aperte sui temi trattati dal testo di riferimento). La durata della prova scritta è di 90 minuti.
ValutazioneTrattandosi di un esame di diritto la valutazione sarà fatta per il 70% sulla base delle cono-scenze dello studente e per il 30% sulle sue capacità di collegare i vari argomenti studiati.
Informatica per le scienze umane - Modulo C Prof.ssa Laura Ascari
50
CFU 2 Obiettivi formativiDotare i discenti di metodi e strumenti utili per comprendere l’organizzazione delle informazio-ni nelle basi di dati relazionali al fine di poter operare criticamente nella definizione delle ope-razioni di architettura dei contenuti e ricerca, in strutture archivistiche di tipo differente. Prerequisiti Consigliato aver superato l’idoneità di Informatica Umanistica I anno. Programma del corsoBasi di dati. Concetti di base: Database, Campo, Record, Tabella, Indice. Progettare un Data-base. Creare tabelle con campi e attributi appropriati. Navigare in una tabella. Inserire dati in una tabella. Definire una chiave primaria. Impostare un indice. Modificare attributi, dati e cam-pi in una tabella. Definire controlli di formato sui dati in input. Aggiungere o eliminare record nel database. Creare una maschera. Inserire i dati utilizzando una maschera semplice. Mo-dificare una maschera e i suoi attributi (colore sfondo, formattazione testo ecc.) Accedere a un database esistente. Trovare un record sulla base dei criteri assegnati. Creare una query di selezione anche parametrica. Creare un semplice report. Le basi di dati al servizio dell’umanista: archivi,biblioteche digitali e sistemi informativi distri-buiti. Basi di dati: I database relazionali e loro applicazioni:OPAC e METAOPAC I sistemi bi-bliotecari SBN e i sistemi internazionali. Standard descrittivi e stato dei fatti. Il rapporto tra ar-chitettura informativa e informazione. The medium is the message? Risorse locali: Cisab, Cib, Sbp
Testi di riferimento● S. Rubini, Basi di dati, Ed. APOGEO● Risorse di rete e materiali digitali le cui indicazioni verranno fornite durante il Corso
verranno resi disponibili all’indirizzo www.lettere.unimo.it/pub nella cartella Informati-ca Corso C.
FrequenzaFacoltativa
Programma per i non frequentantiCome per frequentanti.
Modalità d’esameProva pratica.
ValutazioneIdoneità.
Istituzioni di Economia ed Economia dell’integrazione europea (M-Z)
Docente da definire CFU 8 – ore 60
Programma da definire
Istituzioni di Economia ed Economia dell’integrazione europea (A-L)
Docente da definire CFU 8 – ore 60
51
Programma da definire
Seminario di Lingua Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Inglese
Prof. Giancarlo GagliardelliCFU 4 – 20 ore
“Questioni di Storia della Lingua Inglese”
Obiettivi formativiFornire ai frequentanti, che hanno già sostenuto l’esame obbligatorio di Lingua Inglese, un complesso di informazioni sulla lingua, che peraltro essi già parlano e scrivono, come prodot-to di una serie ininterrotta di fenomeni evolutivi — dall’ortografia alla semantica, dalla morfolo-gia alla formazione delle parole. In definitiva, grazie agli strumenti di indagine che intende for-nire, il seminario si pone come opportunità di riflessione e di consapevolezza linguistica.
Prerequisiti L’aver frequentato, nella scuola superiore, un corso di grammatica descrittiva dell’inglese.La conoscenza dei fondamenti di fonetica e fonologia dell’inglese e la dimestichezza con i simboli dell’Alfabeto Fonetico Internazionale.Programma del corsoIl seminario ripercorre l’evoluzione della lingua inglese nell’ultimo millennio: evoluzione carat-terizzata dalla drastica semplificazione delle forme flesse della declinazione nominale e ag-gettivale e della coniugazione verbale, ma altresì dalla complessificazione della sintassi e del-la fonologia, insieme a uno straordinario arricchimento del lessico. Per ogni “periodo” in cui tradizionalmente viene suddivisa la storia della lingua, il seminario si sforza di esaminere i principali sottosistemi del “sistema lingua”: fonologico, morfosintattico, lessicale, semantico, senza dimenticare l’ininterrotto dibattito interno al mondo anglofono ri-guardo a questi temi.
Testi di riferimento Bailey, R. W., Images of English: a Cultural History of the Language, Cambridge,
1991. Baugh, A.C., Cable T., A History of the English Language, Prentice-Hall, London,
1978. Bertacca, A., Il Great Vowel Shift, Roma, 1995. Bolton, W.F., A living Language: The History and Structure of English, New York,
1982. Burnley, D., History of the English Language: A Source Book, Longman, London,
1991. Crystal, D., The Cambridge Encyclopaedia of The English Language, Cambridge,
2003. Foster, B., The Changing English Language, London, 1981. Francovich Onesti, N., L’inglese dalle origini ad oggi: le vicende di una lingua,
NIS,1988. Francovich Onesti, N., Digilio M.R., Breve storia della lingua inglese, Carocci, Roma,
2004. Hagège, C., L’homme de paroles, Fayard, Paris, 1985. Jespersen, O., The Growth and Structure of the English Language, Oxford, 1982. Leith, D., A Social History of English, London, 1983. McCrum, R., MacNeil, R., Cran, W.,The Story of English, London, 1992. Quirk, R. & Wren, C.L., An Old English Grammar, Methuen, London, 1957.
52
Scardigli, P., Gervasi, T., Avviamento all’etimologia inglese e tedesca, Le Monnier, Firenze,1978.
Strang, B., A History of English, Methuen, Londra, 1970. Walter, H., L’avventura delle lingue in occidente, Bari, 1988
Frequenza
La frequenza è obbligatoria. Gli studenti che non si presentano ai primi tre incontri o non avranno presenziato al 75% dei lavori seminariali non saranno considerati frequentanti.
Modalità d’esameAlla chiusura del seminario gli studenti dovranno redigere una breve “tesi” (dalle 3000 alle 5000 parole) su un argomento, concordato col docente, affrontato nel corso del seminario.
ValutazioneLa valutazione terrà conto per un 50% della correttezza e appropriatezza linguistica, della coesione e della coerenza, nonché dell’organizzazione strategica delle strutture concettuali, al fine di giudicare la capacità di scrivere in inglese per scopi accademici; per l’altro 50%, del-la capacità di analisi, della quantità e qualità dei dati, e della capacità critica. La “tesi” dovrà contenere la bibliografia dei testi letti, nonché l’eventuale sitografia consultata.
Lingua, cultura ed istituzioni dei paesi di lingua inglese
Prof. Marc Silver, Prof. Davide Mazzi, Prof. Silvia CacchianiCFU 10 – 60 ore
Obiettivi formativiL’obiettivo del corso consiste nel dotare gli studenti di: 1) Strumenti di interpretazione e conte-stualizzazione dei testi, così da renderli consci delle correlazioni tra forma e funzione che ca-ratterizzano i testi in quanto eventi comunicativi all’interno di una varietà di ambiti; 2) Metodi di interpretazione testuale applicabili nella costruzione di una visione critica di una cultura na-zionale quale quella degli Stati Uniti d’America; 3) L’acquisizione di una maggiore solidità espressiva scritta e parlata in lingua inglese.
Prerequisiti Gli studenti iscritti regolarmente al CdL devono aver superato l’esame di Inglese I prima di po-ter dare l’esame di Inglese II.
Programma del corsoLa prima parte del corso offre un'introduzione alla cultura statunitense attraverso una lettura attenta di testi da essa prodotti. La lettura si sofferma su aspetti della cultura (storia, antropo-logia, filosofia, letteratura, istituzioni, politica, ecc.), concentrandosi su tipi e generi testuali di-versi (discorso politico, giornalistico, accademico, sermoni, racconti, saggi, film, ecc.). L’enfasi è di avvicinare lo studente alla cultura in questione attraverso una lettura critica dei testi e una riflessione approfondita dell’imprescindibile nesso tra conoscenze culturali e padronanza lin-guistica.La seconda parte del corso si propone di introdurre gli studenti all’analisi del discorso. In pri-mo luogo, le lezioni verteranno su alcuni concetti cruciali nell’interpretazione di testi scritti (coesione, coerenza, rapporti semantici). In secondo luogo, l’attenzione si sposterà su pat-terns testuali più ampi attraverso i quali la natura del testo come momento di interazione verrà discussa. Infine, lo studio del discorso in una prospettiva di genere verrà dapprima affrontato sotto il profilo delle implicazioni teoriche, quindi applicato mediante lo studio di alcuni esempi empirici significativi. I testi su cui verterà questa parte di corso saranno di natura essenzial-mente argomentativi e saranno tratti dalla tradizione britannica.
53
Testi di riferimentoLe letture per il corso sono disponibili in una dispensa disponibile sia in biblioteca che nella copisteria davanti alla Facoltà.
FrequenzaE’ richiesta la frequenza di un minimo di 70% delle presenze alle lezioni.
Programma per i non frequentantiIl Programma per i non frequentanti dovrà essere concordato individualmente con i docenti e con i collaboratori ed esperti linguistici.
Modalità d’esameUn buon esito nel corso richiede il superamento 1) delle prove in itinere di lettorato; 2) la pro-va scritta; 3) l’esame orale.
ValutazioneLe prove di lettorato valgono 30% del voto finaleLa prova scritta vale 35% del voto finaleL’esame orale vale 35% del voto finale
Lingua, cultura ed istituzioni dei paesi di lingua spagnola
Prof. Guillermo CarrascónCFU 10 – 60 ore
“Español hablado”
Obiettivi formativiL’obiettivo fondamentale del corso di Lingua cultura ed istituzione dei paesi di lingua spagnola (Lingua spagnola II anno) è continuare a sviluppare le competenze comunicative e la consa-pevolezza e capacità di adeguazione pragmatica in spagnolo, attraverso l’analisi dei contrasti fra modalità orale e scritta e fra i vari registri all’interno di ognuna di esse, particolarmente di quella orale. Si approfondiranno anche aspetti della cultura spagnola contemporanea utili al miglioramento della competenza pragmatica degli studenti.
Prerequisiti Aver superato la prima annualità di lingua spagnola o possedere conoscenze pregresse di spagnolo, dimostrabili documentalmente, pari al livello A2 del Marco Europeo de Referencia.
Programma del corsoIl corso, di 60 ore di lezione frontale del docente, si articolerà in tre moduli, di 20 ore ciacuno, il primo dei quali si dedicherà ad un approccio linguistico sincronico alle differenze tra le mo-dalità orale e scritta in un piano teorico e nella fattispecie della lingua spagnola contempora-nea (fondamentalmente con riferimento allo spagnolo della Spagna). Successivamente si passerà ad analizzare le diverse modalità di discorso orale, attraverso la lettura e il commen-to delle trascrizioni di discorsi presi a campione delle suddette modalità, per individuare e sot-tolineare le caratteristiche proprie di ognuna di esse. Infine si prenderà in esame, in maniera più particolareggiata e attraverso documenti pertinenti, il discorso della politica e i discorsi po-litici imperanti nella società spagnola dalla fine della Guerra Civile ai giorni nostri, con atten-zione alle diverse fasi e tappe dello sviluppo storico sociopolitico del paese.Contemporaneamente, si svilupperano, como de costumbre, su base annuale, le esercitazio-ni liguistiche tenute dai Collaboratori ed esperti linguistici di lingua materna spagnola, destina-te a permettere la pratica nell’uso della lingua e a proporre diversi aspetti della realtà culturale dei paesi di lingua spagnola.
54
Testi di riferimentoIl seguente non costituisce l’elenco delle letture obbligate; è invece una lista di titoli utili ai fini del corso per diversi aspetti, la cui lettura e/o consultazione è raccomandata. I testi per il pro-gramma di esame verranno indicati durante il corso.
J.C. Barbero, F. San Vicente, Actual. Gramática para comunicar en español, Bologna, CLUEB, 2007.
Antonio Briz Gómez, El español coloquial en la conversacion: esbozo de pragmagramática, Barcelona, Ariel, 1998.
Antonio Briz, El español coloquial: Situación y uso, Madrid, Arco Libros, 1996. M. Carrera Díaz, Grammatica spagnola, Roma-Bari, Laterza, 1997. G. Carrascón e D. Capra, Fondamenti di fonologia e di morfologia dello spagnolo,
Torino, Celid, 20042. M. Fernández Lagunilla, La lengua en la comunicación política I: El discurso del
poder. Madrid, Arco-Libros, 1999. M. Fernández Lagunilla, La lengua en la comunicación política II: La palabra del
poder. Madrid, Arco-Libros, 1999. F. San Vicente, La lengua de los nuevos españoles, Zaragoza, Portico, 2001 M. J. Serrano, Aproximación a la gramática del discurso del español, Muenchen,
Lincom-Europa, 2002.
FrequenzaLa frequenza non è obbligatoria, ma presupposta.
Programma per i non frequentantiGli studenti non frequentanti devono metteresi d’accordo sia con il docente per stabilire il pro-gramma di esame, sia con i collaboratori ed esperti linguistici per sostituire in modo adeguato le esercitazioni linguistiche, finalizzate ad approfondire le strutture della lingua e a raggiunge-re un livello di conoscenza equiparabile al B2 del Marco Europeo de Referencia.
Modalità d’esameLa valutazione finale del corso si articolerà in una prova scritta e un accertamento orale da sostenere con i collaboratori ed esperti linguistici di lingua materna spagnola incaricati dei let-torati; solo dopo aver superato queste prove si potrà accedere alla prova orale da sostenere con il docente del corso.
ValutazioneLe prove scritta e orale di lettorato sono destinate a valutare le conoscenze e competenze grammaticali e comunicative. La prova orale con il docente è mirata a valutare le conoscenze relative ai contenuti del corso e si strutturerà a partire di un commento della trascrizione di un discorso orale attinente agli argomenti del corso, che lo studente dovrà analizzare e commen-tare nei suoi aspetti linguistici e socioculturali, mettendoli in rapporto con i concetti teorici per-tinenti.
Lingua, cultura ed istituzioni dei paesi di lingua tedesca
Prof. Cesare GiacobazziCFU 10 – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone come principale obiettivo formativo la comprensione di testi riguardanti aspetti rilevanti della cultura dei paesi di lingua tedesca. In particolare si eserciterà la com-prensione di testi di finzione con tematica storico contemporanea. Tale esercizio presuppone non solo il confronto con determinate informazioni di carattere storico, culturologico, politico, sociologico e così via, ma anche con la consapevolezza e la posizione storica e ideologica di
55
chi narra la storia.
Programma del corsoIl confronto con più forme discorsive e l’esercizio della comprensione non solo del loro conte-nuto esplicito ma anche della volontà implicita di chi le produce, sono considerate attività pro-pedeutiche allo sviluppo di abilità comunicative complesse nella lingua straniera. La lettura e il commento di brani da opere narrative di storia contemporanea mireranno a dirigere l’atten-zione degli studenti sia sulla realtà storica e culturale cui queste fanno riferimento, sia sull’i-stanza che la rappresenta. Poiché, infatti, le diverse tipologie testuali non rappresentano mai semplicemente dei fatti ma inevitabilmente anche opinioni, e, inoltre, poiché sono espressio-ne di peculiari strategie retoriche e argomentative, il lettore di opere narrative relative alla sto-ria contemporanea deve confrontarsi con chi rappresentando i fatti li spiega, li commenta e li utilizza per un proprio fine. Lo smascheramento della parzialità della narrazione storica e del documento culturale persegue lo scopo di sviluppare la consapevolezza di come sia illusoria la pretesa di potere accedere a informazioni neutre semplicemente riproducibili e, dunque, di come sia sempre necessario un intervento interpretativo. Gli aspetti strettamente linguistici (analisi lessico-sintattiche, riflessione grammaticale, esercizio di abilità orali e scritte) verran-no curati dai collaboratori linguistici sulla base di testi attinenti per argomento alla storia del XX secolo.
Testi di riferimento Wolf , Christa Kindheitsmuster LUCHTERHAND LITERATURVERLAG Grass , Günter, Mein Jahrhundert DTV Schröder, Jürgen; Bonath, Brigitte; Salzmann, Bertram; Wischinski, Claudia; Witt-
mann, Angela (Hrsg.), Die Stunde Null, Reclam
Testi consigliati: ● Cesare Giacobazzi, Voci e silenzi della storia Percorsi di lettura nel „Mio secolo“ di
Günter Grass, Medusa, 2006.
● Deutsche Romane des 20. Jahrhunderts. Interpretationen. 2 Bde. Stuttgart 1993.
Modalità d’esame Per l’esame è richiesta la stesura di una tesina il cui contenuto deve riguardare aspetti trattati nel corso. Il titolo, le modalità di realizzazione e la bibliografia devono essere concordati indi-vidualmente col docente.
Lingua, Cultura e Istituzioni dei paesi di lingua francese
Prof.ssa Giovanna BellatiCFU 10 – 60 ore
Obiettivi formativiSecondo quanto stabilito nel programma di disciplina, il corso ha lo scopo di presentare agli studenti gli aspetti salienti della società e della cultura francese del nostro tempo.
Programma del corsoDa un punto di vista cronologico, l’epoca presa in considerazione sarà il cinquantennio che va dal secondo dopoguerra alla fine del secolo, con particolare riferimento alla nascita e allo svi-luppo della “Cinquième République”. Di questo periodo saranno esaminati gli eventi e i feno-meni più significativi e la loro evoluzione da un punto di vista storico, socio-politico e più ge-nericamente culturale. Le lezioni si articoleranno sulla base di tre moduli, aventi come argo-mento
1) popolazione e territorio2) storia e società
56
3) evoluzione e sviluppo urbanistico di Parigi e della banlieue
Testi di riferimento● Labrune, Géographie de France, Nathan● Pellistrandi, La France depuis 1945, Colin ● Borne, Histoire de la société française depuis 1945 , Colin● Dossier Paris
FrequenzaLa frequenza al corso ufficiale e alle esercitazioni linguistiche è considerata fondamentale; gli studenti che si trovassero nell’impossibilità di frequentare un adeguato numero di lezioni po-tranno concordare col docente un’integrazione del programma, al fine di coprire i crediti nor-malmente acquisiti con la frequenza.
Modalità d’esameLa valutazione del programma inerente al corso ufficiale avverrà attraverso una prova orale fi-nale, volta ad accertare la conoscenza dei contenuti oggetto del corso stesso. Tale prova do-vrà essere sostenuta in lingua francese.
ValutazionePer la valutazione finale si terrà conto, oltre che dei contenuti, anche della correttezza foneti-ca e morfo-sintattica, nonché della proprietà lessicale, che lo studente saprà dimostrare du-rante il colloquio.Si ricorda che le lezioni del corso ufficiale saranno affiancate da esercitazioni linguistiche te-nute da collaboratori di madre lingua, che cureranno l’acquisizione di un’adeguata competen-za comunicativa. La valutazione di questa parte del corso avverrà attraverso una prova scrit-ta, separata dalla prova orale, del cui esito si terrà conto in sede di valutazione finale.
AvvertenzeGli studenti che avessero necessità di colloqui personali col docente sono invitati a prendere visione dell’orario di ricevimento e delle sue eventuali variazioni.
Seminario di Culture nazionali e relazioni economiche tra paesi
Prof. Giuliano AlbaraniCFU 4 – 20 ore
“La costruzione delle identità nazionali nell’Europa contemporanea”
Obiettivi formativiIl seminario intende evidenziare elementi comuni e specificità nei processi storici di costruzio-ne dell’identità nazionale che caratterizzano numerosi stati europei tra la fine del XVIII secolo e gli inizi del XX secolo, con particolare riferimento al caso italiano. Tali processi culturali sa-ranno analizzati alla luce dell’evoluzione della storia economico-sociale, politica ed ideologi-ca. Particolare attenzione sarà riservata all’utilizzo del discorso mitologico e storiografico sulle ‘origini’ per legittimare le specifiche interpretazioni dell’identità nazionale.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoLa prima parte del seminario sarà dedicata a presentare il rapporto fra l’affermazione degli stati nazionali e la nascita delle retoriche sull’identità nazionale. La seconda parte tratterà gli elementi generali e comuni di tali retoriche, ovvero l’importanza del territorio, della lingua, del-
57
la storia, delle memorie nel definire che cos’è una nazione. L’ultima parte del seminario si concentrerà su casi particolari, con specifica attinenza alla vicenda italiana, concordati con gli studenti e affidati alla loro ricerca ed esposizione.
Testi di riferimento● E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi. Programma, mito, realtà, Torino, Einaudi,
2002● B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Roma, Mani-
festolibri, 2006● M. Banti, L' onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo euro-
peo dal XVIII secolo alla Grande Guerra, Torino, Einaudi, 2005
Indicazioni bibliografiche su specifici casi di studio verranno fornite nel corso delle lezioni
FrequenzaObbligatoria (75% delle lezioni)
Programma per i non frequentantiNon previsto
Modalità d’esameOrale
ValutazioneProva finale
Seminario di Letteratura inglese
Prof.ssa Giovanna BuonannoCFU 4 – 20 ore
“Writing the post-imperial metropolis”
Obiettivi formativiThe seminar will introduce students to contemporary English fiction. Its main aim is to encour-age students to appreciate sharing in classroom the experience of reading fictional texts in English, as well as to strengthen their knowledge of contemporary English language and cul-ture.
PrerequisitiNone
Programma del corsoThe seminar will look at ways in which the city of London is re-visioned as a post-imperial metropolis in contemporary English fiction. The analysis will focus on the novels The Lonely Londoners by Sam Selvon and White Teeth by Zadie Smith and the short story “Let them Call it Jazz” by Jean Rhys.The Lonely Londoners (1956) and “Let them Call it Jazz” (1960) each in its own way, explore the city from the perspective of newly arrived Caribbean economic migrants and chronicle their daily struggles and their growing sense of disillusionment with England as their promised “Mother Country”, while bearing testimony to their resilience and their ability to rebuild a sense of community in 1950s London in the face of adverse conditions.White Teeth (2000) recreates the metropolis at the dawn of the third millennium as a vibrant multicultural space with a clearly hybrid make-up, where complex narratives of (un)belonging
58
unfold and fixed notions of “Englishness”, identity, race and nationality are questioned throughout. The texts will be discussed in relation to the cultural forces which were unleashed by the ar-rival and subsequent settlement in the city of communities of displaced people from former British colonies. Recent studies on diaspora and black British writing and representation will provide a historical and theoretical basis for our analysis of the selected works.
Testi di riferimento● Rhys, J. (1st publ.1960) “Let them Call it Jazz”. In Rhys, J. (1968) Tigers are Better
Looking. London: 1968● Selvon, S. (2006) (1st edition 1956). The Lonely Londoners. (Penguin Modern Clas-
sics) With a new introduction by Susheila Nasta. London: Penguin● Smith, Z. (2001). White Teeth. London: Penguin.● Wambu, O (1998). “Black British Literature since Windrush”.www.bbc.co.uk/history
/british/modern/literature_01.shtml [accessed 7 June 2007]
Selected chapters from:● Ball, J. C. 2006. Imagining London: Postcolonial Fiction and the Transnational Met-
ropolis. Toronto and London: University of Toronto Press.● King, B. 2005 The Internationalization of English Literature. The Oxford English Liter-
ary History. Vol.13.1948-2000. Oxford: Oxford U.P. .● McLeod, J. 2004. Postcolonial London: Rewriting the Metropolis. London: Routledge.● Sesay, K. (ed.) 2005. Write Black, Write British. From Post Colonial to Black British
Literature. London: Hansib.Suggestions for further reading will be given in the course of the seminar.
FrequenzaRegular attendance and active participation in the seminar are essential requirements.
Modalità d’esameStudents will take an oral exam at the end of the course.
ValutazioneA final mark will be the result of the oral exam.
Seminario di Letteratura inglese
Prof.ssa Giovanna BuonannoCFU 4 – 20 ore
“Identities in translation. Becoming Asian-British through writing and film”
Obiettivi formativiThe seminar will introduce students to contemporary English fiction and film. Its main aim is to encourage students to appreciate sharing in classroom the experience of reading fictional texts and discussing films in English, as well as to strengthen their knowledge of contempor-ary English language and culture.
Programma del corso.The seminar will introduce students to the writing of contemporary Asian-British authors who have helped to draw the contours of a new, multicultural Britain across a variety of literary genres and through the medium of film. The authors’ ongoing negotiation of their identity between the “home” and “host” countries and their ensuing search for a sense of belonging will be central to the discussion of the selected texts, along with the theme of cultural transla-
59
tion as experienced by second-generation writers who are uniquely positioned as agents of intercultural communication and exchange. The texts will be situated in the social context of the arrival and settlement in Britain of South-Asian diasporic communities and the progressive and increasingly difficult transformation of Britain into a multicultural society. Recent studies on diaspora, cultural translation and black British writing and representation will provide a critical perspective for our readings of the se-lected works.
Testi di riferimento● Syal, M. 1996. Anita and me. London: Flamingo● Kureishi, H. 1986. My Beautiful Laundrette and Other Writings. London: Faber.● Bhaji on the Beach (UK, 1993, dir. G. Chadha)● Roscoe, J. 2000. ”From Bombay to Blackpool. The construction of Indian femininity
in Bhaji on the Beach”. In Crane R. J. and Mohanran, R. (eds.) Shifting Continents/Colliding Cultures: Diaspora Writing of the Indian Subcontinent. Amster-dam: Rodopi. 197-216.
Selected chapters from:● Brah, A. 1996. Cartographies of Diaspora. London: Routledge.● Bromley, R. 2000. Narratives for a New Belonging: Diasporic Cultural Fictions. Edin-
burgh: Edinburgh U. P. . ● King, B. 2005. The Internationalization of English Literature. The Oxford English Lit-
erary History. Vol.13.1948-2000. Oxford: Oxford U.P. .● Procter, J. 2000. Writing Black Britain 1948-1998. Manchester: Manchester U.P. .● Ranasinha, R. 2002. Hanif Kureishi. (Writers and their Work). Horndon: Northcote
House.● Rushdie, S. 1992. Imaginary Homelands. Essays and Criticism 1981-1991. London:
Penguin.
FrequenzaRegular attendance and active participation in the seminar are essential requirements.
Modalità d’esameStudents will take an oral examination at the end of the course
ValutazioneA final mark will be given at the end of the oral exam
Seminario di Lingua, Cultura e Istituzioni dei paesi di lingua spagnola
Prof.ssa Daniela CapraCFU 4 – 20 ore
Obiettivi formativiIl Seminario si propone di potenziare le capacità di lettura e di analisi dei testi, in particolare quelli espositivi e argomentativi, per coglierne gli elementi costitutivi e rintracciare le loro pe-culiarità, ivi comprese le marche ideologiche.
Prerequisiti Nessuno.
Programma del corsoIl Seminario offre un'introduzione su questioni relative alle tipologie testuali e ai loro tratti di-stintivi, per poi passare allo studio di alcuni generi testuali e di come essi sono costruiti in re-
60
lazione ai loro propositi. Agli studenti è richiesta una breve presentazione orale durante il Se-minario, consistente nell'analisi di un testo a scelta.
Testi di riferimento Alcoba, S. (a cura di), La oralización, Barcelona, Ariel, 1999 (solo i capitoli 1, 3 e 4). Plantin, La argumentación, Barcelona, Ariel, 1998. Sokal, A. e J. Bricmont, Imposturas intelectuales, Barcelona, Paidós, 1999.
FrequenzaTrattandosi di un seminario, la frequenza è presupposta.
Programma per i non frequentantiNon è previsto un programma differenziato per i non frequentanti.
Modalità d’esameScritto (tesina di circa 10 pagine dattiloscritte) e orale.
ValutazioneIl lavoro scritto e individuale di ogni studente (la cui base è la presentazione orale effettuata durante il Seminario) verrà valutato e successivamente discusso in sede di esame orale; lo studente dovrà inoltre dimostrare una preparazione globale sulle questioni affrontate durante gli incontri seminariali.Seminario di storia economica A
Docente da definire CFU 4 – 20 ore
Programma da definire
Seminario di storia economica B
Docente da definireCFU 4 – ore 20
Programma da definire
Seminario di traduzione lingua inglese
Prof. Giancarlo GagliardelliCFU 4 – 20 ore
Obiettivi formativiFornire ai frequentanti, che hanno già sostenuto l’esame obbligatorio di Lingua Inglese, un avviamento alla traduzione dall’inglese in italiano di testi appartenenti a varie tipologie, pro-dotti per il raggiungimento di obiettivi comunicativi diversi, mirati a differenti tipi di fruitore.
Prerequisiti E’ raccomandabile che lo studente abbia frequentato le lezioni del corso di Lingua Inglese 1° Anno tenute dal docente, e sostenuto con successo l’esame relativo.E’ ritenuta altrettanto cruciale una buona conoscenza della morfosintassi e dell’ortografia ita-liane, nonché dell’uso appropriato della punteggiatura nella nostra lingua.
Programma del corsoSaranno oggetto di analisi le traduzioni di testi originali in lingua inglese per rendersi consa-
61
pevoli delle scelte dell’enunciatore originario nonché delle opzioni a disposizione del tradutto-re italiano. Saranno anche studiati casi di patologia della traduzione: traduzioni eseguite da programmi di traduzione per computer; annunci pubblicitari; casi di burocratese; ecc. (Si rac-comanda la consultazione di uno dei seguenti lavori: Lepschy Anna L. & Lepschy Giulio C., La lingua italiana: storia, varietà dell’uso, grammatica, Bompiani; Serianni Luca, Italiano, Grammatica, Sintassi, Dubbi, Garzanti.)
Testi di riferimento (fra i quali sceglierne uno per la redazione della “tesina”)
● Berman A., Traduzione e critica produttiva, Oedipus, Salerno, 2001.● Cortese G. (a cura di), Tradurre i linguaggi settoriali, Edizioni Libreria Cortina, Tori-
no, 1996.● Cosmai D, Tradurre per l’unione Europea, Hoepli, Milano, 2007● Di Sabato B., Per tradurre: teoria e pratica della traduzione, ESI, Napoli, 1993.● Eco U., Dire quasi la stessa cosa - Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano,
2003.● Lefevere A., Traduzione e riscrittura, UTET Libreria, Torino, 1988.● Mattioli E., Ritmo e traduzione, Mucchi, Modena, 2001.● Nasi F. (a cura di) Sulla traduzione letteraria, Longo Editore, Ravenna, 2001.● Monacelli C., Traduzione, revisione e localizzazione nel terzo millennio: da e verso
l’inglese, Franco Angeli, Milano, 2001.● Nergaard S. (a cura di), Teorie contemporanee della traduzione, II ed., Strumenti
Bompiani, Milano, 2002.● Ortega y Gasset J., Splendori e miserie della traduzione,, Il Nuovo Melangolo, Geno-
va, 2001.● Οsimo B., Traduzione e nuove tecnologie, Hoepli, Milano, 2002.● Osimo B., Manuale del traduttore, II ed., Hoepli, Milano, 2004.● Osimo B, La traduzione saggistica dall’inglese, Hoepli, Milano, 2007.● Osimo B., Traduzione e nuove tecnologie, Hoepli, Milano, 2002.● Osimo B., Storia della traduzione, Hoepli, Milano, 2002.● Popovic Anton, La scienza della traduzione, Hoepli, Milano, 2006.● Scarpa Federica, La traduzione specializzata, Hoepli, Milano, 2001.● Ulrych M., Translating texts, Cideb, Rapallo, 1992.● Venuti L., L’invisibilità del traduttore, Armando, Roma, 1996.
FrequenzaLa frequenza è obbligatoria. Gli studenti che non si presentano ai primi tre incontri o non avranno presenziato al 75% dei lavori seminariali non saranno considerati frequentanti.
Modalità d’esameAlla chiusura del seminario gli studenti dovranno sostenere una prova di traduzione di un bra-no di circa 200 parole. E’ consentito l’uso del dizionario bilingue. Inoltre sono tenuti a presen-tare al docente una “tesina” (dalle 3000 alle 5000 parole) su uno dei testi di traduttologia pro-posti nella bibliografia: si tratta di una sintesi, scritta in italiano, degli argomenti presentati dal-l’autore scelto, accompagnata da osservazioni personali, esemplificazioni, commenti, critiche.
ValutazioneLa valutazione della traduzione è fatta in trentesimi (voto minimo 18/30): Al voto della tradu-zione va aggiunto il punteggio meritato nella tesina (da 0 a 4). Quest’ultimo tiene conto per un 50% della correttezza e appropriatezza linguistica, della coesione e della coerenza, non-ché dell’organizzazione strategica delle strutture concettuali, al fine di giudicare la capacità di scrivere in inglese per scopi accademici; per l’altro 50%, della capacità di analisi, della quanti-tà e qualità dei dati, e della capacità critica. La “tesi” dovrà contenere la bibliografia dei testi letti, nonché l’eventuale sitografia consultata.
62
Seminario di traduzione lingua inglese
Prof. Giuseppe PalumboCFU 4 – 20 ore
Obiettivi formativiObiettivo del seminario è quello di presentare una panoramica sulle principali problematiche legate ai seguenti aspetti: 1) la traduzione come ricreazione di testi in lingua d’arrivo; 2) le più comuni tecniche di trasposizione linguistica (shifts), con particolare riferimento a quelle comu-nemente adottate nel passaggio dall’inglese all’italiano; 3) l’uso di dizionari e di altri strumenti di consultazione.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoAi partecipanti verrà chiesto di analizzare criticamente testi tradotti già pubblicati e di eseguire traduzioni e revisioni svolte sulla base dei risultati raggiunti nella fase di analisi dei testi. L’atti-vità seminariale si avvarrà di un ambiente on-line che fungerà da forum di discussione perma-nente tra i partecipanti e da archivio dei materiali testuali man mano creati.Testi di riferimentoÈ consigliata la lettura dei seguenti testi:
● Hatim, B. & Munday J. (2004) Translation. An Advanced Resource Book, London, Routledge.
● Laviosa, S. (2006) Linking Wor(l)ds. Lexis and Grammar for Translation, Napoli, Liguori.
FrequenzaObbligatoria
Programma per i non frequentantiGli studenti che non possono frequentare sono pregati di rivolgersi al docente per la scelta di un percorso individuale.
Modalità d’esameLa prova d'esame consiste nella traduzione dall'inglese in italiano di un testo analogo a quelli discussi nel corso del seminario.
ValutazioneLa valutazione tiene conto sia dell'esito della prova finale d'esame sia dell'assiduità dimostra-ta dallo studente nello svolgere le attività di esercitazione proposte durante il seminario.
Seminario di letteratura tedesca
Prof. Cesare GiacobazziCFU 4 – 20 ore
“Amore e prevaricazione”
Programma del corsoLa concezione dominante dell’amore richiama in genere esperienze edificanti quali la dona-zione di sé, la passione disinteressata e l’altruismo più incondizionato. In letteratura invece, se talvolta si celebra l’amore come ciò che dà senso e compiutezza all’esistenza, altre volte
63
se ne smaschera la natura violenta, oppressiva e prepotente. Nel corso del seminario si leg-geranno e commenteranno testi che rappresentano l’altra faccia dell’amore, quella appunto che dà sfogo alla volontà di potenza dell’innamorato.
Testi di riferimento● Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge.● Novalis (Friedrich von Hardenberg), Heinrich von Ofterdingen.● Johann Wolfgang Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre● Theodor Fontane, Effi Briest.● Arthur Schnitzler, Casanovas Heimfahrt
Seminario linguistica francese B
Prof.ssa Giovanna Bellati – Prof.ssa Chiara Preite CFU 4 – 20 ore
Obiettivi formativiObiettivo del seminario è avviare lo studente ad una conoscenza più concreta e approfondita di uno strumento di uso quotidiano quale il dizionario, sia nella sua dimensione teorica che nella sua funzionalità pratica.
Prerequisiti Un’adeguata conoscenza della lingua francese, dato che sia le lezioni sia la prova finale si svolgeranno in lingua francese.
Programma del corso1) Prima parte : Giovanna Bellati La lessicografia francese: uno sguardo in prospettiva diacronica
2) Seconda parte : Chiara Preite Approccio pratico alla lessicografia francese contemporanea
Dopo una definizione dell’oggetto “dizionario” e delle sue tipologie più comuni, la prima parte del seminario presenterà una panoramica storica dei dizionari francesi, dai primi esempi in età umanistica fino ai “monumenti” lessicografici dell’epoca moderna e contemporanea, quali il Dictionnaire de l’Académie, il Robert, il Larousse, il Trésor de la langue française. Esami-nando le caratteristiche generali di questi grandi dizionari, così come le differenze esistenti tra loro, si cercherà di comprendere e di definire quali concezioni teoriche ne hanno orientato la stesura, ed anche quali aspetti più pratici (ad esempio: la possibilità di diffusione e di vendita, il pubblico al quale l’opera si rivolge) possono condizionare il lessicografo nel suo lavoro.La seconda parte del seminario, invece, procederà alla descrizione dei contenuti dei dizionari bilingue e monolingue. Particolare spazio verrà dato all’analisi di macrostruttura e microstrut-tura nei dizionari monolingue d’uso, nonché ad alcuni aspetti lessicologici di interesse (polise-mia, omonimia, sinonimia, antonimia, ecc.). Le nozioni teoriche verranno accompagnate da esercitazioni pratiche.
Testi di riferimento● Dossier: Lexicographie française ● CELOTTI N., COHADE M.-T., Des mots dans tous les sens, La Nuova Italia, Firenze
1994.● PRUVOST J., Les dictionnaires de la langue française, coll. Que sais-je?, PUF,
Paris 2002.
Frequenza La frequenza al seminario è considerata fondamentale; gli studenti impossibilitati a frequenta-
64
re un adeguato numero di lezioni (70/75%) potranno concordare con i docenti un’integrazione del programma.
Programma per i non frequentantiNell’eventualità da concordare con i docenti.
Modalità d’esamePer la prima parte del seminario la valutazione sarà unicamente orale e avverrà attraverso un colloquio in lingua francese. Per la seconda parte oltre al colloquio orale verrà proposto un breve esercizio scritto da completare.
Sistemi giuridici comparati
Prof. Marcello StalteriCFU 4 – 30 ore Obiettivi formativiIl corso intende esplorare i fondamenti della comparazione giuridica, dopo aver ripercorso al-cune nozioni base di diritto e ad aver proposto spunti di particolare interesse per lo studente di Lingue e Culture Europee.
PrerequisitiAl fine di sostenere l’esame di Sistemi Giuridici Comparati non sono previste particolari pro-pedeuticità.Programma del corso
1) I profili del diritto moderno e del diritto comparato2) Le fonti3) La nozione di famiglia giuridica4) Diritto e traduzione giuridica5) Gli ordinamenti di civil law e la tradizione dei codici6) Il diritto nei paesi anglosassoni7) La Costituzione statunitense
Testi di riferimento(Per frequentanti e non frequentanti)
● V.Varano, V.Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, vol I, II o III ed., Giappichel-li, Torino.
Oltre ai materiali che accompagnano i primi III capitoli, ed al Cap.IV, lo studente è esonerato dalla lettura dei seguenti paragrafi:Cap.II: Par.1.1. (includere tuttavia la lex mercatoria); Par.2.3 e 2.4; Par.2.6.Cap.III: Par.1.3; Par.4.5; Par.4.6.
E’ consentita la preparazione dell’esame su manuali alternativi, ma la selezione dovrà tassa-tivamente essere concordata a tempo debito con il docente.
Completa il carico didattico, per tutti, la lettura di materiali riguardanti i temi della traduzione giuridica e dell’analisi economica del diritto. Il docente provvederà a mettere a disposizione degli studenti i relativi suggerimenti bibliografici.
Parte speciale per coloro che non abbiano sostenuto la prova scritta, o che intendano miglio - rarne l’esito:
● E.A.FARNSWORTH, An Introduction to the Legal System of the United States, III ed., New York, 1996, pp.1-30.
65
FrequenzaSi suggerisce di frequentare assiduamente le lezioni, tanto per la vastità della materia trattata che per ottimizzare la preparazione.
Modalità d’esameLa prova d’esame si svolgerà in forma scritta ed in unica sessione, dopo un ragionevole lasso di tempo da dedicare al perfezionamento di quanto già appreso durante il corso. Potrà essere sostenuta tanto dai frequentanti che dai non frequentanti.Chi abbia tuttavia escluso di sottoporsi all’esame in forma scritta, ovvero intenda migliorare il giudizio ivi ottenuto, potrà sempre sostenere in seguito l’esame in forma orale. In tal caso, la verifica riguarderà anche alcune pagine di storia del diritto statunitense.
Terza Lingua Tedesco
Prof.ssa Antonella Nardi - Prof.ssa Antonie HornungCFU 10 – 60 oreMetodi didatticilezione
Obiettivi formativiNel primo semestre si esercitano prevalentemente le abilità di ascolto, parlato e lettura; nel secondo si esercita anche l’abilità della produzione scritta. Gli studenti si esercitano a com-prendere messaggi orali di diverso genere (brevi dialoghi quotidiani, annunci, messaggi pub-blicitari, notiziari ecc.); a esprimersi correttamente e in modo appropriato rispetto a contesto, interlocutore, situazione e intenzione comunicativa; a comprendere testi scritti relativi a situa-zioni di vita quotidiana; a scrivere testi corretti e appropriati alle funzioni comunicative propo-ste; ad apprendere gli elementi morfo-sintattici di base e un lessico fondamentale, necessari all’esercizio delle abilità comunicative suddette; infine a conseguire una conoscenza essen-ziale degli aspetti storici, geografici e culturali del mondo di lingua tedesca. La competenza fi-nale di studenti principianti dovrebbe corrispondere al livello A2 e in alcune abilità anche B1 dei parametri europei.
Prerequisiti Curiosità e coraggio
Programma del corsoLa parte della prof.ssa Nardi affronta le abilità orali mentre nella parte della prof.ssa Hornung si sviluppano le competenze nello scritto.
1) Le funzioni comunicative di base legate a situazioni quotidiane che verranno trattate nel lettorato: presentarsi, dare informazioni, invitare, offrire, descrivere luoghi, perso-ne, oggetti, il decorso della giornata, un progetto, ordinare cibi e bevande, chiedere informazioni, ecc.)
2) Funzioni comunicative più avanzate legate alla comprensione di testi e all’espressio-ne: comprendere i punti principali di testi scritti e orali, riportarne brevemente il con-tenuto ed esprimere la propria opinione.
3) Grammatica: sintattica e morfologia di base. 4) Cultura: attraverso letture e articoli di giornale conoscere le caratteristiche principali
dei paesi di lingua tedesca, le fasi più significative della storia del paese e alcuni temi di carattere interculturale.
Testi di riferimentoFotocopie distribuite a lezione riunite alla fine del corso in una dispensa messa a disposizione presso il copy shop di fianco alla facoltà e disponibili in rete alla fine del corso sullo spazio
66
condiviso della Dr. Nardi..
FrequenzaConsigliata (al minimo 80 %)
Programma per i non frequentantiDispensa
Modalità d’esame:Scritto: produzione di un testo in tedescoOrale: presentazione e discussione di argomenti selezionati sui paesi germanofoni
ValutazioneProve finali (scritto + orale + lettorato)
Terza Lingua Francese
Prof.ssa Chiara Preite – Prof.ssa Alida M. SillettiCFU 10 – 60 ore
Obiettivi formativiObiettivo del corso è di fornire competenze linguistiche funzionali all’espressione e alla com-prensione orale e scritta in lingua francese. Inoltre, verrà prestata particolare attenzione ad al-cuni aspetti interlinguistici contrastivi e verranno presentati dizionari bilingue e monolingue al fine metterne in luce le potenzialità e farne utili strumenti di lavoro.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso mira alla padronanza della lingua e della cultura da/verso la quale è orientata la co-municazione; al consolidamento delle basi grammaticali, e all’arricchimento lessicale; nonché allo sviluppo di capacità di analisi, comprensione, riformulazione, sintesi orale e scritta del contenuto logica, sintesi, generalizzazione, deduzione, argomentazione e memorizzazione. A tal fine verrà proposto agli studenti un lavoro su documenti di complessità progressiva che af-frontano temi di attualità. A tale lavoro si affiancherà una serie di esercitazioni (applicative e traduttive) relative alla corretta manipolazione dei dizionari e ad alcuni aspetti contrastivi del confronto tra italiano e francese. Le tematiche affrontate in chiave interlinguistica verteranno su segni grafici, determinanti, pronome e frase.
Testi di riferimentoLa bibliografia verrà comunicata durante il corso.Dossier 1 (Dott.ssa Chiara Preite)Dossier 2 (Dott.ssa Alida M. Silletti)
FrequenzaLa frequenza è considerata fondamentale; gli studenti impossibilitati a frequentare un ade-guato numero di lezioni (70/75%) potranno concordare con i docenti un’integrazione del pro-gramma.Le attività di lettorato costituiranno parte integrante del corso e saranno finalizzate al poten-ziamento delle abilità di comprensione ed espressione.
Programma per i non frequentantiIntegrazioni bibliografiche da concordare con i docenti.
67
Modalità d’esameL’esame consisterà in una prova scritta con le lettrici (e integrata dai docenti con modalità da concordare). Farà seguito un colloquio orale relativo ai contenuti del corso per valutare la ca-pacità di comprensione, analisi e sintesi di eventi comunicativi; la capacità di rielaborare in maniera autonoma una comunicazione ed esprimerla correttamente in lingua francese; la ca-pacità, in genere, di produrre e la gestire la comunicazione a partire da determinate conse-gne.
Terza lingua spagnolo
Prof. Marco CipolloniCFU 10 – 60 ore
“Immagine e mito dell’identità latinoamericana nel cinema di Werner Herzog e Ken Loach”
Programma del corsoNel cinema di Herzog e in quello di Loach, l’America Latina è uno scenario naturale e umano di grande rilievo. Il corso intende mettere a confronto due modelli di interpretazione molto di-versi tra loro, anche se collegabili ad una pratica di rovesciamento e riappropriazione dell’eso-tismo e degli stereotipi ad esso collegati.
Testi di riferimento● Iciar Bollain, Ken Loach, un observador solidario, Madrid, El País/Aguilar, 1998.● G. Fuller, Loach secondo Loach, Milano, Ubulibri, 2000.● W. Herzog, La conquista dell’inutile, Milano, Mondadori, 2007.
Film:K. Loach:
● Ladybird, Ladybird● Carla’s Song● Bread & Roses● 9/11
R.W. Fassbinder:● Rio das Mortes
W. Herzog:● Aguirre, furore di Dio● Fitzcarraldo● Ιl mio nemico più caro
Ulteriori indicazioni, bibliografiche e filmografiche, saranno fornite durante il corso
Traduzione Lingua Francese
Prof.ssa Luciana T. SolimanCFU 6 – 40 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di sviluppare nello studente una buona competenza traduttiva grazie all'ac-quisizione degli strumenti metodologici e linguistici per l'analisi e la traduzione di testi scritti di carattere divulgativo tratti dalla stampa francese quotidiana e periodica.Per individuare una strategia traduttiva coerente con l'intento comunicativo del testo di parten-za, lo studente imparerà a effettuare un'analisi preliminare del testo. Oltre a sviluppare la competenza testuale e traduttiva dal francese in italiano, il corso promuove la conoscenza del
68
contesto socioculturale francofono.
PrerequisitiBuona comprensione scritta della lingua francese. Buona produzione scritta della lingua italia-na.
Programma del corsoIl corso prevede esercitazioni pratiche di traduzione dal francese in italiano con analisi preli-minare delle funzioni comunicative del testo di partenza e discussione in classe delle scelte traduttive adottate. I testi proposti saranno di carattere divulgativo, tratti dalla stampa quotidia-na e periodica francese. Nel corso delle esercitazioni verranno affrontati tangibilmente i pro-blemi del tradurre; per la loro soluzione si farà riferimento a principi teorici fondamentali della traduzione.
Testi di riferimento● Celotti, N. (1997): Guida all'uso del dizionario francese-italiano, Bologna, Zanichelli.● Newmark, P. (1982): "Communicative and semantic translation", in Approaches to
translation, Oxford, Pergamon Press, p. 38-56.● Podeur, J. (1993): La pratica della traduzione, Napoli, Liguori.● Scarpa, F. (1997): "Equivalenza funzionale e tipologie testuali nella traduzione", in
M. Ulrych (a cura di), Tradurre. Un approccio multidisciplinare, Torino, Utet, p. 3-30.
FrequenzaAltamente raccomandata.
Programma per i non frequentantiGli studenti non frequentanti sono tenuti a elaborare una tesina su "L'editoriale: traduzione di un genere". Per maggiori informazioni, contattare la docente.
Modalità d’esameL'esame prevede una prova scritta che consiste nell'analisi del testo di partenza (tipologia te-stuale e funzioni comunicative; motivazione delle strategie traduttive) e nella traduzione di quest'ultimo con l'ausilio di dizionari (monolingui e bilingui).
ValutazioneValutazione sommativa.
Traduzione lingua spagnola
Prof.ssa Daniela CapraCFU 6 – 40 ore
Obiettivi formativiL'obiettivo principale del corso è quello di sviluppare competenze traduttive a partire da testi in lingua spagnola di diverse tipologie. A seconda delle competenze linguistiche degli studen-ti, potrebbe essere necessario lavorare sull'acquisizione di nozioni che stanno alla base di una corretta operazione traduttiva.
Prerequisiti Nessuno.
Programma del corsoLa docente esporrà diverse prospettive critiche sulla traduzione e indicherà i presupposti fon-damentali su cui la traduzione dei vari tipi testuali si può basare. Verranno assegnate eserci-
69
tazioni traduttive sui testi che gli studenti dovranno svolgere; queste verranno poi commenta-te e corrette durante le lezioni.
Testi di riferimento● Barbero, J.C. e F. San Vicente, Actual. Gramática para comunicar en español, Bolo-
gna, CLUEB, 2006.● Hurtado Albir, A., Traducción y traductología, Madrid, Cátedra, 2001.
Testi facoltativi:● Eco, U., Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani, 2003.● Faini, P., Tradurre, Roma, Carocci, 2004● Mounin, G., Teoria e storia della traduzione, Torino, Einaudi, ultima ed.
Dizionari:● Moliner, M., Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1998.● Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe,
2003.● Tam, L., Dizionario spagnolo-italiano. Diccionario italiano-español, Milano, Hoepli,
1997.
Frequenza Dato il carattere teorico-pratico del corso, la frequenza non solo è presupposta, ma consiglia-ta.Programma per i non frequentantiNon è previsto un programma differenziato per i non frequentanti: si veda quello per i fre-quentanti.Modalità d’esameScritto (prova di traduzione e commento teorico del lavoro svolto).
ValutazioneIl lavoro scritto verrà valutato dalla docente, in base ai criteri che formeranno parte delle lezio-ni teoriche; gli studenti avranno la possibilità, in sede di verbalizzazione, di discutere le loro scelte traduttive.
Traduzione lingua tedesca
Prof. Hans HonnackerCFU 6 – 40 ore
Obiettivi formativiPrincipale obiettivo del corso è fornire allo studente strumenti per una corretta riflessione sul-l’atto di tradurre e sull’interdipendenza tra il tipo di testo, la sua funzione linguistica o comuni-cativa e la forma di traduzione. Il corso si propone inoltre di mettere in luce le differenze strut-turali fra lingua e/o cultura tedesca e quella italiana, e completare le cinque tradizionali abilità linguistiche con la cosiddetta “sesta” abilità, cioè la traduzione, aumentando così il livello di “Sprachgefühl” (sensibilità linguistica) negli studenti. Infine, attraverso la lettura di testi tede-schi, austriaci e svizzeri, è obiettivo non secondario del corso mettere in evidenza il pluricen-trismo della lingua tedesca.
Prerequisiti Gli studenti che intendono seguire questo corso, dovrebbero aver acquisito, prima dell’inizio del corso stesso, le competenze linguistiche previste dal livello B1 del Portfolio Europeo delle Lingue (PEL).
70
Programma del corsoDopo una prima parte introduttiva sulla storia della traduzione, il primo modulo del corso verte su varie questioni che la teoria della traduzione odierna pone in ambito letterario e non. In se-guito vengono affrontati “micro-generi” testuali, cioè testi di attualità in lingua tedesca presi da giornali, riviste e da internet che vengono prevalentemente tradotti a vista in aula, applicando modelli linguistici della comunicazione alla traduzione ed analizzando i vari tipi di testo e la loro funzione linguistica nella lingua di partenza e nella lingua di arrivo. Infine tali testi verran-no raffrontati con articoli italiani sullo stesso argomento.
Nel secondo modulo vengono invece tradotti brani scelti da testi letterari tedeschi, austriaci e svizzeri che forniscono una visione generale, benché da un punto di vista personale, della cultura e della letteratura in lingua tedesca in Germania, Austria e Svizzera del Novecento, quali S. Haffner, Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914-1933, München, Dtv-Verlag, 2002 o J. Fest, Ich nicht. Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend, Hamburg, Ro-wohlt, 2006, W. Haas, Auferstehung der Toten, Hamburg, Rowohlt, 1996 o Idem, Das Wetter vor 15 Jahren, Hamburg, Hoffmann und Campe, 2006 e F. Dürrenmatt, Das Versprechen, München, Dtv-Verlag, 1978.
Testi di riferimentoBassnett-McGuire (1993)
● Bassnett-McGuire, S., La traduzione. Teorie e pratica, a c. di D. Portolano, trad. di G. Bandini, Milano, Bompiani, 1993
Cosmai (2003)● Cosmai, Domenico, Tradurre per l’Unione Europea. Problematiche e strategie ope-
rative, Milano, Hoepli, 2003
Eco (2003)● Eco, U., Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003
Folena (1991)● Folena, G., Volgarizzare e tradurre, Torino, Einaudi, 1991
Handschuhmacher (2003)● Handschuhmacher, S., Aspetti didattici della traduzione in tedesco dall’italiano, Pe-
scara, Edizioni Campus, 2003
Hönig/Kußmaul (19995)● Hönig, H.G./Kußmaul, P., Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, Tü-
bingen, Gunter Narr Verlag, 19995
Kautz (20022)● Kautz, U., Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, a cura del Goe-
the-Institut, München, Iudicium Verlag GmbH, 20022
Nasi (2004)● Nasi, F., Poetiche in transito. Sisifo e le fatiche del tradurre, Milano, Medusa, 2004
Nergaard (cur.) (1993)● Nergaard, S. (cur.) La teoria della traduzione nella storia. Testi di Cicerone, San Ge-
rolamo, Bruni, Lutero, Goethe, von Humboldt, Schleiermacher, Ortega y Gasset, Croce, Benjamin, Milano, Bompiani, 1993
Nergaard (cur.) (1995)● Nergaard, S. (cur.) Teorie contemporanee della traduzione. Testi di Jakobson, Levý,
Lotman, Toury, Eco, Nida, Zohar, Holmes, Meschonnic, Paz, Quine, Gadamer, Der-rida, Milano, Bompiani, 1995
71
Osimo (2001)● Osimo, B., Propedeutica della traduzione. Corso introduttivo con tavole sinottiche,
Milano, Hoepli, 2001
Rega (2001)● Rega, L., La traduzione letteraria: aspetti e problemi, Torino, UTET, 2001
Snell-Hornby/Hönig/Kußmaul/Schmitt (cur.) (19992)● Snell-Hornby, M./Hönig, H.G./Kußmaul, P./Schmitt, P.A. (cur.), Handbuch Translati-
on, Tübingen, Stauffenburg Verlag, 19992
Indicazioni bibliografiche più dettagliate e materiali di studio verranno forniti nel corso delle le-zioni.
FrequenzaLa frequenza del corso è obbligatoria (almeno il 66% delle lezioni).
Modalità d’esameEsame scritto alla fine del corso annuale (40 ore).Seminario sulle teorie della traduzione
Prof. Marc Silver – Prof. Franco NasiCFU 4 – 20 ore
Obiettivi formativi1) conoscere storia e pratiche della traduzione;2) comprendere le principali teorie linguistiche, filosofiche e interculturali della traduzio-
ne;3) avere un'idea dell'identità professionale del traduttore.
Prerequisiti “Nessuno”
Programma del corsoIl seminario, che si articola in dieci incontri, prevede l’intervento di altrettanti specialisti che af-fronteranno aspetti specifici della traduzione, con particolare attenzione ai rapporti tra tradu-zione e discipline come la linguistica, l’ermeneutica, la psicologia, la letteratura, le neuro-scienze, la sociologia ecc.
Testi di riferimentoI testi di riferimento saranno indicati durante il corso
FrequenzaE’ richiesta la frequenza. La percentuale minima di presenza alle lezioni è del 70 %
Programma per i non frequentantiDa concordare con i docenti
Modalità d’esameTesina di dieci cartelle su un argomento relativo alla teoria della traduzione da concordare con i docenti
ValutazioneDiscussione della tesina
72
Lingue e Culture Europee – III anno
Diritto commerciale comunitario Prof.ssa Maria Donata PanfortiCFU 4 – 30 ore Obiettivi formativi Il corso di Diritto Commerciale Comunitario si propone di introdurre gli studenti alla tematica della compravendita nei sistemi giuridici principali nell’area europea (la famiglia romano-ger-manica e la common law inglese), nonché nel diritto comunitario ed internazionale. Particolare attenzione verrà dedicata agli aspetti terminologici di questo istituto giuridico e alla traduzione dei relativi contratti. Prerequisiti del corsoE’ indispensabile avere superato gli esami di Sistemi Giuridici Comparati e Diritto dell’Unione Europea. Contenuti del corsoGli argomenti principali del corso sono :- I caratteri fondamentali del contratto di vendita- La vendita negli ordinamenti di civil law- La vendita nella common law inglese- La disciplina comunitaria- La vendita internazionale- Le prospettive di uniformazione Le lezioni sono di tipo frontale. Per alcuni argomenti trattati a lezione sono previsti approfondi-menti attraverso l’esame di materiali cartacei distribuiti dalla docente. Modalità d’esame Studenti frequentanti Gli studenti partecipanti possono scegliere se:1) preparare una tesina su un tema attinente agli argomenti del corso. La scelta del tema della tesina deve essere concordata con la docente, che fornirà indicazioni di base sui libri da usare nonché sulle modalità di redazione della tesina stessa. Agli studenti che scelgono di redigere la tesina non verranno richiesti altri adempimenti di esame. 2) sostenere un esame orale su un testo che verrà tempestivamente indicato. La qualifica di “frequentante” si acquisisce avendo preso parte ad almeno il 75% delle lezioni. La frequenza è accertata mediante lettura ottica del tesserino universitario. Programma per i non frequentanti Gli studenti non frequentanti devono preparare un manuale i cui riferimenti verranno pubblica-ti in questa pagina all’inizio del nuovo anno accademico. L’esame è orale. Ricevimento L’orario di ricevimento della prof. Maria Donata Panforti è indicato nell’apposita pagina del sito web della Facoltà. In alternativa, è possibile rivolgersi anche alla dott. Cinzia Valente, il cui orario è reperibile in modo analogo.
73
Etnologia
Prof. Fabio VitiCFU 4 – 40 ore
“Schiavitù e dipendenza personale”
Obiettivi formativiIl corso si propone un duplice intento: fornire agli studenti una introduzione di carattere gene-rale all’Etnologia e presentare un tema di particolare rilevanza etnologica e antropologica quale quello dei rapporti di dipendenza personale (schiavitù, servitù e altre forme di dominio sulla persona).
PrerequisitiNessuno
Programma del corsoNella parte introduttiva generale, il corso fornirà elementi di base per la conoscenza critica dei fondamenti dell’Etnologia, con speciale attenzione alla definizione dei principali campi temati-ci della disciplina, in maniera da mettere lo studente nelle condizioni di acquisire strumenti adeguati alla comprensione di testi e studi etnologici. In particolare, saranno affrontate in modo critico le nozioni fondamentali di cultura, identità e etnia; sarà inoltre fornita una presen-tazione generale dei campi tematici più specifici della politica e della parentela.
La parte monografica del corso intende sviluppare l’argomento della schiavitù, dei rapporti di dipendenza personale, delle forme di possesso e di dominio sulla persona. Saranno presen-tati materiali etnografici e storici relativi ai rapporti di dipendenza “ordinari”, alle forme di appartenenza familiare (rapporti di inclusione, filiazione e affiliazione) e ai connessi ostacoli ai processi di individualizzazione nelle società “semplici” o “pre-moderne”. A partire da esempi tratti dall’antichità greco-romana, dall’Europa feudale, dal mondo arabo-musulmano, dall’Afri-ca precoloniale e coloniale e dalle Americhe schiaviste, sarà inoltre esaminata la categoria della dipendenza “incrementata” e in particolare la figura dello schiavo-merce (schiavi “dome-stici” e di tratta; prezzo e valore; stato e condizione degli schiavi; forme legali di riduzione in schiavitù e di proprietà degli schiavi; rapporto tra schiavitù e violenza). Infine, saranno pre-sentate e discusse le persistenze di rapporti servili e le nuove forme di asservimento presenti nel mondo contemporaneo e globalizzato (pegno umano, schiavitù per debiti, lavoro coatto o vincolato, rapporti di sfruttamento paternalista, lavoro infantile, fenomeno dei bambini soldato, tratta di persone).
Testi di riferimentoIl programma d’esame per 4 CFU prevede la preparazione di un manuale generale (lista 1) e di un testo sull’argomento del corso monografico (lista 2).Chi avesse seguito il corso di Antropologia culturale può sostituire il manuale con un testo della lista 2.
1. Manuali:● Beattie, J., Uomini diversi da noi. Lineamenti di antropologia sociale (1964), Roma-
Bari, Laterza, 1972 (e successive ristampe).● Bernardi, B., Uomo cultura società. Introduzione agli studi demo-etno-antropologici,
Milano, Angeli, 1974 (e successive ristampe).● Signorini, I., a cura di, I modi della cultura. Manuale di etnologia, Roma, NIS (poi Ca-
rocci), 1992 (e successive ristampe).
2. Testi a scelta2.1. Schiavitù in generale
● Sichirollo, L. (ed.), Schiavitù antica e moderna. Problema Storia Istituzioni, Napoli,
74
Guida, 1979.● Testart, A., L’esclave, la dette et le pouvoir, Paris, Errance, 2001.● Vecchie e nuove schiavitù (Dispensa didattica a cura del docente, disponibile in Bi-
blioteca).
2.2. Rapporti di dipendenza personale● Solinas, P.G., a cura di, La dipendenza. Antropologia delle relazioni di dominio, Lec-
ce, Argo, 2005.● Solinas, P.G., a cura di, La vita in prestito. Debito, dipendenza, lavoro, Lecce, Argo,
2007.● Viti, F., a cura di, Antropologia dei rapporti di dipendenza personale, Modena, Il Fio-
rino, 2006.● Viti, F., a cura di, Lavoro, dipendenza personale e rapporti familiari, Modena, Il Fiori-
no, 2007.
2.3. Schiavitù e dipendenza personale in Africa● Falola, T. & P.E. Lovejoy (eds.), Pawnship in Africa. Debt Bondage in Historical Per-
spective, Boulder, Westview Press, 1994.● Meillassoux, C., Antropologia della schiavitù (1986), Milano, Mursia, 1992.● Meillassoux, C. (ed.), L’esclavage en Afrique précoloniale, Paris, Maspero, 1975.● Miers, S. & I. Kopytoff (eds.), Slavery in Africa. Historical and Anthropological Per-
spectives, Madison, The University of Wisconsin Press, 1977.● Tardits, C. (ed.), Princes et serviteurs du royaume. Cinq études de monarchies
africaines, Paris, Société d’Ethnographie, 1987.● Viti, F., Schiavi, servi e dipendenti. Antropologia dei rapporti di dipendenza persona-
le in Africa, Milano, Raffaello Cortina, 2007.
2.4. Tratta atlantica ● Davidson, B., Madre Nera. L’Africa nera e il commercio degli schiavi (1961), Torino,
Einaudi, 1966.● Deschamps, H., Storia della tratta dei negri dall’antichità ai nostri giorni (1971), Mila-
no, Mondadori, 1974.● Pietrostefani, G., La tratta atlantica. Genocidio e sortilegio, Milano, Jaca Book, 2000.● Renault, F. & S. Daget, Les traites négrières en Afrique, Paris, Karthala, 1985.
2.5. Schiavitù americana● Armellin, B., La condizione dello schiavo. Autobiografie degli schiavi neri negli Stati
Uniti, Torino, Einaudi, 1975.● Genovese, E., L’economia politica della schiavitù (1961), Torino, Einaudi, 1972.
2.6. La schiavitù nel mondo arabo-musulmano● Lewis, B., Razza e colore nell’Islam (1971), Milano, Longanesi, 1975.● Gordon, M., Slavery in the Arab World, New York, New Amsterdam Press, 1989.● Heers, J., Les Négriers en terre d'islam, Paris, Perrin, 2003.
2.7. Le nuove schiavitù● Arlacchi, P., Schiavi. Il nuovo traffico di esseri umani, Milano, Rizzoli, 1999.● Bales, K., I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale (1999), Milano,
Feltrinelli, 2000.● Carchedi, F., G. Mottura, E. Pugliese, a cura di, Il lavoro servile e le nuove schiavitù,
Milano, Angeli, 2003.● Esclavage moderne ou modernité de l’esclavage?, numero speciale della rivista
Cahiers d’Etudes africaines, 45 (3-4), 179-180, 2005.● Geffray, C., Chroniques de la servitude en Amazonie brésilienne, Paris, Karthala,
75
1995.● L’Ombre portée de l’esclavage. Avatars contemporains de l’oppression sociale,
numero speciale della rivista Journal des africanistes, 70, 1-2, 2000.● Leone, L., Infanzia negata. Piccoli schiavi nel pianeta globale, Roma, Prospettiva
Edizioni, 2003.
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è raccomandata ma non è obbligatoria.
Modalità d’esameL’esame è orale.
ValutazioneL’esame intende valutare la preparazione dello studente, le sue capacità espositive, la sua padronanza dei concetti della disciplina. La valutazione si basa sulla verifica della conoscen-za critica dei testi prescelti.
Linguistica francese
Prof.ssa Luciana T. SolimanCFU 8 – 40 ore
Obiettivi formativiIl corso intende far acquisire allo studente una buona competenza nell'ambito dell'analisi lin-guistica del francese dal punto di vista sincronico. Particolare attenzione viene riservata al re-perimento dei termini, alla loro spiegazione e presentazione su supporti cartacei ed elettroni-ci.
Prerequisiti Comprensione di una vasta gamma di testi complessi in lingua francese e di significati implici-ti. Produzione spontanea scorrevole. Spirito critico rilevabile attraverso una struttura articolata dell'esposizione scritta e orale nella lingua francese. Conoscenza della grammatica scolasti-ca.
Programma del corsoIl corso esamina la morfologia e la sintassi delle unità lessicali francesi e si focalizza sull'attivi-tà terminologica: i linguaggi specialistici, la formazione dei termini, la classificazione in mate-ria di terminologia, le varie tappe dell'attività terminologica/terminografica, la schedatura dei dati.Corso ed esami si svolgeranno in lingua francese.
Testi di riferimentoTesto principale:
● Cabré, M.T. (1998): La terminologie. Théorie, méthode et applications, Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa.
Alcuni dei testi cui viene fatto riferimento durante il corso:● Bergenholtz, H. et Tarp, S. (1995): Manual of specialised lexicography,
Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.● CST (1993): Raccomandazioni per l'attività terminologica, Berna, Cancelleria della
Confederazione Svizzera.● Dubuc, R. (1978): Manuel pratique de terminologie, Montréal, Linguatech.● Kocourek, R. (1991): La langue française de la technique et de la science: vers une
linguistique de la langue savante, Wiesbaden, Brandstetter.
76
● Landau, S.I. (1989): Dictionaries: the art and craft of lexicography, Cambridge, CUP.● Lerat, P. (1995), Les langues spécialisées, Paris, PUF.● Loffler-Laurian, A.-M. (1983): "Typologie des discours scientifiques: deux
approches", Etudes de linguistique appliquée, 51, p. 8-20.● Magris, M., M.T. Musacchio, L. Rega e F. Scarpa (a cura di) (2002): Manuale di Ter-
minologia. Aspetti teorici, metodologici e applicativi, Milano, Hoepli.● Mareschal, G. (1994): "Etude typologique et comparative de l'anglicisation et des
anglicismes dans quatre aires de la francophonie". In AA.VV., Etudes, recherches et documentation, Actes du Colloque sur les Anglicismes et leur Traitement Lexicographique (Magog, 24-27 septembre 1991), Québec, Gouvernement du Québec, p. 25-37.
● Pavel, S. (1993): "Neology and phraseology as terminology-in-the-making". In H.B. Sonneveld and K.L. Loening (eds), Terminology. Applications in interdisciplinary communication, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, p. 21-34.
● Perrin, M. (2002): "Langue de spécialité ou langue pour le spécialiste? Un faux débat!". In L. Schena e L.T. Soliman (a cura di), Prospettive linguistiche della nuova Europa, Atti del Congresso Linguistico Internazionale, Università Bocconi (Milano, 9-10 novembre 2001), p. 79-96.
● Rey, A. (1979): La terminologie. Noms et notions, Paris, PUF.● Rizzo, D. (1983): "La metodologia di identificazione dei neologismi francesi in termi-
nologia", Studi italiani di linguistica teorica ed applicata, XII, p. 21-36.● Sager, J.C. (1990): A practical course of terminology processing, Amsterdam/Phil-
adelphia, John Benjamins.
FrequenzaAltamente raccomandata.
Programma per i non frequentantiLettura dei seguenti testi con approfondimento dei temi indicati:
● Les dominantes linguistiques de la langue de la technique et de la science. Kocourek, R. (1991): La langue française de la technique et de la science: vers une linguistique de la langue savante, Wiesbaden, Brandstetter.
● Les fondements de la terminologie. Cabré, M.T. (1998): La terminologie. Théorie, méthode et applications, Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa.
● Le repérage de l'unité terminologique. Magris, M., M.T. Musacchio, L. Rega e F. Scarpa (a cura di) (2002): Manuale di Terminologia. Aspetti teorici, metodologici e applicativi, Milano, Hoepli.
Per maggiori informazioni contattare la docente.
Modalità d’esameL'esame prevede una prova scritta e una prova orale. La prova scritta consiste in un test per l'accertamento dei contenuti del corso. Durante la prova orale si prenderà visione degli elabo-rati delle prove scritte esaminando con attenzione i punti che offrono possibilità di discussione e i temi affrontati durante l'anno accademico. È prevista l'elaborazione di un dossier "A pas comptés dans le domaine de la terminologie" discusso durante la prova orale.
ValutazioneValutazione sommativa.
Linguistica inglese
Prof.ssa Marina Bondi – Prof.ssa Laura GavioliCFU 8 – 40 ore
77
Obiettivi formativiIl terzo anno di lingua inglese da un lato conclude un percorso di riflessione su strutture lingui-stiche e problemi culturali iniziato nei primi due anni, dall'altro vuole dare agli studenti stru-menti per applicare le conoscenze acquisite nel triennio di lingua inglese ad ambiti più specia-listici. L'obiettivo principale del III anno è quello di riflettere su convenzioni testuali, lessicali e fra-seologiche e di far capire come queste possono essere manipolate secondo i tipi testuali e l’interazione discorsiva che si vuole produrre. In un’ottica di formazione continua, si intende fare in modo che lo studente impari a “notare” tali convenzioni e ad associarle a determinati tipi di generi testuali, in modo che sia quindi in grado di riprodurre questo processo di appren-dimento in ambiti futuri. Il corso ha inoltre i seguenti obiettivi:Condurre lo studente all'acquisizione di un elevato grado di competenza linguistica pratica, in cui sia rispettato l'equilibrio fra le abilità di comprensione e di produzione, tanto nell'ambito orale che in quello scritto. Promuovere una consapevolezza di differenze culturali e dinamiche linguistiche che permet-tano di adattare testi alle varie situazioni comunicative Promuovere l'acquisizione di strumenti di analisi delle pratiche linguistiche che favoriscano la formazione continua, anche in contesti professionali, attraverso la riflessione sulla lingua e sulle metodologie di analisi della lingua.
Prerequisiti Avere superato gli esami relativi agli insegnamenti di Lingua inglese (I anno) e Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese (II anno).
Programma del corsoIl corso è così organizzato: - un corso ``principale'' che si svolge attraverso lezioni frontali a cura delle Prof. Marina Bon-di e Laura Gavioli.- esercitazioni linguistiche che si svolgono in gruppi di 25 studenti a cura del centro linguistico d’ateneo. - un seminario operativo in laboratorio informatico
Il corso si focalizza su caratteristiche lessicali e fraseologiche di testi di tipo accademico e po-litico e sul significato della loro realizzazione nel testo. Come prospettiva metodologica, si concentra sul problema del “ripensare” alla struttura linguistica partendo dal suo uso, piuttosto che da una astrazione formale di tipo grammaticale. Si osserva che le associazioni fra le pa-role non seguono soltanto una logica di tipo razionale, ma sono largamente condizionate da convenzioni di tipo culturale o sociale. In questa prospettiva, che viene messa in luce partico-larmente attraverso la corpus linguistics, si nota che i concetti di idiomaticità e di “collocazio-ne” lessicale occupano una parte non periferica nell’uso della lingua, soprattutto in relazione a linguaggi specialistici o settoriali. Verrà dato ampio spazio ad attività in cui gli studenti si eser-citeranno nell’analisi di aspetti lessicali, fraseologici e testuali, attraverso gli strumenti della corpus linguistics, e alla discussione di tali analisi in classe. Il corso si tiene in lingua inglese.Le esercitazioni linguistiche saranno mirate ad approfondire da un lato capacità relative all'a-scolto e al parlato, dall'altro alla lettura e scrittura critica. I temi trattati saranno sia di interesse generale sia di osservazione linguistica.Per il seminario, vedi i programmi relativi delle docenti: M. Bondi, S. Cacchiani, G. Diani, L. Gavioli, D. Malavasi
Testi di riferimentoSi suggerisce di leggere i testi nell’ordine dato qui sotto:
● Sinclair, J. 1991. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.
● Hunston, S. and G. Thompson 2000. Introduction to the volume. In S. Hunston and G. Thompson (eds) Evaluation in text. Oxford: Oxford University Press. 74-101.
78
● Hunston, S. 2004. “It has rightly been pointed out …”: Attribution, Consensus and Conflict in Academic Discourse. In M. Bondi, L. Gavioli and M. Silver (eds.) Academ-ic Discourse, Genre and Small Corpora. Roma: Officina.
● Stubbs, M. 2001. Words in culture 1: Case studies of cultural keywords. In M. Stubbs Words and Phrases. Oxford. Blackwell. 145-169.
● Sinclair, J. 1996. “The search for units of meaning”. Textus, 9,1. 75-106.● Louw, B. 1993. “Irony in the text or insincerity in the writer? The diagnostic potential
of semantic prosodies”. In Baker et al. 157-176.
Altri Strumenti
● Oxford Collocations dictionary for students of English", Oxford University Press, 2002.
● Randolph Quirk, Jan Svartvik, Geoffry Leech, Sidney Greenbaum "A Comprehensive Grammar of the English Language" Longman, 1984.
● Douglas Biber, Stig Johansson, Susan Conrad, "Longman Grammar of Spoken and Written English", Longman, 1999.
FrequenzaLa frequenza è data per presupposta. Sono considerati studenti frequentanti coloro che han-no seguito indicativamente almeno il 75% delle lezioni
Programma per i non frequentantiGli studenti non frequentanti devono preparare i seguenti testi:
● Sinclair, J. 1991. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: OUP● Hunston, S. and G. Thompson (eds) 2000. Evaluation in text. Oxford: Oxford Uni-
versity Press.● Hunston, S. 2004. “It has rightly been pointed out …”: Attribution, Consensus and
Conflict in Academic Discourse. In M. Bondi, L. Gavioli and M. Silver (eds.) Academ-ic Discourse, Genre and Small Corpora. Roma: Officina.
● Stubbs, M. 2001. Words in culture 1: Case studies of cultural keywords. In M. Stubbs Words and Phrases. Oxford. Blackwell. 145-169.
● Sinclair, J. 1996. “The search for units of meaning”. Textus, 9,1. 75-106.● Louw, B. 1993. “Irony in the text or insincerity in the writer? The diagnostic potential
of semantic prosodies”. In Baker et al. 157-176.
Devono inoltre imparare ad analizzare le concordanze attraverso la preparazione del seguen-te testo:
● Sinclair, J. 2003. Reading Concordances. London: Longman/Pearson.
Devono infine procurarsi le dispense di Testi e Concordanze ed esercitarsi ad esemplificare quanto acquisito
Modalità d’esameLaboratorio, scritta e orale
ValutazioneLa valutazione tiene conto della prova in laboratorio linguistico (listening comprehension), del-la prova scritta e della prova orale. Tutte le prove devono essere sufficienti per contribuire alla valutazione. Per gli studenti frequentanti si tiene conto anche delle prove in itinere svolte du-rante il lettorato.
79
Linguistica spagnola
Prof.ssa Daniela CapraCFU 8 – 40 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di affinare la consapevolezza sulle strutture linguistiche della lingua spa-gnola in un'ottica contrastiva e di aumentare la competenza linguistica attiva.
Prerequisiti L'esame può essere affrontato solo dopo aver superato la seconda annualità, ma la frequen-za al corso è ovviamente aperta a tutti gli studenti del terzo anno.
Programma del corsoLa presentazione teorica delle strutture sintattiche, morfosintattiche e testuali dello spagnolo attuale si alternerà con l'analisi di testi appartenenti alle diverse tipologie. Particolare attenzio-ne verrà data anche ad aspetti lessicali e fraseologici e al loro uso contestualizzato.
Testi di riferimento● Alcoba, S., "El léxico: condiciones de uso", in S. Alcoba (ed.), La oralización, Barce-
lona, Ariel, 1999, pp. 63-101.● Barbero, J.C. e F. San Vicente, Actual. Gramática para comunicar en español, Bolo-
gna, CLUEB, 2006.● Calvi, M.V. e L. Chierichetti, Nuevas tendencias en el discurso de especialidad,
Bern, Peter Lang, 2007.● Corpas Pastor, G., Diez años de investigación en fraseología: análisis sintáctico-se-
mánticos, contrastivos y traductológicos, Madrid, Iberoamericana, 2003.
FrequenzaNon obbligatoria, ma presupposta e consigliata.
Programma per i non frequentantiNon sono previsti testi aggiuntivi né alternativi rispetto al programma per i frequentanti.
Modalità d’esameOrale.
ValutazioneL'esame finale, orale, verterà sugli aspetti teorici presentati a lezione e accessibili attraverso la lettura dei testi in bibliografia. Per potere accedere all'esame con la docente, gli studenti dovranno aver superato l'esame scritto di spagnolo III e il relativo accertamento linguistico.
Linguistica Tedesca
Prof. Ernst KretschmerCFU 8 – 40 ore
Obiettivi formativiL’obiettivo del corso è quello di introdurre alle categorie descrittive e alle metodologie analiti-che ed empiriche della “linguistica del contatto”.
Prerequisiti Il corso si svolgerà in tedesco.
Programma del corso
80
Al centro del corso sta il concetto del “contatto linguistico”, inteso, nel senso più generale, come contatto tra due o più lingue diverse. I tentativi di descrivere il fenomeno, che fa parte della nostra realtà linguistica quotidiana, in termini scientifici, risalgono agli ultimi decenni del IXX sec. (August Schleicher, Hermann Paul, Graziadio Ascoli, Hugo Schuchardt) e portano negli anni ‘70 del XX sec. alla nascita e allo sviluppo della “linguistica del contatto”, termine creato da Nelde nel 1980 (“Kontaktlinguistik”). All’interno di essa si possono distinguere tre campi di ricerca principali che corrispondono a tre aspetti fondamentali della linguistica in ge-nerale: la lingua come sistema, l’individuo che si serve della lingua e l’ambito costituito dagli individui che si servono di una lingua. Del primo aspetto si occupa la linguistica sistematica, del secondo la psicolinguistica e del terzo la sociolinguistica. In questo quadro si collocano i temi principali del corso: il bilinguismo individuale e collettivo e le rispettive categorie descritti-ve (code switching e mixing; diglossia e dominio; pidgin e creolo) – lingua, cultura ed identità – l’influsso linguistico (trasferenza ed interferenza; calchi e prestiti) – la mediazione linguistica (traduzione ed interpretariato, insegnamento e apprendimento).
Testi di riferimentoLibri da acquistare:
● Riehl, Claudia Maria (2004), Sprachkontaktforschung. Eine Einführung, Tübingen: Narr.
● Heringer, Hans Jürgen (2004), Interkulturelle Kommunikation, Tübingen, Basel: Francke (UTB 2550).
La bibliografia completa sarà comunicata all’inizio del corso
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è normalmente presupposta. In casi motivati, lo studente può chie-dere, all’inizio del corso, di essere dispensato dalla frequenza concordando un programma per non-frequentanti con il docente. Si considerano frequentanti gli studenti che seguono al-meno il 75% delle lezioni.
Modalità d’esameScritto e orale
ValutazioneCon prova finale
Marketing internazionale
Prof.ssa Marina VignolaCFU 8 – 30 ore
Obiettivi formativiIl corso è strutturato in due moduli: il primo presenta le principali problematiche relative alla formulazione della strategia di marketing e alla sua applicazione in termini operativi attraverso l'utilizzo delle leve di marketing: prodotto, prezzo, promozione e distribuzione. Il secondo mo-dulo è dedicato ai processi di internazionalizzazione delle imprese. In particolare il corso si propone di analizzare le motivazioni che spingono le imprese ad entrare sui mercati interna-zionali e le problematiche strategiche e organizzative che esse devono affrontare per supera-re i confini nazionali e operare sui mercati esteri. Esso fornisce conoscenze teoriche ed appli-cate per la comprensione delle strategie di marketing internazionale con le quali le imprese sviluppano la loro presenza sul mercato europeo ed internazionale, ponendo particolare enfa-si sul tema delle differenze culturali che caratterizzano i singoli mercati e le implicazioni di queste sulla definizione delle strategie di marketing mix.
Prerequisiti Nessuno
81
Programma del corsoI contenuti del primo modulo vertono sui seguenti temi: introduzione alla disciplina del marke-ting (distinzione tra marketing strategico ed operativo); definizione di settore e analisi del comportamento della concorrenza (definizione dei confini settoriali, concetto di concorrenza); analisi della domanda (analisi del comportamento del consumatore); strategie concorrenziali di base (definizione di strategia, definizione di vantaggio competitivo, analisi delle strategie concorrenziali di base); analisi del mercato e processo di segmentazione (definizione del si-stema informativo di marketing; processo di segmentazione della domanda e criteri di seg-mentazione); pianificazione di marketing (sviluppo di un piano di marketing); strategie di pro-dotto (descrizione di prodotto; analisi del ciclo di vita del prodotto; innovazione di prodotto; po-litiche di gestione della marca); strategie di prezzo (analisi dei costi, descrizione delle modalità di determinazione del prezzo, politiche di prezzo); strategie di comunicazione di mar-keting (analisi degli strumenti di comunicazione aziendale; sviluppo di una campagna pubbli-citaria); strategie distributive (descrizione delle tipologie di canale distributivo; analisi dei prin-cipali fattori di scelta della lunghezza del canale distributivo).
I contenuti del secondo modulo vertono sulle conoscenze teoriche ed applicate per la com-prensione delle strategie di marketing internazionale con le quali le imprese sviluppano la loro presenza sui mercati internazionali. Più in dettaglio, i contenuti del modulo vertono sui seguenti temi: analisi delle motivazioni e degli ostacoli all’internazionalizzazione; analisi e selezione dei mercati esteri; analisi delle strategie e delle modalità di entrata (esportazione diretta, esportazione indiretta, accordi di collaborazione internazionale, investimenti diretti esteri; analisi dei fattori di scelta della moda-lità di entrata); analisi degli strumenti di marketing operativo attraverso cui le imprese svilup-pano e realizzano le strategie di presenza sui mercati esteri; tecniche di segmentazione dei mercati esteri; strategie di prodotto e relative politiche di standardizzazione e di adattamento; strategie di prezzo e relativi criteri di definizione; strategie di comunicazione e scelta dei prin-cipali strumenti di comunicazione. Testi di riferimento
● Fiocca R., Marketing, impresa e mercato, McGraw-Hill, 2005● Valdani E., Bertoli G., Mercati internazionali e marketing, Egea 2006
FrequenzaLa frequenza è fortemente consigliata
Programma per i non frequentantiNon è previsto un programma alternativo per i non frequentanti
Modalità d’esameProva scritta: test e domande aperte
Mediazione scritta e orale francese - italiano
Prof. Aleardo TridimontiCFU 4 – 40 ore
Obiettivi formativiIl corso mira a fornire allo studente competenze linguistiche funzionali ad una corretta com-prensione ed interpretazione di situazioni di comunicazione di varia natura e di vari ambiti, fi-nalizzate alla mediazione orale e scritta interlinguistica.Verranno potenziati i prerequisiti o abilità preliminari, come: la padronanza della lingua e del-la cultura francese; la capacità di comprensione, analisi, sintesi di tipologie discorsive, eventi o scambi comunicativi orali e scritti dal francese all’italiano e dall’italiano al francese di com-
82
plessità progressiva; l’abilità del parlare in pubblico; la capacità di concentrazione e di memo-rizzazione; la capacità di trasmettere con rigore, precisione e naturalezza messaggi via via più complessi nel pieno rispetto del registro e della prosodia.A seconda degli eventi comunicativi proposti, gli studenti saranno chiamati a svolgere il lavoro preparatorio in vista dell’attività di simulazione di una specifica situazione di mediazione da e verso il francese: elaborazione di una rete o mappa di conoscenze riguardanti l’argomento oggetto dell’attività di mediazione; ricerca documentaria mirata (corpora paralleli); elaborazio-ne di un glossario funzionale nelle due lingue. Di particolare importanza è la padronanza di una tecnica della presa di appunti.
Prerequisiti possedere una buona base culturale e linguistica (italiano e francese);possedere, in lingua francese, buone competenze linguistico-culturali orali e scritte.
Programma del corsoIl corso è di durata annuale e si articola in due moduli:
1) Modulo scritto (1° semestre): le esercitazioni si svolgono in laboratorio di informatica.Uso delle risorse della rete per la comunicazione e la gestione dell’informazione: impostazio-ne di una ricerca documentaria mirata ed efficace; uso dei corpora paralleli; dizionari, glossa-ri, banche terminologiche on-line; approccio al lessico settoriale con elaborazione di glossari funzionali nelle due lingue. Avviamento al trattamento verso il francese, di alcune tipologie di testi scritti e alla traduzione di documenti di natura commerciale, turistica, culturale, riguar-danti scambi situazionali di comunicazione afferenti gli ambiti di cui sopra. Al termine del modulo, è prevista la prova scritta (valida per la valutazione finale) per accerta-re le competenze acquisite.
2) Modulo orale (secondo semestre): le esercitazioni si svolgono in laboratorio di lingue.Potenziamento delle capacità di attenzione, di concentrazione, di memorizzazione e di comu-nicazione interpersonale. Padronanza di una efficace tecnica della presa di appunti. Capacità di preparare un’attività di mediazione e trattativa su una tematica specifica: approfondimento delle conoscenze sull’argomento con elaborazione di una rete o mappa concettuale; capacità di gestire un evento comunicativo simulando una situazione di mediazione linguistica in simul-tanea e/o consecutiva; abilità del parlare in pubblico e capacità di trasmettere con rigore, pre-cisione e naturalezza messaggi via via più complessi nel pieno rispetto del registro e della specificità del lessico.
La scelta dei materiali verrà modulata secondo il livello degli studenti
Testi di riferimento● Josiane Podeur: La pratica della traduzione: dal francese in italiano, dall’italiano in
francese, Napoli, Liguori, 1993.Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite dal docente durante il corso.
FrequenzaLa partecipazione alle lezioni non è da intendersi come mero assolvimento di un obbligo for-male, ma risulterà essenziale in vista delle finalità formative del corso e dell’esame previsto. Le lezioni sono delle esercitazioni pratiche o “ateliers” che si svolgono alternativamente in la-boratorio di informatica (per consultazione, ricerca documentaria e terminologica, corpora pa-ralleli, attività scritte) e in laboratorio linguistico per la parte orale.
Programma per i non frequentantiTrattandosi di esercitazioni in laboratorio, è difficile programmare attività per non frequentanti. Ogni situazione verrà valutata individualmente.
Modalità d’esame(con riserva di modifica che verrà comunicata in itinere):
83
1) Una prova di produzione scritta dall’italiano verso il francese riguardante un evento o scambio comunicativo trattato durante il corso ; 2) Due prove orali: A partire da brevi documenti pre-registrati su audio/videocassetta, lo studente dovrà, a partire dalla presa di appunti, simulare in consecutiva una attività di mediazione interlinguistica orale.
a) francese-italiano riguardante un argomento trattato durante il corso.b) italiano-francese riguardante un argomento trattato durante il corso.
ValutazionePer ogni candidato, la scheda di valutazione delle sue prove comporta le seguenti voci:Per la parte scritta: correttezza formale, coesione, contenuto, pertinenza, efficacia della pro-duzione secondo le consegne fornite;Per la parte orale: a) francese - italiano:
capacità di concentrarsi, di seguire il ritmo della fonte emittente, di memorizzarne il contenuto, di restituirlo in l’italiano, nonché di gestire la comunicazione.
livello di completezza, chiarezza, precisione dell’informazione ed efficacia della rifor-mulazione.
proprietà di linguaggio; pertinenza del lessico; correttezza della costruzione; adegua-tezza dello stile; coesione.
b) italiano-francese: qualità dell’esposizione; capacità di gestire la comunicazione; naturalezza e
“fluency”. contenuti; capacità di sintesi; completezza e chiarezza; efficacia dell’informazione. proprietà di linguaggio; pertinenza del lessico; correttezza della costruzione; adegua-
tezza dello stile; coesione. pronuncia.
Mediazione scritta e orale inglese-italiano
Prof.ssa Michela Giorgio Marrano, Prof. Giuseppe PalumboCFU 4 – 40 ore
Obiettivi formativiIl corso intende sviluppare, in tema di mediazione orale, le capacità di interazione in situazioni che richiedono la conoscenza dell'inglese e dell'italiano. Per quanto riguarda la mediazione scritta, il corso mira ad accrescere la consapevolezza degli studenti su aspetti quali la retorica contrastiva, le differenze tra generi testuali e i riferimenti culturali . Ha inoltre i seguenti obietti-vi:promuovere una consapevolezza delle dinamiche interazionali della conversazione e della costruzione congiunta dei ruoli personali, professionali e culturali dei partecipanti all'interazio-ne;promuovere una consapevolezza di differenze culturali e dinamiche linguistiche che permetta-no di facilitare la comunicazione fra culture diverse in interazioni istituzionali di diverso tipo (di affari, presso servizi sociali, ecc.).
Prerequisiti Conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue
Programma del corsoIl corso si concentra sulla lingua come interazione fra situazioni e partecipanti e si focalizza
84
su strategie adottate dai parlanti nel rendere esplicito ed accettabile non solo un messaggio, ma anche il proprio ruolo istituzionale e/o personale all'interno dell'interazione. Si discute il problema dell'"implicito" nel discorso e di come la negoziazione del "non detto" possa avere valenze importanti nell'interazione cross-culturale. Vengono analizzate le dinamiche della conversazione, secondo il metodo della "conversation analysis'' in interazioni cross-culturali mediate da un traduttore. Per quel che concerne la lingua scritta, gli studenti verranno spinti ad analizzare e confrontare testi in inglese e italiano, soffermandosi da un lato sugli aspetti di retorica contrastava e dal-l'altro sui riferimenti, impliciti e ed espliciti, al contesto socio-culturale in cui i testi sono stati prodotti.Poiché il corso ha carattere di laboratorio, ampio spazio verrà dato ad attività pratiche di ascolto e di traduzione in interazioni verbali e scritte.
Testi di riferimentoLibri
● Gentile, A., U. Ozolins and M. Vasilakakos; with L. Ko and T.-T. Quynh-Du (1996) Li-aison interpreting: a handbook. Victoria, Melbourne University Press.
● Katan, D. (2004) Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. 2nd revised edition, Manchester, St Jerome.
● Wadensjö, C. (1998) Interpreting as interaction. London, Longman.Articoli
● Bruce, R. and W. Anderson, (2002) “Perspectives on the Role of the Interpreter”. In F. Pöchhacker and M. Shlesinger (eds) The Interpreting Studies Reader. London and New York, Routledge.
● Garzone, G. (2001) "Mediazione Linguistica e Interculturalità nell'ambiente Azienda-le". Culture, 15 (http://www.club.it/culture/culture2001/giuliana.garzone/corpo.tx.garzone.html).
● Garzone, G. (2002) "The Cultural Turn. Traduttologia, Interculturalità e Mediazione Linguistica". Culture, 16 (http://www.club.it/culture/culture2002/giuliana.garzone/corpo.tx.garzone.html)
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è considerata un presupposto della organizzazione didattica.
Programma per i non frequentantiGli studenti che non potessero frequentare sono pregati di rivolgersi ai docenti per scegliere un percorso individuale di letture integrative.
Modalità d’esameL'esame si articola in due parti: una prova scritta e una prova in laboratorio di ascolto e tradu-zione orale di un testo a carattere divulgativo non specialistico; la prova di ascolto sarà segui-ta da un colloquio che verterà in parte sul commento della prova in laboratorio, in parte sui te-sti in bibliografia.
ValutazioneLa valutazione terrà conto della capacità del candidato di individuare i fattori della situazione comunicativa e di trasporli in lingua di arrivo
Mediazione scritta e orale tedesco-italiano
Prof. Cesare Giacobazzi – Prof. Hans HonnackerCFU 4 – 40 ore
Metodi didattici
85
L’approccio sarà prevalentemente di tipo linguistico-comunicativo e contrastivo che verrà spiegato ed esercitato durante il seminario
Obiettivi formativiPrincipale obiettivo del seminario è fornire allo studente nozioni sulla teoria e sulla prassi del-la “mediazione” nei paesi germanofoni (concetto di “mediazione”, campi di applicazione, ecc.) e dotarlo degli strumenti linguistici adeguati, in particolare della terminologia specifica, al fine di un’ipotetica soluzione di casi di mediazione.
PrerequisitiGli studenti che intendono seguire questo seminario, dovrebbero aver acquisito, prima dell’ini-zio del seminario stesso, le competenze linguistiche previste dal livello B2 del Portfolio Euro-peo delle Lingue (PEL).
Programma del corsoIl seminario di “Mediazione scritta e orale tedesco/italiano” si rivolge agli studenti del terzo anno della laurea di base. In un primo modulo vengono introdotti i concetti della “mediazione” e della professione del “mediatore” come vengono intesi nei paesi germanofoni (cfr. al riguar-do anche gli artt. 1754 sgg. del codice civile italiano: “mediatore è colui che mette in relazione due o più persone per la conclusione di un affare. Il mediatore agisce con imparzialità ed au-tonomia rispetto alle parti interessate ai negozi di cui si occupa [...].”). In un secondo modulo, tali nozioni teoriche vengono applicate a casi conflittuali di vari ambiti (mediazione scolastica, mediazione ambientale, mediazione economica ecc.), tratti dalla cronaca attuale, per simula-re un’eventuale mediazione in lingua tedesca.
Testi di riferimento● Baumer (2002)Baumer, Thomas, Handbuch Interkulturelle Kompetenz, Zürich, Orell
Füssli, 2002, 2 voll.● Cosmai (2003)● Cosmai, Domenico, Tradurre per l’Unione Europea. Problematiche e strategie ope-
rative, Milano, Hoepli, 2003● Hösl (2002)● Hösl, Gerhard G., Mediation. Die erfolgreiche Konfliktlösung. Grundlagen und prakti-
sche Anwendung, München, Kösel-Verlag, 2002
Modalità d’esameL’esame finale consiste in una prova orale in cui viene simulata un’eventuale mediazione di un caso conflittuale.
Mediazione scritta e orale spagnolo-italiano
Docente da definireCFU 4 – ore 40
Programma da definire
Seminario di Linguistica Inglese
Prof.ssa Marina BondiCFU 4 – 20 ore
“Introducing text and corpus analysis: analysing news discourse”
Obiettivi formativi
86
Il seminario si propone di introdurre gli studenti ai metodi della corpus linguistics e di metterli in grado di analizzare raccolte di testi elettronici
Prerequisiti Si consiglia la frequenza del corso di Linguistica Inglese.
Programma del corsoA partire da un corpus di articoli di giornale, verranno presentati alcuni strumenti operativi per la costruzione e l’analisi di corpora elettronici. Gli studenti saranno quindi guidati a un proget-to di lavoro autonomo nel corso del quale dovranno costruire un corpus di testi elettronici e utlizzarlo per un progetto di traduzione, di redazione testuale o di analisi lessico-fraseologica.
Testi di riferimentoA seconda del tipo di progetto che svilupperanno, gli studenti faranno riferimento ad almeno uno dei seguenti testi:
● Bowker, L. and J. Pearson 1997. Working with specialised language. London: Rout-ledge.
● Hunston, S. 2002. Corpora in applied linguistics. Cambridge : Cambridge University Press.
● Baker, P. 2006, Using Corpora in Discourse Analysis, London:Continuum.● Partington, A. 1998. Patterns and meanings. Amsterdam: John Benjamins● Scott, M. and C. Tribble 2006. Textual Patterns. Amsterdam: John Benjamins.● Tognini Bonelli, E. 2001. Corpus linguistics at work. Amsterdam: John Benjamins● Adolphs, S. 2006. Introducing electronic text analysis. London: Routledge
Frequenzaobbligatoria, almeno il 70% delle lezioni
Programma per studenti “non frequentanti”Studenti “non frequentanti assoluti” (sia corso di Linguistica Inglese sia seminario) Gli studenti studieranno il programma per “non frequentanti” del Corso di Linguistica Inglese (proff. Bondi/Gavioli). Per il seminario, dovranno leggere tre libri (Partington 1998, Tognini Bo-nelli 2001, Hunston 2002) e, nella tesina redatta in inglese, discuteranno tre usi delle concor-danze che ritengono interessanti per la propria formazione linguistica. La discussione dovrà essere trasversale rispetto ai tre volumi.
● Partington, A. 1998. Patterns and meanings. Amsterdam: John Benjamins ● Tognini Bonelli, E. 2001. Corpus linguistics at work. Amsterdam: John Benjamins ● Hunston, S. 2002. Corpora in applied linguistics. Cambridge : Cambridge University
Press
Studenti “non frequentanti” il seminario Gli studenti che hanno seguito il corso di Linguistica Inglese ma che non hanno frequentato il seminario potranno essere seguiti a distanza dal docente così da poter svolgere il progetto e la tesina come gli studenti frequentanti il seminario. Dovranno leggere due libri, che verranno indicati dal docente, e saggi pertinenti al progetto, unitamente ai tutorials on-line per imparare a usare le concordanze, di cui si riporta il sito:http://devoted.to/corpora. All’interno del sito, gli studenti dovranno fare riferimento specificamente ad alcune pagine che verranno selezionate dal docente.
Modalità d’esameGli studenti elaboreranno un progetto e una tesina. La tesina verrà discussa in inglese al mo-mento della verbalizzazione.
Valutazione
87
Sulla base della prova finale
Seminario di Linguistica Inglese
Prof.ssa Silvia CacchianiCFU 4 – 20 ore
“Lessico valutativo e concordanze”
Obiettivi formativiIl seminario si propone di introdurre gli studenti ai metodi della corpus linguistics al fine di analizzare raccolte di testi in formato elettronico.
Prerequisiti Frequenza del corso di Linguistica Inglese.
Programma del corsoA partire da un corpus di book reviews e un corpus di book blurbs, verrannopresentati gli strumenti che il software (AntConc3.2.: http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp) met-te a disposizione per la costruzione e l’analisi di corpora elettronici. Particolare attenzione sarà dedicata al lessico valutativo e a sviluppare la consapevolezza nello studente di come lo scopo della ricerca determini la scelta di materiali e metodi di indagine. Gli studenti saranno quindi guidati nella elaborazione di un proprio progetto di ricerca e nella costruzione di un pro-prio piccolo corpus. Lo studente dovrà quindi dimostrare nella elaborazione autonoma del saggio finale (tesina) come l’utilizzo del corpus si sia rivelato utile/ fondamentale al fine della traduzione, dell’analisi testuale o dell’analisi lessico-fraseologica.
Testi di riferimentoGli studenti dovranno fare riferimento ad almeno uno dei seguenti testi in base al progetto che svilupperanno:
● Bowker, L. and J. Pearson 1997. Working with specialised language. London: Rout-ledge.
● Hunston, S. 2002. Corpora in applied linguistics. Cambridge : Cambridge University Press.
● Olohan, M. 2004. Introducing corpora in translation studies. London/New York: Rout-ledge.
● Partington, A. 1998. Patterns and meanings. Amsterdam: John Benjamins● Scott, M. and C. Tribble 2006. Textual Patterns. Amsterdam: John Benjamins.● Tognini Bonelli, E. 2001. Corpus linguistics at work. Amsterdam: John Benjamins
Frequenza Frequenza obbligatoria, almeno per il 70% delle lezioni
Programma per studenti “non frequentanti”Studenti “non frequentanti assoluti” (corso di Linguistica Inglese e seminario) Gli studenti studieranno il programma per “non frequentanti” del Corso di Linguistica Inglese (proff. Bondi/Gavioli). Per il seminario, dovranno leggere tre libri (Partington 1998, Tognini Bo-nelli 2001, Hunston 2002) e, nella tesina redatta in inglese, discuteranno tre usi delle concor-danze che ritengono interessanti per la propria formazione linguistica. La discussione dovrà essere trasversale rispetto ai tre volumi.
● Partington, A. 1998. Patterns and meanings. Amsterdam: John Benjamins ● Tognini Bonelli, E. 2001. Corpus linguistics at work. Amsterdam: John Benjamins ● Hunston, S. 2002. Corpora in applied linguistics. Cambridge : Cambridge University
Press
88
Studenti “non frequentanti” il seminario Gli studenti che hanno seguito il corso di Linguistica Inglese ma che non hanno frequentato il seminario potranno essere seguiti a distanza dal docente così da poter svolgere il progetto e la tesina come gli studenti frequentanti il seminario. Dovranno leggere due libri, che verranno indicati dal docente, e saggi pertinenti al progetto, e svolgere i tutorials on-line per imparare a usare le concordanze (http://devoted.to/corpora). All’interno del sito, gli studenti dovranno fare riferimento specificamente ad alcune pagine che verranno selezionate dal docente.
Modalità d’esameGli studenti elaboreranno un progetto e una tesina in inglese che consegneranno al docente via email ([email protected]). La tesina verrà discussa in inglese al momento della verbalizzazione.
ValutazioneSulla base della prova finale (tesina e discussione).
Seminario di Linguistica Inglese
Prof.ssa Giuliana DianiCFU 4 – 20 ore“Le concordanze per lo studio del contratto legale”
Obiettivi formativiIl seminario si propone di introdurre agli studenti gli strumenti e i metodi della corpus lingui-stics e di metterli così in grado di analizzare raccolte di testi da cui derivarne aspetti caratte-rizzanti.
Prerequisiti Si consiglia la frequenza del corso di Linguistica Inglese.
Programma del corsoIl seminario si focalizza sul genere del contratto legale, di cui si analizzeranno le caratteristi-che lessico-sintattiche e testuali. Gli studenti saranno guidati a un progetto di ricerca condotto sulla base degli strumenti metodologici forniti durante il seminario (costruzione di un corpus di contratti al fine di produrre un’analisi lessicale o traduzione accompagnata da commento criti-co).
Testi di riferimentoA seconda del tipo di progetto che svilupperanno, gli studenti faranno riferimento ad almeno uno dei seguenti testi per ogni area (discorso legale - corpus linguistics)
Discorso legale
● Danet, B. 1985. “Legal Discourse”. In Van Dijk, T.A. (ed.) Handbook of Discourse Analysis. Vol. 1. London: Academic Press, pp.273-291.
● Gibbons, J. 2003. Forensic Linguistics. An Introduction to Language in the Justice System. Oxford: Blackwell Publishing. (Chap. 2 “The Pursuit of Precision”, pp.36-73; Chap. 5 “Communication Issues in the Legal System”, pp.162-186)
● Rossini Favretti, R. 1994. Reading Legal Texts in English. Bologna: Pitagora Editri-ce.
● Tiersma, P.M. 1999. Legal Language. Chicago and London: Chicago University (Part II. The nature of Legal Language, pp.51-143)
● Trosborg, A. 1997. Rhetorical Strategies in Legal Language. Discourse Analysis of Statutes and Contracts. Tübingen: Narr.
89
Corpus Linguistics● Partington, A. 1998. Patterns and meanings. Amsterdam: John Benjamins● Hunston, S. 2002. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University
Press (Chapters 1 to 4)
FrequenzaObbligatoria, almeno il 70% delle lezioni
Programma per studenti “non frequentanti”Studenti “non frequentanti assoluti” (sia corso di Linguistica Inglese sia seminario) Gli studenti studieranno il programma per “non frequentanti” del Corso di Linguistica Inglese (proff. Bondi/Gavioli). Per il seminario, dovranno leggere tre libri (Partington 1998, Tognini Bo-nelli 2001, Hunston 2002) e, nella tesina redatta in inglese, discuteranno tre usi delle concor-danze che ritengono interessanti per la propria formazione linguistica. La discussione dovrà essere trasversale rispetto ai tre volumi.
● Partington, A. 1998. Patterns and meanings. Amsterdam: John Benjamins ● Tognini Bonelli, E. 2001. Corpus linguistics at work. Amsterdam: John Benjamins ● Hunston, S. 2002. Corpora in applied linguistics. Cambridge : Cambridge University
Press
Studenti “non frequentanti” il seminario Gli studenti che hanno seguito il corso di Linguistica Inglese ma che non hanno frequentato il seminario potranno essere seguiti a distanza dal docente così da poter svolgere il progetto e la tesina come gli studenti frequentanti il seminario. Dovranno leggere due libri, che verranno indicati dal docente, e saggi pertinenti al progetto, unitamente ai tutorials on-line per imparare a usare le concordanze, di cui si riporta il sito: http://devoted.to/corpora. All’interno del sito, gli studenti dovranno fare riferimento specificatamente ad alcune pagine che verranno selezio-nate dal docente.
Modalità d’esameGli studenti elaboreranno un progetto e una tesina. La tesina verrà discussa in inglese al mo-mento della verbalizzazione.
ValutazioneSulla base della prova finale
Seminario di Linguistica Inglese
Prof.ssa Laura GavioliCFU 4 – 20 ore
“Le concordanze per l’apprendimento di un linguaggio specialistico”
Obiettivi formativiIl seminario si propone di introdurre gli studenti ai metodi della corpus linguistics e di metterli in grado di analizzare raccolte di testi elettronici
Prerequisiti Si consiglia la frequenza del corso di Linguistica Inglese.
Programma del corsoA partire da un corpus di linguaggio economico, verranno presentati alcuni strumenti operativi per la costruzione e l’analisi di corpora elettronici. Gli studenti saranno quindi guidati a un pro-getto di lavoro autonomo nel corso del quale dovranno costruire un corpus di testi elettronici e
90
utlizzarlo per un progetto di traduzione, di redazione testuale o di analisi lessico-fraseologica.
Testi di riferimentoA seconda del tipo di progetto che svilupperanno, gli studenti faranno riferimento ad almeno uno dei seguenti testi:
● Bowker, L. and J. Pearson 1997. Working with specialised language. London: Rout-ledge.
● Hunston, S. 2002. Corpora in applied linguistics. Cambridge : Cambridge University Press.
● Olohan, M. 2004. Introducing corpora in translation studies. London/New York: Rout-ledge.
● Partington, A. 1998. Patterns and meanings. Amsterdam: John Benjamins● Scott, M. and C. Tribble 2006. Textual Patterns. Amsterdam: John Benjamins.● Tognini Bonelli, E. 2001. Corpus linguistics at work. Amsterdam: John Benjamins
Frequenzaobbligatoria, almeno il 70% delle lezioni.
Programma per studenti “non frequentanti”Studenti “non frequentanti assoluti” (sia corso di Linguistica Inglese sia seminario) Gli studenti studieranno il programma per “non frequentanti” del Corso di Linguistica Inglese (proff. Bondi/Gavioli). Per il seminario, dovranno leggere tre libri (Partington 1998, Tognini Bo-nelli 2001, Hunston 2002) e, nella tesina redatta in inglese, discuteranno tre usi delle concor-danze che ritengono interessanti per la propria formazione linguistica. La discussione dovrà essere trasversale rispetto ai tre volumi.
● Partington, A. 1998. Patterns and meanings. Amsterdam: John Benjamins ● Tognini Bonelli, E. 2001. Corpus linguistics at work. Amsterdam: John Benjamins ● Hunston, S. 2002. Corpora in applied linguistics. Cambridge : Cambridge University
Press.
Studenti “non frequentanti” il seminario Gli studenti che hanno seguito il corso di Linguistica Inglese ma che non hanno frequentato il seminario potranno essere seguiti a distanza dal docente così da poter svolgere il progetto e la tesina come gli studenti frequentanti il seminario. Dovranno leggere due libri, che verranno indicati dal docente, e saggi pertinenti al progetto, unitamente ai tutorials on-line per imparare a usare le concordanze, di cui si riporta il sito: http://devoted.to/corpora. All’interno del sito, gli studenti dovranno fare riferimento specificamente ad alcune pagine che verranno selezionate dal docente.
Modalità d’esameGli studenti elaboreranno un progetto e una tesina. La tesina verrà discussa in inglese al mo-mento della verbalizzazione.
ValutazioneSulla base della prova finale
Seminario di Linguistica Inglese
Prof.ssa Donatella MalavasiCFU 4 – 20 ore
“Corpus Linguisitcs and the Financial/Business Discourse”
Obiettivi formativi
91
Il seminario ha come obiettivo quello di familiarizzare gli studenti con gli strumenti della lingui-stica dei corpora (wordlists, concordances and keywords) e di metterli così in grado di utiliz-zare tale metodologia per la produzione di traduzioni e per l’analisi di raccolte di testi.
Prerequisiti Non ci sono pre-requisiti formali anche se la frequenza del corso di Linguistica Inglese può fa-cilitare la comprensione dei contenuti trattati nel corso del seminario.
Programma del corsoIl seminario propone un’introduzione agli strumenti della linguistica dei corpora e alla loro applicabilità ad analisi di raccolte di testi. Lo studio di un corpus di materiali riconducibili al settore finanziario sarà utilizzato per determinarne le parole chiave, analizzarne il lessico spe-cialistico e valutativo. Gli studenti saranno guidati a raccogliere un corpus di materiali e a for-mulare, sulla base dello stesso, un progetto analitico (osservare e descrivere un particolare fenomeno lessicale) o a produrre la traduzione di un testo in lingua inglese.
Testi di riferimentoGli studenti dovranno fare riferimento ad almeno uno dei seguenti testi:
● Partington, A. 1998. Patterns and Meanings. Using Corpora for English Language Research and Teaching. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
● Bowker, L. and J. Pearson. 2002. Working with Specialised Language. A practical guide to using corpora. London/New York: Routledge.
● Hunston, S. 2002. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
● Scott, M. and C. Tribble 2006. Textual Patterns. Key words and corpus analysis in language education. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Ulteriori riferimenti bibliografici saranno forniti a lezione.
Frequenzaobbligatoria, almeno il 70% delle lezioni
Programma per studenti non frequentantiStudenti “non frequentanti assoluti” (sia corso di Linguistica Inglese sia seminario) Gli studenti prepareranno il programma per “non frequentanti” del Corso di Linguistica Inglese (proff. Bondi/Gavioli). Per il seminario, gli studenti dovranno leggere tre libri (Partington 1998, Tognini Bonelli 2001, Hunston 2002) e, procedendo alla stesura di una tesina in lingua ingle-se, discutere tre usi delle concordanze che ritengono maggiormente rilevanti ai fini della loro formazione linguistica. La discussione dovrà interessare trasversalmente i tre volumi. • Partington, A. 1998. Patterns and Meanings. Using Corpora for English Language Re-
search and Teaching. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins• Tognini-Bonelli, E. 2001. Corpus Linguistics at Work. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins • Hunston, S. 2002. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University
Press. Studenti “non frequentanti” il seminario Gli studenti che hanno seguito il corso di Linguistica Inglese ma che non hanno frequentato il seminario potranno essere seguiti a distanza dal docente così da poter elaborare un progetto similare a quello degli studenti frequentanti il seminario. Dovranno leggere due libri, che ver-ranno suggeriti dal docente, e saggi pertinenti al progetto, unitamente ai tutorials on-line che consentiranno agli studenti di acquisire dimestichezza con le concordanze e il loro uso (cf. http://devoted.to/corpora).
Modalità d’esameGli studenti raccoglieranno un corpus di materiali ed elaboreranno una tesina. La tesina verrà
92
discussa in lingua inglese al momento della verbalizzazione.
ValutazioneSulla base della prova finale
Seminario di Linguistica Francese
Prof.ssa Luciana T. SolimanCFU 4 – 20 ore
Obiettivi formativiIl seminario intende esplorare gli elementi coordinanti e subordinanti che danno coesione al discorso consentendo allo studente di acquisire una buona competenza nell'ambito dell'anali-si linguistica della frase francese sul piano sincronico. Il seminario costituisce un itinerario gui-dato che mira a riflettere sulle possibilità di (ri)formulazione degli enunciati.
Prerequisiti Comprensione di una vasta gamma di testi complessi in lingua francese e di significati implici-ti. Produzione spontanea scorrevole. Spirito critico rilevabile attraverso una struttura articolata dell'esposizione scritta e orale nella lingua francese. Conoscenza della grammatica scolasti-ca.
Programma del corsoIl seminario offre un quadro informativo completo dei fenomeni grammaticali della frase filtrato attraverso una rilettura trasformazionale. Vengono passati in rassegna ed esaminati gli ele-menti coesivi che esprimono l'antefatto, lo scopo, la causa, la conseguenza, la concessione-opposizione, l'ipotesi e il paragone. L'accento sarà posto sul valore delle scelte stilistiche.Corso ed esame si svolgeranno in lingua francese.
Testi di riferimentoTesto principale:
● Schena, L. (1991): Etude descriptive de la phrase. Ses constituants, ses formes, ses transformations, Milano, Pubblicazioni ISU Università Cattolica.
● Schena, L. et R. Del Maestro (1991): Etude descriptive de la phrase. Exercices, Mi-lano, Pubblicazioni ISU Università Cattolica.
Alcuni dei testi cui viene fatto riferimento durante il seminario:● Charaudeau, P. (1992): Grammaire du sens et de l'expression, Paris, Hachette.● Le Goffic, P. (1993): Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette.● Riegel, M., J.-C. Pellat et R. Rioul (1994): Grammaire méthodique du français, Paris,
PUF.● Weinrich, H. (1989): Grammaire textuelle du français, Paris, Didier/Hachette.● Wilmet, M. (1997), Grammaire critique du français, Louvain-la-Neuve, Duculot.
FrequenzaAltamente raccomandata.
Programma per i non frequentantiLettura dei seguenti testi con approfondimento dei temi indicati:
● De la phrase simple à la phrase complexe et de la phrase unique à la phrase multiple. Wilmet, M. (1997), Grammaire critique du français, Louvain-la-Neuve, Duculot.
● Les types de relations logiques. Charaudeau, P. (1992): Grammaire du sens et de l'expression, Paris, Hachette.
93
● Nominalisation et transformation infinitive. Schena, L. (1991): Etude descriptive de la phrase, Milano, Pubblicazioni ISU Università Cattolica.
Per maggiori informazioni contattare la docente.
Modalità d’esameÈ prevista l'elaborazione di una tesina su "La phrase: conditions d'emploi".
ValutazioneValutazione sommativa.
Seminario linguistica spagnola
Docente da definireCFU 4 – ore 20
Programma da definire
Seminario linguistica spagnola
Docente da definire CFU 4 – ore 20
Programma da definire
Seminario di linguistica tedesca
Prof. Ernst KretschmerCFU 4 – 20 ore
Obiettivi formativiIl corso mira ad una applicazione pratica delle metodologie di ricerca finora acquisite, offren-do agli studenti la possibilità di condurre uno studio autonomo per presentare i risultati ottenu-ti in aula e per discuterli con gli altri partecipanti al seminario.
Prerequisiti Il corso si svolgerà in tedesco.
Programma del corsoIl seminario si abbina al corso di linguistica tedesca e prevede l’approfondimento degli argo-menti trattati attraverso tesine scritte e presentate dagli studenti (vedi il programma del corso di linguistica tedesca).
Testi di riferimentoLibri da acquistare:
● Riehl, Claudia Maria (2004), Sprachkontaktforschung. Eine Einführung, Tübingen: Narr.
● Heringer, Hans Jürgen (2004), Interkulturelle Kommunikation, Tübingen, Basel: Francke (UTB 2550).
La bibliografia completa sarà comunicata all’inizio del corso.
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è normalmente presupposta. In casi motivati, lo studente può chie-dere, all’inizio del corso, di essere dispensato dalla frequenza concordando un programma
94
per non-frequentanti con il docente. Si considerano frequentanti gli studenti che seguono al-meno il 75% delle lezioni.
Modalità d’esame Tesina scritta e presentazione orale della tesina in aula.
Semiotica della comunicazione
Prof.ssa Annalisa ColivaCFU 4 – 40 ore
Obiettivi formativiIl corso di Semiotica della comunicazione ha la funzione di completare gli studi delle lingue e del linguaggio da un punto di vista teorico con particolare attenzione al fenomeno della comu-nicazione e al linguaggio pubblicitario.
PrerequisitiNessuno.
Programma del corsoIl corso sarà diviso in due parti – Corso istituzionale e Corso monografico – di 20 ore ciascu-na.
Corso istituzionale (parte in comune con Filosofia del linguaggio, SDC): Natura umana o cul-tura? Il problema della relazione tra linguaggio e pensiero.Questa parte del corso s’incentra sul rapporto tra linguaggio e pensiero per come è stato con-cepito all’interno della filosofia analitica dalle sue origini ai giorni nostri e fornisce strumenti e concetti di base che si riveleranno utili per la parte monografica.
Corso monografico: Comunicazione, conversazione, metafore e ironia1. Dalla teoria della “forza” di Frege alla teoria degli atti linguistici di Austin;2. Il rapporto tra semantica e pragmatica (da Wittgenstein alla teoria degli atti linguisti-
ci);3. La teoria del significato di Grice e le obiezioni di Searle;4. Il rapporto tra convenzioni e intenzioni;5. Implicature e massime conversazionali;6. Alcune applicazioni della teoria di Grice: metafora e ironia;7. Altre teorie della metafora: Davidson;8. L’analisi freudiana del motto di spirito.
Testi di riferimentoCorso istituzionale (LCE)Testi
● Frege, G. [1918] “Il pensiero”, in Ricerche logiche, Guerini, 1988, pp. 43-74.● Wittgenstein, L. [1953] Ricerche filosofiche, Einaudi, 1967, i paragrafi 1-3; 23-25, 32;
198-270, 326-350, 358-362, 571.
CommentiGenerali: Coliva, A. I concetti. Teorie ed esercizi, Carocci, 2004, Introduzione e cap. 1.Su Frege: Coliva, A. Dispense disponibili negli Spazi condivisi.Su Wittgenstein: Coliva, A. Dispense disponibili negli Spazi condivisi. Perissinotto, L. Wittgenstein. Una guida, Feltrinelli, 1997, pp. 88-113.
Corso monografico (LCE) Testi
95
● Austin, J. L 1962 Come fare cose con le parole, tr. it. Marietti, Torino, 1990 (Lezioni I-IV, VIII, XI: pp. 7-42; 71-81; 98-107).
● Davidson, D. “Che cosa significano le metafore”, in Verità e interpretazione, Il Muli-no, Bologna, 1994, pp. 337-360.
● Freud, S. Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio, Bollati Boringhieri, 1991, pp. 33-52; 54-68; 71-89; 97-180.
● Grice, P. Logica e conversazione, Il Mulino, 1993, capp. 2, 3, 9.● Searle, J. Atti linguistici, Bollati Boringhieri, 1992, par. 2.6 (pp. 72-80).
Commenti● Coliva, A. Dispense disponibili negli Spazi condivisi, sotto “Filosofia del linguaggio”.● Lycan, W. G. Filosofia del linguaggio. Un’introduzione contemporanea, Raffaello
Cortina, 2002, capp. (7), 11-14.
FrequenzaVivamente consigliata. Ancorché il numero di pagine da studiare non sia particolarmente alto, si tratta di testi difficili e impegnativi che trovereste grandi difficoltà ad affrontare da soli.
Modalità dell’esameLa frequenza (almeno il 75% del monte ore) dà la possibilità di sostenere una prova scritta a metà del corso e una alla fine. Il voto sarà dato dalla media delle due prove, con la possibilità di migliorare con un orale mirato là ove i risultati non siano soddisfacenti.
Sociologia dei processi culturali
Prof. Vittorio Iervese CFU 4 – ore 40
Mutuato da Scienze della Cultura
96
Scienze della Cultura – I anno
Antropologia Culturale
Prof. Stefano BoniCFU 10 – 60 ore
“Identità, alterità e valore nelle culture e nella scrittura antropologica”
Metodi didattici Lezione frontale, occasionali proiezioni video
Obiettivi formativiIl corso introdurrà nozioni di base dell’antropologia culturale illustrandole secondo la polarità identità / alterità. Le rappresentazioni del sociale sono immagini potenti, nel senso che consi-stono in operazioni cognitive appetibili per la loro capacità di ridurre la complessità a schemi fuorvianti ma facilmente assimilabili. Queste rappresentazioni sono, al contempo, immagini del potere, nel senso che le dinamiche di devalorizzazione, discriminazione, sfruttamento e oppressione si fondano sulla diffusione di tale immaginario. L’antropologia verrà vista come una delle discipline che ha cercato di mettere in crisi rappresentazioni semplicistiche e mistifi-catorie di cosa sia il sesso, la razza, la cultura, l’etnia, la nazione. Il processo simultaneo di immersione in socialità estranee all’orizzonte ideologico di riferimento del ricercatore e di di-stanziamento critico dalle potenti rappresentazioni del potere, genera le premesse epistemo-logiche per raffinare le categorie concettuali e ripensare le linee teoriche adatte a rappresen-tare i raggruppamenti sociali.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso verterà sulla classificazione dell’umanità in gruppi e sulla rappresentazione degli attri-buti di tali raggruppamenti. Il discorso si articolerà sul legame dialettico tra realtà e rappresen-tazione delle regolarità sociali: modelli di condotta differenziata, comportamenti standardizza-ti, evocano e legittimano canoni di delimitazione ed ordinamento delle individualità; al contem-po, le rappresentazioni generano aspettative di condotta differenziata per categorie di appartenenza. Verranno analizzate le logiche che regolano l’immagine e l’immaginario dei raggruppamenti: l’amplificazione delle differenze, spesso mediante la riduzione della com-plessità ad una opposizione binaria; l’essenzializzazione, ossia la spiegazione delle diverse caratteristiche dei gruppi con riferimento ad una essenza comune al gruppo e irriducibilmente distinta dagli altri; l’iconicità, l’associazione di simboli alle categorie sociali; l’inserimento della tassonomia sociale vigente nella sfera di ciò che è naturale e quindi universale e immodifica-bile; la lettura dei raggruppamenti attraverso i canoni della purezza e della contaminazione.
Testi di riferimentoIl programma d'esame prevede la preparazione dei seguenti testi.
La dispensa “Identità, alterità e valore nelle culture e nella scrittura antropologica”, con testi scelti dal docente, che raccoglie i contributi che verranno discussi in classe. Tra gli altri S. Na-del, F. Remotti, N. Elias, A. Jacquard, N.-C. Mathieu, H. Trevor-Roper, R.R. Grinker.
Un testo a scelta tra i seguenti: ● S. Boni, 2003 Le Strutture della Disuguaglianza: Capi, appartenenze e gerachie nel
mondo Akan, Africa Occidentale, Milano, Franco Angeli.● P. Bourdieu, 1972 Per Una teoria della pratica, Milano, Cortina (2003).
97
● P. Bourdieu, 1979 La distinzione, Bologna, Il mulino (1983).● S.F. Nadel, 1949 Lineamenti di Antropologia Sociale, Bari, Laterza (1974).● F. Remotti, 1990 Noi Primitivi, Torino, Bollati Boringhieri.● P.G. Solinas (ed.), 1995 Luoghi d’Africa, NIS, Roma.
Un testo a scelta tra i seguenti:
● R. Astuti, 1995 People of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press.● M. Busoni, 2000 Genere, sesso, cultura, Roma, Carocci.● P. Clastres, 1974 La società contro lo stato, Verona, Ombre Corte (2003).● U. Fabietti, 1995 L’identità Etnica, NIS, Roma.● F. Héritier, 2002 Dissolvere la gerarchia, Milano, Cortina (2004).● M. Herzfeld, 2003 Intimità Culturale, Napoli, L’Ancora.● R. Lewontin, 1991 La biologia come ideologia, Torino, Boringhieri (1993).● F. Remotti (ed.), 1997 Le antropologie degli altri. Saggi di etno-antropologia, Torino,
Scriptorium.● T. Todorov, 1982 La conquista dell'America: Il problema dell' "altro", Torino, Einaudi
(1984).● L. Piasere, 2002 L’etnografo imperfetto, Bari, Laterza.● F. Laplantine, 1999 Identità e métissage: Umani al di là delle apparenze, Milano,
Elèuthera (2004).
FrequenzaFacoltativa
Programma per i non frequentantiIl programma di esame per i non-frequentanti è identico a quello per i frequentanti. Vedere, sopra, la voce “testi di riferimento”.
Modalità d’esameOrale
ValutazioneIn base al suddetto esame orale. I criteri di valutazione sono i seguenti: capacità dello studen-te di riassumere in maniera chiara e sintetica i contenuti dei libri letti; capacità di svolgere confronti e analisi dei testi; di espriemere le proprie opinioni e chiavi di lettura dei suddetti te-sti.
Informatica per le Scienze Umane
Prof.ssa Laura AscariCFU 4 – 20 ore
Obiettivi formativiIl Corso intende dotare gli/le studenti/esse di conoscenze e competenze informatiche di base in linea con il curriculum proposto per la disciplina di Informatica Umanistica la quale, sebbe-ne non abbia ancora raggiunto formalmente lo statuto di disciplina autonoma, nondimeno è da anni oggetto di studi e ricerche specifiche sia in Italia sia all’esterno dove è comunemente nota con la denominazione Computer and the Humanities. L’obiettivo del corso è dotare gli studenti di strumenti e metodi che consentano loro di rappor-tarsi alle nuove tecnologie non semplicemente come utenti passivi ma come interlocutori attivi in grado di assumere un atteggiamento critico nell’utilizzo delle nuove tecnologie in relazione al contesto sociale e culturale attuale, di orientarsi nella scelta di strumenti informatici struttu-rati secondo approcci e filosofie differenti.
98
Il corso intende sottolineare inoltre il rapporto tra tecnologia e scienze umane al fine di valo-rizzare il contributo che l’umanista può apportare al dialogo tra strutture, rappresentazioni e contenuti nell’ICT. Parte del Corso affronterà il tema dell’accesso all’informazione in rete, per introdurre strategie utili ad evitare l’overload of information insita nell’approccio spontaneo e in assenza di stru-menti critici per la valutazione e la selezione dell’informazione. Si tratteranno quindi strategie di ricerca avanzata on line e analisi critica dell’usabilità e del-l’autorevolezza dei contenuti in rete. Introdurremo elementi di scrittura per Web e l’approccio user-centered alla strutturazione dei contenuti per la rete.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl Corso di Informatica è strutturato in un Corso unico annuale 4 crediti suddiviso in due mo-duli I semestre-SdC – formazione a distanzaII semestre-SdC—tutoring su progettoI semestreIntroduzione al Corso e agli strumenti per i percorsi di autoapprendimento (Incontro in presen-za I semestre – 2 ore) Introduzione alla ICT e alla multimedialità. Il concetto di multimedialità e di comunicazione multimediale. I sistemi operativi e la gestione del PC. La rivoluzione GUI. Sistema Windows e filosofia opensource. (Autoapprendimento – 3 ore) La struttura dell’elaboratore: i sistemi di memoria; le periferiche e l’unità di elaborazione cen-trale. (Autoapprendimento – 4 ore) La compatibilità tra sistemi e applicativi. Il File System e l’organizzazione della memoria- (Au-toapprendimento – 2 ore)Testi ed elaboratori di testi. Formato dei file, compatibilità e portabilità dei file di testo. I font: font scalabili e font bitmap. L’elaboratore Word per Windows: funzioni di base utili alla scrittu-ra di un documento di tesi.(Stili personalizzati, indici e sommari, formattazione di un testo, note, integrazione immagini, grafici e oggetti nel documento.) Funzioni utili all’utilizzo in am-biente multilingue: modifica impostazioni tastiera, impostazione della lingua, correttori orto-grafici. L’uso dei modelli di documento. Adobe Acrobat R/W. Gestire documenti estesi: com-primere, decomprimere file. (Autoapprendimento – 15 ore) Introduzione alle reti. Le reti locali. Internet e il WWW concetti di URL, HTML, Account, pas-sword, userid, ISP, ADSL, dominio, host (Autoapprendimento – 2 ore). Stili di navigazione: categoriale e prototipica. Information overload – censire, catalogare e va-lutare è possibile? Strategie di ricerca avanzata i concetti di discovery e retrieval. Motori di ri-cerca. Metamotori di ricerca. L’utilizzo degli operatori logici, l’analisi della pertinenza e la sele-zione della informazioni. Criteri di valutazione delle fonti: paratesti, riferimenti bibliografici, co-pyright. Criteri di autenticazione della qualità del testo. (FAD – 6 ore) Ergonomia cognitiva. Usabilità e accessibilità degli strumenti informatici: il concetto di usabili-tà per gli strumenti, usabilità dei contenuti. Elementi di Web writing. Lettore ideale e lettore reale. L’iniziativa WAI nella P.A. (FAD – 4 ore) Strumenti e ambienti: Piattaforme web-based per la condivisione di materiali. Chat Forum Blog (FAD – 2 ore)Reti e società: cyberspazio e realtà virtuale. Il cyberspazio come spazio sociale: le comunità on line, comunità di pratica, comunità di apprendimento. Lévy e l’intelligenza collettiva. Il pro-blema del digital divide.(FAD – 4 ore) Le risorse in rete: Tipologia di risorse: Web text versus repository texts. Informazione struttu-rata e de-strutturata. Le biblioteche digitali. I cataloghi in rete: OPAC-METAOPAC; sistemi in-formativi e accesso all’informazione. Le risorse “locali”: Cisab, Sistema Bibliotecario Provin-ciale, CIB. La letteratura digitale: e-book e scrittura collettiva. (FAD – 3 ore) Strumenti di presentazione: Power Point (FAD – 3 ore) II semestre
99
Utilizzo degli strumenti informatici e delle conoscenze acquisite nell’applicazione ipermediale in altro abito disciplinare.Progetti particolari possono essere concordati con il docente.
Testi di riferimentoRisorse di rete e materiali digitali verranno resi disponibili all’indirizzo www.lettere.unimo.it/pub accessi autenticati, nella cartella Informatica Scienze Umane. SDC
● F. Ciotti, G. Roncaglia, Il mondo digitale, Ed. Laterza, 2000 ● Parte pratica, quando necessario.● S. Rubini, Elaborazione testi, Ed. APOGEO ● S. Rubini. Strumenti di Presentazione, Ed. APOGEO
FrequenzaSi intenda come frequenza la partecipazione allo spazio condiviso dedicato (BSCW) al quale occorre iscriversi tramite apposita lista sul sito Web di Facoltà lasciando nome cognome ed indirizzo e-mail di Facoltà. ([email protected])
Programma per i non frequentantiCome per frequentanti
Modalità d’esameProva orale annuale.
ValutazionePer l’idoneità è richiesta agli studenti la partecipazione allo spazio condiviso, la preparazione in merito ai contenuti teorici, la creazione di un ipertesto, di una presentazione Power Point o di una tesina Word il cui contenuto sviluppi uno degli argomenti teorici incontrati durante il Corso di Laurea, a scelta tra tutte le discipline e previo accordo con il docente interessato. La forma dovrà includere tutte le potenzialità tecniche dello strumento di presentazione scelto.
Letteratura italiana
Prof. Duccio TongiorgiCFU 6 – 60 ore
“Il tema della “beffa” nella letteratura italiana tra Tre e Cinquecento”
Obiettivi formativiConoscenza critica dell’opera dei maggiori esponenti della letteratura italiana dal Trecento al Cinquecento. Capacità di contestualizzare storicamente i movimenti culturali più rilevanti del periodo indicato. Conoscenza dello sviluppo del tema letterario della “beffa” nel periodo indi-cato.
Prerequisiti Gli studenti che sanno di avere gravi lacune nella conoscenza dei movimenti e degli autori cir-coscrivibili ai secoli di riferimento del corso sono consigliati, anche se frequentanti, di avviare una preparazione personale, studiando attentamente almeno le sezioni del manuale indicate nel programma per “non frequentanti”.
Programma del corsoFilo conduttore delle lezioni sarà il tema della "beffa" tra Tre- e Cinquecento, con particolare (ma non esclusiva) attenzione alla sua codificazione letteraria nel genere breve della novella. Sono previste letture da:DANTE ALIGHIERI, Inferno (canti XXI-XXIII)GIOVANNI BOCCACCIO, Decameron (in specie le giornate VII e VIII)
100
La novella del Grasso LegnaiuoloNICCOLÒ MACHIAVELLI, La mandragolaLUDOVICO ARIOSTO, Orlando FuriosoANTON FRANCESCO GRAZZINI (Il Lasca), Le cene (I Cena, novella VIII)
Testi di riferimentoÈ richiesta la conoscenza dei testi presentati durante le lezioni. Di ciascun autore trattato ver-rà fornita durante il corso una adeguata presentazione critica. In ogni caso la preparazione potrà convenientemente essere consolidata attraverso lo studio di un buon manuale liceale.Si studino inoltre i seguenti saggi:
● M. PICONE, Giulleria e poesia nella Commedia: una lettura intertestuale di Inferno XXI-XXII, “Letture classensi”, 1989, pp. 11-30 (in biblioteca).
● L. BATTAGLIA RICCI, Giovanni Boccaccio, in Storia della letteratura italiana, diretta da Enrico Malato, Roma, Salerno, vol. II (Il Trecento), pp. 783-830.
● G. FERRONI, “Mutazione” e “riscontro” nel teatro di Machiavelli e altri saggi sulla com-media del Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1972, pp. 19-101.
● R. BIGAZZI, Le risorse del romanzo, Pisa, Nistri-Lischi, 1996, pp.17-46.● R. MAURIELLO, Artisti e beffe in alcune novelle del ’500 (Lasca, Doni, Fortini), “Lettera-
tura e arte”, 2005, 3, pp. 81-91 (in biblioteca).
FrequenzaSi considereranno “frequentanti” gli studenti che abbiano seguito il corso con continuità e che si siano procurati gli appunti delle (poche) lezioni a cui non hanno potuto partecipare.
Programma per i non frequentantiLettura, su una buona edizione commentata, di
● DANTE ALIGHIERI, Inferno, canti XIX, XXI-XXII.● GIOVANNI BOCCACCIO, Decameron (si consiglia l’edizione a cura di V. Branca, Torino,
Einaudi): giornata I, novelle 1, 3, 7; giornata IV, Introduzione; giornata VI, novella 1; giornata VII, novelle 1, 2, 8; giornata VIII, novelle 3, 4, 6; giornata IX, novelle 3 e 5; giornata X, novella 10.
● NICCOLÒ MACHIAVELLI, La Mandragola.● LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso raccontato da Italo Calvino, Milano, Mondadori,
1995: Angelica inseguita (pp.35-60); Le incatenate dell'isola del Pianto (pp.99-108); Cloridano e Medoro (pp.151-166); La pazzia d'Orlando (pp.189-198); Astolfo sulla luna (pp.237-249).
Gli studenti non frequentanti dovranno anche studiare: ● Z. G. BARAŃSKI, La Commedia, in Manuale di letteratura italiana, a cura di F. Brioschi
e C. Di Girolamo, vol. I, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, pp. 492-560.● L. BATTAGLIA RICCI, Boccaccio, Roma, Salerno editore, 2000.● G. FERRONI, “Mutazione” e “riscontro” nel teatro di Machiavelli e altri saggi sulla com-
media del Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1972, pp. 19-101.● S. ZATTI, Il Furioso fra epos e romanzo, Lucca, Pacini Fazi, 1990, pp. 9-111.
Gli studenti non frequentanti dovranno infine conoscere bene – preparandosi su un buon ma-nuale liceale – i profili dei seguenti autori: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boc-caccio, Angelo Poliziano, Luigi Pulci, Matteo Maria Boiardo, Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini, Pietro Bembo, Ludovico Ariosto.
Modalità d’esameEsame orale
101
Lingua Francese
Prof.ssa Giovanna BellatiCFU 10 – ore 60 Mutuato da Lingue e Culture Europee
Lingua Inglese
Prof.ssa Franca Poppi10 CFU – 60 ore
Obiettivi formativi Il corso intende condurre all’acquisizione di strumenti teorici e metodologici per l’analisi de-scrittiva della lingua inglese. Oggetto di studio saranno i sotto-sistemi: fonologico (in particola-re la divaricazione fra il sistema dei suoni della lingua inglese e quello della loro rappresenta-zione grafica), morfologico, sintattico, semantico-lessicale, nonché il confronto costante con quelli dell’italiano e di altre lingue moderne. L’allenamento alla riflessione rigorosa sui ‘fatti di lingua’, dovrebbe agevolare il raggiungimento di un ragionevole livello di consapevolezza lin-guistica.
PrerequisitiLa frequenza, nella scuola superiore, di un corso aggiornato di grammatica descrittiva dell’in-glese.
Programma del corsoFonetica e Fonologia: La scelta dello standard inglese - Lo standard italiano - Foni, Fonemi, Allòfoni - Gli alfabeti fonetici - Cenni di anatomia e fisiologia dell'apparato fonatorio - Vocali e Consonanti - I fonemi dell'italiano - I fonemi dell'inglese - I due sistemi a confronto - Studio dei singoli fonemi segmentali - Fonemi soprasegmentali: accento, ritmo, intonazione.Grammatica dell'enunciato: InvarianteVs. Effetti del senso. Tense e Time - La nozione verbo - Presente e Preterito - Invariante e usi di 0/S/D - L'operatore TO - Modalizzazione, modalità, modali. Modalità assertiva, interrogativa, negativa, ingiuntiva, riassertiva, epistemica, deonti-ca, dinamica - Riasserzione vs. enfasi - L'operatore DO - L'Aspetto verbale: imperfettivo, per-fettivo, perfetto - Il Perfetto inglese: di risultato, di esperienza, di persistenza, di "passato re-cente" - BE e la caratterizzazione del Soggetto - Invariante e usi di BE +ING - HAVE e la lo-calizzazione del Predicato - Invariante e usi di HAVE +EN - L'espressione della futurità in inglese - La diàtesi passiva.Grammatica del nome: La nozione nome - Determinanti - Quantificatori - Pro-forme - Relazio-ni fra nomi: NN, N's N, N of N - Altri operatori notevoli.Grammatica dell'enunciato complesso: Coordinazione - Subordinazione.
Testi di riferimento● G. Gagliardelli, The words of an Economist, Pitagora, Bologna, 1997.● G. Gagliardelli, Elementi di grammatica enunciativa della lingua inglese, CLUEB,
1999.
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è normalmente presupposta, in quanto permette di acquisire in modo guidato orientamenti fondamentali che permettono di raggiungere nei tempi previsti gli obiettivi formativi proposti e dichiarati per l’insegnamento. In casi motivati, lo studente può chiedere, all’inizio del corso, di essere dispensato dalla frequenza concordando un program-ma per non-frequentanti con i docenti. Si considerano frequentanti gli studenti che seguono almeno il 75% delle lezioni.
102
Modalità d’esameL’esame finale consta in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta, sotto forma di test di completamento di frasi, di cloze procedures, di quesiti a scelta multipla, ecc., avrà come oggetto gli argomenti trattati dai docenti nelle lezioni frontali e dai collaboratori linguistici nel corso dei lettorati. La prova orale, che si sostiene con il docente di cui si sono frequentate le lezioni, verte sul programma svolto da quest’ultimo.
ValutazioneE’ ammesso a sostenere la prova orale chi ha superato la prova scritta riportando un voto di almeno diciotto/30. Il voto meritato nella prova orale fa media col voto della prova scritta e co-stituisce il voto finale che in sede d’esame sarà riportato nel processo verbale e nel libretto dello studente.
Lingua Spagnola
Prof.ssa Silvia BettiCFU 10 – ore 60
Obiettivi formativiIl corso di Lingua Spagnola intende portare gli studenti alla conoscenza di alcuni degli aspetti fondamentali della lingua e della cultura spagnola e ispanoamericana.
PrerequisitiNessuno
Programma del corsoLingua spagnolaIl corso di Lingua Spagnola, annuale, si propone di introdurre gli studenti alla lingua e cultura spagnola. Mediante lezioni frontali si fornirà una panoramica della lingua spagnola attraverso lineamenti storici e le aree di diffusione della lingua (spagnolo peninsulare e spagnolo d’Ame-rica). Si parlerà delle altre lingue ufficiali della Spagna (catalano, basco, galiziano), dello spa-gnolo negli Stati Uniti e del fenomeno dello spanglish.In sintonia con gli obiettivi dei due corsi di laurea a cui si rivolge (Lingue e Culture Europee e Scienze della Cultura) questo corso presterà attenzione contemporaneamente agli aspetti lin-guistici, culturali e storici propri dei due corsi di laurea, in modo da preparare lo studente ad affrontare il secondo anno di spagnolo, in cui tali aspetti verranno approfonditi.
Lingua spagnola-parte linguisticaLETTORATOSi consiglia agli studenti di frequentare le lezioni di lettorato tenute dalle Docenti di lingua ma-dre, lezioni che intendono fornire e consolidare le strutture morfosintattiche e comunicative di base, attraverso lo sviluppo delle quattro macroabilità (comprensione orale e scritta ed espressione orale e scritta).
Testi di riferimento● Alatorre, Antonio, Los 1001 años de la lengua española, Madrid, FCE, 2003.● Berschin, H.-Fernández-Sevilla, J.-Felixberger, J., La lingua spagnola- Diffusione,
storia, struttura, Taravacci, P. (ed. it.), Firenze, Le Lettere, 1999.● Betti, Silvia, Apuntes sobre el español de ayer y de hoy, Modena, Il Fiorino, 2006,
2^edizione.● Canepari, Luciano, Introduzione alla fonetica,Torino, Piccola Biblioteca Einaudi,
1979, pp. 268 – 277.● Fontanella de Weinberg, M.Beatriz, El español de América, Madrid, MAPFRE, 1993
(2°edizione).● Grijelmo, Álex, La seducción de las palabras, Madrid, Taurus, 2004.
103
● Henríquez Ureña, Pedro, Storia della cultura nell’America Spagnola, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1961 (2°edizione).
● Lodares, Juan R., El paraíso políglota, Madrid, Taurus, 2000.● Lodares, Juan R., Gente de Cervantes, historia humana del idioma español, Madrid,
Taurus, 2001.● Nooteboom, Cees, Verso Santiago. Itinerari spagnoli, Milano, Feltrinelli, 2001.● Quesada Marco, Sebastián, España siglo XXI, Madrid, Edelsa, 2004.● Siguan, Miquel, España plurilingüe, Madrid, Alianza Editorial Universidad, 1992.● Todorov, Tzvetan, La conquista dell’America. Il problema dell’”altro”, Torino, Einaudi,
1992.
LettoratoI titoli dei testi in uso durante il lettorato saranno comunicati dalle docenti il primo giorno di le-zione.
Ulteriori riferimenti bibliografici verranno dati nel corso delle lezioni.*Eventuali modifiche e/o integrazioni al programma presentato saranno comunicate agli stu-denti durante le lezioni.
DIZIONARI consigliati● AA.VV., Clave, diccionario de uso del español actual, SM, Madrid, ultima edizione;
MONOLINGUE● AA.VV., Gran diccionario de la lengua española, Madrid, SGEL, ultima edizione;
MONOLINGUE● CALVO RIGUAL - GIORDANO, Diccionario italiano (italiano-español; español- italia-
no), Barcellona, Herder, ultima edizione;● Diccionario Salamanca de la lengua española, Santillana, Madrid 1996; MONOLIN-
GUE● Tam, Laura, Dizionario spagnolo-italiano, italiano-spagnolo, Milano, Hoepli, ultima
edizione.
FrequenzaLa regolare frequenza alle lezioni è normalmente presupposta per tutti gli studenti.
Programma per i non frequentantiNel caso di motivati impedimenti, gli studenti sono pregati di presentarsi ad un ricevimento con la docente per concordare un programma alternativo.
Modalità d’esameL’esame prevede una prova scritta in lingua ed una prova orale in lingua sui temi affrontati durante il lettorato da sostenere con i Collaboratori linguistici; superate queste due prove, in ogni loro parte ( es. esercizio a, b, c, ecc. ), si accede all’esame orale di Lingua Spagnola che consiste in un colloquio con la docente del corso principale. Per il primo anno la lingua veico-lare è l’italiano, ma gli studenti che lo vorranno, potranno utilizzare lo spagnolo (o esporre in lingua partidel programma a scelta).
ValutazioneLa valutazione finale del corso principale sarà su tutto il materiale fornito dalla docente duran-te i semestri (appunti del corso e materiale distribuito nel corso delle lezioni) e terrà conto del lavoro svolto durante i lettorati (eventuali verifiche intermedie scritte e orali da sostenere du-rante i semestri con i Collaboratori linguistici) e delle prove finali in lingua.
Lingua Tedesca
Prof. Ernst Kretschmer
104
CFU 10 – ore 60
Mutuato da Lingue e Culture Europee
Sistemi sociali e culture della comunicazione
Prof. Claudio Baraldi10 CFU – 60 ore
Obiettivi formativiFornire la conoscenza (a) dei concetti fondamentali per la descrizione e la spiegazione dei processi interni alla società, con particolare riferimento alle relazioni che intercorrono tra pro-cessi globali e processi locali e (b) dei fondamenti epistemologici e metodologici degli studi sociologici. Per questo scopo, il corso introduce all’analisi della comunicazione e delle produ-zioni culturali nella comunicazione, permettendo di acquisire capacità di studio critico dei ma-teriali sociologici. In particolare, si focalizza sui concetti diversità delle forme culturali e di co-municazione interculturale, nel quadro della società contemporanea.
PrerequisitiNessuno
Programma del corsoIl programma intende porre le basi per una comprensione generale dei rapporti tra società e culture, considerando in particolare le dinamiche societarie mondiali nel loro intreccio con quelle delle società europee.Il corso introduce anzitutto alcuni concetti fondamentali: comunicazione, individui e comunica-zione, forme e contesti di comunicazione, società, cambiamento socioculturale, cultura e for-me culturali, forme della comunicazione interculturale, significato sociale delle diversità (con diversi esempi specifici). In seguito, esso propone l’analisi delle diverse forme di società e di differenziazione interna alla società, con particolari approfondimenti sulle caratteristiche fon-damentali delle società contemporanee. Su questo sfondo, sarà proposta un’analisi dei rap-porti tra società e culture e della comunicazione interculturale, con un’attenzione particolare per il tema della diversità e delle sue varie espressioni.Il metodo didattico del corso consiste nell’alternanza di fasi di spiegazione a fasi di discussio-ne, basata su stimoli verbali, scritti e visivi forniti dal docente. Attraverso questa metodologia, si intende far scaturire i significati sociologici dall’esperienza diretta delle studentesse e degli studenti, mostrando come la sociologia si occupi di problemi concreti, di diretta esperienza, ma anche come la riflessione teorica su tale esperienza sia essenziale per comprendere i processi sociali e per utilizzare questa comprensione nelle professioni fornite dalla laurea.Il corso prevede inoltre un breve precorso, in collaborazione con il corso di Informatica per le Scienze umane, che prevede (1) una ricerca di bibliografie e siti su internet sui temi della co-municazione e della mediazione interculturale e (2) la costruzione di una breve relazione in Microsoft Word e/o Power Point.
Testi di riferimento(frequentanti)Frequentanti sono considerati coloro che raggiungono il 75% delle frequenze alle lezioni. Il programma di esame per i frequentanti prevede un testo fondamentale, che sarà utilizzato e commentato durante le lezioni, e due ulteriori brevi testi che approfondiscono le tematiche af-frontate a lezione.
1. Testo fondamentale● Claudio Baraldi, Comunicazione interculturale e diversità, Carocci, Roma
2. Percorso a scelta tra 2.1, 2.2, 2.3.
105
2.1 La personalizzazione nella cultura di origine europea. ● Harry G. Frankfurt, Le ragioni dell’amore, Donzelli, Roma● Anthony Giddens, La trasformazione dell’intimità, il Mulino, Bologna
2.2 La società multiculturale.● Enzo Colombo, Le società multiculturali, Carocci, Roma● Ian. Nederveen Pieterse, Melange globale, Carocci, Roma
2.3 La comunicazione e la mediazione interculturale● Ida Castiglioni, La comunicazione interculturale, Carocci, Roma● Giovanna Ceccatelli Gurrieri, Mediare culture, Carocci Roma
3. Si prevede inoltre la realizzazione di una breve relazione in Microsoft Word e/o Power Point, basata su ricerche bibliografiche e di siti su Internet. La realizzazione della tesina sarà accompagnata da alcune ore di tutorato da parte del docente, che si aggiungeranno alle le-zioni.
Frequenza In base alla normativa stabilita dalla Facoltà, coloro che si dichiarano non frequentanti o che comunque non raggiungono la quota del 75% delle frequenze delle lezioni, dovranno portare un programma aggiuntivo.
Programma per i non frequentantiIl programma per non frequentanti equipara il monte ore trascorso a lezione dai frequentanti (equivalenti a 60 ore di frequenza). Il programma è il seguente:
● Claudio Baraldi, Comunicazione interculturale e diversità, Carocci, Roma.● Ida Castiglioni, La comunicazione interculturale, Carocci, Roma● Giovanna Ceccatelli Gurrieri, Mediare culture, Carocci Roma ● Enzo Colombo, Le società multiculturali, Carocci, Roma● Harry G. Frankfurt, Le ragioni dell’amore, Donzelli, Roma● Anthony Giddens, La trasformazione dell’intimità, il Mulino, Bologna● Ian Nederveen Pieterse, Mélange globale, Carocci, Roma
Modalità d’esame Per l’esame finale, sono disponibili due opzioni: 1) esame soltanto orale; 2) esame in due par-ti, scritta e orale. In entrambi i casi, la valutazione ha lo scopo di verificare la conoscenza dei contenuti dei testi studiati e le capacità critiche acquisite grazie allo studio.
Storia Moderna
Prof. Giovanni Vittorio Signorotto10 CFU – 60 ore [seminario: 15 ore]
Obiettivi formativiScopo primario del corso è porre gli studenti in condizione di acquisire coscienza della dimen-sione storica dei problemi odierni, offrendo gli strumenti concettuali per comprendere il rap-porto tra storia vissuta e interpretazione storica. Un’analisi delle principali revisioni storiografi-che farà emergere il legame tra ideologia, metodo di indagine e scelta delle fonti, e quindi la funzione del lavoro storico nella costruzione della memoria pubblica e delle identità collettive (con particolare attenzione al processo di formazione dell’identità italiana). L’esame delle strutture politiche e dei valori ideali e religiosi di antico regime, condotto attraverso una rifles-sione sulle successive interpretazioni, mostrerà il condizionamento della modernità – e della sua attuale crisi – nelle ricostruzioni del passato. Al fine di sviluppare un’attitudine alla conte-stualizzazione storico-critica, si proporranno esercitazioni di lettura e interpretazioni di fonti
106
edite e manoscritte, fornendo le premesse per eventuali percorsi di approfondimento perso-nale.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoAlcune lezioni introduttive, partendo da una serie di concetti fondamentali, offriranno un qua-dro delle principali tendenze storiografiche, sottolineando il rapporto con i percorsi metodolo-gici e l’utilizzo delle fonti. Una seconda parte si concentrerà sull’esercizio dei poteri politici e religiosi nella società della prima età moderna, con particolare attenzione alle dinamiche isti-tuzionali e sociali negli antichi stati italiani. Infine verranno esaminate alcune fasi cruciali della storia europea e internazionale. Il corso di Storia moderna è affiancato da due Seminari di approfondimento, ognuno della du-rata di 15 ore, tenuti dalla Dott.ssa Laura Turchi. La loro funzione è quella di consentire un contatto diretto con tipologie diverse di documentazione storica, attraverso una lettura attenta e una interpretazione critica:
- Seminario 1: Giustizia del principe, processi penali, lesa maestà.Gli studenti saranno condotti ad esaminare un processo per congiura contro il duca di Ferrara (secolo XVI), sulla base di trascrizioni dei documenti coevi fornite dalla docente. Scopo dell’e-sercitazione sarà evidenziare il rapporto tra esercizio della giustizia, affermazione dello stato territoriale e ricerca del consenso.
-Seminario 2 : Informazione politica e relazioni diplomatiche.Verrà trattato il tema dell’informazione politica e dei rapporti diplomatici tra gli Stati dell’Euro-pa di antico regime, attraverso l’esame della documentazione prodotta dalle corti principe-sche e dagli ambasciatori. Particolare attenzione sarà rivolta alle relazioni degli ambasciatori veneziani, che costituirono il modello di riferimento per le diplomazie degli altri paesi.
N.B.: La frequenza di uno dei Seminari, a scelta, è consigliata ma non obbligatoria. Agli stu-denti che non parteciperanno a un Seminario è richiesta la lettura di un volume sostitutivo (vedi qui sotto le indicazioni per i non frequentanti).
Testi di riferimento1.E’ indispensabile una buona conoscenza della storia europea ed extraeuropea dalla fine del secolo XV alla prima metà del XIX, da acquisire attraverso lo studio di un manuale scolastico.Manuali consigliati:
● Renata AGO - Vittorio VIDOTTO, Storia moderna, Laterza 2004● Francesco BENIGNO, L’età moderna, Laterza 2005.
2. Un testo a scelta tra i seguenti:● E. Le ROY LADURIE, Lo Stato del re. La Francia dal 1460 al 1610, Il Mulino, 1999.● Serge GRUZINSKY, La colonizzazione dell’immaginario. Società indigene e occi-
dentalizzazione nel Messico spagnolo, Einaudi, 1994● Bernard BAILYN e Gordon S. WOOD, Le origini degli Stati Uniti, Il Mulino,1987.● John H. ELLIOTT, La Spagna imperiale. 1469-1716, Il Mulino, 1982● Edward P. THOMPSON, Società patrizia, cultura plebea. Otto saggi di antropologia
storica sull’Inghilterra del Seicento, Einaudi, 1981.● Natalie ZEMON DAVIS, Le culture del popolo. Sapere, rituali e resistenza nella
Francia del Cinquecento, Einaudi 1980● Domenico SELLA, L’Italia del Seicento, Laterza, 2000.● Edoardo TORTAROLO, L’illuminismo. Ragioni e dubbi sulla modernità, Carocci,
2002.
107
FrequenzaFacoltativa.
Programma per i non frequentantiAgli studenti che non avranno frequentato il corso si richiede la lettura di uno a scelta dei se-guenti testi:
● George HUPPERT, Storia sociale dell’Europa nella prima età moderna, Il Mulino (Paperbacks) 1999.
● Jean-Pierre LABATUT, Le nobiltà europee. Dal XV al XVIII secolo, Il Mulino 1999.
Agli studenti che non avranno frequentato uno dei Seminari (vedi sopra) si richiede la lettura di
● R. BIZZOCCHI, Guida allo studio della storia moderna, Manuali di base Laterza, 2006
Modalità d’esame. Prova orale
108
Scienze della Cultura – II anno
Etnologia
Prof. Fabio VitiCFU 6 o 10 – 60 ore o 75 ore
“Schiavitù e dipendenza personale”
Obiettivi formativiIl corso si propone un duplice intento: fornire agli studenti una introduzione di carattere gene-rale all’Etnologia e presentare un tema di particolare rilevanza etnologica e antropologica quale quello dei rapporti di dipendenza personale (schiavitù, servitù e altre forme di dominio sulla persona).
PrerequisitiNessuno
Programma del corsoNella parte introduttiva generale, il corso fornirà elementi di base per la conoscenza critica dei fondamenti dell’Etnologia, con speciale attenzione alla definizione dei principali campi temati-ci della disciplina, in maniera da mettere lo studente nelle condizioni di acquisire strumenti adeguati alla comprensione di testi e studi etnologici. In particolare, saranno affrontate in modo critico le nozioni fondamentali di cultura, identità e etnia; sarà inoltre fornita una presen-tazione generale dei campi tematici più specifici della politica e della parentela.
La parte monografica del corso intende sviluppare l’argomento della schiavitù, dei rapporti di dipendenza personale, delle forme di possesso e di dominio sulla persona. Saranno presen-tati materiali etnografici e storici relativi ai rapporti di dipendenza “ordinari”, alle forme di appartenenza familiare (rapporti di inclusione, filiazione e affiliazione) e ai connessi ostacoli ai processi di individualizzazione nelle società “semplici” o “pre-moderne”. A partire da esempi tratti dall’antichità greco-romana, dall’Europa feudale, dal mondo arabo-musulmano, dall’Afri-ca precoloniale e coloniale e dalle Americhe schiaviste, sarà inoltre esaminata la categoria della dipendenza “incrementata” e in particolare la figura dello schiavo-merce (schiavi “dome-stici” e di tratta; prezzo e valore; stato e condizione degli schiavi; forme legali di riduzione in schiavitù e di proprietà degli schiavi; rapporto tra schiavitù e violenza). Infine, saranno pre-sentate e discusse le persistenze di rapporti servili e le nuove forme di asservimento presenti nel mondo contemporaneo e globalizzato (pegno umano, schiavitù per debiti, lavoro coatto o vincolato, rapporti di sfruttamento paternalista, lavoro infantile, fenomeno dei bambini soldato, tratta di persone).
Testi di riferimentoIl programma d’esame da 6 CFU prevede la preparazione di un manuale generale (lista 1) e di due testi sull’argomento del corso monografico (lista 2). Il programma d’esame da 10 CFU prevede la preparazione di un manuale generale (lista 1) e di quattro testi sull’argomento del corso monografico (lista 2). Soltanto chi abbia frequentato il Seminario di Etnologia potrà sostituire due dei testi d’esame della lista 2 con il programma del Seminario (vedi oltre).
1. Manuali (uno a scelta):● Beattie, J., Uomini diversi da noi. Lineamenti di antropologia sociale (1964), Roma-
Bari, Laterza, 1972 (e successive ristampe).
109
● Bernardi, B., Uomo cultura società. Introduzione agli studi demo-etno-antropologici, Milano, Angeli, 1974 (e successive ristampe).
● Signorini, I., a cura di, I modi della cultura. Manuale di etnologia, Roma, NIS (poi Ca-rocci), 1992 (e successive ristampe).
2. Testi a scelta (due per il programma da 6 CFU; quattro per quello da 10 CFU)(N.B.: Non si può scegliere più di un testo da ogni sottoraggruppamento)
2.1. Schiavitù in generale● Sichirollo, L. (ed.), Schiavitù antica e moderna. Problema Storia Istituzioni, Napoli,
Guida, 1979.● Testart, A., L’esclave, la dette et le pouvoir, Paris, Errance, 2001.● Vecchie e nuove schiavitù (Dispensa didattica a cura del docente, disponibile in Bi-
blioteca).
2.2. Rapporti di dipendenza personale● Solinas, P.G., a cura di, La dipendenza. Antropologia delle relazioni di dominio, Lec-
ce, Argo, 2005.● Solinas, P.G., a cura di, La vita in prestito. Debito, dipendenza, lavoro, Lecce, Argo,
2007.● Viti, F., a cura di, Antropologia dei rapporti di dipendenza personale, Modena, Il Fio-
rino, 2006.Viti, F., a cura di, Lavoro, dipendenza personale e rapporti familiari, Mo-dena, Il Fiorino, 2007.2.3. Schiavitù e dipendenza personale in Africa
● Falola, T. & P.E. Lovejoy (eds.), Pawnship in Africa. Debt Bondage in Historical Per-spective, Boulder, Westview Press, 1994.
● Meillassoux, C., Antropologia della schiavitù (1986), Milano, Mursia, 1992.● Meillassoux, C. (ed.), L’esclavage en Afrique précoloniale, Paris, Maspero, 1975.● Miers, S. & I. Kopytoff (eds.), Slavery in Africa. Historical and Anthropological Per-
spectives, Madison, The University of Wisconsin Press, 1977.● Tardits, C. (ed.), Princes et serviteurs du royaume. Cinq études de monarchies afri-
caines, Paris, Société d’Ethnographie, 1987.● Viti, F., Schiavi, servi e dipendenti. Antropologia dei rapporti di dipendenza persona-
le in Africa, Milano, Raffaello Cortina, 2007.
2.4. Tratta atlantica ● Davidson, B., Madre Nera. L’Africa nera e il commercio degli schiavi (1961), Torino,
Einaudi, 1966.● Deschamps, H., Storia della tratta dei negri dall’antichità ai nostri giorni (1971), Mila-
no, Mondadori, 1974.● Pietrostefani, G., La tratta atlantica. Genocidio e sortilegio, Milano, Jaca Book, 2000.● Renault, F. & S. Daget, Les traites négrières en Afrique, Paris, Karthala, 1985.
2.5. Schiavitù americana● Armellin, B., La condizione dello schiavo. Autobiografie degli schiavi neri negli Stati
Uniti, Torino, Einaudi, 1975.● Genovese, E., L’economia politica della schiavitù (1961), Torino, Einaudi, 1972.
2.6. La schiavitù nel mondo arabo-musulmana● Lewis, B., Razza e colore nell’Islam (1971), Milano, Longanesi, 1975.● Gordon, M., Slavery in the Arab World, New York, New Amsterdam Press, 1989.● Heers, J., Les Négriers en terre d'islam, Paris, Perrin, 2003.
2.7. Le nuove schiavitù
110
● Arlacchi, P., Schiavi. Il nuovo traffico di esseri umani, Milano, Rizzoli, 1999.● Bales, K., I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale (1999), Milano,
Feltrinelli, 2000.● Carchedi, F., G. Mottura, E. Pugliese, a cura di, Il lavoro servile e le nuove schiavitù,
Milano, Angeli, 2003.● Esclavage moderne ou modernité de l’esclavage?, numero speciale della rivista Ca-
hiers d’Etudes africaines, 45 (3-4), 179-180, 2005.● Geffray, C., Chroniques de la servitude en Amazonie brésilienne, Paris, Karthala,
1995.● L’Ombre portée de l’esclavage. Avatars contemporains de l’oppression sociale, nu-
mero speciale della rivista Journal des africanistes, 70, 1-2, 2000.● Leone, L., Infanzia negata. Piccoli schiavi nel pianeta globale, Roma, Prospettiva
Edizioni, 2003.
Altri testi potranno essere aggiunti al programma d’esame durante il corso.
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è raccomandata ma non è obbligatoria.
Modalità d’esameL’esame è orale. La verbalizzazione è unica, per corso e seminario.
ValutazioneL’esame intende valutare la preparazione dello studente, le sue capacità espositive, la sua padronanza dei concetti della disciplina. La valutazione si basa sulla verifica della conoscen-za critica dei testi prescelti.
Seminario di EtnologiaDott.sa Simona Morganti15 ore
“Ripensare l’infanzia: antropologia della socializzazione dei bambini in Africa”
Il seminario si propone di rimettere in questione il concetto d’infanzia e le categorie di riferi-mento più classiche cui il termine rinvia, in relazione ad approfondimenti etnografici nel conte-sto africano. Nello specifico, si procederà ad un’introduzione teorica che permetta di chiarire i termini ed i significati materiali e simbolici del processo di socializzazione infantile con partico-lare riferimento al Bénin meridionale: i rituali d’integrazione a cui il nuovo nato è soggetto, il posto che occupa nel sistema familiare, i valori comunitari che deve apprendere, l’integrazio-ne vissuta nell’economia della cellula domestica che gli offre sostentamento e protezione. Si focalizzerà poi l’attenzione sui fenomeni dello sfruttamento del lavoro infantile, del traffico dei minori, dei bambini di strada e dei bambini soldato che, tra eredità della tradizione e debiti della modernità, coinvolgono diversi stati africani, attirando un interesse umanitario ed una mediatizzazione crescenti e suscitando lo scandalo delle coscienze di tutti coloro che dei dirit-ti dell’infanzia si dichiarano essere i difensori.
Il programma d’esame prevede la preparazione di due testi a scelta dell’elenco che segue:● Dispensa a cura del docente (reperibile presso la Biblioteca di Facoltà)● Lallemand, S., La circulation des enfants en société traditionnelle, Paris,
L’Harmattan, 1993.● Pisani, L., Bambini Dogon, Roma, Armando, 2007.● Riesman, P., Società e libertà nei Peul Djelgôbé dell’Alto Volta, Milano, Jaca Book,
111
1977.● Rosen, D.M., Un esercito di bambini. Giovani soldati nei conflitti internazionali, Mila-
no, Raffaello Cortina, 2007.● Schlemmer, B. (ed.), L’enfant exploité. Oppression, mise au travail, prolétarisation,
Paris, Karthala, 1996 [trad. ingl. Schlemmer B. (ed.), The Exploited Child, London-New York, Zed Books, 2000].
● Singer, P.W., I signori delle mosche. L’uso militare dei bambini nei conflitti contem-poranei, Milano, Feltrinelli, 2006.
● Taliani, S., Il bambino ed il suo doppio. Malattia, stregoneria, e antropologia dell’in-fanzia in Camerun, Milano, Franco Angeli, 2006.
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
Prof.ssa Giovanna BuonannoCFU 10 – 60 ore
“Nazione e narrazione nella Gran Bretagna contemporanea”
Obiettivi formativiIl corso offre un’introduzione alla cultura britannica contemporanea attraverso una lettura at-tenta di testi da essa prodotti. Verranno proposti agli studenti tipologie e generi testuali diversi (discorso politico, saggistica, letteratura, e film). Il corso si basa sull’imprescindibile nesso tra conoscenze culturali e padronanza linguistica e si prefigge il doppio scopo di avvicinare gli studenti alla cultura in questione e di riflettere sull’atto stesso di interpretazione.
Prerequisiti E’ auspicabile che gli studenti abbiano frequentato il corso e superato l’esame di Lingua ingle-se del I anno.
Programma del corsoIl corso pone al centro la questione dell’identità culturale nella Gran Bretagna post-imperiale/multiculturale alla luce dei profondi mutamenti della società britannica successivi alla II guerra mondiale, e legati alla progressiva dissoluzione dell’Impero e alla conseguente immigrazione verso la madrepatria dalle ex-colonie.Viene proposta la lettura e l’analisi di testi e documenti esemplificativi della pluralità e diversi-tà culturale del paese . Nel corso delle lezioni si discuterà sui diversi modi in cui i testi oggetto di analisi contribuiscono a narrare la nazione contemporanea.Il corso si svolgerà prevalentemente in lingua inglese.
Testi di riferimento● Bassnett, S. (ed.) 2003. Studying British Cultures. London Routledge. (“Introduction”
e “Afterword”).● Hall, S. 1991. “The Local and the Global: Globalisation and Ethnicity’; “Old and New
Identities” In A. D. King (ed.) Culture, Globalisation and the World-system: Contem-porary Conditions for the Representation of Identity. London: Macmillan.
● Kureishi, H. 1986. “The Rainbow Sign”. In My Beautiful Laundrette and Other Writ-ings. London: Faber.
Una scelta di capitoli e saggi tratti dai seguenti testi verrà indicata nel corso delle lezioni:● Colls, R. 2004. Identity of England. Oxford: Oxford U. P. ● Morley, D and K. Robins (eds.) 2001. British Cultural Studies. Geography, National-
ity, and Identity. Oxford: OUP● Procter, J. 2000. Writing Black Britain 1948-1998. Manchester: Manchester U.P. ● Weight, R. 2003. Patriots: National Identity in Britain 1940-2000. London: Pan Books
112
.● Winder, R. 2005. Bloody Foreigners. London: Abacus
Costituisce parte integrante del corso la visione e la discussione dei seguenti film:● Brief Encounter (UK, 1945; dir. D. Lean).● A Taste of Honey (UK, 1961; dir. T. Richardson).● My Beautiful Laundrette (UK, 1985;dir. S. Frears).
Sono inoltre parte integrante del corso, che si articola in lezioni frontali, le esercitazioni svolte dai collaboratori di madrelingua nelle quali gli studenti sono divisi in gruppi. Le esercitazioni riflettono la natura e gli obiettivi del corso e mirano nello specifico a sviluppare la competenza linguistica degli studenti. Lezioni ed esercitazioni, affrontano, per quanto attiene allo studio della lingua, i seguenti punti: Analisi lessico-grammaticale dal periodo al testo Introduzione ai registri e alla differenza tra discorso orale e discorso scritto Introduzione ai generi testuali attraverso la lettura/analisi di testi di generi diversi Approfondi-mento di metodi di lettura/analisi di discorsi/testi.
FrequenzaPer la natura e gli obiettivi del corso, sono richieste frequenza e partecipazione alle lezioni e alle esercitazioni. La percentuale minima di frequenza è pari al 70% delle lezioni.
Programma per i non frequentantiGli studenti non frequentanti concorderanno con la docente una scelta di testi ad integrazione della bibliografia di riferimento. Modalità d’esameGli studenti sosterranno le seguenti prove: Prove di accertamento linguistico curate dai collaboratori di madrelingua sulla lingua scritta (organizzazione e composizione, registro accademico, macro-strutture grammaticali, ecc.); sulla comprensione e produzione della lingua parlata (forme argomentative, capacità di sinte-si, chiarezza espositiva, ecc.)
Esame scritto: trattazione in forma di saggi brevi dei temi proposti nel corso.Esame orale: lettura e commento dei testi proposti e dei documenti visionati nel corso
ValutazioneLa valutazione finale si basa sul superamento delle prove d’esame.
Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Francese
Prof.ssa Giovanna BellatiCFU 10 – ore 60
Mutuato da Lingue e Culture Europee
Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Spagnola
Prof. Guillermo Carrascon CFU 10 – ore 60
Mutuato da Lingue e Culture Europee
113
Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Tedesca
Prof. Cesare Giacobazzi CFU 10 – ore 60
Mutuato da Lingue e Culture Europee
Sociologia dei Processi Culturali
Prof. Vittorio IerveseCFU 6 – 60 ore
Obiettivi formativiGli obiettivi formativi dell’insegnamento della Sociologia dei processi Culturali sono essenzial-mente di tipo metodologico. Infatti, ci si propone di trattare i significati e i modi in cui può es-sere realizzata un’analisi sociologica, teorica ed empirica. In particolare, saranno ripresi ed ampliati i principali concetti introdotti nel corso di Sistemi sociali e culture della comunicazione e applicati a specifici percorsi di ricerca già realizzati o da costruire. Gli obiettivi del corso pos-sono quindi essere così dettagliati: 1) conoscenza dei concetti fondamentali per la descrizione e la spiegazione dei processi cul-turali interni alla società europea e mondiale, con particolare attenzione alle società multicul-turali e alle forme di ibridazione culturale; 2) trattamento e analisi di alcune esemplari esperienze di ricerca sui processi culturali con-temporanei;3) Formulazione di percorsi di ricerca originali e sviluppo di capacità di studio critico delle pro-duzioni culturali.
Prerequisiti Per un’agevole comprensione delle tematiche che saranno affrontate durante il corso è im-portante la conoscenza dei principali elementi di teoria della comunicazione, della società e della comunicazione interculturale. Questi concetti rappresentano il punto di partenza del la-voro che verrà sviluppato durante il corso. Gli studenti che non hanno frequentato il corso di Sistemi sociali e culture della comunicazione, sono invitati a rivolgersi al docente per concor-dare modalità di recupero dei concetti fondamentali.
Programma del corsoIl corso si concentrerà sull’osservazione dei modi di costruzione delle differenze e si articolerà seguendo le fasi di realizzazione di un’ipotetica ricerca empirica sociologica (costruzione del problema, piano metodologico, raccolta dati, analisi dei dati, presentazione dei risultati). Dopo una prima fase di impostazione generale dell’argomento, si passerà a delineare le possibili li-nee metodologiche, concentrandosi soprattutto sull’analisi del Discorso (M. Foucault) e sull’a-nalisi della Semantica (N. Luhmann). Si passerà così a formulare un ipotetico piano di ricerca, servendosi di casi di studio esemplari. In questa fase saranno affrontate anche alcune tecni-che proprie della ricerca qualitativa valutandone il potenziale euristico e l’adeguatezza nel-l’ambito degli obiettivi di ricerca. Infine, gli studenti saranno impegnati in una simulazione di raccolta dati e nella conseguente fase di analisi degli stessi. La fase finale del corso prevede la discussione delle forme di restituzione e discussione delle ricerche con particolare attenzio-ne al dibattito interno alle Performative Social Sciences. Questa fase si concluderà con la re-lazione in aula dei lavori di alcuni studenti.Il tema della costruzione delle differenze, sarà affrontato da una prospettiva propriamente cul-turale, in modo da individuare i processi che permettono di affermare e consolidare le distin-zioni principali La didattica prevede:
114
Lezioni frontali con domande di chiarimento e discussioni. Analisi di materiali multimedialiEsercitazioni in classe.Contributi attivi degli studenti attraverso relazioni e produzione di materiali.
Testi di riferimentoStudenti frequentantiDi seguito alcuni testi consigliati per approfondire i temi affrontati a lezione. Il docente fornirà durante le lezioni indicazioni più specifiche su questi materiali e sulle modalità d’esame.
● Beck, U. La Società cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale. Il Mulino, Bologna 2003
● Iervese, V. Cultura e selezione. Gli studi culturali e la lotta per l’attenzione. (dispense disponibili in biblioteca)
● Cometa, M. Dizionario degli studi Culturali, Meltemi, Roma 2004. ● Foucault, M. L’ordine del discorso.
Studenti non frequentanti● B. Pearce. Comunicazione e condizione umana.● Beck, U. La Società cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale. Il Mulino,
Bologna 2003● Baumann, G. L’enigma multiculturale. Il Mulino, Bologna, 2003● Kymlicka, W. Il pluralismo liberale può essere esportato? Teoria politica occidentale
e relazioni etniche nell'Europa dell'Est, Il Mulino, Bologna 2003
FrequenzaSi considerano frequentanti gli studenti che hanno partecipato ad almeno il 75% delle lezioni.
Programma per i non frequentantiGli studenti che non frequenteranno le lezioni saranno tenuti a seguire un programma finaliz-zato a fornire alcuni concetti generali dello studio dei processi culturali e specifici approfondi-menti. I testi previsti sono quelli precedentemente indicati.
Modalità d’esamePer i frequentanti:A coloro che frequenteranno si richiede di produrre un elaborato da discutere oralmente con il docente. I lavori riguarderanno la progettazione di un percorso di ricerca e di analisi di specifi-ci argomenti proposti a lezione. In alternativa, gli studenti potranno concordare con il docente un programma bibliografico da discutere oralmente.
Per i non frequentanti:E’ previsto un esame orale sui testi sopra indicati. Il docente è però disponibile a concordare programmi alternativi.
ValutazioneLa valutazione è finalizzata a verificare la capacità degli studenti di cogliere le forme e i modi di alcuni processi culturali, utilizzando gli strumenti forniti a lezione. L’esame si concentrerà quindi sull’applicazione dei metodi e dei concetti studiati su specifi casi e materiali forniti dal docente.
Storia Contemporanea
Prof.ssa Giovanna Procacci e prof. Andrea PanaccioneCFU 10 – 60 e 15 ore
Corso (60 ore: prof.ssa Procacci)
115
Obiettivi formativiIl corso di storia contemporanea si propone di fornire gli elementi necessari per la compren-sione dei fondamenti storici dei processi politici, sociali e culturali del XIX e XX secolo. Ver-ranno presi in esame alcuni nodi storici attinenti la storia europea e mondiale, di cui saranno approfonditi i caratteri, con attenzione alle continuità e alle fratture, alle relazioni tra le vicende nazionali ed internazionali, alla problematica interpretativa. Alcuni argomenti riguardanti la storia d’Italia verranno esaminati in modo più analitico.
PrerequisitiAver sostenuto e superato l’esame di Storia moderna.
Programma del corsoVerranno affrontati, e approfonditi criticamente:
● Il pensiero politico dell’Ottocento. Liberalismo, democrazia, socialismo, idee nazio-nali e nazionalismo, razzismo.
● Il processo di industrializzazione. L’industrializzazione dei principali paesi europei ed extraeuropei. Il differente impatto sulla struttura sociale e politica dei vari paesi.
● Espansione coloniale e imperialismo. ● Il trauma della prima guerra mondiale. Massacri, prigionie.● Le società europee tra le due guerre. Fascismi e antifascismi.● I “totalitarismi”. Analogie e differenze.● La rivoluzione russa e il regime sovietico.● Nazismo, antisemitismo, genocidio.● L’espansione giapponese. La Cina.● La seconda guerra mondiale. Cause, caratteri, conseguenze.● Guerra fredda e conflitti armati● Il processo di decolonizzazione ● Welfare state e consumi di massa● La crisi petrolifera● Caduta del muro di Berlino e dissoluzione dell’Urss● L’Italia dopo l’Unità. Caratteri del trasformismo● Protezionismo e questione meridionale● Età giolittiana, industrializzazione, riformismo politico e conflitti sociali.● La prima guerra mondiale in Italia.● La crisi dello stato liberale in Italia e l’avvento del fascismo. Il regime fascista e il “to-
talitarismo imperfetto”.● L’alleanza con la Germania, la guerra, la caduta del fascismo e la Resistenza (Resi-
stenza armata, Resistenza senza armi, Resistenza passiva). L’antifascismo come base dell’identità nazionale italiana.
● La ricostruzione e il miracolo economico. Centrismo e centro-sinistra● Il terrorismo. I piani di destabilizzazione.● Gli anni 80 e la fine dell’egemonia democristiana
Il corso di Storia contemporanea verrà coordinato con i seminari di Storia contemporanea.
Testi di riferimentoLa preparazione dell’esame si baserà sullo studio di un manuale; si consiglia quello di Sabba-tucci-Vidotto per i licei, sia nella tradizionale edizione, sia nella nuova veste, quest’ultima dal titolo:
● G.Sabbatucci-V.Vidotto, Storia contemporanea, L’Ottocento (a partire dal 1870 cir-ca), e Il Novecento, Laterza 2002
116
Gli studenti dovranno inoltre saper riferire sui temi trattati a lezione, ed attuare una lettura cri-tica di due dei seguenti volumi, scelti uno dal primo gruppo e uno dal secondo:
Primo gruppo:● E.J.Hobsbawm, L’età degli imperi, 1875-1914, Laterza● E.J.Hobsbawm, Il secolo breve (alcune parti, da concordare)● E.Collotti, Fascismo, fascismi, Sansoni● G.L. Mosse, L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste, Laterza● G. L. Mosse, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’olocausto, Laterza● M.Lewin, Storia sociale dello stalinismo● I.Kershaw, Che cosa è il nazismo?, Bollati Boringhieri● J. Smith, Storia della guerra fredda, Il Mulino● R.F.Betts, La decolonizzazione, Il Mulino● J. Osterhammel-N.Petersson, Storia della globalizzazione, Il Mulino
Secondo gruppo● A.Del Boca, Italiani brava gente?, Neri Pozza● P. Corner, Riformismo e fascismo. L’Italia fra il 1900 e 1940, Bulzoni● G.Procacci, Dalla rassegnazione alla rivolta. Mentalità e comportamenti popolari nel-
la Grande guerra, Bulzoni● G.Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella Grande guerra, Bollati Boringhieri● E. Gentile, Fascismo e antifascismo. I partiti italiani fra le due guerre, Le Monnier● S.Lupo, Il fascismo. La politica in un regime totalitario, Donzelli● F.Collotti, Il fascismo e gli ebrei, Laterza● C.Pavone, Una guerra civile. 1943-1945. Saggio storico sulla moralità della Resi-
stenza, Bollati Boringhieri (4 capitoli a scelta)● P.Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Einaudi (alcune parti da concor-
dare)● G.Crainz, Il paese mancato, Dal miracolo economico agli anni ottanta, Donzelli● G.Gribaudi, Guerra totale. Tra bombe alleate e violenze naziste. Napoli e il fronte
meridionale, Bollati Boringhieri● Uno dei volumi della Storia d’Italia , a cura di G. Sabbatucci-V.Vidotto, Laterza (alcu-
ni capitoli, da concordare con il docente)
Altri titoli alternativi potranno essere forniti nel corso delle lezioni.
FrequenzaConsigliata. La frequenza verrà verificata ad ogni lezione. Nel caso di frequenza parziale, il programma verrà concordato con il docente alla fine del corso.
Programmi per i non frequentantiGli studenti non frequentanti dovranno portare quattro libri di lettura critica, oltre al manuale.
ValutazioneGli studenti dovranno conoscere la storia contemporanea dal 1870 ad oggi. La valutazione avverrà attraverso alcune domande di storia generale, alcune domande circa gli argomenti trattati a lezione e alcune domande riguardanti i testi scelti.
Seminario A
Prof. Andrea PanaccioneCFU 4 – 15 ore
117
“Politiche della memoria, politiche della storia. L’Europa occidentale”. Metodi didatticilezione ed esercitazioni scritte Obiettivi formativiIl seminario, oltre a fornire agli studenti un orientamento generale sulla problematica conside-rata, dovrà permettere loro di affrontare criticamente una specifica tematica attraverso l’elabo-razione di una relazione scritta, sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dal docente. La relazione sarà discussa con il docente stesso e con gli altri studenti all’interno del semina-rio. PrerequisitiNessuno Programma del corsoIl seminario si svilupperà a partire da alcune premesse di metodo sulla distinzione tra storia e memoria e sul rapporto tra passato e presente, che imprime all’una e all’altra un carattere di-namico, evidenzia gli elementi culturali e artificiali della memoria (individuale e collettiva) e fa della scrittura della storia un’attività sempre aperta alla possibilità di nuove interpretazioni. Tutto ciò rende sia la memoria che la storia oggetti di selezione, di costruzione, di oblio, di mutevoli approcci di ricerca, e ne fa anche dei campi d’azione di forze politiche, poteri pubbli-ci, istituzioni, movimenti.Il percorso del seminario, dopo alcune riflessioni introduttive, prevede l’analisi di specifici casi di politiche della memoria e della storia, delle loro diverse strumentazioni e occasioni (i rituali, i monumenti, i luoghi della memoria, i calendari nazionali, la manualistica; i processi di forma-zione e consolidamento statale, i conflitti identitari e civili, gli interventi militari o “umanitari”, le rimozioni e censure, le campagne di stampa, le nuove acquisizioni documentarie e la loro ge-stione e utilizzazione, le commissioni d’inchiesta, le ricadute giudiziarie della storia, la raccolta e la valorizzazione delle testimonianze, la produzione di nuove ricerche, ecc.) e delle funzioni svolte nei diversi contesti. I casi saranno proposti dal docente, con le relative indicazioni bi-bliografiche, e avranno come riferimento l’area dell’Europa occidentale (a titolo esemplificati-vo: le guerre e le stragi coloniali; la guerra civile spagnola e il franchismo; il regime di Vichy; i conti con il nazismo e gli stermini; fascismo, guerra, resistenza e dopoguerra in Italia; le appartenenze della guerra fredda; ecc.). Gli iscritti al seminario dovranno preparare una rela-zione scritta su uno specifico tema; le relazioni saranno discusse con il docente e con gli altri partecipanti al seminario. FrequenzaObbligatoria. Modalità d’esameLa prova di esame orale, oltre alla presentazione del lavoro tematico condotto durante il semi-nario, prevede lo studio dei seguenti testi:
● E. Traverso, Il passato: istruzioni per l’uso, Verona, Ombre corte, 2006 (Introduzione e primi due capitoli).
● Tra revisioni e revisionismi, a cura di G. Procacci, “Giornale di storia contempora-nea”, giugno 2006, pp. 137-208.
ValutazioneOltre che dell’esito della prova di esame, si terrà conto del contributo dato allo svolgimento del seminario.
Seminario B
118
Prof. Andrea Panaccione15 ore
“Politiche della memoria, politiche della storia. L’Europa centro-orientale”
Metodi didatticilezione ed esercitazioni scritte
Obiettivi formativiIl seminario, oltre a fornire agli studenti un orientamento generale sulla problematica conside-rata, dovrà permettere loro di affrontare criticamente una specifica tematica attraverso l’elabo-razione di una relazione scritta, sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dal docente. La relazione sarà discussa con il docente stesso e con gli altri studenti all’interno del semina-rio.
PrerequisitiNessuno
Programma del corsoIl seminario si svilupperà a partire da alcune premesse di metodo sulla distinzione tra storia e memoria e sul rapporto tra passato e presente, che imprime all’una e all’altra un carattere di-namico, evidenzia gli elementi culturali e artificiali della memoria (individuale e collettiva) e fa della scrittura della storia un’attività sempre aperta alla possibilità di nuove interpretazioni. Tutto ciò rende sia la memoria che la storia oggetti di selezione, di costruzione, di oblio, di mutevoli approcci di ricerca, e ne fa anche dei campi d’azione di forze politiche, poteri pubbli-ci, istituzioni, movimenti.Il percorso del seminario, dopo alcune considerazioni introduttive del docente, prevede l’anali-si di specifici casi di politiche della memoria e della storia, delle loro diverse strumentazioni e occasioni (i rituali e le politiche cerimoniali, i monumenti, i luoghi della memoria, i calendari nazionali, la manualistica; i processi di formazione e consolidamento statale, i conflitti identita-ri e civili, gli interventi militari o “umanitari”, le rimozioni e censure, le campagne di stampa, le nuove acquisizioni documentarie e la loro gestione e utilizzazione, le commissioni d’inchiesta, le ricadute giudiziarie della storia la raccolta e la valorizzazione delle testimonianze, la produ-zione di nuove ricerche, ecc.) e delle funzioni svolte nei diversi contesti. I casi di studio saran-no proposti dal docente, con le relative indicazioni bibliografiche, e avranno come riferimento l’area dell’Europa centro-orientale (a titolo esemplificativo: la seconda guerra mondiale e le resistenze; l’Urss, la Polonia, gli Stati Baltici; il 1956 in Ungheria; la primavera di Praga; il Ko-sovo tra storia e mito; la “nostalgia” del socialismo reale; ecc.). Gli iscritti al seminario dovran-no preparare una relazione scritta su uno specifico tema; le relazioni saranno discusse con il docente e con gli altri partecipanti al seminario.
Frequenzaobbligatoria
Modalità di esameLa prova di esame orale, oltre alla presentazione del lavoro tematico condotto durante il semi-nario, prevede lo studio dei seguenti testi:
● E. Traverso, Il passato: istruzioni per l’uso, Verona, Ombre corte, 2006 (Introduzione e primi due capitoli).
● Tra revisioni e revisionismi, a cura di G. Procacci, “Giornale di storia contempora-nea”, giugno 2006, pp. 137-208.
ValutazioneOltre che dell’esito della prova di esame, si terrà conto del contributo dato allo svolgimento del seminario.
119
Storia della filosofia (6 crediti)
Prof. Antonello La Vergata6 CFU – 60 0re
Obiettivi formativiIl corso intende informare su alcuni dei principali momenti, temi e problemi della storia della fi-losofia fino alla prima guerra mondiale. L’obiettivo principale è dotare gli studenti di conoscen-ze di base, concettuali e terminologiche, e di strumenti di analisi che li mettano in grado di ac-costarsi criticamente al pensiero di un autore o a un problema.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoGli autori su cui si concentrerà l’attenzione sono: Platone, Aristotele, Tommaso d’Aquino, Cartesio, Hume, Kant e Nietzsche. Le correnti o movimenti di pensiero esaminati saranno: il razionalismo, l’empirismo, l’illuminismo, l’idealismo, il positivismo, il marxismo, l’evoluzioni-smo, il pragmatismo, l’irrazionalismo.
Testi di riferimentoLe parti relative agli autori e alle correnti di cui sopra in:
● La Vergata – F. Trabattoni, Filosofia e cultura, Firenze, la Nuova Italia, 2007, 4 voll. (con allegato Dizionario di filosofia, a cura di P. Rossi, in CD).
Ulteriori precisazioni saranno fornite dal docente nel corso delle lezioni, in risposta alle esi-genze che gli studenti dovessero manifestare via via.
FrequenzaFacoltativa
Programma per i non frequentantiCapitoli Platone, Aristotele, Tommaso d’Aquino, Cartesio, Hume, Kant, Comte e il positivi-smo, L’evoluzionismo, Nietzsche in A. La Vergata – F. Trabattoni, Filosofia e cultura, Firenze, La Nuova Italia, 2007 (comprese le parti antologiche dei suddetti capitoli).
Modalità d’esameEsame oraleValutazioneIl candidato dovrà dimostrare: 1) una conoscenza soddisfacente dei temi, dei problemi, delle correnti e degli autori studiati; 2) capacità di esporre concetti, teorie e problemi in modo chia-ro, rigoroso e conciso (oltre che in buon italiano) e di analizzarli criticamente inserendoli in un contesto storico-culturale problematico; 3) capacità di analizzare e commentare i testi antolo-gici che accompagnano i capitoli del testo di riferimento.
Storia della filosofia (10 crediti)
Prof. Antonello La Vergata10 CFU – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso intende informare su alcuni dei principali momenti, temi e problemi della storia della fi-losofia fino alla prima guerra mondiale. L’obiettivo principale è dotare gli studenti di conoscen-ze di base, concettuali e terminologiche, e di strumenti di analisi che li mettano in grado di ac-costarsi criticamente al pensiero di un autore o a un problema.
120
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoGli autori su cui si concentrerà l’attenzione sono: Platone, Aristotele, Tommaso d’Aquino, Cartesio, Hume, Kant e Nietzsche. Le correnti o movimenti di pensiero esaminati saranno: il razionalismo, l’empirismo, l’illuminismo, l’idealismo, il positivismo, il marxismo, l’evoluzioni-smo, il pragmatismo, l’irrazionalismo.
Testi di riferimentoLe parti relative agli autori e alle correnti di cui sopra in:
● La Vergata – F. Trabattoni, Filosofia e cultura, Firenze, la Nuova Italia, 2007, 4 voll. (con allegato Dizionario di filosofia, a cura di P. Rossi, in CD).
Ulteriori precisazioni saranno fornite dal docente nel corso delle lezioni, in risposta alle esi-genze che gli studenti dovessero manifestare via via.
FrequenzaFacoltativa
Programma per i non frequentantiCapitoli Platone, Aristotele, Tommaso d’Aquino, Cartesio, Hume, Kant, Hegel, Marx e il mar-xismo, Comte e il positivismo, L’evoluzionismo, Il pragmatismo, Nietzsche in A. La Vergata – F. Trabattoni, Filosofia e cultura, Firenze, La Nuova Italia, 2007 (comprese le parti antologi-che dei suddetti capitoli).
oppure
un volume completo a scelta fra i quattro che compongono l’opera suddetta.
Modalità d’esameEsame orale
ValutazioneIl candidato dovrà dimostrare: 1) una conoscenza soddisfacente dei temi, dei problemi, delle correnti e degli autori studiati; 2) capacità di esporre concetti, teorie e problemi in modo chia-ro, rigoroso e conciso (oltre che in buon italiano) e di analizzarli criticamente inserendoli in un contesto storico-culturale problematico; 3) capacità di analizzare e commentare i testi antolo-gici che accompagnano i capitoli del testo di riferimento.
Storia delle religioni
Prof.ssa Sabina CrippaCFU 6+4 – 40 ore+20 ore
Obiettivi formativiIl corso serve a fornire una iniziale conoscenza e capacità di valutazione critica delle principali prospettive e istituzioni religiose, sia dal punto di vista del loro divenire storico, sia da quello dei loro significati nell’ambito del mondo contemporaneo. Senza un’adeguata conoscenza dei suoi aspetti religiosi, uno studio di qualsiasi contesto culturale è gravemente carente. Accanto al valore della Storia delle Religioni come modo d’indagine critica su un aspetto importante di ogni società, va dunque sottolineata la funzione più teorica della disciplina, che ha costituito il primo ambito specifico di applicazione della riflessione interculturale e della connessa compa-razione storica, e che per la sua stessa natura ha spesso esercitato una funzione di raccordo e di mediazione teorica e metodologica fra le “ scienze storiche” e le discipline antropologi-
121
che, etnografiche, sociologiche e psicologiche. Il corso mira inoltre a fornire agli studenti un approfondimento di un aspetto specifico e fondamentale come quello dell'immagine nel conte-sto sacro, offrendo un esempio concreto metodologico di ricerca interdisciplinare.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoI modulo (6 CFU):Problema della definizione di “religione”, nozione di sacro.Analisi di alcune categorie interpretative : sacro/profano, misteri, misticismo,iniziazione, sacri-ficio, etc.1.3 Teorie della magia 1.4 Magia, scienza e religione nella tradizione occidentale1.5 Magia e nuovi culti: le sette
II modulo (4 CFU): Immagine e sacro (prof.ssa Elisabetta Gigante):
2.1 Forme e funzioni dell’immagine nella religione2.2 L’utilizzo del sacro nella comunicazione contemporanea (arti visive e mass media)
Testi di riferimento
1) Bibliografia● Brelich, A., Introduzione alla storia delle religioni, Roma, Ed.Ateneo 2003 (pp.1-70)● Massenzio, M., Sacro e identità etnica. Senso del mondo e linee di confine, Milano,
Franco Angeli 2004 (I° parte)● Tambiah, S.J., Magia, Scienza, Religione, Napoli, Guida 1993 (1 cap. a scelta)
oppure in alternativa a Tambiah: Numero monografico rivista Prometeo Civiltà e reli-gioni, n.97, marzo 2007 (parti a scelta)
● Burke, Peter, Testimoni oculari. Il significato storico delle immagini, Roma, Carocci, 2002 (capp. 1, 3, 4, 11)
● Freedberg, David, Il potere delle immagini, Torino, Einaudi, 2001 (capp. VIII, XI)2) Appunti delle lezioni
FrequenzaFrequenza minima : 40 ore
Programma per i non frequentantiUn testo da concordare con le docenti in aggiunta al programma da frequentante ed eventua-le tesina.
Modalità d’esameOraleValutazioneProva finale
122
Scienze della Cultura – III anno
Antropologia Sociale
Prof. Gino SattaCFU 6 – 60 ore
Obiettivi formativiIntroduzione critica ai fondamenti teorico-metodologici dell'Antropologia sociale, con particola-re riguardo ai temi del “fieldwork”, dell'etnografia e della costruzione delle appartenenze.Approfondimento sul tema monografico della relazione tra turismo, etnografia e processi di “patrimonializzazione” della cultura, cioè quei processi attraverso i quali la cultura è costituita in “patrimonio culturale” (heritage).
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoNella prima parte del corso, saranno introdotte alcune nozioni di base dell’antropologia socia-le. Una particolare attenzione verrà dedicata: a) alle questioni teorico-metodologiche relative al “fieldwork” e al rapporto tra questo e l'etnografia; b) al tema della definizione e manipolazio-ne attraverso le pratiche simboliche delle appartenenze (etniche, culturali, sociali).Nella seconda parte sarà affrontato il tema monografico del rapporto tra turismo, etnografia e processi di patrimonializzazione della cultura. Nel mondo contemporaneo, la cultura non è più qualcosa che è semplicemente trasmesso da una generazione all'altra: è diventata un campo di attivo intervento politico per una pluralità di agenzie, alcune istituzionalmente legate allo stato-nazione, o a organizzazioni e burocrazie internazionali, altre emergenti da movimenti e associazioni di base. Turismo ed etnografia giocano entrambi, ognuno a suo modo, un ruolo centrale in tali processi di rimodellamento e istituzionalizzazione delle culture e delle tradizio-ni. La crescente importanza economica pone il turismo al centro degli scambi materiali e sim-bolici in molti contesti, spingendo gli attori locali a vedersi attraverso gli occhi dei turisti e a ri-modellare il proprio “patrimonio culturale” di conseguenza, mentre l'etnografia è usata sia da dall'industria turistica globale che dalle agenzie locali come una delle principali fonti di legitti-mità per le proprie interpretazioni della “proprietà culturale”. Il corso monografico si concentra sui processi di patrimonializzazione dove il turismo e l'etnografia convergono e si incrociano nel definire il campo e le risorse culturali che le differenti agenzie utilizzano per costruire e re-clamare la “proprietà culturale”.
Testi di riferimento● Gallini, C. e Satta, G. (a cura di), Incontri etnografici, Meltemi, Roma 2007.● Satta, G. (a cura di), Turismo, etnografia e patrimonializzazione della cultura, di-
spensa con antologia di testi.
un testo a scelta tra i seguenti:● Ciarcia, G., De la mémoire ethnographique: l'exotisme du pays dogon, Editions de
l'Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris 2003.● Palumbo, B., L'UNESCO e il campanile, Meltemi, Roma 2003.● Satta, G., Turisti a Orgosolo. La Sardegna pastorale come attrazione turistica, Liguo-
ri, Napoli 2001.
e un altro a scelta tra i seguenti:● Brown, M., Who owns native culture?, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)
2003.
123
● Clifford, J., Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo ventesimo, Bollati Borin-ghieri, Torino 1999.
● Dei, F., Beethoven e le mondine: ripensare la cultura popolare, Meltemi, Roma 2002.
● Gallini, C. (a cura di), Patrie elettive. I segni dell'appartenenza, Bollati Boringhieri, Torino 2003.
ulteriori testi a scelta (sostitutivi di quelli riportati sopra) potranno essere concordati il docente durante lo svolgimento del corso.
FrequenzaFacoltativa
Programma per i non frequentantiTesti obbligatori:
● Gallini, C. e Satta, G. (a cura di), Incontri etnografici, Meltemi, Roma 2007.● Satta, G. (a cura di), Turismo, etnografia e patrimonializzazione della cultura, di-
spensa con antologia di testi.
un testo a scelta tra i seguenti:● Ciarcia, G., De la mémoire ethnographique: l'exotisme du pays dogon, Editions de
l'Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris 2003.● Palumbo, B., L'UNESCO e il campanile, Meltemi, Roma 2003.● Satta, G., Turisti a Orgosolo. La Sardegna pastorale come attrazione turistica, Liguo-
ri, Napoli 2001.
e un altro a scelta tra i seguenti:● Brown, M., Who owns native culture?, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)
2003.● Clifford, J., Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo ventesimo, Bollati Borin-
ghieri, Torino 1999.● Dei, F., Beethoven e le mondine: ripensare la cultura popolare, Meltemi, Roma
2002.● Gallini, C. (a cura di), Patrie elettive. I segni dell'appartenenza, Bollati Boringhieri,
Torino 2003.
Gli/le studenti non frequentanti devono concordare il programma prima di sostenere l'esame.
Modalità d’esameEsame finale orale.
ValutazioneL’esame finale orale costituisce la base della valutazione per gli tutti gli studenti. L’attiva par-tecipazione alle attività didattiche (ad esempio: relazioni scritte/orali concordate con il docen-te) può costituire, per i frequentanti, ulteriore elemento di valutazione.Culture dei paesi islamici
Prof. Demetrio GiordaniCFU 2 – 20 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di trasmettere gli strumenti essenziali per poter comprendere la civiltà del-l’Islâm, e dotare lo studente di strumenti adatti a svolgere compiti professionali in contesti multiculturali. A questo scopo lo studente potrà acquisire, se lo desidera, anche una discreta ed iniziale conoscenza della lingua araba classica, scritta e parlata, strumento essenziale per
124
la conoscenza della cultura islamica ed elemento utile nella formazione del profilo professio-nale delineato negli obiettivi del corso di laurea.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoDurante il corso si prenderanno in esame il Corano e la Tradizione profetica (Sunna) in quan-to fonti principali della teologia e della legge (Sharî‘a). Accanto a ciò si esamineranno in modo sintetico le principali correnti teologiche, le quattro principali scuole giuridiche, le confraternite sûfî, le correnti dello Sciismo e infine i movimenti di riforma religiosa del XIX secolo.
Testi di riferimento● Alessandro Bausani: L’Islâm, Milano 1980 (varie ristampe).
FrequenzaVivamente consigliata
Programma per i non frequentantiStesso programma per i non frequentanti
Modalità d’esameEsame orale
ValutazioneIn base all’esito dell’esame orale verrà data un’idoneità
Filosofia del linguaggio
Prof.ssa Annalisa ColivaCFU 6 – 60 ore
Obiettivi del corsoIl corso di Filosofia del Linguaggio ha una duplice funzione: da un lato, esso completa gli studi delle lingue e del linguaggio da un punto di vista teorico; dall’altro, intende approfondire la ri-flessione filosofico-teoretica in particolare sul rapporto tra pensiero e linguaggio e sulla nozio-ne di relativismo.
PrerequisitiAncorché non siano richiesti dei prerequisiti per seguire questo corso, è auspicabile che gli studenti abbiano già qualche familiarità con:la storia della filosofia,la linguistica generale (anche generativista),la storia della scienza (contemporanea, in particolar modo).Conoscenze di psicologia (generale ed evolutiva) potrebbero essere utili per trarre il massimo profitto da questo corso. Per converso, il corso potrebbe essere utile anche a studenti di altra Facoltà, che abbiano interesse per la psicologia e la riflessione teorica sulla mente.
Programma del corsoIl corso sarà diviso in due parti – Corso istituzionale e Corso monografico – di 20 e 30 ore, ri-spettivamente. Solo per gli studenti di SDC, le restanti 10 ore del Corso istituzionale verranno dedicate a una breve introduzione al critical thinking.
Corso istituzionale (parte in comune con Semiotica della comunicazione, LCE): Natura uma-na o cultura? Il problema della relazione tra linguaggio e pensiero.
125
Questa parte del corso s’incentra sul rapporto tra linguaggio e pensiero per come è stato con-cepito all’interno della filosofia analitica dalle sue origini ai giorni nostri. In particolare, analiz-zeremo la cosiddetta “svolta linguistica” (Frege), con cui si è soliti far iniziare la filosofia anali-tica, la sua radicalizzazione (Wittgenstein) e la sua crisi (Fodor). Pertanto, ci interrogheremo sulla natura del pensiero e sul ruolo del linguaggio rispetto al pensiero: il pensiero è un’entità astratta di tipo platonico, oppure è una rappresentazione mentale? Il linguaggio è semplice-mente un medium per afferrare ed esprimere pensieri, oppure è una condizione necessaria al darsi del pensiero? E, in quest’ultimo caso, il pensiero è una facoltà propria della specie uma-na, oppure è un artefatto culturale?Critical Thinking (solo per Filosofia del linguaggio, SDC): Questa parte del corso intende forni-re alcuni strumenti utili all’analisi critica sia di testi in generale sia di testi specificamente filo-sofici.
Corso monografico: RelativismiQuesta parte del corso affronterà il tema del relativismo partendo dal presupposto che ne esi-stano vari tipi (linguistico, culturale, etico, estetico, concettuale, fattuale, epistemico, sulla ve-rità, ecc.), spesso intrecciati tra loro, ma che conviene invece tenere accuratamente separati, onde evitare fraintendimenti, facili entusiasmi, o confutazioni semplicistiche. In particolare, ci concentreremo sul relativismo ontologico (Quine e Putnam) e la sua critica (Boghossian); e sul relativismo epistemico (Rorty, e Wittgenstein, secondo certe letture) e la loro critica (Bo-ghossian).
Testi di riferimentoCorso istituzionale (SDC)Testi:
● Frege, G. [1918] “Il pensiero”, in Ricerche logiche, Guerini, 1988, pp. 43-74.● Wittgenstein, L. [1953] Ricerche filosofiche, Einaudi, 1967, i paragrafi 1-3; 23-25, 32;
198-270, 326-350, 358-362, 571.● Fodor, J. I concetti. Dove sbaglia la scienza cognitiva, McGraw-Hill, 1999, capp. 1, 4,
5, 6.CommentiGenerali:
● Coliva, A. I concetti. Teorie ed esercizi, Carocci, 20062, Introduzione e Cap.1Su Frege:
● Coliva, A. Dispense disponibili negli Spazi condivisi.Su Wittgenstein:
● Coliva, A. Dispense disponibili negli Spazi condivisi.● Perissinotto, L. Wittgenstein. Una guida, Feltrinelli, 1997, pp. 88-113.
Su Fodor:● Coliva, A. I concetti. Teorie ed esercizi, Carocci, 2004, cap. 2.● Marconi, D. “Il ritorno della natura umana”, in Filosofia e scienza cognitiva, Laterza,
2001, pp. 124-139.Critical thinking (SDC)
● Coliva, A., Lalumera, E. Pensare. Leggi ed errori del ragionamento, Carocci, 2006.
Corso monografico (SDC)Testi
● Quine, W. von O. La relatività ontologica e altri saggi, Roma, Armando editore, 1986, cap. 2.
● Putnam, H. Realismo dal volto umano, Bologna, Il Mulino 1995, capp. 1, 6.● Rorty, R. La filosofia e lo specchio della natura, Milano, Bompiani, 1986/1992, cap.
7.● Wittgenstein, L. Della certezza, Torino, Einaudi, 1969, i parr. 7, 92-9, 110, 130, 132,
144, 148, 162-7, 196-206, 222, 232-3, 262-4, 307, 331, 338, 358-9, 395, 402, 411, 414, 430-1, 475, 499, 559, 609, 612.
126
CommentiGenerali:
● Boghossian, P. Paura di conoscere. Contro il relativismo e il costruttivismo, Roma, Carocci, 2006, capp. 1-5, 7, 9.
Su Rorty e Wittgenstein● Coliva, A. Dispense disponibili negli Spazi condivisi● Coliva, A. 2003 Moore e Wittgenstein. Scetticismo, certezza e senso comune, Pado-
va, Il Poligrafo, 2003, capp. 1, 4.● Coliva, A 2007 “Was Wittgenstein an epistemic relativist?”, negli Spazi condivisi.● Perissinotto, L. Wittgenstein. Una guida, Feltrinelli, 1997, pp. 114-123.
FrequenzaVivamente consigliata. Ancorché il numero di pagine da studiare non sia particolarmente alto, si tratta di testi difficili e impegnativi che trovereste grandi difficoltà ad affrontare da soli.
Modalità dell’esameLa frequenza (almeno il 75% del monte ore) dà la possibilità di sostenere una prova scritta a metà del corso e una alla fine. Il voto sarà dato dalla media delle due prove, con la possibilità di migliorare con un orale mirato là ove i risultati non siano soddisfacenti. (Lo scritto sulla par-te di critical thinking darà diritto, in caso di superamento, a un bonus sul voto finale).
Fondamenti di linguistica e sociolinguistica
Prof. Augusto CarliCFU 6 – 60 ore
Obiettivi formativiRiconoscere, analizzare, interpretare e comprendere i rapporti fra gli usi linguistici e le intera-zioni comunicative nelle loro realizzazioni concrete e simboliche all’interno di singole comuni-tà che usano delle lingue storico-naturali. In particolare si tratta di:conoscere gli ambiti investigativi della linguistica, le sue principali teorie e metodologie di in-dagine; conoscere e applicare le tecniche di analisi e di descrizione linguistica;riconoscere i rapporti fra il linguaggio e il suo divenire sociale.
Prerequisiti Disporre delle comuni abilità per affrontare lo studio universitario
Programma del corsoLa sociolinguistica si occupa dei rapporti fra il linguaggio e le sue manifestazioni di natura so-ciale. La comprensione di tale rapporto è possibile solo attraverso l’analisi delle dimensioni speculative della linguistica generale. Il programma si concentrerà sui seguenti ambiti: Rapporto fra lingua e cultura, la relatività linguistica e i suoi legami con l’antropologia culturale e l’etnolinguistica; Fenomeni di lingue a contatto, i loro rapporti di forza e di influenza; lingue minoritarie e lingue maggioritarie; il mutamento linguistico e fenomeni di sostituzione, erosione, obsolescenza lin-guistica; Forme e fenomeni di bilinguismo/plurilingusismo; acquisizione di lingue native e lingue secon-de; Rapporti fra lingue standard e vari tipi di dialetto (urbano, rurale, sociale ecc.); barriere lingui-stiche, svantaggi individuali/sociali e discriminazioni linguistiche e sociali; Restrizioni alla varietà e alla variazione linguistica; fenomeni di pidginizzazione e creolizzazio-ne delle lingue; Riflessi dell’”ideologia” (individuale o sociale) negli usi linguistici concreti: analisi della comuni-cazione politica, massmediale, istituzionale;
127
g) Pianificazione di lingue standard, lingue nazionali, lingue per scopi di comunicazione i in-ternazionale, lingue artificiali e lingue storico-naturali.
Testi di riferimento● T. De Mauro (1998), Linguistica elementare. Bari, Laterza (Universale Laterza 778).● G. Berruto (2004), Prima lezione di sociolinguistica. Bari, Laterza (Universale Later-
za 848).● C. Bazzanella (2005), Linguistica e pragmatica del linguaggio. Bari, Laterza.
Da concordare eventuale bibliografia sostitutiva a scelta, anche in lingue diverse dall’italiano.
FrequenzaLa frequenza è in generale obbligatoria, almeno in una percentuale minima del 60% di pre-senza alle lezioni.
Programma per i non frequentantiIl programma per i non frequentanti viene concordato individualmente attraverso un colloquio personale che si terrà nell’orario di ricevimento da stabilire reciprocamente.
Modalità d’esameLa valutazione finale avviene attraverso un colloquio orale su singoli aspetti collegati ai conte-nuti svolti. L’esame finale tiene conto anche degli esiti delle prove intermedie in itinere che le/gli studenti frequentanti hanno sostenuto.
ValutazioneLa valutazione è espressa in trentesimi.
Geografia culturale
Prof.ssa Anna Maria SalaCFU 6 – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di affrontare: la lettura del complesso rapporto che intercorre tra il paesaggio storico e l’ambiente fisico; individuare gli strumenti ed i metodi per analizzare il paesaggio come differenziazione spazia-le prodotta dai legami che l’uomo ha instaurato nel tempo con il territorio e dalle differenti cul-ture ad esso sottese; interpretare il paesaggio come espressione culturale delle generazioni passate e di quelle presenti.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoNella prima parte il corso intende analizzare: le tappe dell’evoluzione della geografia come scienza d’analisi; le componenti territoriali e gli effetti che queste hanno prodotto nello spazio; l’identità regionale quale espressione dell’identità culturale dei gruppi umani che su di essa hanno lasciato proprie impronte. Nella seconda parte si affronterà la lettura degli elementi, materiali ed immateriali, che consentono di individuare le espressioni culturali come “segni” ri-scontrabili nel paesaggio; questi segni verranno decodificati come eredita’ delle generazioni che ci hanno preceduto e analizzati come valore storico per le generazioni presenti.
Testi di riferimento● Dagradi P., Cencini C., Compendio di geografia umana, Bologna,Patron,2003
128
e un testo a scelta fra i seguenti:● Bellezza G., Geografia e beni culturali, Milano, F. Angeli, 1999 ● Caldo C., Guarrasi V., Beni culturali e geografia, Bologna , Patron,1994● Claval P., La geografia culturale, Novara, De Agostini, 2002 ● Vallega A., Geografia culturale, Torino, UTET,2002
FrequenzaAlmeno per il 60% delle lezioni
Programma per i non frequentantiTesina da concordare con il Docente
Modalità d’esameEsame scritto
Laboratorio filosofico interdisciplinare
Prof.ssa Annalisa ColivaCFU 4 - 20 ore
Metodi didatticiUn incontro settimanale di due ore, per dieci settimane.
Obiettivi formativiIl laboratorio filosofico interdisciplinare ha come obiettivo quello di affrontare temi e autori del-la filosofia contemporanea in un’ottica quanto più interdisciplinare e attraverso metodi compo-siti che affiancano alle lezioni e allo studio tradizionali la lettura e la visione di opere teatrali, film e opere d’arte nonché l’ascolto di opere musicali.
PrerequisitiNessuno. È però auspicabili che gli studenti seguano (o abbiano seguito) corsi di storia della filosofia, filosofia morale, filosofia del linguaggio, storia dell’arte, lingua e civiltà tedesca e/o in-glese.
Programma del corsoScetticismo, relativismo e senso comune: Della certezza di Ludwig WittgensteinIl laboratorio fa parte del Progetto Wittgenstein, di durata triennale, volto a portare a cono-scenza degli studenti la figura e l’opera di uno dei più importanti filosofi del ‘900 – Ludwig Wittgenstein –, con particolare attenzione alle sue tre opere principali: il Tractatus logico-phi-losophicus, Ricerche filosofiche e Della certezza. Wittgenstein infatti non solo ha avuto e ha tutt’oggi un’influenza enorme sul pensiero filosofico, in aree così diverse come la filosofia del linguaggio della logica e della matematica, la filosofia della mente e della psicologia, l’etica, l’estetica, la teoria della conoscenza e la filosofia della religione, ma ha inciso anche sullo svi-luppo dell’antropologia teorica, sulle scienze sociali, sulla letteratura e la sua teoria. Non solo, Wittgenstein ha vissuto all’intersezione di due mondi – la “grande Vienna” di Mahler, Loos e Klimt e la Cambridge di Russell e G. E. Moore, ispiratori del “Bloomsury group” – che dopo di lui conosceranno destini storico-politici e culturali diversi e per molti aspetti inconciliabili. Witt-genstein è quindi un filosofo del ‘900 che, in maniera esemplare, può essere studiato secon-do una molteplicità di prospettive differenti, ognuna delle quali può venire incontro agli inte-ressi del più largo numero di studenti e dottorandi.Più specificatamente, alcuni dei temi che verranno affrontati sono:Il problema dello scetticismo: Descartes e Hume; La filosofia del senso comune: G. E. Moore;Naturalismo e forme di vita: può la natura umana fondare la nostra immagine del mondo?;
129
Le interpretazioni anti-naturaliste di Della certezza.Relativismo epistemico: le interpretazioni relativiste di Della certezza e la loro critica.La nozione di mitologia: tra antropologia e filosofia.Farà parte integrante del corso la proiezione del film di D. Jarman Wittgenstein. Si prevedono inoltre sia incontri con esperti di Wittgenstein sui temi trattati, sia con esperti di altre discipline (storia dell’arte, antropologia, sociologia) sull’influenza su e di Wittgenstein nei rispettivi ambi-ti.
Testi di riferimento● Wittgenstein, L. 1969 Della certezza, Einaudi, Torino.● Wittgenstein, L. 1974 Note sul Ramo d’oro di Frazer, Adelphi.
Commenti: ● Coliva, A. 2003 Moore e Wittgenstein. Scetticismo, certezza e senso comune, Pado-
va, Il Poligrafo, 2003.● Coliva, A 2007 “Was Wittgenstein an epistemic relativist?”, negli Spazi condivisi.● Perissinotto, L. Wittgenstein. Una guida, Feltrinelli, 1997, pp. 114-123.● Perissinotto, L. Logica e immagine del mondo, Guerini, 1991, parti che verranno in-
dicate in classe.● Marconi, D. L’eredità di Wittgenstein, Laterza 1987, cap. 7.● Bouveresse, J. 1974 “Wittgenstein antropologo”, saggio di commento in Wittgen-
stein, L. 1974 Note sul Ramo d’oro di Frazer, Adelphi.
Altri articoli che verranno discussi saranno specificati e messi a disposizione degli studenti al-l’inizio delle lezioni.
Frequenzaalmeno il 75% delle lezioni.
Modalità d’esame L’esame, per coloro che intendano conseguire i 4 crediti, consisterà nella presentazione e di-scussione di una tesina di approfondimento (tra le 5.000 e 6.000 parole) su uno dei temi del laboratorio a scelta dello studente.
Modulo di cultura spagnola
Prof.ssa Silvia BettiCFU 2 – 20 ore
“La vita quotidiana in Al-Andalus”
Metodo didatticoLezioni (seminario) Obiettivi formativiScopo del corso è porre gli studenti in condizione di conoscere e approfondire aspetti fonda-mentali di storia, cultura e società della cosiddetta “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti ed il loro rapporto con i popoli presenti nella Penisola Iberica a partire dal 711 d.C.
PrerequisitiNessuno
Programma del corso L’espansione araba, nelle sue varie fasi, produsse trasformazioni molto durature nell’ambien-te e negli usi quotidiani dei popoli; alcune ‘mode’, per esempio, hanno resistito secoli e si
130
sono introdotte in modo persistente nel tessuto sociale europeo. Più che per la quantità, le impronte della cultura araba e islamica incidono nella storia europea per la profondità e l’am-piezza. Numerosi sono gli elementi islamici così strettamente collegati alla vita quotidiana da esserne diventati parte integrante, anche se la maggior parte delle volte non sono immediata-mente riconoscibili e non vengono identificate le loro origini.
*Eventuali modifiche e/o integrazioni al programma presentato saranno comunicate agli stu-denti durante le lezioni.
Testi di riferimento● Faure, Éliane, Andalusia, Colonia, Evergreen-B.Taschen Verlag Gmbh, 1999.● Lo Jacono, Claudio, Il Vicino Oriente, Storia del mondo islamico (VII-XVI secolo),
vol. I, Torino, PBE, 2003, pp. 115-117 e pp. 321-365.● Marín, Manuela, Storia della “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti, Milano, Jaca
Book, 2001.● Martínez Montávez, Pedro e Ruiz Bravo, Carmen, Europa Islamica, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 1991.● Muñoz Molina, Antonio, La città dei califfi, Milano, Feltrinelli, 1996.● Wheatcroft, Andrew, Infedeli, 638-2003: il lungo conflitto fra cristianesimo e islam,
Bari, Laterza, 2004, in particolare da p. 73 a 190.
Ulteriori riferimenti bibliografici verranno dati nel corso delle lezioni.
FrequenzaConsigliata.
Programma per I non frequentantiGli studenti lavoratori e gli studenti non-frequentanti sono pregati di presentarsi ad un ricevi-mento con la docente.
Modalità d’esameL’esame prevede una prova orale (discussione di una tesina per gli studenti frequentanti e non frequentanti, appunti del corso) sui temi affrontati durante il corso.
ValutazioneLa valutazione finale del corso sarà su tutto il materiale fornito dalla docente durante il seme-stre .
Lingua araba
Prof. Ahmad Addous [titolare: prof. Demetrio Giordani]CFU 4 – 20 ore
Obiettivi formativiIl corso è rivolto ai discenti privi di conoscenza della lingua araba ed offre loro: le nozioni fon-damentale della fonetica, una piena conoscenza ortografica, lettura vocalizzata e scrittura. L'obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti iniziali per lo studio dell'arabo nella forma standardizzata; al termine del corso lo studente potrà essere in grado di leggere e scrivere un testo elementare in lingua araba; avrà acquisito un numero di vocaboli sufficiente per poter affrontare una semplice conversazione e avrà una conoscenza sintetica della struttura gram-maticale e delle forme linguistiche in uso nell'arabo letterario moderno.
Prerequisiti
131
Nessuno
Programma del corsoIl corso di lingua araba affronterà in ordine i seguenti argomenti: l'articolo, i pronomi, i dimo-strativi, il nome (singolare, duale, plurale sano e fratto, maschili e femminili), alcuni interrogati-vi, lo stato costrutto, l'aggettivo, il comparativo, i colori, i numerali, la frase nominale semplice, la frase verbale semplice, le concordanze elementari ed il verbo semplice di prima forma (il perfetto, l'imperfetto e l'imperativo). Oltre allo studio dell'arabo letterario scritto, sarà data allo studente la possibilità di esercitarsi per esprimersi in modo semplice in alcune situazioni comuni come: presentarsi ad altri, salu-tare e usare le forme linguistiche usate in ambito familiare, ricevere indicazioni in città, comu-nicare in un negozio, in un ristorante, ecc. Testi di riferimento
● Manca, Grammatica di arabo letterario moderno, Roma, Ass. Amicizia e Coopera-zione
● E. Baldissera, Dizionario compatto Italiano-arabo e Arabo-Italiano, Bologna Zani-chelli.
FrequenzaFortemente raccomandata
Programma per i non frequentantiNessuno
Modalità d’esameUna prova scritta e una orale. Il superamento dell’esame scritto consente di accedere alla prova orale.
ValutazioneNella valutazione dell’esame orale si terrà conto anche dell’esito della prova scritta.
Lingua francese e culture francofoneCFU 2 o 6 o 10
docente da definire
Lingua Spagnola e Culture Ispanofone
Dott.ssa Lia Poggio e prof.ssa Silvia BettiCFU 6/10 – 60 ore
Metodo didatticoLezioni-seminario
Obiettivi formativiObiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti necessari per conoscere aspetti fonda-mentali della cultura della penisola Iberica nel periodo di dominazione araba. Particolare attenzione sarà dedicata alla storia della cultura gastronomica andalusí, caratteriz-zata dalle contaminazioni arabe.
PrerequisitiNessuno
Programma del corso
132
Attraverso la lettura antologica della storia della letteratura spagnola dalle origini al Quattro-cento, il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti per una corretta metodologia nell’approccio a testi letterari spagnoli dell’epoca, al fine di cogliere gli aspetti salienti dell’in-fluenza della cultura islamica nella penisola. Il percorso proposto agli studenti si propone inol-tre di esaminare altri aspetti della cultura della Spagna musulmana concentrandosi sugli ele-menti fondamentali della tradizione gastronomica.Parte del corso sarà inoltre dedicata all’analisi della storia recente dell’immigrazione magrebi-na nella penisola Iberica, attraverso letture di testi e documenti.
Le lezioni si articoleranno nella lettura e commento dei testi forniti dal docente. Parte linguisticaLETTORATOSi consiglia agli studenti di frequentare le lezioni di lettorato tenute dai Docenti di lingua ma-dre,lezioni che intendono fornire e consolidare le strutture morfosintattiche e comunicative di base, attraverso lo sviluppo delle quattro macroabilità (comprensione orale e scritta ed espressione orale escritta).
*Eventuali modifiche e/o integrazioni al programma presentato saranno comunicate agli stu-denti durante le lezioni.
Testi di riferimento● Alvar, C; Mainer J.C. e Navarro, R., Storia della letteratura spagnola. Vol. I , Il Me-
dioevo e l’Età d’Oro, Einaudi, Torino 2000.● Cantare del Cid . Introduzione, traduzione e note di Andrea Baldissera (testo a fron-
te), Garzanti, Milano, 2003● Legido (ed.), El romancero, Madrid, Castalia Prima, 1999.● Varvaro , A.; .Samonà, C., La letteratura Spagnola dal Cid ai Re Cattolici, BUR,
1993.● Vives, Jaime Vicens, Profilo della storia di Spagna, Einaudi, Torino 2003● Benavides Barajas, L., Nueva - clásica cocina andalusí, Dulcinea, 1995.● Benavides Barajas, L., Al Andalus, la cocina y su historia, Dulcinea, 1992.
Ulteriori riferimenti bibliografici verranno dati nel corso delle lezioni.
Programma per i non frequentantiGli studenti lavoratori e gli studenti non-frequentanti sono pregati di presentarsi ad un ricevi-mento con la docente (appunti delle lezioni quando possibile, testi in bibliografia, tesina).“ Studenti a tempo parziale ” : La regolare frequenza alle lezioni è normalmente presupposta per tutti gli studenti. Nel caso di motivati impedimenti, gli studenti sono pregati di presentarsi ad un ricevimento con la docente per concordare un programma alternativo.
Modalità d’esameL’esame prevede una prova scritta in lingua ed una prova orale in lingua sui temi affrontati durante il lettorato da sostenere con i Collaboratori linguistici; superate queste due prove, in ogni loro parte (es. esercizio a, b, c, ecc.), si accede all’esame orale che consiste in un collo-quio con la docente del corso principale. Essendo un corso per principianti la lingua veicolare è l’italiano, ma gli studenti che lo vorranno, potranno utilizzare lo spagnolo (o esporre in lin-gua parti del programma a scelta).
ValutazioneLa valutazione finale del corso sarà su tutto il materiale fornito dalla docente durante il seme-stre (appunti del corso e materiale distribuito nel corso delle lezioni) e terrà conto del lavoro svolto durante i lettorati (verifiche intermedie scritte e orali da sostenere durante i semestri con i Collaboratori linguistici) e delle due prove finali (vedi sopra: tipo esame), una scritta e
133
una orale in lingua, sostenute con i Collaboratori linguistici.
Lingua tedesca e culture germaniche
Prof.ssa Antonie HornungCFU 2/6/10
Mutuato da Lingue e Culture Europee (II anno – Terza Lingua Tedesco)
Storia dell’Europa
Prof. Andrea PanaccioneCFU 6 – 60 ore
Obiettivi formativi Obiettivo formativo del corso di Storia dell’Europa è fornire agli studenti gli strumenti critici e interpretativi per orientarsi efficacemente all’interno delle vicende del continente nel corso del Novecento e dei diversi approcci culturali al tema dell’Europa. In particolare il corso prenderà in esame: La configurazione dell’Europa dopo la prima guerra mondiale, le questioni nazionali e sociali, i movimenti e i regimi politici, la crisi della democrazia tra le due guerre mondiali L’impatto della seconda guerra mondiale e il confronto tra la situazione europea prima e dopo la seconda guerra mondiale Il posto dell’Europa nel mondo e i cambiamenti nella coscienza dello stesso attraverso la sto-ria del ‘900 Le politiche e le ideologie su cui si fonda la rinascita del secondo dopoguerra, i casi nazionali più significativi, la dimensione internazionale e la divisione dell’Europa in due blocchi, i siste-mi di welfare e la società dei consumi nel trentennio successivo alla seconda guerra mondiale La crisi degli anni Settanta e le sue conseguenze sul piano socio-economico, politico, cultura-le La storia dell’integrazione europea e lo sviluppo delle organizzazioni internazionali La crisi dei socialismi reali e i problemi della “nuova Europa”.Il corso vuole offrire agli studenti la possibilità di collocare criticamente i fondamenti e gli esiti della storia politica e sociale europea in una prospettiva aperta al contributo delle diverse scienze umane nella comprensione dei grandi cambiamenti del mondo del ‘900 sul piano del-le conoscenze e delle tecnologie, del rapporto tra le culture, delle ideologie politiche, dei mo-delli di società, delle forme della politica, dei modi di vita, del conflitto sociale e della sua rego-lazione, della percezione dei rischi globali. Una specifica attenzione sarà dedicata ai temi: Russia / Urss / Russia tra Europa e Eurasia; l’impatto dell’Urss sull’Europa dagli anni ’30 alla guerra fredda.
PrerequisitiNessuno
Programma del corsoIl corso di Storia dell’Europa si sofferma sulle vicende continentali analizzando le ragioni del declino dell’eurocentrismo, la crisi dei sistemi liberali e i conflitti tra diverse vie alla moderniz-zazione - democrazia, fascismo, comunismo - fino alla nascita di due blocchi politico-ideologi-ci contrapposti, al ridimensionamento dell’Europa nel mondo e ai processi di decolonizzazio-ne, al crollo dell’Unione sovietica nel 1991, al ruolo e destino dell’Europa nel confronto tra le civiltà e nei problemi della globalizzazione.Saranno approfonditi i processi di trasformazione più significativi nell’Europa in generale e nelle diverse aree e Paesi (Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Italia, Stati dell’Euro-pa orientale), a partire da un quadro di riferimento sulle questioni e sui grandi movimenti poli-
134
tici nell’Europa tra le due guerre e concentrandosi soprattutto sul periodo successivo alla se-conda guerra mondiale. Verranno analizzati in particolare i seguenti argomenti:
● l’impatto della prima guerra mondiale sulla società europea ● le questioni nazionali nell’Europa tra le due guerre ● i movimenti politici di massa nell’Europa tra le due guerre ● l’esperienza sovietica e il suo impatto in Europa ● fascismo e antifascismo; ● la seconda guerra mondiale come guerra totale ● il nuovo assetto politico e la divisione in blocchi dell’Europa nel dopoguerra ● la crisi degli imperialismi europei ● le politiche di ricostruzione nell’Europa occidentale ● i regimi dell’Europa orientale: instaurazione, sviluppi, contraddizioni ● la divisione della Germania, la guerra fredda e le sue fasi● l’Italia del secondo dopoguerra ● la destalinizzazione e la distensione internazionale● l’Italia dal centrismo al centro-sinistra ● le trasformazioni sociali e culturali degli anni sessanta ● la crisi economica e politica degli anni settanta nell’Europa occidentale e orientale ● la “rivoluzione” degli anni ottanta: trasformazioni economiche, sociali e politiche; ● l’Urss di Gorbaciov, il crollo del blocco orientale e la riunificazione tedesca ● l’integrazione dell’Europa dalla Comunità all’Unione Europea● la lunga crisi della prima repubblica in Italia ● le guerre nella ex Jugoslavia e l’identità politica europea ● i conflitti dopo la fine della guerra fredda.
L’esame dei testi di riferimento del corso sarà integrata da alcuni materiali e documenti messi a disposizione dal docente. Gli studenti interessati saranno guidati nella stesura di un elabo-rato scritto nell’ambito dei contenuti del corso.
Testi di riferimento
Per tutti
● M. Mazower, Le ombre dell’Europa, Milano, Garzanti, ultima edizione.● Un testo a scelta tra:● C. Crouch, Postdemocrazia, Roma-Bari, Laterza, 2003.● E. J. Hobsbawm, Intervista sul nuovo secolo, a cura di A. Polito, Roma-Bari, La-
terza, 1999.
Un testo a scelta tra:● B. Bongiovanni, Storia della guerra fredda, Roma-Bari, Laterza, 2001.● W. Hitchcock, Il continente diviso. Storia del continente dal 1945 ad oggi, Roma, Ca-
rocci 2003 (l’Introduzione più una delle 4 parti del libro a scelta).● Panaccione, Socialisti europei, Milano, FrancoAngeli, 2000 (capitoli 5, 6, 7, 8). ● Panaccione, Il 1956. Una svolta nella storia del secolo, Milano, Unicopli, 2006.● J. Smith, La guerra fredda 1945-1991, Bologna, il Mulino, 2000● N. Trubeckoj, L’Europa e l’umanità, Torino, Einaudi, 1982.
La scelta di eventuali altri testi potrà essere concordata con il docente durante il corso.
Frequenza Consigliata
Programma per i non frequentantiPer gli studenti non frequentanti il programma d’esame prevede inoltre:
● L. Rapone, Storia dell’integrazione europea, Roma, Carocci, 2002.
135
Modalità d’esameLa prova di esame è orale
ValutazioneAttraverso la prova d’esame.
Storia dell’Islâm
Prof. Demetrio GiordaniCFU 6 – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso di Storia dell’Islâm ha come obiettivo lo studio dei principi su cui è fondata la civiltà islamica attraverso l’analisi delle fonti della tradizione e di alcuni dei più importanti eventi sto-rici.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoDurante il corso si prenderanno in esame innanzitutto il Corano e la Tradizione profetica (Sunna) in quanto fonti principali della teologia e della Legge islamica (Sharî‘a), poi le dottrine di alcuni tra i più importanti teologi e intellettuali musulmani, le quattro principali scuole giuridi-che, le confraternite sûfî, le correnti dello Sciismo. A ciò si affiancherà l’analisi storica dell’I-slam sunnita nel periodo classico, dalla rivelazione del Corano alla formazione del Califfato abbaside. Infine si analizzerà il rapporto tra la civiltà islamica e l’Occidente durante l’epoca coloniale, e la genesi dei movimenti di riforma religiosa del XIX secolo e delle correnti del pensiero radicale.
Testi di riferimento● Khaled Fouad Allam, Claudio Lo Jacono, Alberto Ventura: Islam, a cura di Giovanni
Filoramo Roma-Bari 1999, (in alternativa: Alessandro Bausani: L’Islâm, Milano 1980, varie ristampe).
● Il Corano, traduzione di Alessandro Bausani, Milano 2001 (in particolare l’introduzio-ne e alcune sure che verranno commentate durante il corso).
Si consiglia: ● Alain Ducellier, Françoise Micheau: L’Islam nel Medioevo, Bologna 2004.
Va inoltre scelto a discrezione dello studente uno o più tra i testi seguenti:● Annemarie Schimmel: La mia anima è una donna. Il femminile nell’Islam, Genova
1998.● Amin Maalouf: Le crociate viste dagli arabi, Milano 1989● Vite antiche di Maometto, Milano 2007. ● Nizâm al-Mulk: L’arte della politica, Milano 1999.● Carlo Saccone: Viaggi e visioni di re, sufi, profeti, Milano 1999.● Biancamaria Scarcia Amoretti: Un altro Medioevo. Il quotidiano nell’Islam. Milano
2001
Frequenza Vivamente raccomandata
Programma per i non frequentanti
136
Gli studenti non frequentanti devono portare un testo a scelta in più, oppure, se scelgono di preparare per l’esame testi non presenti nell’elenco, dovranno informare preventivamente il docente e nel caso produrre una breve recensione.
Modalità d’esameEsame orale
Teoria e metodi del dialogo e della mediazione
Prof. Claudio BaraldiCFU 6 – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di fornire le competenze teoriche e pratiche per (1) la progettazione, (2) la metodologia di realizzazione e (3) l’analisi valutativa di interventi dialogici e di mediazione, realizzati in organizzazioni complesse (come scuole, organizzazioni per la cooperazione, coo-perative, associazioni, imprese, organizzazioni internazionali) e su uno specifico territorio (in paesi europei o in aree nelle quali si richiede cooperazione per lo sviluppo), con particolare ri-ferimento alla dimensione interculturale.Il corso mira a fornire competenze di ricerca e competenze professionali utili per l’inserimento in équipe di progettazione ed intervento dialogico e di mediazione, con particolare riferimento alle relazioni interculturali, in Italia, in Europa ed in Paesi extra-europei.
PrerequisitiPer studentesse e studenti del corso di laurea di Scienze della Cultura: è possibile sostenere l’esame soltanto dopo aver sostenuto gli esami di Sociologia e Sociologia dei processi cultu-rali. Programma del corsoIl corso è suddiviso in tre moduli. Il primo modulo (20 ore) tratta il tema della progettazione e della realizzazione di interventi dialogici e di mediazione: in particolare, vengono illustrate le componenti metodologiche delle “buone pratiche” di progettazione e di intervento, confrontan-do diversi approcci teorici e metodologici. Il secondo modulo (10 ore) è dedicato alle metodo-logie e alle tecniche di osservazione e di analisi valutativa dei processi e dei risultati degli in-terventi. Il terzo modulo (30 ore) presenta una serie di casi specifici di analisi del dialogo e della mediazione e consente di confrontare pratiche diverse, con particolare riferimento al-l’ambito interculturale. Saranno presentati materiali sui temi fondamentali del corso, introdu-cendo e commentando esperienze di progettazione ed intervento interculturale in Italia (edu-cazione interculturale, mediazione linguistico-culturale, educazione alla pace) e nelle aree di cooperazione e negoziazione internazionali (in particolare, Organizzazioni non Governative per lo Sviluppo e Nazioni Unite). Nel complesso, il corso intende articolare concetti teorici ed analisi di esperienze empiriche, discutendo metodi e strumenti per realizzare progetti, inter-venti ed analisi valutative. Il corso può essere raccordato allo svolgimento di tirocini proposti dal docente (secondo un programma che sarà illustrato all’inizio delle lezioni), oppure suggeriti dagli studenti.
Testi di riferimento● Lorenzo Luatti (a cura di), Atlante della mediazione linguistico-culturale, Franco An-
geli, Milano, 2006. ● C. Baraldi (a cura di), Il dialogo in classe, Donzelli, Roma, 2007
Come integrazione di uno dei testi o in alternativa ai testi proposti, è possibile concordare pro-grammi ad hoc sulla base delle esigenze specifiche delle studentesse e degli studenti.
Frequenza In base alla normativa stabilita dalla Facoltà, coloro che si dichiarano non frequentanti o che comunque non raggiungono la quota del 75% delle frequenze delle lezioni, dovranno portare
137
un programma aggiuntivo.
Programma per non frequentantiIl programma per non frequentanti equipara il monte ore trascorso a lezione dai frequentanti (equivalenti a 60 ore di frequenza). Il programma è il seguente:
● Lorenzo Luatti (a cura di), Atlante della mediazione linguistico-culturale, FrancoAn-geli, Milano, 2006.
● C. Baraldi (a cura di), Il dialogo in classe, Donzelli, Roma, 2007
Uno a scelta tra i seguenti:● C. Rogers, Terapia centrata sul cliente, La Nuova Italia, Firenze, 1997 (capp. I, II, III,
IV e VI) + T. Gordon, Relazioni efficaci, Meridiana, Bari, 2005.● Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruono Mondatori, 2003● Daniel Goleman, Intelligenza sociale, Rizzoli, 2006
Modalità d’esame Per l’esame finale, sono disponibili due opzioni: 1) esame orale; 2) relazione (tra i 20.000 ed i 30.000 caratteri a stampa) contenente un’analisi valutativa di un progetto o di un intervento di mediazione, sulla base di testi e materiali concordati con il docente.
138
Laurea magistrale in Analisi dei Conflitti, delle Ideologie e della Politica del Mondo Contemporaneo
Culture dei paesi islamici contemporanei
Prof. Demetrio GiordaniCFU 4 – 30 ore
“Origini storiche del fondamentalismo islamico”
Obiettivi formativiIl corso si propone di dotare lo studente di adeguati mezzi di conoscenza per comprendere il fenomeno del radicalismo islamico, attraverso lo studio dei principali fatti storici che hanno ca-ratterizzato i rapporti tra Oriente e Occidente negli ultimi tre secoli e attraverso l’analisi delle idee di alcuni dei pensatori islamici più rappresentativi.
Prerequisiti Conoscenza dei fondamenti della civiltà dell’Islâm.
Programma del corsoIl corso si divide in due parti: nella prima si analizzeranno le cause e l’evoluzione della deca-denza del mondo islamico a partire dal XVIII secolo, nella seconda parte si analizzerà la ri-sposta che il mondo islamico ha opposto al colonialismo e all’occidentalizzazione attraverso le fasi della rinascita, del riformismo e del radicalismo.
Testi di riferimento● Pier Giovanni Donini: Il Mondo Islamico. Breve storia dal Cinquecento a oggi. Later-
za, Roma-Bari 2003.● Youssef Choueiri: Il fondamentalismo islamico. Origini storiche e basi sociali. Il Muli-
no, Bologna 1993.Oltre a questi due testi verranno proposte agli studenti dispense su argomenti specifici.
FrequenzaE’ necessario il 75% delle presenze per essere considerati frequentanti.
Programma per i non frequentantiDa contrattare con il docente.
Modalità d’esameEsame orale.
Demografia
Prof. Luciano NicoliniCFU 4 – 30 ore
Obiettivi formativiScopo del corso è, in primo luogo, fornire ai partecipanti gli strumenti indispensabili per com-prendere l’esatto significato degli indicatori forniti dai demografi ed interpretarne correttamen-te le variazioni; in secondo luogo metterli in grado di realizzare autonomamente ricerche sulla
139
popolazione, con particolare riferimento alle popolazioni del passato e a quelle sprovviste dei moderni sistemi di rilevazione dei fenomeni demografici.
Prerequisiti Nessuno.
Programma del corsoIl corso si articolerà in tre parti rispettivamente dedicate a: indicatori, fonti e teorie.Durante la prima parte saranno introdotti i concetti che stanno alla base della demografia. Verranno quindi illustrati i principali indicatori utilizzati nello studio dell’ammontare della popo-lazione, della sua distribuzione sul territorio, della struttura per sesso ed età, della mortalità, della fecondità, del movimento migratorio, della nuzialità, dell’endogamia e della consangui-neità. Si accennerà inoltre ai principali sistemi di classificazione delle famiglie e delle convi-venze utilizzati in demografia. Nello sviluppare la seconda parte saranno analizzate le fonti statistiche e le fonti amministrati-ve ma anche, in considerazione degli obiettivi formativi dei corsi di laurea in cui è inquadrato l’insegnamento, le fonti per lo studio della demografia storica, della paleodemografia e delle popolazioni sulle quali maggiormente si concentra l’interesse dell’antropologia. Ci si sofferme-rà poi sui metodi di proiezione della popolazione, accennando anche alle proiezioni derivate e alle proiezioni inverse, particolarmente utilizzate nel campo della demografia storica.La terza parte, infine, sarà dedicata alle più accreditate teorie formulate per spiegare le tra-sformazioni demografiche che hanno accompagnato la diffusione della pratica dell’agricoltura e dell’allevamento e, soprattutto, in epoca contemporanea, i fenomeni costituiti dall’industria-lizzazione e dall’urbanizzazione. Di tali mutamenti si prenderanno in considerazione anche gli effetti sulla biologia delle popolazioni umane, introducendo alcuni elementari concetti di ecolo-gia e di genetica delle popolazioni.
Testi di riferimentoIl testo consigliato per lo studio è:
● Massimo Livi Bacci, Introduzione alla demografia, Loescher, Torino, 1999 (limitata-mente agli argomenti trattati durante il corso).
Utile la lettura di● L. Del Panta e R. Rettaroli, Introduzione alla demografia storica, Laterza, Roma-
Bari,1994 (con riferimento al primo capitolo, dedicato alle fonti) e, per quanto riguar-da l’immigrazione più recente, Dominutti G. e Jahier F (a cura di), Presenza stranie-ra in Italia. Ricognizione delle principali fonti informative, CISIS, Roma, 2001 (scari-cabile dal sito www.cisis.it).
Saggi a carattere storico-demografico, dei quali prendere visione come esempi di ricerca nel settore, sono reperibili in
● L. Del Panta, L. Pozzi, R. Rettaroli, E. Sonnino (a cura di), Dinamiche di popolazio-ne, mobilità e territorio in Italia, secoli XVII-XX, Forum, Udine, 2002 e, con riferimen-to alle popolazioni montane
● Fornasin, A. Zannini (a cura di), Uomini e comunità delle montagne, Paradigmi e specificità del popolamento dello spazio montano (secoli XVI-XX), Forum, Udine, 2002.
FrequenzaE’ necessario il 75% delle presenze per essere considerati frequentanti.
Programma per i non frequentantii non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente per concordare il program-ma in modo più dettagliato.
140
Metodologia della ricerca storica
Prof. Fabio Degli EspostiCFU 4 – 30 ore
Obiettivi formativiIl corso si prefigge di analizzare le specificità metodologiche della storia contemporanea. Verranno affrontati: La definizione delle grandi categorie e delle periodizzazioni che connotano la contemporanei-tà e in particolare il Novecento. Le principali correnti storiografiche fra Otto e Novecento.L’uso delle fonti e il problema della loro selezione nell’epoca della loro moltiplicazione; il rap-porto tra fonti tradizionali - fonti archivistiche - e le “nuove fonti”: dalle fonti orali alle fonti on-line e audiovisive..Obiettivo del corso è, inoltre, di affrontare il tema dell’uso pubblico della storia e delle trasfor-mazioni della disciplina nella società contemporanea di fronte alla tendenza alla “industrializ-zazione” delle produzioni sulla storia da parte dei mass-media e in relazione all’utilizzo della storia come strumento della battaglia politico-culturale.
Prerequisiti Prerequisito indispensabile è la conoscenza di nozioni di base sulla metodologia della storia contemporanea: vedi ad es. Vittorio Vidotto, Guida allo studio della storia contemporanea, La-terza (consigliato solo a quanti lo ritengano necessario).
Programma del corsoIl corso di metodologia della ricerca storica si concentra sui fondamenti scientifici della storia contemporanea, sulla loro evoluzione nel corso del Novecento attraverso una ricognizione sulla storia della storiografia europea e italiana. Il ruolo dello storico, il rapporto tra verità e soggettività, l’interpretazione dei dati e le domande alle fonti saranno oggetto di attenzione specifica, così come il rapporto costante tra la dimen-sione del passato e del presente e, infine, la dilatazione degli oggetti di interesse dello storico (ad es.: dalla storia politico-istituzionale alla storia sociale). Si analizzeranno i passaggi dalla storia intesa come scienza positiva e oggettiva alla storia come scelta e interpretazione e dalla storia come scienza “neutrale” sul passato alla storia che muove dagli interrogativi che agitano il presente dello storico. Il corso prevede anche la visita di archivi d’importanza locale e nazionale per una conoscenza diretta del materiale in essi conservato e il loro uso nella ricerca .
Testi di riferimento(Indicazioni provvisorie)
● Giovanni De Luna, La passione e la ragione. Fonti e metodi dello storico contempo-raneo, La Nuova Italia.
● Angelo D’Orsi, Piccolo manuale di storiografia, Bruno Mondatori .● Novecento, rivista semestrale, n. 11-2004, “Fare storia oggi”, Carocci editore.● Nicola Gallerano, La verità della storia. Scritti sull’uso pubblico del passato, Manife-
stolibri.● Marc Bloch, Apologia della storia, Einaudi (solo l’introduzione di Jacques Le Goff).
FrequenzaE’ necessario il 75% delle presenze per essere considerati frequentanti.
Programma per i non frequentantiGli studenti non frequentanti concorderanno un programma ad hoc con il docente.
Modalità d’esameColloquio orale.
141
Religioni e conflitti
Prof.ssa Sabina CrippaCFU 6 – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso intende fornire competenze specifiche sulla rilevanza dello studio dei fenomeni stori-co-religiosi nella comprensione dei fatti culturali e sociali della storia in età contemporanea.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoI)In una parte introduttiva si tracceranno le linee fondamentali del costituirsi della storia delle religioni e del ruolo della scuola italiana nel dibattito storico e politico a partire dall’inizio del 1900.
II)Nella seconda parte si presenteranno alcuni dei grandi “paradossi”del Novecento tra seco-larizzazione, l’affermazione del pensiero laico e il ritorno all’irrazionalismo in relazione specifi-ca alla dimensione dei conflitti.In particolare si analizzeranno le diverse ideologie relative al corpo e la loro centralità nelle forme totalitarie.Argomenti:-Storiografia e storia delle religioni-Guerra e sacro tra la prima e seconda guerra mondiale: ideologie e correnti storico-religiose-Totalitarismi e forme del sacro: concettualizzazioni del corpo e culto del corpo-Conflitti e leggibilità interculturale
Testi di riferimento● S. Barbera, C.Grottanelli A. Savorelli, La riscoperta del 'sacro' tra le due guerre mon-
diali, Quaderni del "Giornale critico di filosofia italiana" Firenze 2005.● E. Conte – C. Essner, Culti di sangue. Antropologia del nazismo, Roma, Carocci,
2000.● C. Grottanelli, Il sacrificio Laterza, Bari 1999● C. Natali, Sabbia sugli dei.Pratiche commemorative tra le Tigri tamil (Sri Lanka), Il
segnalibro, Torino 2004.● A.K.SEN, Identità e violenza, Laterza 2006.
Altre letture (da concordare):● G.L.Larson, India’s Agony over Religion,Suny Press 1995● J. Sacco, Goradze.Area protetta. Mondadori 1997.● C. Degli Abbati-O. Roy, Afghanistan. L’Islam Afgano.ECIG 200● A.Marzo Magno, La guerra dei dieci anni,Il Saggiatore 2001.
FrequenzaE’ necessario il 75% delle presenze per essere considerati frequentanti.
Programma per i non frequentanti- 2 testi da concordare con la docente ( v. Bibliografia orientativa)- relazione scritta di argomento da concordare
Modalità d’esameOrale
142
Scienza, tecnologia e ambiente
Prof.ssa Vallori Rasini – Prof. Giacomo ScarpelliCFU 8 – 60 ore (40+20)
“Antropologia filosofica ed evoluzionismo biologico”
Metodo didatticoLezione.
Obiettivi formativi Fornire cognizioni generali e l’acquisizione di strumenti storici e concettuali su temi del pen-siero filosofico e scientifico contemporaneo, con particolare riferimento alle teorie antropologi-che contemporanee.
Prerequisiti Non sono richieste particolari competenze disciplinari. Sarebbe tuttavia auspicabile una gene-rica conoscenza delle maggiori correnti filosofiche e dei principali eventi storici dell’800 e del ‘900.
Programma del corso Il corso sarà diviso in due parti. La prima (40 ore) tratterà delle teorie antropologiche di due importanti intellettuali contemporanei, Max Scheler e Arnold Gehlen, che nel corso del Nove-cento – pur seguendo metodi di indagine profondamente diversi – hanno cercato di coniugare elementi specifici del pensiero filosofico e speculativo con i più recenti risultati delle indagini scientifiche contemporanee, al fine di elaborare una teoria dell’uomo attendibile e aggiornata. La seconda parte (20 ore) sarà dedicata allo studio delle teorie evoluzionistiche di Charles Darwin, in particolare a quelle sulle origini della specie umana. Si cercherà di appurare come la concezione darwiniana costituisse un’eccezione nel panorama evoluzionistico e di verifica-re come essa possa essere stata oggetto di fraintendimenti e deformazioni in ambito filosofico e scientifico.
Testi di riferimento● M. Scheler, La posizione dell’uomo nel cosmo, Milano, Angeli, 2000● Gehlen, Prospettive antropologiche, Bologna, il Mulino, 200● M.T. Pansera, Antropologia filosofica, Milano, Bruno Mondadori, 2001 (le parti dedi-
cate a Scheler e a Gehlen)● V. Rasini, Arnold Gehlen: natura umana e azione, in M.T. Pansera (a cura di), Il pa-
radigma antropologico di Arnold Gehlen, Milano, Mimesis, 2005, pp. 91-105● Darwin, L’origine dell’uomo e la selezione sessuale, Roma, Newton Compton 2007 (i
capitoli I, VI, VII e il Sommario generale).● G. Barsanti, Una lunga pazienza cieca: storia dell’evoluzionismo, Torino, Einaudi
2005 (da pag. 209 a pag. 244).● G. Scarpelli, Il cranio di cristallo. Evoluzione della specie e spiritualismo, Torino, Bol-
lati Boringhieri 1993 (capitoli 1,2,7,8,9,10,11).
Letture consigliate (non obbligatorie):● E. Coreth Antropologia filosofica, Brescia, Morcelliana, 2000 ● M.T. Pansera (a cura di), Il paradigma antropologico di Arnold Gehlen, Milano, Mi-
mesis, 2005● S.J. Gould, Il pollice del panda, Milano, Il Saggiatore 2001 (oppure, dello stesso au-
tore, Risplendi grande lucciola, Milano, Feltrinelli 2006).● E.J. Wagner, La scienza di Sherlock Holmes, Torino, Bollati Boringhieri 2007
143
Altri materiali saranno eventualmente forniti durante il corso.
FrequenzaE’ necessario il 75% delle presenze per essere considerati frequentanti.
Programma per i non frequentantiChi non potrà seguire le lezioni sarà tenuto a concordare personalmente con i docenti (V. Ra-sini e G. Scarpelli) il programma da portare all’esame.
Storia dei conflitti politico religiosi nell’Europa moderna
Prof. Giovanni Vittorio SignorottoCFU 8 – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso intende offrire una conoscenza di base e gli strumenti per un approccio storico critico, aggiornato sul contributo delle diverse scienze umane, riguardo ai problemi della storia del cristianesimo. Alla luce dei problemi del mondo attuale, gli studenti dovranno acquisire una attitudine alla considerazione dei rapporti tra religione, società e politica nella loro complessità e in un’ottica interdisciplinare.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoTenendo debitamente conto degli aspetti teologici e delle pratiche religiose, si prenderà in esame la presenza istituzionale delle Chiese cristiane, con le loro diverse forme organizzati-ve, nel rapporto con il potere politico e la società civile. Particolare attenzione sarà rivolta alla cultura e alla storia d’Europa, come pure alle vicende dell’Italia moderna e contemporanea, caratterizzate da una marcata presenza della Chiesa cattolica nella dinamica politica e socia-le. L’approfondimento storico di alcuni contesti esemplari sarà importante per dare il senso della complessità del mondo attuale e una maggiore coscienza dei suoi problemi politico-reli-giosi. Alcune lezioni tratteranno il passaggio dall’orizzonte religioso di antico regime all’affermarsi del processo di secolarizzazione con particolare riferimento alla storia europea. Il corso sarà in gran parte dedicato alle tappe fondamentali del rapporto tra Cristianesimo e democrazia, dalla reazione alla rivoluzione francese fino al compimento del Concilio Vaticano II. A tal fine si analizzeranno fonti documentarie fornite durante le lezioni.
Testi di riferimento● John Bossy, L’Occidente cristiano. 1400-1700, Einaudi, 2001● G. Filoramo- D. Menozzi (a cura di), Storia del cristianesimo, vol. IV, L’età contem-
poranea, Laterza Roma-Bari 2002 (Collana Economica Laterza)
Inoltre, un testo a scelta tra i seguenti:● D. MENOZZI, Percorsi della «societas christiana». Da Leone XIII al Vaticano II, in:, Id.,
La chiesa cattolica e la secolarizzazione, Einaudi, Torino 1993, pp. 136-197.● G. MICCOLI, Chiesa e società in Italia dal Concilio Vaticano I (1870) al pontificato di
Giovanni XXIII, in: Storia d’Italia, vol V, I documenti, Einaudi, Torino 1973, pp. 1495-1548.
● G. VERUCCI, La chiesa postconciliare, in: Storia dell’Italia repubblicana, v. II, La tra-sformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri, Einaudi Torino 1995 , pp. 297-382.
● MELLONI, Chiesa madre, chiesa matrigna. Un discorso storico sul cristianesimo che
144
cambia, Einaudi 2004. N.B.: Gli studenti iscritti a un corso di laurea di base dovranno sostituire al testo a scelta la lettura di
● P. Rémond, La secolarizzazione. Cristianesimo e società nell’Europa contempora-nea, Laterza 1999.
FrequenzaE’ necessario il 75% delle presenze per essere considerati frequentanti.
Programma per i non frequentantiAi non frequentanti si richiede la lettura di due testi a scelta tra quelli indicati al punto 2. I non frequentanti iscritti a un corso di laurea di base dovranno aggiungere alla lettura del li-bro di Rémond uno dei testi a scelta.
Modalità d’esameOrale
Valutazione Prova fina
Storia delle dottrine politiche
Prof. Andrea PanaccioneCFU 4 – 30 ore
“Socialismi e nazionalismi nella storia del ‘900”
Metodi didatticilezioni
Obiettivi formativi. Il corso dovrà fornire agli studenti un orientamento generale sulla storia del pensiero politico dell’età contemporanea e permettere l’acquisizione di strumenti e metodi di ricerca e di appro-fondimento sul processo di trasformazione delle idee politiche in ideologie dei movimenti di massa, sul ruolo degli intellettuali in questo processo, sulla funzione svolta dalle ideologie nei processi di Nation- e di State-building.
PrerequisitiNessuno
Programma del corso Il corso sarà articolato in una parte di riferimenti generali sulle principali correnti del pensiero politico nell’età contemporanea e in una parte più specificamente dedicata alle ideologie e culture politiche dei movimenti di ispirazione socialista, nazionale e nazionalista, attraverso l’esame sia degli elementi di contrapposizione ideale e politica tra questi movimenti sia dei loro intrecci e contaminazioni in alcune congiunture della storia del ‘900 (le questioni nazionali e le forme della mobilitazione politica, i socialismi nazionali, i passaggi di campo da un movi-mento all’altro, l’idea di patria nel movimento operaio, ecc.) sia del ruolo delle ideologie nei processi di Nation- e di State-building. Uno specifico approfondimento sarà dedicato al ruolo degli intellettuali nei movimenti politici di massa e alla questione dell’impegno degli intellettuali nel ‘900. L’analisi dei testi di riferimento indicati sarà integrata da alcuni materiali e documenti messi a disposizione dal docente. Gli studenti interessati saranno guidati nella stesura di un elaborato scritto nell’ambito dei contenuti del corso.
145
Testi di riferimentoCome testo di orientamento generale per tutti gli studenti,
● K. D. Bracher, Il Novecento secolo delle ideologie, Roma-Bari, Economica Laterza, 2002 (la Introduzione e le prime due parti),
che sarà affiancato da un altro testo a scelta per gli studenti frequentanti, e due a scelta, per i non frequentanti, tra quelli sotto indicati:
● O. Bauer, La questione nazionale, a cura di N. Merker, Roma, Editori Riuniti, 1999: le due Prefazioni e il Cap. I, La nazione.
● R. Brubacher, I nazionalismi nell’Europa contemporanea, Roma, Editori Riuniti, 1998: Parte I, Cap. 3, Minoranze nazionali, Stati nazionalizzatori e patrie nazionali esterne nella nuova Europa; Parte II, Cap. 1, Stati nazionalizzatori nella vecchia “Nuova Europa” e nella nuova.
● Campi, Nazione, Bologna, il Mulino, 2004: Premessa e Cap. V, Novecento.● E. Gentile, La Grande Italia, Milano, Oscar Saggi Mondadori, 1999: Parte II, Quale
Italia? (cap. IV-VII)..● G. Haupt, L’Internazionale socialista dalla Comune a Lenin, Torino, Einaudi, ultima
edizione: gli ultimi due capitoli (Guerra o rivoluzione? L’Internazionale e l’Union sa-crée nell’agosto del 1914; Guerra e rivoluzione in Lenin).
● Th. Herzl, Lo stato ebraico; Genova, Il melangolo, 2003.● E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi, Torino, Einaudi, ultima edizione: Cap. V,
L’apogeo del nazionalismo● Ž. e R. Medvedev, Stalin sconosciuto, Milano, Feltrinelli, 2006: Cap. 13, Stalin nazio-
nalista russo e Postfazione, Stalin e i suoi interpreti.● G. L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, Bologna, il Mulino, ultima edizione:
Cap. VII, Il contributo dei lavoratori; Cap. VIII, I gusti di Hitler; Cap. IX, Il culto politi-co.
● Panaccione, Socialisti europei, Milano, FrancoAngeli, 2000: Cap. 1, La trasformazio-ne dell’internazionalismo socialista dalla prima guerra mondiale; Cap. 5, Crisi della democrazia, antifascismo, Unione Sovietica.
● Z. Sternhell, La nascita di Israele, Milano, Baldini & Castoldi, ultima edizione: Intro-duzione. Nazionalismo, socialismo e socialismo nazionalista
● M. Weber, La scienza come professione. La politica come professione, Milano, Oscar Mondadori, 2006
● H.-U. Wehler, Nazionalismo. Storia, forme, conseguenze, Torino, Bollati Boringhieri, 2002: Cap. 7, Tipologie del nazionalismo; Cap. 8, La storia dello sviluppo del nazio-nalismo.
FrequenzaE’ necessario il 75% delle presenze per essere considerati frequentanti.
Modalità d’esameLa prova d’esame orale prevede lo studio dei seguenti testi:
ValutazioneAttraverso la prova finale, ma tenendo conto anche di eventuali elaborazioni scritte presenta-te durante il corso
Storia dei paesi europei e delle relazioni internazionali
Prof. Lorenzo BertuccelliCFU 8 – 60 ore
146
Obiettivi formativiIl corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti critici e interpretativi per sviluppare, in una prospettiva comparativa, una conoscenza approfondita della storia politica, istituzionale e sociale degli Stati europei anche in relazione al contesto mondiale. Il corso intende intrecciare un’analisi di lungo periodo sui diversi percorsi di modernizzazione che si sviluppano nel continente con un approfondimento di alcune fasi cruciali della storia del Novecento, così da fornire agli studenti gli elementi utili per orientarsi sul complesso rapporto tra continuità e rotture che caratterizza la storia europea degli ultimi due secoli. Un’attenzione particolare viene assegnata alla relazione tra la storia della conflittualità sociale e la storia del-la formazione delle grandi ideologie del novecento.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso si sofferma sull’analisi delle forme di modernizzazione che hanno caratterizzato l’Eu-ropa e il mondo Otto-Novecentesco: la via democratica alla società di massa, il fascismo e l’opzione rivoluzionaria “degli operai e dei contadini”. Un’attenzione specifica viene poi assegnata alla grande crisi politico-istituzionale che colpisce l’Europa dopo la prima guerra mondiale e alla successiva instabilità del continente fino alla seconda guerra mondiale. Il corso prende in esame la parabola del XX secolo per coglierne le interpretazioni, le relazio-ni tra i diversi periodi e soprattutto il continuo mutamento delle culture sociali e politiche: in particolare le origini delle culture classiste e di quelle nazionaliste. Infine, viene affrontato il nesso tra storia e memoria e la sua evoluzione nel corso del secon-do dopoguerra.Il corso prevede la possibilità di esercitazioni scritte e/o orali durante e al termine delle lezioni.
Testi di riferimento● Barrington Moore jr, Le origini sociali della dittatura e della democrazia. Proprietari e
contadini nella formazione del mondo moderno, Edizioni di Comunità (nel corso delle lezioni verranno indicate le parti utili per le esercitazioni o l’esame)
● Dan Diner, Raccontare il novecento, Garzanti ● Mariuccia Salvati, Il Novecento. Interpretazioni e bilanci, Laterza● Un testo sulla crisi europea tra le due guerre mondiale che sarà indicato a inizio le-
zioni.
Frequenza E’ richiesta la frequenza nella misura almeno del 75% di presenza alle lezioni.
Programma per i non frequentantiPer i non frequentanti si aggiunge
● Eric J. Hobsbawn, Nazioni e nazionalismo, Einaudi
Modalità d’esameColloquio finale orale con possibilità – in relazione al numero dei frequentanti – di prove scrit-te e orali intermedie.
Storia della scienza e della tecnica in età moderna e contemporanea
Prof.ssa Berenice CavarraCFU 8 – 60 ore
Programma del corsoIl corso tratterà alcuni aspetti rilevanti del pensiero scientifico e filosofico dei secoli XVIII e
147
XIX, con speciale riferimento alle teorie riguardanti le scienze della vita (biologia, medicina).Fra i temi in esame, i seguenti, soprattutto, saranno oggetto di approfondimento: meccanici-smo cartesiano e post cartesiano:; “anatomia animata” e vitalismo francese; evoluzione del-l’embriologia; metafisica e scienze della natura: l’età romantica; la fisiologia del primo ‘800, fra osservazione ed esperimento; chimica , fisica e scienze della vita; la crisi del vitalismo; teorie evoluzionistiche.
Testi di riferimentoFONTITre letture a scelta fra:
● Johann Friedrich Blumenbach, Impulso formativo e generazione, a cura di A. De Cieri, Salerno 1982.
● X. Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Paris 1822 (IV édition).● Emil Du Bois – Reymond, I sette enigmi del mondo, a cura di V. Cappelletti, Firenze,
Philosophia, 1057.● Cl. Bernard, Introduzione allo studio della medicina sperimentale, note introduttive a
cura di M. Baldini, Traduzione di F. Giretti, Padova, Piccin, 1994.● La Vergata, L’evoluzione biologica: da Linneo a Darwin, 1753, 1871, Torino Loe-
scher, 1979.
BIBLIOGRAFIA CRITICA● W. Bernardi, Scienze della vita e materialismo nel ‘700, in Storia della scienza mo-
derna e contemporanea, diretta da P. Rossi, I: Dalla rivoluzione scientifica all’Età dei Lumi, Torino, UTET, 1988, 567 e segg.
● W. Bernardi, Il problema della generazione, ibidem, 591 e segg.● S. Fabbri Bertoletti, Impulso, formazione e organismo: per una storia del concetto di
Bildungstrieb nella cultura tedesca, Firenze, Olschki, 1990.● E. Mayr. Storia del pensiero biologico, Torino, Bollati Boringhieri, 1990.● G. Barsanti, Una lunga pazienza cieca: storia dell’evoluzionismo, Torino, Einaudi,
2005.
La sopra menzionata bibliografia potrà subire variazioni che verranno comunicate ai frequen-tanti nel corso delle lezioni.
Programma per i non frequentantiI non frequentanti dovranno concordare con il docente letture supplementari.
Dott.ssa BERENICE CAVARRAVIA CAMPI , 213, DPT. CHIMICA, IV PIANO.TEL. 059/2055319.CELL. 347/[email protected] DI RICEVIMENTO: GIUGNO – LUGLIO 2007: GIOVEDI’, 16.00 – 18.00.SETTEMBRE 2007 – LUGLIO 2008: DA DEFINIRSI.
Storia sociale del mondo contemporaneo
Prof.ssa Giovanna ProcacciCFU 8 – 60 ore
Obiettivi formativi Il corso intende offrire agli studenti elementi di riflessione e strumenti critici e interpretativi di un evento cruciale della storia del XX secolo, quello della prima guerra mondiale. Verranno analizzati gli aspetti assunti dal conflitto nei vari paesi belligeranti, le strategie militari e le
148
morti in massa di militari e civili, i mutamenti delle funzioni dello Stato, il ruolo delle istituzioni e della politica, i rapporti tra classi e ceti e le trasformazioni della mentalità collettiva, i nazio-nalismi e i germi di guerra civile innescati dal conflitto, la continuità con la seconda guerra mondiale.
PrerequisitiIl corso richiede una conoscenza di base della storia contemporanea e della guerra 1914-1918.
Programma del corsoIl corso si articolerà in lezioni, discussione di alcuni testi e presentazione di una relazione scritta ed orale.Gli studenti prepareranno l’esame sui seguenti testi:
1. G. Procacci, La prima guerra mondiale, in Storia d’Italia, 5, Guerre e fascismo, a cura di G.Sabbatucci-V.Vidotto, Laterza
2. P. Fussel, La grande guerra e la memoria moderna, Il Mulino
oppureo G.De Luna, Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contempora-
nea, Einaudi oppure
o B.Bianchi ( a cura di), La violenza contro la popolazione civile. Deportati, profughi, internati, Unicopli
3. G. Procacci, Dalla rassegnazione alla rivolta. Mentalità e comportamenti popolari nella Grande guerra, Bulzoni
Oppureo G. Procacci, Soldati e prigionieri nella Grande Guerra, Bollati Boringhieri
Gli studenti dovranno inoltre scegliere uno dei seguenti temi, per i quali verranno forniti duran-te il corso i testi e alcune fotocopie. Sul tema prescelto svolgeranno la propria relazione- La guerra al fronte. Le strategie militari e le battaglie.- La guerra la fronte. Le trincee e i soldati.- La guerra al fronte. Come evitarla: diserzioni, suicidi, follia.- La prigionia. I primi campi di concentramento e di internamento, la morte per fame.- Deportazioni di civili, occupazioni, stragi. Il genocidio armeno- Lo Stato. Militarizzazione della vita civile e repressione del dissenso.- Lo Stato. Nuova politica di intervento in economia e in ambito sociale.- Il paese. Le agitazioni, gli scioperi, il mito rivoluzionario.- Il paese. La vita quotidiana: campagne, città, fabbriche, donne e ragazzi.- La guerra, la politica, la cultura. Interventismo e pacifismo.- Le ideologie. Fanatismi, millenarismi.- Guerra e dopoguerra. Gli effetti geopolitici, sociali, politici e ideologici.- Guerra totale e totalitarismo- Prima e seconda guerra mondiale: continuità o rottura?
Eventuali altri temi potranno essere indicati durante il corso
FrequenzaE’ necessario il 75% delle presenze per essere considerati frequentanti.
Programma per i non frequentantiGli studenti non frequentanti dovranno concordare il programma con il docente.
149
Modalità d’esameRelazioni orali e scritte e esame orale finale.
ValutazioneAttraverso le relazioni scritte ed orali e la prova finale.
Teorie della pace e della guerra
Prof. Antonello La VergataCFU 8 – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso intende offrire un panorama delle immagini e delle dottrine della guerra e della pace nella cultura contemporanea (grosso modo a partire dalla Rivoluzione francese), prendendo in esame testi di filosofi, scienziati, sociologi, psicologi, antropologi e scrittori. L’impostazione è quella interdisciplinare della storia delle idee.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso è articolato in moduli. A 20 ore di lezioni di argomento generale seguiranno 20 ore di analisi e discussione dei testi di riferimento. Le ultime 20 ore saranno dedicate a esercitazioni in forma di seminario, in cui gli studenti svolgeranno relazioni su argomenti specifici concor-dati con il docente.
Testi di riferimento● N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, Il Mulino, 1991.● R. Crépon, Le religioni e la guerra, Genova, Il Melangolo, 1991.● Eibl-Eibesfeldt, Etologia della guerra, Torino, Bollati Boringhieri, 1983.● La Vergata, Guerra e darwinismo sociale, Soneria Mannelli, Rubbettino, 2005.● La Vergata, Pace e guerra, in A. La Vergata, F. Trabattoni (a cura di), Filosofia e cul-
tura, Firenze, La Nuova Italia, 2007, vol. 3b, pp. 676-686.● D. Pick, La guerra nella cultura contemporanea, Bari, Laterza, 1994.
A scelta, uno dei seguenti:● M. Isnenghi, Il mito della Grande Guerra, Bologna, Il Mulino, 1997; sesta ed. 2007.● P. Fussell, La Grande Guerra e la memoria moderna, Bologna, Il Mulino, 1984; nuo-
va ed. 2000.
Per un inquadramento generale e per supplire a eventuali carenze delle proprie informazioni di base sulla storia della filosofia e della cultura dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri, lo studente è invitato a servirsi delle parti che riterrà utili di A. La Vergata, F. Trabattoni (a cura di), Filosofia e cultura, Firenze, La Nuova Italia, 2007.
FrequenzaE’ necessario il 75% delle presenze per essere considerati frequentanti.
Programma per i non frequentantiI non frequentanti dovranno portare all’esame entrambi i testi di Isnenghi e Fussell sopra indicati e uno a scelta fra i seguenti:
● M. Harris, Cannibali e re. Le origine delle culture, Milano, Feltrinelli, 1988.
150
● M. Sahlins, The use and abuse of biology. An anthropological critique of sociobio-logy, London, Tavistock Publications, 1977; trad. it. Critica della sociobiologia, Tori-no, Loescher, 1985.
● K. Lorenz, L’aggressività, Milano, Il Saggiatore- Bruno Mondadori● C. Vogel, Anatomia del male. Natura e cultura dell’aggressività, Milano, Garzanti,
1989.● E.J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima
guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 1985.● Gibelli, L’officina della guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo men-
tale, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.● M.K. Gandhi, Teoria e pratica della non violenza, scritti scelti a cura di G. Pontata,
Torino, Einaudi, 1997.● D. Losurdo, La comunità, la morte, l’Occidente. Heidegger e l’”ideologia della guer-
ra”, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.● Kant, Per la pace perpetua, a cura di N. Bobbio, Roma, Editori Riuniti, 1992 (o altre
edizioni, purché integrali). ● S. Freud, Il disagio della civiltà, Torino, Bollati Boringhieri, varie edizioni.● W.B. Gallie, Filosofie di pace e di guerra, Bologna, Il Mulino, 1993.
Modalità d’esameRelazioni orali o scritte durante il corso (v. sopra) ed esame orale finale
ValutazioneIl candidato dovrà dimostrare nelle relazioni e nel colloquio finale 1) una conoscenza appro-fondita dei testi letti, 2) capacità di esporre i contenuti in modo chiaro, rigoroso e conciso e di analizzarli criticamente inserendoli in un contesto storico-culturale problematico.
151
Laurea magistrale in Comunicazione nel-l'Impresa e nelle Organizzazione Internazio-nali
Comunicazione d’azienda
Prof.ssa Marina Vignola4 CFU - 30 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di analizzare le strategie comunicative dell’impresa, facendo riferimento sia alla comunicazione verso interlocutori interni, sia alla comunicazione verso interlocutori esterni. L’ambito di riferimento è il contesto nazionale e internazionale.
Prerequisiti Conoscenze di base di Marketing strategico e operativo
Programma del corsoLe strategie di comunicazione rivolte agli interlocutori interni contribuiscono a rafforzare l’iden-tità collettiva dei membri, e a diffondere la cultura d’impresa. Nel dettaglio i contenuti proposti ruotano intorno ai temi di: cultura aziendale e suo ruolo; contenuti della comunicazione inter-na; comunicazione come strumento di soddisfazione dei clienti interni. Le strategie di comunicazione rivolte agli interlocutori esterni promuovono l’azienda e i suoi prodotti con la finalità di ricercare la legittimazione e l’accreditamento degli interlocutori, in particolare dei clienti finali, influenzandone il comportamento nella direzione degli obiettivi aziendali. Si analizzano tre aree della comunicazione rivolta ai pubblici esterni:la comunicazione di marketing la comunicazione istituzionalela comunicazione economico-finanziariaCon particolare riferimento alla comunicazione di marketing, i contenuti proposti ruotano intor-no ai seguenti temi: analisi del segmento di settore e del target di riferimento, con particolare riguardo agli ele-menti caratterizzanti il comportamento di acquisto e di consumo del cliente finale e ai loro ri-flessi sulla struttura e sul contenuto della comunicazioneanalisi delle principali fasi del processo di comunicazione: definizione degli obiettivi, in funzione delle esigenze del target audience definizione del contenuto del messaggio; analisi degli strumenti del communication mix: pubblicità, promozione vendite, vendita perso-nale, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, fiere;individuazione degli strumenti del communication mix in funzione degli obiettivi aziendali e delle risorse disponibilivalutazione delle risorse disponibili e loro allocazione tra gli strumenti del communication mix; elaborazione di una campagna pubblicitaria:creazione del messaggio pubblicitarioscelta dei mezzi pubblicitariruolo e servizi di una agenzia pubblicitariadeterminazione del budget pubblicitario analisi della comunicazione internazionale: strategie di adattamento e di standardizzazione in relazione alle specificità del mercato di riferimento. Analisi delle influenze delle differenze cul-turali sulle strategie di comunicazione internazionale
Testi di riferimento
152
● Corvi E., La comunicazione aziendale: obiettivi, tecniche, strumenti, Egea (2007).
FrequenzaLa frequenza è fortemente consigliata
Programma per i non frequentantiNon è previsto un programma alternativo per i non frequentanti
Modalità d’esameLa valutazione si basa sull’elaborazione e la discussione di un caso aziendale per i frequen-tanti e su una prova scritta per i non frequentanti.
Comunicazione interculturale e Varietà della lingua – Lingua tedesca
Prof. Ernst Kretschmer – Prof.ssa Antonie Hornung10 CFU – 60 ore
Modulo di comunicazione interculturale
Obiettivi formativiL’obiettivo del corso è quello di trattare, nelle 30 ore previste, le possibilità di definire il con-cetto della cultura umana e di paragonare le diverse manifestazioni di essa nel contesto della comunicazione: quali difficoltà comunicative – ma anche quali stimoli – nascono dalle diffe-renze culturali?
Prerequisiti Il corso si tiene in lingua tedesca.
Programma del corsoSi parte dall’interpretazione di alcuni testi basilari sul concetto della «cultura» (Windelband, Rickert, Simmel, Weber, Cassirer, Assmann), per prendere poi in considerazione diverse si-tuazioni della comunicazione quotidiana, verbali e non-verbali, gli ostacoli dei pregiudizi e de-gli stereotipi, nonché le prospettive di un loro superamento. In particolare si prenderanno in considerazione gli aspetti interculturali nei campi dell’economia e della pubblicità, della comu-nicazione scientifica e quella giornalistica.
Testi di riferimento● Bolten, Jürgen und Ehrhardt, Claus (Hrsg.) (2003), Interkulturelle Kommunikation.
Texte und Übungen zum interkulturellen Handeln, Sternenfels: Wissenschaft und Praxis
● Fauser, Markus (2004), Einführung in die Kulturwissenschaft, Darmstadt: Wissen-schaftliche Buchgesellschaft.
● Heringer, Hans Jürgen (2004), Interkulturelle Kommunikation, Tübingen, Basel: Francke (UTB 2550).
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è normalmente presupposta. In casi motivati, lo studente può chie-dere, all’inizio del corso, di essere dispensato dalla frequenza concordando un programma per non-frequentanti con il docente. Si considerano frequentanti gli studenti che seguono al-meno il 75% delle lezioni.
Modalità d’esame e valutazioneTesina scritta.
153
Modulo di varietà della lingua
Obiettivi formativiConoscere alcuni modelli di comunicazione ed essere in grado di adoperarli per l'analisi di di-versi generi comunicativi, ad es. dei siti WEB con particolare riferimento alle diversità culturali tedesco-italiani. Prerequisiti Livello di tedesco B2/C1
Programma del corsoIl modello "organon" di Karl Bühler - analisi della comunicazione nei contesti istituzionali. La contestualizzazione della comunicazione secondo R. Jakobson - analisi della comunica-zione mediale.L'uso legittimo della lingua - Pierre Bourdieu - analisi della comunicazione nei contesti di for-mazione.
Testi di riferimento● Auer, Peter (1999): Sprachliche Interaktion. eine Einführung anhand von 22 Klassi-
kern. Tübingen, Niemeyer. (Ne sono presenti in biblioteca 3 esemplari)● Bühler, Karl (1992). Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache.
Stuttgart/New York: Fischer.● Bourdieu, Pierre (1982; dt. 1990): Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachli-
chen Tausches. Aus dem Französischen von Hella Beister. – Wien: Braumüller.● Jakobson, Roman (1974): Form und Sinn. Sprachwissenschaftliche Betrachtungen.
Wilhelm Fink Verlag, München. ● Jakobson, Roman (2005):Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921-1971.(Hrg. von Elmar
Holenstein und Tarcisius Schelbert). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
FrequenzaÉ richiesta la frequenza di almeno l'80 % delle lezioni.
Modalità d’esamescritto: Verbale di una lezione.orale: Presentazione orale (minimo 10 minuti) di un'analisi contrastiva di due siti WEB basata su una delle teorie discusse.
ValutazioneIl voto finale si compone dai voti per il verbale, la presentazione e il lettorato.
Comunicazione interculturale e Varietà della lingua – Lingua spagnola
Prof. Marco Cipolloni10 CFU 60 ore
“Buñuel, Almodóvar y los “Otros”: identità e sistema dei generi nel cinema spagnolo, dal surrealismo alla pop art”
Programma del corsoIl corso, partendo dalla presenza di echi buñueliani nei film di Almodóvar, analizza i muta-menti di prospettiva che, nel sistema dei generi del cinema spagnolo, ha caratterizzato il gio-co, l’uso e il riciclo degli stereotipi identitari.
Testi di riferimento(indicativi)
154
● Isabel Santaolalla, Los “Otros”: Etnicidad y “raza” en el cine español contemporá-neo, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.
● AAVV, Cartapacio: Buñuel en Almodóvar, in “Turia”, 76, febrero 2006, pp. 161-277.● Barry Jordan & Rikki Morgan-Tamosunas, Contemporary Spanish Cinema,
Manchester University Press, 1998.● Maurizio Fantoni Minnella, Trasgressione e Hispanidad. Il cinema di Pedro Almodó-
var, Tarab, Firenze, 1998.
Ulteriori indicazioni, bibliografiche e filmografiche, verranno fornite durante il corso.
Comunicazione interculturale e Varietà della lingua – Lingua francese
Prof.ssa Chiara Preite10 CFU – 60 ore
Modulo di comunicazione interculturale
Obiettivi formativiLa riflessione mira a mettere in rilievo le sfaccettature delle realtà insite nei concetti di civiltà e di intercultura, per giungere successivamente alla presa di coscienza delle problematiche le-gate alla comunicazione tra culture diverse, e alle molteplici varietà linguistiche frutto dell’in-contro di culture della francofonia, nonché all’analisi delle varietà sociali che compongono la lingua francese dell’Esagono. L’attenzione si concentrerà infine sui parler giovanili (argot, ver-lan, ecc.) e sul franglais o frenglish.
Prerequisiti Il corso si svolge il lingua francese.
Programma del corsoIl corso vuole mettere in evidenza le ricadute linguistiche del contatto culturale che si produce non solo a livello “interculturale”, ma anche nell’ambito della francofonia e all’interno dello stesso francese di Francia. La riflessione, accompagnata da una serie di testi originali tratti da fonti diverse, che mettono in luce elementi legati alla variazione linguistica e culturale, segue quindi un percorso che, partendo dall’analisi della comunicazione interculturale tra gruppi di etnia e lingua differente, si sofferma poi sull’“utopia” del francese standard, sulla variazione linguistica diatopica della francofonia, per concludersi con l’analisi delle variazione diastratica e diafasica in Francia.
Testi di riferimento● Un dossier sarà messo a disposizione degli studenti all’inizio del corso.● DE CARLO M., L’interculturel, Cle International, Paris 1998.● GADET F., La variation sociale en français, Ophrys, Paris 2003 (chap. 4-5-6)● MERLE P., Argot, verlan et tchatches, Milan eds. « Essentiels Milan », Toulouse,
2006.
NB: La bibliografia potrebbe essere oggetto di modifiche, la versione definitiva sarà comun-que inserita nel dossier.
FrequenzaLa frequenza è considerata fondamentale; gli studenti impossibilitati a frequentare un ade-guato numero di lezioni (70/75%) dovranno integrare il programma.Il corso ufficiale sarà completato da un ciclo di esercitazioni tenuto da collaboratrici di madre lingua. Per un iter formativo completo ne è fortemente consigliata la frequenza.
155
Programma per i non frequentantiIntegrazione del programma con la lettura di tre articoli (da concordare con il docente) conte-nuti nel seguente volume:
● PAULIN C. (dir.), Multiculturalisme, multilinguisme et milieu urbain, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2005.
Modalità d’esameL’esame consiste in un colloquio orale in francese sui contenuti del corso.
Modulo di varietà della lingua
Obiettivi formativiIl corso mira all’approfondimento della variazione diafasica in francese, con particolare atten-zione alle varietà specialistiche dei tipi di discorso giuridico e giudiziario, politico ed economi-co. Dopo un’introduzione relativa alle caratteristiche delle langues spécialisées e della loro terminologia, il corso si incentra sull’analisi delle peculiarità testuali che contraddistinguono di-versi generi comunicativi. Prerequisiti Il corso si svolge il lingua francese.
Programma del corsoLa riflessione teorica legata allo studio delle tipologie dei generi testuali ci condurrà alla pre-sentazione di una griglia di analisi su più livelli, che troverà applicazione pratica nella presa in esame di svariati generi specialistici. A tal fine, un dossier composto da testi originali tratti da fonti diverse (in particolare facenti capo a diverse langues spécialisées di cui verranno pre-sentate le caratteristiche terminologiche) sarà messo a disposizione degli studenti. L’analisi prenderà le mosse da un livello macrotestuale (riconoscimento delle tipologie prototipiche dei testi), per passare poi ad un livello microtestuale in cui verranno prese in considerazione le strategie linguistiche finalizzate ad assicurare coerenza e coesione ai testi, le teorie dell’enun-ciazione e della polifonia, e l’argomentazione nel discorso.
Testi di riferimento● Un dossier sarà messo a disposizione degli studenti all’inizio del corso.● MAINGUENEAU D., Analyser les textes de communication, Nathan, Paris 2000.● LERAT P., Les langues spécialisées, Paris, PUF, 1995.
NB: La bibliografia potrebbe essere oggetto di modifiche, la versione definitiva sarà comun-que inserita nel dossier.
FrequenzaLa frequenza è considerata fondamentale; gli studenti impossibilitati a frequentare un ade-guato numero di lezioni (70%) dovranno integrare il programma.Il corso ufficiale sarà completato da un ciclo di esercitazioni tenuto da collaboratrici di madre lingua. Per un iter formativo completo ne è fortemente consigliata la frequenza.
Programma per i non frequentantiIntegrazione del programma con la lettura dei seguenti volumi:
● PREITE C., Langage du droit et linguistique. Étude de l’organisation textuelle, énonciative et argumentative des arrêts de la Cour (et du Tribunal) de Justice des Communautés européennes, Aracne, Roma, 2005. (Chap. 2 pp. 83-111; Chap. 3 pp. 113-139 – 153-176; Chap. 4 pp. 227-260.
● PAISSA P., “L’analisi del testo come prassi metodologica di convergenza tra didattica della lingua e della civiltà, linguistica e letteratura francese”, in AA.VV., Prospettive della francesistica nel nuovo assetto della didattica universitaria, Atti del XXIV Con-vegno internazionale SUSLLF, Napoli-Pozzuoli 13-14 ottobre 2000, pp. 137-167.
156
Modalità d’esameGli esami si svolgeranno in francese.- Esame scritto: analisi di un testo specialistico secondo le modalità apprese durante il corso. L’esame scritto potrà essere sostituito dalla redazione di una tesina in cui si analizzi un picco-lo corpus relativo ad un genere testuale specialistico (da concordare con il docente).- Esame orale: discussione sull’esame scritto/tesina e colloquio sui contenuti del corso.
ValutazioneLa valutazione in trentesimi si basa sul voto ottenuto al colloquio relativo al modulo di Comu-nicazione interculturale + i voti ottenuti agli esami (scritto + orale) relativi al modulo di Varietà della lingua.
Comunicazione interculturale e Varietà della lingua – Lingua inglese
Prof.ssa Marina Bondi – Prof.ssa Franca Poppi10 CFU – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso intende sviluppare negli studenti capacità di analisi del rapporto tra scelta linguistica e varietà funzionali della lingua, attraverso una esplorazione delle nozioni di genere e di registro in una varietà di testi in inglese. In particolare, il corso si propone di: Condurre lo studente all’acquisizione di un elevato grado di competenza linguistica pratica, in cui sia rispettato l’equilibrio fra le abilità di comprensione e di produzione, con particolare rife-rimento alle abilità scritte. Promuovere l’acquisizione di strumenti di analisi delle pratiche linguistiche che favoriscano la formazione continua, anche in contesti professionali, attraverso la riflessione sulla lingua e sulle metodologie di analisi dei generi comunicativi.
Prerequisiti Un buon livello di competenza della lingua, conoscenza delle nozioni di base di analisi della lingua a livello sintattico, lessico-semantico e testuale.
Programma del corso
Modulo di comunicazione interculturalePartendo da una tassonomia sviluppata da Quirk nel 2003 che individua l’utilizzatore (user) e l’uso (use) come i due spartiacque per la definizione delle diverse varietà dell’inglese, si pren-deranno in esame le varietà prodotte da ciascun parlante e le si analizzeranno da un punto di vista linguistico. Successivamente ci si soffermerà sulla differenza tra varietà native e non-na-tive, considerate come performance varieties (Quirk, 1981). Nel tentativo di fornire una rispo-sta al quesito formulato da Kachru a proposito dell’esistenza di una codificazione a livello in-ternazionale di una lingua come l’inglese, che ha oltre 700 milioni di utilizzatori in tutto il mon-do, si prenderanno in esame le origini coloniali di EIL; il post-colonial English; e si metteranno a confronto diversi punti di vista, quali ad esempio quelli relativi all’heterogeny position vs. world Englishes.
Modulo di varietà della linguaNel modulo si tratteranno problemi legati alla variabilità della lingua in termini di use, conside-rando soprattutto le varietà occupazionali dell’inglese. Partendo dai problemi della comunica-zione interculturale, l’attenzione delle lezioni si concentrerà sulle nozioni di genere e registro, sulla loro definizione in diversi prospettive disciplinari e sull’analisi di casi specifici. Particolare attenzione verrà prestata allo studio di tipi e generi della comunicazione professionale. Si guarderà in specifico alla comunicazione esterna delle organizzazioni pubbliche e private, at-traverso una analisi della varietà delle sue forme. L’impatto della dimensione globale della co-
157
municazione verrà studiato a partire dall’analisi di siti web e della molteplicità di generi che li compongono, capaci di muovere dal discorso pubblicitario, a quello commerciale, finanziario e giuridico.
Testi di riferimento
Modulo di Comunicazione Interculturale:
• Bamford, J., Salvi, R. (2007), Business Discourse: Language at Work, Roma: Arac - ne Editore.
• Bondi, M, Maxwell, N. (eds.) Cross-cultural Encounters: Linguistic Perspectives, Roma, Officina, 2005.
• Brutt-Griffler, J. (2002), World English. A study of its Development., Clevedon, Buffa-lo, Toronto: Multilingual Matters.
• Burns and C. Coffin (eds.) (2001), Analysing English in a Global Context, New York, Routledge.
• D. Crystal (2002), The English Language, London: Penguin Books.• Garzone, G., Poncini, G., Catenaccio, P. (2007), Multimodality in Corporate Commu-
nication. Web genres and dicursive identity, Milano: Franco Angeli.• Mair (ed.) (2003), The Politics of English as a World Language, Amsterdam: Rodopi. • Pennycook (1994), The Cultural Politics of English as an International Language,
Edinburgh: Pearson Education Limited.
Modulo di Varietà della linguaI materiali per l’analisi, da utilizzare durante le lezioni, saranno resi disponibili all’inizio del cor-so.
● Bamford, J., Salvi, R. (2007), Business Discourse: Language at Work, Roma: Arac-ne Editore.
● F. Bargiela-Chiappini and S. Harris (1997), Managing Language. The discourse of corporate meetings, Amsterdam, Benjamins.
● F. Bargiela-Chiappini and C. Nickerson (1999), Writing Business. Genres, Media and Discourses, London, Longman.
● G.Cook (2001), Advertising Discourse, London, Routledge● Garzone, G., Poncini, G., Catenaccio, P. (2007), Multimodality in Corporate Commu-
nication. Web genres and dicursive identity, Milano: Franco Angeli.● J. Gibbons (ed. 1994),Language and the Law, London, Longman (part I e una scelta
fra II e III). ● Myers (1994), Words in ads, London, Arnold, 1994 ● C. Nickerson (2000), Playing the Corporate Language Game, Amsterdam, Rodopi. ● S. Niemeyer, C. Campbell, R.Dirven (eds. 1998) The Cultural Context in Business
communication, Amsterdam, Benjamins.● A. Trosborg (1997), Rhetorical Strategies in Legal Language, Tübingen, Narr.
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è considerata un presupposto della organizzazione didattica.
Programma per i non frequentantiGli studenti che non potessero frequentare il modulo di ‘Comunicazione Interculturale’ potran-no sostituire gli appunti delle lezioni con l’analisi di un testo a scelta tra quelli indicati in biblio-grafia.Gli studenti che non potessero frequentare il modulo di ‘Varietà della lingua’ potranno sostitui-re gli appunti delle lezioni con: V. Bhatia, Analysing Genre. Language Use in Professional Settings, London, Longman, 1993.
158
Modalità d’esameTutti gli studenti devono superare una prova scritta, che si svolgerà al termine del modulo di ‘Varietà della lingua’. In alternativa, è possibile sostituire la prova scritta con l’elaborazione di una tesina di analisi di un piccolo corpus, da concordare con una delle docenti, che sarà poi oggetto di discussione, in occasione dell’esame orale.Inoltre, per quanto riguarda il modulo di ‘Comunicazione interculturale’, tutti gli studenti, (sia frequentanti, sia non frequentanti) sono tenuti a prendere in esame il testo: M. Bondi, and Maxwell, N. (eds.) Cross-cultural Encounters: Linguistic Perspectives, Roma, Officina, 2005.Per quanto riguarda infine il modulo di ‘Varietà della lingua’, sussiste per tutti gli studenti, in-clusi i frequentanti, l’esigenza di portare un libro a scelta tra quelli indicati in bibliografia.
ValutazioneÈ ammesso a sostenere la prova orale chi ha superato la prova scritta riportando un voto di almeno diciotto/30. Il voto conseguito nella prova orale fa media col voto della prova scritta e costituisce il voto finale.
Comunicazione professionale scritta in italiano
Prof. Domenico Proietti8 CFU – 60 ore
Modulo di Laboratorio di scrittura in italiano
Obiettivi formativifornire agli studenti le nozioni scientifiche e tecnico-operative per la comprensione, l’analisi e la schematizzazione di testi (in particolare dei testi di studio), avviandoli alla redazione di testi argomentativi e saggi brevi, anche in prospettiva della stesura della dissertazione di laurea (specialistica).Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso sarà costituito da lezioni ed esercitazioni sul modo di leggere, riassumere e schema-tizzare testi di tipo saggistico e manualistico (abilità di lettura) e sul modo di stendere brevi saggi, relazioni, dissertazioni, ecc. (abilità di scrittura). Tali attività saranno affiancate e inte-grate da una serie di lezioni ed esercitazioni sulle strutture generali della lingua italiana, allo scopo di rinforzare le conoscenze di base nel campo della morfosintassi, dell’ortografia e del-la punteggiatura, e di fornire le cognizioni elementari sulla dimensione testuale della lingua e la tipologia dei testi. Alla parte teorica, in ogni incontro, seguirà una parte di esercitazione su testi forniti dal docente (inseriti anche nello spazio condiviso nel sito Internet di facoltà) e/o su materiali prodotti dagli studenti. Le 30 ore di corso sono così divise: 8 ore sulla lettura e le connesse operazioni di scrittura (glossa, parafrasi, riassunto, schema-tizzazione, riscrittura, scheda/recensione di testi); 10 ore sulla struttura del verbo e della frase, sulla tipologia dei testi (in partic. sui testi manua-listici, su testi saggistici e giornalistico-informativi), su altri aspetti del sistema linguistico e su-gli usi della punteggiatura: in questa parte del corso le “informazioni” e i “rafforzamenti” di lin-guistica prenderanno spunto dalle pratiche di lettura e scrittura già svolte nel Corso di laurea di base e dalle carenze emerse nell’esame della produzione scritta degli studenti; 10 ore: elaborazione di testi originali degli studenti;2 ore prova scritta finale del Laboratorio/Modulo.
Testi di riferimento● F. Sabatini, L’“italiano dell’uso medio”: una realtà tra le varietà linguistiche italiane , in
Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart , a cura di G. Holtus – E.
159
Radtke, Tübingen, Narr, 1985, pp. 154-184;● F. Sabatini, Lingua e comunicazione, in Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua ita-
liana. Guida all’uso del Dizionario, Milano, Rizzoli-Larousse, 2003, pp. 5-30 e 42-47;● F. Sabatini, Lettera sulla grammatica, in «La Cruscaper voi», 2004;● B. Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, Bari, Laterza, 2003.
N.B.: dei testi di Sabatini è stata depositata, a cura del docente, fotocopia presso l’Ufficio In-formazioni della Facoltà
FrequenzaIl Laboratorio/Modulo ha carattere pratico-applicativo, pertanto la frequenza è obbligatoria: saranno considerati frequentanti gli studenti che avranno partecipato ad almeno 11 dei 15 in-contri in cui il Laboratorio/Modulo è articolato.
Programma per i non frequentantiAgli studenti che non possono frequentare il corso è richiesto, oltre alla preparazione di quan-to indicato nel Programma per i frequentanti, lo studio dei seguenti testi:
● P. D’Achille, L’italiano contemporaneo , Bologna, Il Mulino, 2006, capp. 7 ( Sintassi , pp. 155-175) e 9 ( Le varietà scritte , pp. 203-223);
● F. Sabatini, Il traduttore e la dimensione testuale dell’italiano, in «Rivista di psicolin-guistica applicata», I (2001), pp. 111-132 (fotocopie fornite dal docente: in distribu-zione presso l’Ufficio Informazioni in Facoltà)
Modalità d’esameper i frequentanti: scritto e orale; per i non frequentanti: orale.
Valutazioneper lo scritto: correttezza e adeguatezza dell’elaborato alle richieste formulate nella traccia; per l’orale: grado di conoscenza, comprensione e capacità di esposizione-rielaborazione dei testi indicati nel programma.
Modulo di varietà della lingua
Obiettivi formativiFornire agli studenti le cognizioni e gli strumenti scientifici per analizzare e - almeno per alcu-ni tipi testuali della scrittura professionale - produrre esemplari dei diversi tipi di testo dell’ita-liano contemporaneo, mettendoli in condizione di riconoscerne i macrocaratteri comunicativi e le peculiarità linguistiche sulla base di una tipologia testuale.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoNei quindici incontri in cui si articola il corso la parte teorica sarà costantemente affiancata da esercitazioni su testi reali, secondo il seguente programma:
1. Introduzione: fondamenti della comunicazione; la comunicazione verbale; canali comunica-tivi (scritto, orale e trasmesso); grammatica e pragmatica; frase ed enunciato; contesto e si-tuazione; efficacia/felicità comunicativa; testualità e concetto di testo; caratteri del testo (inten-zionalità, accettabilità, informatività, situazionalità; intertestualità); unità, completezza, coeren-za e coesione; testo e tipi di testo; tipologie testuali (deduttive e induttive); testo e ricevente; una tipologia di testo basata sul vincolo posto al ricevente; 2. diversi tipi di testo e diversi usi della lingua; elementi essenziali della sintassi della frase; modello Tesnière-Sabatini e collocazione degli elementi informativi nella catena sintattico-te-
160
stuale; noto-nuovo e prospettiva informativa del testo; costruzioni marcate e non marcate;3. scritto e orale; lingua e variazione linguistica: le varietà del repertorio linguistico italiano; ita-liano standard e «italiano dell’uso medio» (o «substandard»); testi di italiano popolare; 4. principali fenomeni morfosintattici dell’«italiano dell’uso medio»; legamenti e sostituenti nel testo; i connettivi testuali: le «congiunzioni testuali» («elasticità» vs. «rigidità»);5. testi mediamente vincolanti e italiano dell’uso medio: la lingua dei giornali; tra lingua e codi-ce iconico: la titolistica; 6. diversi tipi di giornali e diverse pagine; fenomeni sintattico-stilistici e testuali nella lingua dei giornali; una tendenza recente: la «sintassi paratattizzata», tra testualità e iconicità;7. un linguaggio sincretico: la pubblicità tra lingua, immagine e suono; archeologia della lin-gua pubblicitaria; dall’advertising alla publicity; analisi di comunicati pubblicitari attuali;8. lingua e persuasione: la lingua della politica o dei politici; caratteri e strategie della comuni-cazione e del discorso politico;9. per una diacronia del discorso politico italiano da Mussolini alla «seconda Repubblica»: analisi di testi;10. il discorso e il testo saggistico tra dialogicità e persuasione; la prosa saggistica italiana dall’Ottocento al Novecento e la definizione dell’«italiano dell’uso medio»;11. la lingua «vincolata»: usi e generi testuali; nozione e forme della scrittura professionale;12. la lingua «vincolata»: la scrittura professionale aziendale: forme testuali e flussi comunica-tivi;13. la lingua «vincolata»: la scrittura burocratico-amministrativa;14 la lingua «vincolata»: la comunicazione pubblica e istituzionale; tentativi e direzioni di sem-plificazione della comunicazione pubblica e istituzionale;15. la lingua «vincolata»: i testi giuridici e il testo normativo.
Testi di riferimento(Per i frequentanti)
● F. Sabatini, Rigidità/esplicitezza vs. elasticità/implicitezza: possibili parametri massi-mi per una tipologia generale dei testi, in, Linguistica testuale comparativa. In me-moriam Maria-Elisabeth Conte, a cura di Gunver Skytte – Francesco Sabatini, Cope-naghen, Museum Tusculanum Press, 1999, pp. 141-172;
● F. Sabatini, Il traduttore e la dimensione testuale dell’italiano, in «Rivista di psicolin-guistica applicata», I (2001), pp. 111-132;
● D. Proietti, Saggio, in Le Muse. Dizionario enciclopedico, X, Novara, De Agostini, 2004, pp. 342-347.
● dal Manuale della comunicazione, a cura di S. Gensini, Roma, Carocci, 1999, i capi-toli:
● La comunicazione pubblica e istituzionale, di M.E. Piemontese, pp. 315-342; ● La comunicazione pubblicitaria, di F. Iannucci, pp. 363-389; ● La comunicazione politica, di P. Desideri, pp. 391-418;● da La lingua italiana e i mass media, a cura di I. Bonomi – A. Masini – S. Morgana,
Roma, Carocci, 2003, i capitoli:● La lingua dei quotidiani, di I. Bonomi, pp. 127-164;● La lingua della pubblicità, di R. Giacomelli, pp. 223-248;● dal Manuale di scrittura amministrativa (scaricabile in rete all’indirizzo: www.gover-
no.it/GovernoInforma/Dossier/manuale_scrittura), i capitoli:● La sintassi nei testi amministrativi, di S. Gigli, pp. 131-151;● Il rapporto tra testi legislativi e testi amministrativi, di S. Brunamonti, pp. 181-200;● C. Robustelli, La scrittura professionale, L’italiano professionale: linee di ricerca e
applicazioni didattiche’, in Uno sguardo alle lingue professionali. Atti del XII Incontro del Centro Linguistico dell’Università Bocconi (Milano, 8-11-2003), a cura di G. Belli-ni, L. Merlini, S. Vecchiato, Milano, Egea, 2005, pp. 183-195.
N.B.: dei testi dei punti 1,2, 3, 4, 5 e 7 può essere richiesta fotocopia presso l’Ufficio Informa-zioni in Facoltà.
161
FrequenzaFacoltativa, ma vivamente raccomandata, dato il carattere teorico-applicativo del Corso.
Programma per i non frequentantiAgli studenti che non possono frequentare il corso è richiesto, oltre alla preparazione di quan-to indicato nel Programma per i frequentanti, lo studio, a scelta, di uno dei seguenti testi:
● F. Bruni - S. Fornasiero - S. Tamiozzo Goldmann, Manuale di scrittura professionale, Bologna, Zanichelli, 1997;
● M.A. Cortelazzo - F. Pellegrino, Guida alla scrittura professionale, Roma-Bari, Later-za, 2003;
● T. Raso, La scrittura burocratica, Roma, Carocci, 2005;● S. Ondelli, La lingua del diritto, Trieste, Università degli Studi di Trieste, Centro lin-
guistico di Ateneo, 2005 (scaricabile in rete all’indirizzo: www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/983/1/La+lingua+del+diritto+-+On-delli.pdf)
Modalità d’esameOrale
ValutazioneGrado di conoscenza, comprensione e capacità di esposizione-rielaborazione dei testi indicati nel programma. Capacità di analizzare e commentare linguisticamente esempi di testi reali.
Comunicazione Web per le Organizzazioni (CWO)
Prof. Paolo Davoli8 CFU - 60 ore
Obiettivi formativiI sistemi di comunicazione delle organizzazioni devono oggi prevedere servizi informatici che ruotano attorno all’accesso e condivisione dell’informazione attraverso un uso sicure della rete e all’uso di sistemi di communitiy per lo scambio di informazioni ed esperienze. Il Web e la rete sono i fattori unificanti, ed hanno avuto una evoluzione da sistema di presen-tazione dell’attività attraverso un sito Web (sito vetrina) a sistemi per l’accesso ai beni e servi-zi delle organizzazioni, per passare poi alla fornitura di servizi di valore aggiunto strutturati in-torno alla rete e la creazione di comunità di utenti.Il corso si propone di fornire le competenze macro-tecnologiche e culturali per comprendere l’architettura dei servizi avanzati forniti oggi sui sistemi Web e sulla sicurezza delle informa-zioni aziendali. Si propone anche di fornire il supporto tecnico per comprendere le nuove sfide (cambiamento organizzativo, sicurezza delle informazioni e dell’organizzazione stessa) e nuove opportunità a cui le organizzazioni si trovano davanti. L’obiettivo del corso non è quindi quello di formare tecnici esperti nella disciplina informatica, ma di fare maturare la sensibilità necessaria per potere fornire un contributo di idee e di pro-gettazione, in un contesto di reciproche “contaminazioni” tra persone con competenze umani-stiche, organizzative, giuridiche, economiche, informatiche.
Prerequisiti Prerequisito del corso è che gli studenti possiedano le conoscenze di base di utilizzo del com-puter e di navigazione Internet.
Programma del corsoPRIMA PARTE Modulo 1. Architettura delle reti - Informatica distribuita, modello client-server. LAN e WAN,
162
protocolli, canali analogici e digitali, pacchetti, larghezza di banda. Compressione lossy e los-slessModulo 2. Architettura di Internet – Protocolli TCP e IP. Indirizzi IP e routing. IP privati e dina-mici. DNS. Gli strumenti organizzativi di Internet e standardizzazioni. Il software open sourceModulo 3. I servizi di Internet – Il Web come “killer application”. Struttura di un documento HTML, tag e attributi principali. Retorica e servizi dei portali. Posta e newsgroups. Autentica-zioni LDAP e uso di Moodle.
SECONDA PARTE Modulo 4. Tecnologie standard del Web. Fogli di stile, da HTML a XML. Modulo 5. Ipertesti, sviluppo storico e problematiche. Usabilità dei siti Web: pagine, contenu-to, navigazione. Internazionalizzazione. Accessibilità e normative collegate. Sviluppo e ge-stione di un sito Web. Modulo 6. Sistemi informativi delle organizzazioni. ERP, DSS, CRM. Sicurezza e gestione della privacy e DPS. Disponibilità dei dati. Confidenzialità e autenticità. Crittografia, firma digi-tale, protocolli per la sicurezza. Codice maligno, network security. Pubblica amministrazione digitale. Elementi di diritto dell’informatica.
Testi di riferimento● Dispense del docente e link a risorse in rete disponibili sul portale di e-learning
http://dolly.lettere.unimo.it● Lorenzi. Informatica: sistemi operativi e reti per il sistema informativo aziendale -
Atlas● Calvo, Ciotti, Roncaglia, Zela: Internet 2004, Laterza, disponibile free su www.later-
za.it/internet/leggi/internet2004/online/● Jakob Nielsen - Designing Web Usability: The Practice of Simplicity - New Riders
(ed. it. Apogeo)● Guide disponibili on line su HTML: http://www.html.it/
FrequenzaLa frequenza è fortemente consigliata. Gli studenti non frequentanti trovano sul portale ad ac-cesso riservato tutte le lezioni ed i compiti assegnati, insieme ad eventuali indicazioni specifi-che (dolly.lettere.unimore.it).Programma per i non frequentantiLo stesso dei frequentanti
Modalità d’esameL’esame finale consisterà in un test scritto, a domande chiuse ed aperte. Per sostenere l’esa-me si dovranno produrre materiali intermedi attraverso la piattaforma di e-learning dolly.lette-re.unimore.it (in caso contrario il voto finale potrà essere penalizzato di uno o due punti).
ValutazioneVerrà valutato l'esito del test ed i materiali intermedi prodotti.
Corso di formazione per gli utenti della Biblioteca Umanistica
Prof.ssa Ombretta Malavasi – Prof. Gianluca TosettoCFU 2 – 18 ore
“Biblioteca: fonti di informazione e strategie di ricerca bibliografica”
Modulo 1: La biblioteca come struttura organizzata Obiettivi formativiIl modulo intende permettere allo studente di orientarsi nell’utilizzo dei servizi offerti dalla Bi-
163
blioteca Umanistica. Abilità e conoscenze da valorizzare: fruizione dei servizi bibliotecari, uti-lizzo del Catalogo di Ateneo Programma del modulo1° Lezione: come è organizzata la Biblioteca Umanistica (regolamenti, servizi, ecc.) cosa si trova nella Biblioteca Umanisticadescrizione e distinzione delle tipologie di risorse: monografie, periodici, risorse elettroniche 2° Lezione: sistema Bibliotecario di Ateneo (Sba) e Biblioteche del territoriola ricerca sul Catalogo dello SBA Esercitazioni Modulo 2: La ricerca di informazione elettronica Obiettivi formativi Il modulo si propone di fornire le conoscenze e le abilità tecniche necessarie per individuare l’informazione desiderata attraverso l’utilizzo degli strumenti di rete.Abilità e conoscenze da valorizzare: conoscenza dei metodi di interrogazione; elaborazione di una strategia di ricerca; conoscenza dei motori di ricerca. Programma del modulo3° Lezione: elaborazione di una strategia di ricerca (parole chiave, termini correlati, scelta del-le fonti) e linguaggi di interrogazione (operatori booleani, di troncamento e altri accorgimenti)motori di ricerca, metamotori e indici sistematici4° Lezione: valutazione delle fonti di informazione online gratuiteEsercitazioni Modulo 3: l’informazione elettronica per gli specifici ambiti disciplinari della Facoltà di Lettere e Filosofia Obiettivi formativiIl modulo affronta l’analisi delle risorse elettroniche di interesse per gli ambiti disciplinari ine-renti la Facoltà di Lettere e Filosofia. Abilità e conoscenze da valorizzare: conoscenza ed uti-lizzo mirato delle principali risorse elettroniche in rete specificatamente relative alle discipline oggetto di studio e ricerca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.
Programma del modulo5° Lezione: Banche dati: online e off-line 6° Lezione: Esercitazioni sull’utilizzo delle Banche dati7° Lezione: Periodici cartacei ed elettronici: ricerca nel Catalogo d’Ateneo e ACNPEsercitazioni 8° Lezione: Periodici elettronici: ricerca nel Catalogo SBAEsercitazioni
Modulo 4: Norme essenziali per la stesura di relazioni e tesi Obiettivi formativiTrasmettere allo studente che deve redigere una relazione o la tesi di laurea le principali re-gole per la redazione dei testi. Abilità e conoscenze da valorizzare: conoscenza delle tecni-che di redazione del testo, delle strategie di ricerca e delle regole per la citazione bibliografi-ca.Programma del modulo9° Lezione: Strategia di lavoro per la stesura della tesi di laureaRedazione di citazioni, note e bibliografia
Testi di riferimentoAll’inizio del Corso verrà comunicata la bibliografia.Durante lo svolgimento dei Moduli saranno disponibili delle dispense.
Modalità d’esame
164
Prova finale
Diritto delle organizzazioni internazionali
Prof.ssa Ivana Palandri8 CFU – 60 ore
Obiettivi formativiIl corso di Diritto delle organizzazioni internazionali si prefigge lo scopo di approfondire il feno-meno, crescente ed ormai diffuso a livello mondiale e regionale, del governo multilaterale me-diante la costituzione di organizzazioni internazionali. A tal fine saranno analizzate, seppure in modo non esaustivo, le principali organizzazioni internazionali, il perché della loro istituzio-ne, la loro struttura ed il loro funzionamento. Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoInquadramento giuridico delle organizzazioni internazionali nell’ambito del diritto internaziona-le convenzionale – Le organizzazioni quali soggetti secondari di diritto internazionale – Strut-tura “classica” delle organizzazioni internazionali – Le organizzazioni internazionali a caratte-re universale: l’ONU; il Fondo Monetario Internazionale; l’Organizzazione Mondiale del Com-mercio; l’Organizzazione Internazionale del Lavoro – Le organizzazioni a carattere regionale: l’Unione Europea; il Consiglio d’Europa; l’Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa; la NATO – I Gruppi di Stati, in particolare il ruolo del G7/G8.
Testi di riferimento● Rossi Lucia Serena (a cura di), Le organizzazioni internazionali come strumenti di
governo multilaterale, Milano, Giuffrè, 2006 (esclusi i capitoli da pagina 165 a 190; 259 a 284; 385 a 464).
FrequenzaLa frequenza al corso è facoltativa.
Modalità d’esamePer gli studenti frequentanti l’esame consisterà nella redazione di un elaborato scritto su uno degli argomenti trattati durante il corso.Per gli studenti non frequentanti l’esame sarà orale sugli argomenti trattati nel testo di riferi-mento.
ValutazioneLa valutazione sarà fatta in gran parte sulle conoscenze dello studente, ma si terrà conto an-che delle sue capacità critiche, in particolare alla luce degli eventi internazionali in atto.
Diritto privato comparato – Diritto ed economia delle organizzazioni private
Prof. Marcello Stalteri8 CFU - 60 ore
Obiettivi formativi Lo studente che aspiri a diventare imprenditore, o ad inserirsi dentro una società commerciale già avviata, o che immagini di dedicare la dovuta attenzione al settore non profit, dovrebbe essere nelle condizioni di filtrare lucidamente la nozione di rischio economico e giuridico, per poter accedere al mondo imprenditoriale con maggiore consapevolezza. Lo studio delle orga-
165
nizzazioni private operanti sul mercato (anche in chiave non profit), l’analisi dei loro metodi di governance, i profili dell’impatto che le regole possono avere sui rispettivi risultati, costituiran-no – in chiave inter-disciplinare – il nucleo centrale del corso.Partendo dall’esperienza italiana, verranno dedicati alcuni accenni sul piano della compara-zione ai più rilevanti modelli contemporanei, in particolare agli Stati Uniti.Inoltre, poiché l’impresa multinazionale è divenuta un fondamentale pilastro del tessuto socia-le ed economico contemporaneo, auspicio del docente è quello di dedicare particolare atten-zione ai temi collegati a tale figura, tra cui quello della cd. responsabilità sociale, divenuti par-te integrante della moderna comunicazione d’impresa.Alla luce del complessità della materia e della necessità di formare lo studente anche attra-verso una lettura guidata di norme e testi, è tassativamente obbligatoria la costante frequen-za.Ai non frequentanti è riservato invece un programma alternativo e più accessibile, vertente sull’impresa non profit in chiave di comparazione giuridica ed economica. Chi intenda inserirsi nel cd. Terzo Settore, pur senza aver frequentato in precedenza corsi specializzati, troverà utile approfondire fisionomia e struttura di tale complessa categoria giuridica ed economica. A tale scopo, dopo una parte iniziale di inquadramento teorico, lo studente sarà invitato ad esaminare da vicino il modello inglese delle charities, tra i più antichi ed avanzati tra quelli oggi conosciuti nel mondo del non profit.
PrerequisitiFerme restando le classiche propedeuticità, non è obbligatorio aver sostenuto l’esame di Si-stemi Giuridici Comparati. Sul piano didattico, la prima settimana di lezioni si concentrerà a tal proposito sui rudimenti della comparazione giuridica.
Programma del corso - Introduzione alla comparazione ed ai sistemi giuridici. Cenni sull’analisi economica del dirit-to.- La nozione di impresa e di società nel diritto italiano ed europeo contemporaneo.- L’impresa ed il ruolo degli investitori. La teoria contrattuale del contratto societario- Tipologie societarie e problemi di governance- L’impresa ed il ruolo dei lavoratori. - Cenni sulle società cooperative- L’impresa/ente non profit: natura e disciplina (cenni)- Responsabilità sociale dell’impresa
Testi di riferimento● H.HANSMANN, La proprietà dell’impresa, Bologna, Il Mulino, 2005, pp.1-157, 207-
269● Codice Civile Italiano, lettura ragionata di norme selezionate● Cap.I del volume V.VARANO.V.BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale, Tori-
no, Giappichelli, ult. ed., relativamente alla parte introduttiva al corso, Cap.I., esclusi i materiali
● Materiali integrativi forniti di volta in volta dal docentePer facilitare lo studio della disciplina del diritto societario e d’impresa in Italia, nel corso delle lezioni verrà suggerita allo studente la lettura di parti scelte di un aggiornato manuale di diritto commerciale/societario.
Programma per i non frequentanti- Storia dello sviluppo del non profit e del cd.Terzo settore- Definizione della categoria giuridica del non profit assistito nel common law- Le tipologie di enti non profit nell’ordinamento giuridico inglese- Profili gius-economici in tema di amministrazione degli enti non profit- I controlli amministrativi. La Charity Commission- Il fund-raising. Inquadramento economico, disciplina giuridica.
166
-Cenni sull’ordinamento italianoPer i non frequentanti che intendano approfondire lo studio dell’impresa non profit:
● Cap.I del citato volume V.VARANO-V.BARSOTTI, La tradizione giuridica occidenta-le, Torino, Giappichelli, ult.ed., per la parte introduttiva del corso, Cap.I, esclusi i ma-teriali
● M.STALTERI, Enti Non Profit e Tutela della Fiducia, Torino, Giappichelli, 2002● Manoscritto di aggiornamento in fase di preparazione da parte del docente
Modalità d’esameL’esame si svolgerà in forma orale per i frequentanti e non, con programmi dai contenuti di-versi a seconda della frequenza o meno delle lezioni svolte dal docente.Programma di studio per i frequentanti:
Economia applicata e Processi di Internazionalizzazione delle Imprese
Prof. Paolo Panico8 CFU - 60 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di fornire gli strumenti conoscitivi per la comprensione dei principali feno-meni economici internazionali. A questo fine, l’attenzione non è tanto concentrata su nozioni di teoria economica, bensì sull’approccio economico all’analisi della realtà (la cosiddetta “eco-nomic way of thinking”).Dopo una parte generale, il corso si sofferma su approfondimenti monografici relativi alle va-riabili rilevanti nei processi di internazionalizzazione delle imprese, prendendo in considera-zione sia la dimensione socio-culturale sia quella istituzionale e giuridica, lette sempre attra-verso il prisma dell’analisi economica.In vista della rilevanza della dimensione internazionale dei mercati finanziari, uno specifico modulo approfondisce i principali strumenti finanziari e le loro dinamiche.
Prerequisiti Non sono richiesti prerequisiti formali
Programma del corso e Testi di riferimentoParte I –Economia Applicata (strumenti e concetti di analisi economica)
Mercato, equilibrio ed efficienza● L. A. Franzoni, Introduzione all’economia del diritto, Bologna, 2003, cap. I “Mercato
ed efficienza”
Diritti di proprietà e sviluppo economico● L. A. Franzoni (op. cit.), cap. II “Teorie economiche della proprietà”● W. J. Bernstein, The Birth of Plenty, New York, 2004, cap. 2 “Property”● J. E. Stiglitz, Globalization and it Discontents, Londra, 2002, cap. 5 “Who lost Rus-
sia?” (lettura consigliata)● H. de Soto, The Mystery of Capital, Basic Books, 2000, cap. 1 “The Five Mysteries
of Capital” (lettura consigliata)
Istituzioni finanziarie internazionali e misure di politica economica● J. E. Stiglitz (op. cit.), cap. 1 “The promise of global institutions”● J. E. Stiglitz (op. cit.), cap. 3 “Freedom to choose?” (lettura consigliata)● O. J. Blanchard, Macroeconomics, Upper Saddle Row, NJ, 1997, cap. 26 “Transition
in Eastern Europe” (lettura consigliata)● P. Krugman, “The Myth of Asia’s Miracle”, Foreign Affairs, November/December
167
1994 (lettura consigliata)
Parte II – Imprese e finanza in un contesto globalizzato
Teorie economiche dell’impresa; lettura di un bilancio● L. A. Franzoni (op. cit.), cap. VI “L’impresa”● M. Parkinson – D. Jones, Diploma in International Trust Management (Trust Admin-
istration and Accounts), Birmingham, 2005, Module 4 (passim)
Strumenti e mercati finanziari● W. J. Bernstein, The Birth of Plenty, New York, 2004, cap. 4 “Capital”● The STEP Guide to Trusts and Investments, London, 2006, Ch. 2.1. “The role of act-
ive asset allocation”● The STEP Guide to Trusts and Investments, London, 2006, Ch. 2.2. “Stocks ● The STEP Guide to Trusts and Investments, London, 2006, Ch. 2.3. “Bonds”
Assetti proprietari, corporate governance e finanza● L. A. Franzoni (op. cit.), cap. VII “Diritto e finanza”● “Asterix and the old allergy to the market”, Financial Times, 16 April 2007● P. Panico, I nuovi modelli di corporate govenance, Milano, 2004, cap. 1.1, 1.2,
1.3.2., 1.4, 1.5
Principi generali di tassazione● M. Parkinson, Diploma in International Trust Management (Company Law and Prac-
tice), Birmingham, 2004, Appendix 4 “General Principles of Taxation”
Islamic banking● M. Umer Chapra,”Il sistema bancario islamico: un modello alternativo per l’interme-
diazione finanziaria”, relazione presentata in occasione del Convegno “Le Banche islamiche”, Roma, 19 dicembre 2002
● A El-Ashker, The Islamic Business Enterprise, London, 1999, Ch. 3 “Foundations of Islamic Economics” (lettura consigliata)
Il trust● M. Lupoi, Trust interni e negozi di affidamento fiduciario, testo in corso di elaborazio-
ne, cap. I “I dati introduttivi”, cap. X “Specifiche applicazioni italiane”, Excursus I “La Convenzione de L’Aja e i trust interni in Italia”, Excursus III “I trust sham”
● P. Panico, I nuovi modelli di corporate govenance, Milano, 2004, cap. 2.1
FrequenzaFacoltativa
Programma per i non frequentantiLe letture consigliate sono obbligatorie per i non frequentanti, in quanto suppliscono ad approfondimenti e collegamenti presentati a lezione.
Modalità d’esameColloquio orale.
ValutazioneIn base all’esito del colloquio sulle diverse parti del programma.
Geografia economico-politica e del Turismo
Prof.ssa Anna Maria Sala
168
8 CFU - 60 ore
Modulo di geografia economico-politica
Obiettivi formativiIl corso si propone di considerare lo spazio geoeconomico e la sua dicontinuità , in particolare di quello industriale, quale effetto delle scelte localizzative prodotte dalla globalizzazione.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso intende fornire gli strumenti di analisi geografica a scala regionale e locale per focaliz-zare le problematiche inerenti le aree deboli o marginali per le quali sovente si parla di ri/va-lorizzazione territoriale . Particolare attenzione sarà rivolta ai contesti rurali e montani le cui caratteristiche di marginalità stimolano interventi mirati all’innesco di processi di recupero de-mografico ed economico mediante l’inserimento di attività agri-turistiche.
Testi di riferimento● Bencardino F., Prezioso M., Geografia economica, Milano, McGraw-Hill, 2006.
FrequenzaAlmeno il 50% delle lezioni
Programma per i non frequentantiUna lettura aggiuntiva da concordare col Docente
Modalità d’esameScritto
Modulo di geografia del turismo
Obiettivi formativiIl corso si propone di fornire le conoscenze di base per comprendere l'evoluzione del fenome-no turistico, un'attività che presenta forti valenze economiche, ma che appare sempre piu' connessa alla percezione personale e collettiva del tempo e luogo del non-lavoro. Alla lettura delle caratteristiche tipologiche con le quali si esprime l'offerta, sarà affiancata quindi l'analisi delle motivazioni che inducono la domanda di spazi turistici in quanto e' sotto questo aspetto che possono essere interpretate le politiche di settore intraprese a livello nazionale ed inter-nazionale.
Prerequisiti Aver sostenuto un esame di Geografia nel triennio
Programma del corsoIl concetto di risorsa turistica; turismo e loisir; i luoghi e le tipologie dell'offerta consolidate e nuove forme di turismo; le motivazioni economiche, sociali e psicologiche sottese alla doman-da; il ruolo dei trasporti nella determinazione dei flussi nazionali ed internazionali; gli effetti territoriali delle politiche turistiche ; i sistemi locali turistici e loro individuazioneIl turismo come consumo dello spazio; il turismo sostenibile quale strumento di valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale e culturale; la promozione turistica
Testi di riferimento● Bagnoli Lorenzo, Manuale di geografia del turismo, UTET, 2006
169
FrequenzaAlmeno il 70% delle lezioni
Programma per i non frequentantiUna lettura aggiuntiva da concordare col Docente
Modalità d’esameEsame scritto
Mediazione e Trattativa – Lingua francese
Prof. Aleardo Tridimonti8 CFU - 60 ore
Mutuato da: Progettazione e gestione di attività culturali
Obiettivi formativiPerfezionamento della capacità di comprensione, sintesi e riformulazione di eventi o scambi comunicativi orali e scritti dal francese verso l’italiano e dall’italiano verso il francese di diffi-coltà crescente.Progressivo approccio ai linguaggi settoriali (turismo, import-export, gestione eventi culturali). Pratica della mediazione scritta durante ateliers di scrittura, di trattamento testi, di traduzio-ne.Pratica della mediazione orale attraverso esercitazioni che preparano alla formulazione con-secutiva verso l’italiano e il francese, nonché alla formulazione simultanea verso l’italiano.Potenziamento della capacità di elaborare in maniera autonoma un'architettura dinamica delle conoscenze.- Conoscenza delle regole etiche, comportamentali e tecniche di un mediatore linguistico.
A scanso di ogni equivoco,lo scopo di questo corso non è quello di formare dei traduttori o degli interpreti. Per queste figure professionali, esistono altre sedi altamente qualificate. Agli studenti che frequentano il nostro corso, vorremmo non solo fornire quegli strumenti e quei contenuti che consentono loro di sviluppare ulteriormente le conoscenze culturali e linguisti-che sia orali che scritte, attive e passive da e verso il francese che già possiedono, ma anche far loro acquisire alcune competenze funzionali all’attività di mediazione interlinguistica, spen-dibili in vari ambiti.Per fare questo, ricorreremo ad alcune attività e strategie in uso per la formazione dei tradut-tori e degli interpreti perché le riteniamo adatte ed efficaci non solo per l’arricchimento delle abilità linguistiche di studenti a livello di specialistica, ma anche per una effettiva operatività in campo lavorativo.
Prerequisiti possedere una solida base culturale e linguistica (italiano e francese);possedere, in lingua francese, sicure competenze linguistico-culturali orali e scritte (pari al li-vello C1 o C2 del Common European Framework of Reference).
Programma del corso Il corso si articola in due moduli:
a) Modulo scritto: le esercitazioni si svolgono in laboratorio di informatica.Uso delle risorse della rete per la comunicazione e la gestione dell’informazione: impostazio-ne di una ricerca documentaria mirata ed efficace; uso dei corpora paralleli; dizionari, glossa-ri, banche terminologiche on-line; acquisizione di lessico tecnico specifico con elaborazione di glossari funzionali nelle due lingue. Avviamento al trattamento verso il francese, di alcune ti-pologie di testi scritti e alla traduzione di documenti di natura commerciale, turistica, culturale,
170
riguardanti scambi situazionali di comunicazione riguardanti gli ambiti di cui sopra.
b)Modulo orale: le esercitazioni si svolgono in laboratorio di lingue.Potenziamento delle capacità di attenzione, di concentrazione, di memorizzazione e di comu-nicazione interpersonale. Padronanza di una efficace tecnica della presa di appunti. Capacità di preparare un’attività di mediazione e trattativa su una tematica specifica: approfondimento delle conoscenze sull’argomento con elaborazione di una rete o mappa concettuale; capacità di gestire un evento comunicativo simulando una situazione di mediazione linguistica in simul-tanea e/o consecutiva; abilità del parlare in pubblico e capacità di trasmettere con rigore, pre-cisione e naturalezza messaggi via via più complessi nel pieno rispetto del registro e della specificità del lessico.
Considerata la sua particolare finalità, il corso si svolge, a seconda della situazione, sia in lin-gua francese che in lingua italiana.
Testi di riferimento● Josiane Podeur: La pratica della traduzione: dal francese in italiano, dall’italiano in
francese, Napoli, Liguori, 1993Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite dal docente durante il corso.
FrequenzaLa partecipazione alle lezioni non è da intendersi come mero assolvimento di un obbligo for-male, ma risulterà essenziale in vista delle finalità formative del corso e dell’esame previsto. Le lezioni sono delle esercitazioni pratiche o “ateliers” che si svolgono alternativamente in la-boratorio di informatica (per consultazione, ricerca documentaria e terminologica, corpora pa-ralleli, attività scritte) e in laboratorio linguistico per la parte orale.
Programma per i non frequentantiTrattandosi di esercitazioni in laboratorio, è difficile programmare attività per non frequentanti.
Modalità d’esame(con riserva di modifica che verrà comunicata in itinere): - una prova scritta in francese (in laboratorio informatica, con possibilità di sfruttare tutte le ri-sorse fornite dalla rete), riguardante un evento o scambio comunicativo trattato durante il cor-so (a partire da precise consegne, redazione di un documento in lingua: rapporto, sintesi, in-formativa, traduzione …- una prova di mediazione/interpretazione simultanea orale (in laboratorio linguistico), dal francese verso l’italiano di un evento o scambio comunicativo trattato durante il corso; una prova di mediazione/interpretazione consecutiva orale (in laboratorio linguistico), dall’ita-liano verso il francese, a partire da appunti presi durante l’ascolto di un evento o scambio co-municativo pre-registrato e trattato durante il corso.
ValutazionePer ogni candidato, la scheda di valutazione delle sue prove comporta le seguenti voci:Per la parte scritta: correttezza formale, coesione, contenuto, pertinenza, efficacia della pro-duzione secondo le consegne fornite;Per la parte orale: a) francese - italiano: capacità di concentrarsi, di seguire il ritmo della fonte emittente, di memorizzarne il contenuto, di restituirlo in l’italiano, nonché di gestire la comunicazione. livello di completezza, chiarezza, precisione dell’informazione ed efficacia della riformulazio-ne.proprietà di linguaggio; pertinenza del lessico; correttezza della costruzione; adeguatezza del-lo stile; coesione.
b) italiano-francese:
171
qualità dell’esposizione; capacità di gestire la comunicazione; naturalezza e “fluency”.contenuti; capacità di sintesi; completezza e chiarezza; efficacia dell’informazione.proprietà di linguaggio; pertinenza del lessico; correttezza della costruzione; adeguatezza dello stile; coesione.pronuncia.
N.B: La prova scritta è propedeutica all’orale. Pertanto, per essere ammessi a sostenere le prove orali, occorre aver conseguito una valutazione minima di 18/30 allo scritto.
Mediazione e Trattativa – Lingua inglese
Prof.ssa Laura Gavioli8 CFU - 60 ore
Mutuato da: Progettazione e gestione di attività culturali
Obiettivi formativiIl corso di mediazione inglese intende sviluppare una capacità avanzata di interazione in si-tuazioni che richiedono la conoscenza dell’inglese e dell’italiano e di mediazione di rapporti cross-culturali in ambiti aziendali e istituzionali. Ha inoltre i seguenti obiettivi:Migliorare le capacità d’uso della lingua orale e della partecipazione al parlato;Promuovere una capacità di osservazione delle dinamiche del parlato in modo da rendersi conto di strategie comunicative di parlanti di diversi background culturali;Migliorare la consapevolezza delle dinamiche interazionali della conversazione e della costru-zione congiunta dei ruoli personali, professionali e culturali dei partecipanti all’interazione;Promuovere una consapevolezza di differenze culturali e dinamiche linguistiche che permet-tano di facilitare la comunicazione fra culture diverse in interazioni istituzionali di diverso tipo (di affari, presso servizi sociali, ecc.)Riflettere sulle caratteristiche dell’inglese usato in ambito internazionale.
Prerequisiti Si consiglia di avere sostenuto l’esame di inglese del primo anno e la certificazione C1 (o pari livello) per la lingua inglese prima dell’esame
Programma del corsoIl corso si concentra su alcuni concetti dell’Analisi della Conversazione e delle strategie di-scorsive che possano servire a chiarire l’idea del parlato come interazione fra i partecipanti. Si focalizza sulle dinamiche che emergono in interazioni di tipo istituzionale o aziendale e mo-stra come tali dinamiche tengano conto non solo del messaggio da trasmettere, ma anche dei ruoli istituzionale e/o personali dei partecipanti. Si discute il ruolo dell’interprete-mediatore non solo legato alla sua funzione di traduttore, ma anche alla funzione di coordinatore dell’in-contro e di partecipante all’interazione e si nota come tale partecipazione possa avere valen-ze importanti nell'interazione cross-culturale. In particolare si intende sottolineare il modo in cui il parlato (conversazionale o meno) si verifica come co-gestione dei partecipanti all’intera-zione e come continua negoziazione.La didattica mira a far raggiungere gli obiettivi proposti attraverso una partecipazione attiva degli studenti alle attività proposte. Da un punto di vista metodologico, si integrano attività vol-te a sviluppare capacità operative nella lingua attraverso la creazione di situazioni comunicati-ve, ad attività volte a sviluppare consapevolezza linguistica e capacità critiche attraverso una riflessione sulla lingua e sulla cultura. Un ruolo importante assume anche la dimensione del-l'apprendere ad apprendere e dello sviluppo della capacità di formazione autonoma. Un ruolo altrettanto importante avrà la riflessione sulla propria produzione verbale.L'esame si articola in due parti: una prova in laboratorio di ascolto e traduzione orale di un te-sto le cui caratteristiche verranno definite nel corso delle lezioni e un colloquio che compren-derà un’analisi di una conversazione registrata e trascritta e una discussione della bibliogra-
172
fia.
Testi di riferimentoGli studenti devono mostrare di conoscere i seguenti testi (reperibili presso la biblioteca):
● Hutchby, I. and R. Wooffitt 1998. Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press.● Mason, I. 1999. Dialogue Interpreting. Manchester: St. Jerome.
Devono inoltre scegliere di discutere 2 dei testi elencati qui sotto (e contenuti in questa di-spensa) illustrando i punti principali sulla base di analisi di trascrizioni (distribuite a lezione, ri-portate nelle letture o raccolte individualmente dagli studenti)
● Bolden, G. 2000. “Toward understanding practices of medical interpreters’ involve-ment in history taking”. Discourse Studies 2/4: 387-419.
● Cronin, M. 2002. “The empire talks back: orality, heteronomy and the cultural turn in interpreting studies. In F. Pöchhacker and M. Schlesinger (eds) The Interpreting studies reader. London/ New York: Routledge. 386-397.
● Davidson, B. 2000. “The interpreter as an institutional gatekeeper: The social-lin-guistic role of interpreters in Spanish-English medical discourse. Journal of Sociolin-guistics 4/3: 379-405.
● Gavioli, L. and N. Maxwell, in stampa. Interpreter intervention in mediated business talk. H. Bowls and P. Seedhouse (eds.) Conversation and ESP. Peter Lang.
● Mason, I. 2006. On mutual accessibility of contextual assumptions in dialogue inter-preting. Journal of Pragmatics, 38. 359-373.
● Mulholland, J. 1997. “The Asian connection: business requests and acknowledg-ments”. In F. Bargiela and S. Harris (eds) The languages of business. Edinburgh: Edinburgh University Press. 94-114.
● Roy, C. 1993/2002. “The problem with definitions, descriptions and the role meta-phors of interpreters”. In F. Pöchhacker and M. Schlesinger (eds) The Interpreting studies reader. London/ New York: Routledge. 344-353.
● Wadensjö, C. 1993/2002. “The double role of a dialogue interpreter”. In In F. Pöch-hacker and M. Schlesinger (eds) The Interpreting studies reader. London/ New York: Routledge. 354-371.
FrequenzaLa frequenza è data per presupposta. Sono considerati studenti frequentanti coloro che han-no seguito indicativamente almeno il 75% delle lezioni
Programma per i non frequentantiGli studenti devono mostrare di conoscere i seguenti testi (reperibili presso la biblioteca):
● Hutchby, I. and R. Wooffitt 1998. Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press.● Mason, I. 1999. Dialogue Interpreting. Manchester: St. Jerome.
Devono inoltre preparare i seguenti saggi con l’esclusione di:- studenti di Comunicazione nell’Impresa e nelle Organizzazioni Internazionali:Bolden 2000- studenti di Progettazione e Gestione di Attività CulturaliMulholland 1997
● Bolden, G. 2000. “Toward understanding practices of medical interpreters’ involve-ment in history taking”. Discourse Studies 2/4: 387-419.
● Cronin, M. 2002. “The empire talks back: orality, heteronomy and the cultural turn in interpreting studies. In F. Pöchhacker and M. Schlesinger (eds) The Interpreting studies reader. London/ New York: Routledge. 386-397.
● Davidson, B. 2000. “The interpreter as an institutional gatekeeper: The social-lin-
173
guistic role of interpreters in Spanish-English medical discourse. Journal of Sociolin-guistics 4/3: 379-405.
● Gavioli, L. and N. Maxwell, in stampa. Interpreter intervention in mediated business talk. H. Bowls and P. Seedhouse (eds.) Conversation and ESP. Peter Lang.
● Mason, I. 2006. On mutual accessibility of contextual assumptions in dialogue inter-preting. Journal of Pragmatics, 38. 359-373.
● Mulholland, J. 1997. “The Asian connection: business requests and acknowledg-ments”. In F. Bargiela and S. Harris (eds) The languages of business. Edinburgh: Edinburgh University Press. 94-114.
● Roy, C. 1993/2002. “The problem with definitions, descriptions and the role meta-phors of interpreters”. In F. Pöchhacker and M. Schlesinger (eds) The Interpreting studies reader. London/ New York: Routledge. 344-353.
● Wadensjö, C. 1993/2002. “The double role of a dialogue interpreter”. In In F. Pöch-hacker and M. Schlesinger (eds) The Interpreting studies reader. London/ New York: Routledge. 354-371.
Modalità d’esameprova di traduzione orale (in laboratorio) e colloquio
ValutazioneLa valutazione si basa sulle prove previste per l’esame. Tutte le prove devono essere suffi-cienti per contribuire alla valutazione.
Mediazione e Trattativa – Lingua spagnola
Docente da definire8 CFU - 60 ore
Mutuato da: Progettazione e gestione di attività culturali
Obiettivi formativiL'obiettivo del corso è collegare operativamente le competenze ottenute nella lingua straniera e nella lingua madre, collocando le conoscenze acquisite in un contesto comunicativo, di me-diazione linguistica e culturale, specificamente orientato all’interpretazione di trattativa/comu-nità e alla sottotitolazione. Programma del corsoModulo 1 (30 ore): Il mestiere di sottotitolareDopo un excursus sulla traduzione audiovisiva in Italia e il preponderante utilizzo della moda-lità traduttiva del doppiaggio, verranno introdotte problematiche traduttologiche relative al pro-cesso di sottotitolazione, sia in termini teorici che pratici. Il corso sarà affiancato da momenti di attività pratica di sottotitolazione su testi audiovisivi di diverso genere.
Modulo 2 (30 ore): Introduzione all’interpretazione di trattativa/comunità In questo modulo verrà fornito un quadro storico-culturale relativo al settore e alla sua orga-nizzazione professionale e verrà favorita l'acquisizione di microabilità fondamentali per l'inter-pretazione di trattativa. Si porrà inoltre l'accento sul ruolo comunicativo dell'interprete come operatore sociale e come mediatore in vari settori della cultura, nelle istituzioni internazionali e nelle imprese. Le esercitazioni prevedono l'analisi e il riconoscimento delle diverse tipologie testuali, la tra-duzione a vista, la memorizzazione, il riassunto e la parafrasi; prevedono inoltre la rielaborazione ora-le di brevi testi scritti con cenni sulla presa di note, esposizioni libere e preparate, per passare successivamente all'assistenza linguistica e all'interpretazione di trattativa vera e propria, con la compresenza di interlocutori italofoni e ispanofoni.
174
Testi di riferimento● Baigorri Jalón, J., La interpretación de conferencias: el nacimiento de una profesión.
De París a ● Nuremberg. Granada, Comares, 2000 ● Collados Aís, A.; Fernández Sánchez, M. (a cura di), Manual de interpretación
bilateral, Editorial ● Comares, 2001 ● Kelly, D. (ed.), La traducción y la interpretación en España hoy: perspectivas
profesionales, ● Granada, Editorial Comares, 2000 ● Russo, M.; Mack, G. (a cura di), Interpretazione di trattativa, Hoepli, 2005
Ulteriore materiale verrà fornito agli studenti durante le lezioni.
FrequenzaAltamente consigliata. Gli studenti non frequentanti sono pregati di contattare i docenti.
Modalità d’esamePer il modulo 1: tesina e discussione dell’elaboratoPer il modulo 2: una breve simulazione di interpretazione dialogica
ValutazioneLa valutazione verterà sulla prova d’esame e sulla tesina.
Mediazione e trattativa - Lingua tedesca
Prof.ssa Antonie Hornung8 CFU - 60 ore
Mutuato da: Progettazione e gestione di attività culturali
Obiettivi formativiConoscere i concetti chiavi della mediazione nonché le teorie attualmente in discussione nei paesi di lingua tedesca; conoscere gli ambiti nei quali si pratica la mediazione e il linguaggio specifico; essere in grado di analizzare i testi specialistici e di tradurrli adequatamente in ita-liano.
Prerequisiti Livello B2 o più alto in tedesco
Programma del corsoIl corso si terrà in tedesco. Verranno usato diversi metodi di insegnamento in aula per coinvol-gere gli studenti nella discussione. Si studieranno testi specialistici sull'argomento della me-diazione selezionati con particolare riferimento al rispettivo lessico, la terminologia e la fra-seologia. L'analisi dei testi affronterà la questione della traduzione prendendo in considerazio-ne il livello macro, meso e micro dei testi nonché la loro specificità culturale. Si eserciteranno inoltre diverse metodologie di mediazione per approfondire le competenze linguistiche orali.
Testi di riferimentoIndirizzi internet rilevanti:
Zur Einführung in den Begriff:http://de.wikipedia.org/wiki/Mediation
175
Homepage des "Bundesverband Mediation":http://www.bmev.de/www/(La rivista del "Bundesverband Mediation" è a disposizione in biblioteca)
"Interkulturelle Mediation":http://www.bmev.de/www/documents/mediation-interkulturell.pdf
Libri e saggi:● Altmann, Gerhard/Fiebiger, Heinrich/Müller, Rolf (1999): Mediation. Konfliktmanage-
ment für moderne Unternehmen. Weinheim/Basel: Beltz.● Besemer, Christoph (1993): Mediation. Vermittlung in Konflikten. Königsfeld/Heidel-
berg/Freiburg: Stiftung Gewaltfreies Leben/Werkstatt für Gewaltfreie Aktion, Baden.● Breidenbach, Stephan (1995): Mediation. Struktur, Chancen und Risiken von Ver-
mittlung im Konflikt. Köln: Schmidt● Geißler, Peter (Hrsg.) (2000): Mediation - die neue Streitkultur. Kooperatives Kon-
fliktmanagement in der Praxis. Gießen: Psychosozial-Verlag.● Klammer, Gerda (Hrsg.) (1999): Mediation. Einblicke in Theorie und Praxis profes-
sioneller Konfliktregelung. Wien: Falter. EUV: 321/PG 470 K63.● Ladmiral, Jean-René (2000): Interkulturelle Kommunikation: Zur Dynamik mehrspra-
chiger Gruppen. Frankfurt am Main: Edmond Marc Lipiansky.● Liebe, Frank/Haumersen, Petra (1998): "Interkulturelle Mediation. Empirisch-analyti-
sche Annäherung an die Bedeutung von kulturellen Unterschieden". In: Breidenstein, L./Kiesel, D./Walther, J. (Hrsg.): Migration, Konflikt und Mediation. Zum interkulturel-len Diskurs in der Jugendarbeit. Frankfurt/Main: Haag und Herder: 135-155.
● Luchtenberg, Sigrid (1999): Interkulturelle Kommunikative Kompetenz: Kommunikati-onsfelder in Schule und Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag.
● Müller-Jacquier, Bernd/ten Thije, Jan D. (2000): "Interkulturelle Kommunikation: in-terkulturelles Training und Mediation". In: Becker-Mrotzek, Michael/Brünner, Gisela/Cölfen, Hermann (Hrsg.): Linguistische Berufe. Ein Ratgeber zu aktuellen lin-guistischen Berufsfeldern. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York, Ox-ford, Wien: Lang: 39-59.
● Schramkowski, Barbara (2001): Interkulturelle Mediation: Mediation als eine Metho-de des konstruktiven Umgangs mit interkulturellen Konflikten in Städten mit hohem multikulturellen Bevölkerungsanteil. Konstanz: Hartung-Gorre.
FrequenzaE' richiesta la frequenza per approfondire le competenze linguistiche.
Programma per i non frequentantiNessuno
Modalità d’esameScritto: Tesina Orale: Discussione della tesina
ValutazioneVoto sulla tesina (contenuto, struttura, linguaggio e livello di competenza linguistica) + voto sulla discussione (argomentazione e livello di competenza linguistica)
Organizzazione delle Aziende e delle Amministrazioni
Prof. Alberto Gozzi6 CFU - 60 ore
176
Obiettivi formativiModalità didattiche: lezioni ed esercitazioni, oltre che a carattere teorico, avranno contenuto eminentemente pratico e pertanto faranno riferimento a casi aziendali concreti, con supporti visivi riepilogativi.Moduli formativi. Casi pratici / conferenze: Strategie di internazionalizzazione d'impresa italia-na - Organizzazione di rete commerciale internazionale - Declino, riposizionamento e rilancio organizzativo - Comportamenti organizzativi e interpretazione dei fermenti evolutivi della so-cietà.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoLe lezioni procedono in termini problematici sui seguenti argomenti:Evoluzione storica della progettazione organizzativa - Organizzazione come Agente Economi-co - Scientific management, direzione amministrativa, leadership e motivazione, teoria contin-gente, learning organization - Struttura organizzativa tra risorse umane e risorse naturali, bi-sogni collettivi e servizi pubblici, attività reali e attività finanziarie - Organizzazione tra settore d'appartenenza e valore aggiunto - Configurazione organizzativa: nucleo operativo, tecno-struttura, staff di supporto, vertice strategico, linea intermedia - Organizzazione come sistema aperto - Interazione con l'ambiente esterno: trasformazioni e adattabilità delle organizzazioni - Eco-ambiente organizzativo tra competizione e collaborazione - Modelli input-output e moni-toraggio dei confini - Amministrazioni pubbliche e organizzazione dei servizi - Macro e micro ambienti di riferimento - Dal villaggio al villaggio globale, dalla economy alla new-economy, dal saper fare alle competenze - Dimensioni strutturali: formalizzazione, specializzazione, ge-rarchia, centralizzazione, professionalità, indicatori del personale - Dimensioni contestuali: tecnologia, strategia, dimensione, ambiente, cultura - Organizzazione internazionale e rela-zioni interpersonali - Vulnerabilità delle organizzazioni - Le attuali sfide basate su motivazio-ne, etica, responsabilità sociale - Organizzazioni tra cultura aziendale e ambiente globale.
Testi di riferimentoPer gli studenti frequentanti, che baseranno la loro preparazione sugli appunti delle lezioni, al-cuni argomenti aggiuntivi d'esame nonché gli eventuali capitoli di alcuni testi consigliati a le-zione ai quali fare maggiore riferimento, saranno definiti direttamente con il docente al termi-ne del corso.
● G. COSTA, P. GUBITTA, Organizzazione aziendale. Mercati, gerarchie, convenzio-ni, McGraw-Hill, Milano 2004
FrequenzaRaccomandata
Programma per i non frequentantiLibro di testo da concordare con il docente
Modalità d’esameColloquio orale
Teoria e metodi del dialogo e della mediazione
Prof. Claudio Baraldi4 CFU - 40 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di fornire le competenze teoriche e pratiche per (1) la progettazione, (2) la metodologia di realizzazione e (3) l’analisi valutativa di interventi dialogici e di mediazione,
177
realizzati in organizzazioni complesse (come scuole, organizzazioni per la cooperazione, coo-perative, associazioni, imprese, organizzazioni internazionali) e su uno specifico territorio (in paesi europei o in aree nelle quali si richiede cooperazione per lo sviluppo), con particolare ri-ferimento alla dimensione interculturale.Il corso mira a fornire competenze di ricerca e competenze professionali utili per l’inserimento in équipe di progettazione ed intervento dialogico e di mediazione, con particolare riferimento alle relazioni interculturali, in Italia, in Europa ed in Paesi extra-europei.
PrerequisitiNessuno
Programma del corsoIl corso è mutuato da Scienze della Cultura. Il primo modulo (20 ore) tratta il tema della pro-gettazione e della realizzazione di interventi dialogici e di mediazione: in particolare, vengono illustrate le componenti metodologiche delle “buone pratiche” di progettazione e di intervento, confrontando diversi approcci teorici e metodologici. Il secondo modulo (10 ore) è dedicato alle metodologie e alle tecniche di osservazione e di analisi valutativa dei processi e dei risul-tati degli interventi. Il terzo modulo (30 ore) presenta una serie di casi specifici di analisi del dialogo e della mediazione e consente di confrontare pratiche diverse, con particolare riferi-mento all’ambito interculturale (la frequenza di questo terzo modulo è opzionale per studen-tesse e studenti di Comunicazione nell’impresa e nelle organizzazioni internazionali). Saran-no presentati materiali sui temi fondamentali del corso, introducendo e commentando espe-rienze di progettazione ed intervento interculturale in Italia (educazione interculturale, mediazione linguistico-culturale, educazione alla pace) e nelle aree di cooperazione e nego-ziazione internazionali (in particolare, Organizzazioni non Governative per lo Sviluppo e Na-zioni Unite). Nel complesso, il corso intende articolare concetti teorici ed analisi di esperienze empiriche, discutendo metodi e strumenti per realizzare progetti, interventi ed analisi valutati-ve. Il corso può essere raccordato allo svolgimento di tirocini proposti dal docente (secondo un programma che sarà illustrato all’inizio delle lezioni), oppure suggeriti dagli studenti.
Programma per frequentanti È possibile scegliere parti del programma di Scienze della cultura (concordate a lezione con il docente):
● Lorenzo Luatti (a cura di), Atlante della mediazione linguistico-culturale, FrancoAn-geli, Milano, 2006.
● C. Baraldi (a cura di), Il dialogo in classe, Donzelli, Roma, 2007
In alternativa è possibile scegliere un programma specifico per Comunicazione nell’impresa e nelle organizzazioni internazionali, scegliendo parti dei seguenti testi e saggi (concordate a lezione con il docente):
● L. Samovar, R. Porter e E. McDaniel, Intercultural Communication. A Reader, Wadsworth Publishing Company, Belmont.
● M. Guirdham, Communicating across cultures at work, Macmillan, London.● H. Gallestrup, The Complexity of Intercultural Communication in Cross-Cultural
Management, in Intercultural Communication, n. 6, 2002: 1-19● F. Bargiela-Chiappini & C. Nickerson, Intercultural Business Communication: A Rich
Field of Studies, in Journal of Intercultural Studies, 24/1, 2003: 3-15Frequenza In base alla normativa stabilita dalla Facoltà, coloro che si dichiarano non frequentanti o che comunque non raggiungono la quota del 75% delle frequenze delle lezioni, dovranno portare un programma aggiuntivo.
Programma per non frequentanti● M. Guirdham, Communicating across cultures at work, Macmillan, London.
178
● L. Samovar, R. Porter e E. McDaniel, Intercultural Communication. A Reader, Wadsworth Publishing Company, Belmont (Parti 1, 6, 7).
● H. Gallestrup, The Complexity of Intercultural Communication in Cross-Cultural Management, in Intercultural Communication, n. 6, 2002: 1-19
● F. Bargiela-Chiappini & C. Nickerson, Intercultural Business Communication: A Rich Field of Studies, in Journal of Intercultural Studies, 24/1, 2003: 3-15
Modalità d’esame Per l’esame finale, sono disponibili due opzioni: 1) esame orale; 2) relazione (tra i 20.000 ed i 30.000 caratteri a stampa) contenente un’analisi valutativa di un progetto o di un intervento di mediazione, sulla base di testi e materiali concordati con il docente.
179
Laurea Magistrale in Progettazione e Ge-stione di Attività Culturali
Analisi dei generi comunicativi – Lingua francese
Prof.ssa Chiara PreiteCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiIl corso mira all’approfondimento della variazione diafasica in francese, con particolare atten-zione alle varietà specialistiche dei tipi di discorso giuridico e giudiziario, politico ed economi-co. Dopo un’introduzione relativa alle caratteristiche delle langues spécialisées e della loro terminologia, il corso si incentra sull’analisi delle peculiarità testuali che contraddistinguono di-versi generi comunicativi.Prerequisiti Il corso si svolge il lingua francese.
Programma del corsoLa riflessione teorica legata allo studio delle tipologie dei generi testuali ci condurrà alla pre-sentazione di una griglia di analisi su più livelli, che troverà applicazione pratica nella presa in esame di svariati generi specialistici. A tal fine, un dossier composto da testi originali tratti da fonti diverse (in particolare facenti capo a diverse langues spécialisées di cui verranno pre-sentate le caratteristiche terminologiche) sarà messo a disposizione degli studenti. L’analisi prenderà le mosse da un livello macrotestuale (riconoscimento delle tipologie prototipiche dei testi), per passare poi ad un livello microtestuale in cui verranno prese in considerazione le strategie linguistiche finalizzate ad assicurare coerenza e coesione ai testi, le teorie dell’enun-ciazione e della polifonia, e l’argomentazione nel discorso.
Testi di riferimento● Un dossier sarà messo a disposizione degli studenti all’inizio del corso.● MAINGUENEAU D., Analyser les textes de communication, Nathan, Paris 2000.● LERAT P., Les langues spécialisées, Paris, PUF, 1995.
NB: La bibliografia potrebbe essere oggetto di modifiche, la versione definitiva sarà comun-que inserita nel dossier.
FrequenzaLa frequenza è considerata fondamentale; gli studenti impossibilitati a frequentare un ade-guato numero di lezioni (75%) dovranno integrare il programma.Il corso ufficiale sarà completato da un ciclo di esercitazioni tenuto da collaboratrici di madre lingua. Per un iter formativo completo ne è fortemente consigliata la frequenza.
Programma per i non frequentantiIntegrazione del programma con la lettura dei seguenti volumi:
● PREITE C., Langage du droit et linguistique. Étude de l’organisation textuelle, énonciative et argumentative des arrêts de la Cour (et du Tribunal) de Justice des Communautés européennes, Aracne, Roma, 2005. (Chap. 2 pp. 83-111; Chap. 3 pp. 113-139 – 153-176; Chap. 4 pp. 227-260.
● PAISSA P., “L’analisi del testo come prassi metodologica di convergenza tra didattica della lingua e della civiltà, linguistica e letteratura francese”, in AA.VV., Prospettive della francesistica nel nuovo assetto della didattica universitaria, Atti del XXIV Con-vegno internazionale SUSLLF, Napoli-Pozzuoli 13-14 ottobre 2000, pp. 137-167.
Modalità d’esame
180
Gli esami si svolgeranno in francese.- Esame scritto: analisi di un testo specialistico secondo le modalità apprese durante il corso. L’esame scritto potrà essere sostituito dalla redazione di una tesina in cui si analizzi un picco-lo corpus relativo ad un genere testuale specialistico (da concordare con il docente).
- Esame orale: discussione sull’esame scritto/tesina e colloquio sui contenuti del corso.
ValutazioneLa valutazione in trentesimi si basa sui voti ottenuti all’esame scritto e al colloquio.
Analisi di tipi e generi comunicativi – Lingua inglese
prof.ssa Marina BondiCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiIl corso intende sviluppare negli studenti capacità di analisi del rapporto tra scelta linguistica e varietà funzionali della lingua, attraverso una esplorazione delle nozioni di genere e di registro in una varietà di testi in inglese. In particolare, il corso si propone di: Condurre lo studente all’acquisizione di un elevato grado di competenza linguistica pratica, in cui sia rispettato l’equilibrio fra le abilità di comprensione e di produzione, con particolare rife-rimento alle abilità scritte. Promuovere l’acquisizione di strumenti di analisi delle pratiche linguistiche che favoriscano la formazione continua, anche in contesti professionali, attraverso la riflessione sulla lingua e sulle metodologie di analisi dei generi comunicativi.Prerequisiti
Il corso presuppone un buon livello di competenza della lingua e una adeguata conoscenza di strumenti di analisi lessico-sintattica, lessico-semantica e testuale.
Programma del corsoIl corso tratterà problemi legati alla variabilità della lingua inglese, considerando soprattutto le forme della promozione e della comunicazione di istituzioni culturali Partendo dalla nozione di genere e registro e dalla loro definizione in diverse prospettive disciplinari, si passerà all’anali-si di casi specifici. Particolare attenzione verrà prestata allo studio di tipi e generi della comu-nicazione esterna nel campo dei musei e dei teatri. Partendo dalla analisi di siti web artistici e teatrali -e della varietà di forme discorsive che manifestano - il corso guarderà in particolare alla possibilità di individuare le caratteristiche tanto del linguaggio quanto di alcuni generi ca-ratteristici del discorso artistico e di quello teatrale: dalla pubblicità, alla promozione, alla pre-sentazione di mostre o programmi, ai comunicati stampa e alle recensioni.
Testi di riferimentoOpzione arti visive e recensioni
● Radighieri, S. (2007) AR as a genre? A multi-layered approach. In: Describing, Ex-plaining and Evaluating in the Art Review: A genre-based analysis.(Chapter 4, pp. 75-118) PhD dissertation.
● Suárez-Tejerina, L. (2005) Is evaluation structure-bound? An English-Spanish study of book reviews. – In: E. Tognini-Bonelli and G. Del Lungo Camiciotti Strategies in Academic Discourse, 117-132. Benjamins: Amsterdam.
● Römer, U. (2005a) “This seems somewhat counterintuitive, though…”. Negative evaluation in linguistic book reviews by male and female authors. − In: E. Tognini-Bonelli and G. Del Lungo Camiciotti (ed.) Strategies in Academic Discourse, 97-116. Amsterdam: Benjamins.
● Kathpalia, S. S. (1997) Cross-cultural variation in professional of book blurbs. – World Englishes, 16, 3: 417-426.
181
● Bergesen, A. J. (2000) A linguistic model of art history. – Poetics, 28: 73-90.● Tucker, P. (2003) Evaluation in the art-historical research article. – Journal of Eng-
lish for Academic Purposes, 2: 291-312.● Caballero, R. (2003) Metaphor and genre: The presence and role of metaphor in the
building review. – Applied Linguistics, 24, 2: 145-167. ● Gaut, B. (1997) Metaphor and the understanding of art. – Proceedings of the Aris-
totelian Society, 97, 3: 223-241. ● Baxandall, M. (1985) Patterns of Intentions. On the historical explanation of pictures.
– Yale University Press: New Haven, London. (pp. 1-11)● Barnet, S. (2003, 7th ed.) A Short Guide to Writing about Art. – Longman: New York.
(pp. 115-152)● Eerdmans, S. (2003) Sharing an experience: Claude Monet’s Bathers at la Gren-
ouillère. In: P. Nobili (ed.) Camminare per quadri. Clueb: Bologna. (pp. 109-120)● Acton, M. (1997) Learning to Look at Paintings. Routledge: NY, London. (pp. 1-24)
Opzione scrittura web e comunicati stampa● M.Boardmann (2005), The language of websites, London: Routledge (pp.117)● Posteguillo, S. (2002), Netlinguistics and English for Internet purposes, Ibérica, 4,
21-38.● Maat, H. P. (2007), How Promotional Language in Press Releases Is Dealt With by
Journalists: Genre Mixing or Genre Conflict?, Journal of Business Communication, 44; 1, 59-95.
● Lassen, I. (2006). Is the press release a genre? A study of form and content. Dis-course Studies, 2006, 8, 4, Aug, 8(4), 503-530.
● Sleurs, K., Jacobs, G., & Van Waes, L. (2003). Constructing press releases, con-structing quotations: A case study. Journal of Sociolinguistics, 2003, 7, 2, May, 7(2), 192-212.
● Sleurs, K., & Jacobs, G. (2005). Beyond preformulation: An ethnographic perspect-ive on press releases. Journal of Pragmatics, 2005, 37, 8, Aug, 37(8), 1251-1273.
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è considerata un presupposto della organizzazione didattica. Si con-sidera frequentante chi ha partecipato almeno al 75% delle lezioni.
Programma per i non frequentantiGli studenti che non potessero frequentare potranno sostituire gli appunti delle lezioni con:
● V. Bhatia, Analysing Genre. Language Use in Professional Settings, London, Long-man, 1993. A questo aggiungeranno, per un approfondimento, le letture indicate come opzione B.
Modalità d’esameTutti gli studenti devono superare una prova scritta. La prova consiste in un “cloze test” e una analisi di un brano (del tipo di quelli analizzati a lezione). E’ possibile sostituire la prova scritta con l’elaborazione di una tesina di analisi di un piccolo corpus, da concordare con la docente, che sarà poi oggetto di discussione, in occasione dell’esame orale. All’esame orale gli stu-denti porteranno anche una discussione dei temi trattati nel corso e le proprie riflessioni sulle letture di approfondimento (opzioni A e B).
ValutazioneE’ ammesso a sostenere la prova orale chi ha superato la prova scritta riportando un voto di almeno diciotto/30. Il voto conseguito nella prova orale fa media col voto della prova scritta e costituisce il voto finale.
182
Analisi di tipi e generi comunicativi – Italiano
Prof. Domenico ProiettiCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiFornire agli studenti le cognizioni e gli strumenti scientifici per analizzare e - almeno per alcu-ni tipi testuali della scrittura professionale - produrre esemplari dei diversi tipi di testo dell’ita-liano contemporaneo, mettendoli in condizione di riconoscerne i macrocaratteri comunicativi e le peculiarità linguistiche sulla base di una tipologia testuale.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoNei quindici incontri in cui si articola il corso la parte teorica sarà costantemente affiancata da esercitazioni su testi reali, secondo il seguente programma:
1. Introduzione: fondamenti della comunicazione; la comunicazione verbale; canali comunica-tivi (scritto, orale e trasmesso); grammatica e pragmatica; frase ed enunciato; contesto e si-tuazione; efficacia/felicità comunicativa; testualità e concetto di testo; caratteri del testo (inten-zionalità, accettabilità, informatività, situazionalità; intertestualità); unità, completezza, coeren-za e coesione; testo e tipi di testo; tipologie testuali (deduttive e induttive); testo e ricevente; una tipologia di testo basata sul vincolo posto al ricevente; 2. diversi tipi di testo e diversi usi della lingua; elementi essenziali della sintassi della frase; modello Tesnière-Sabatini e collocazione degli elementi informativi nella catena sintattico-te-stuale; noto-nuovo e prospettiva informativa del testo; costruzioni marcate e non marcate;3. scritto e orale; lingua e variazione linguistica: le varietà del repertorio linguistico italiano; ita-liano standard e «italiano dell’uso medio» (o «substandard»); testi di italiano popolare; 4. principali fenomeni morfosintattici dell’«italiano dell’uso medio»; legamenti e sostituenti nel testo; i connettivi testuali: le «congiunzioni testuali» («elasticità» vs. «rigidità»);5. testi mediamente vincolanti e italiano dell’uso medio: la lingua dei giornali; tra lingua e codi-ce iconico: la titolistica; 6. diversi tipi di giornali e diverse pagine; fenomeni sintattico-stilistici e testuali nella lingua dei giornali; una tendenza recente: la «sintassi paratattizzata», tra testualità e iconicità;7. un linguaggio sincretico: la pubblicità tra lingua, immagine e suono; archeologia della lin-gua pubblicitaria; dall’advertising alla publicity; analisi di comunicati pubblicitari attuali;8. lingua e persuasione: la lingua della politica o dei politici; caratteri e strategie della comuni-cazione e del discorso politico;9. per una diacronia del discorso politico italiano da Mussolini alla «seconda Repubblica»: analisi di testi;10. il discorso e il testo saggistico tra dialogicità e persuasione; la prosa saggistica italiana dall’Ottocento al Novecento e la definizione dell’«italiano dell’uso medio»;11. la lingua «vincolata»: usi e generi testuali; nozione e forme della scrittura professionale;12. la lingua «vincolata»: la scrittura professionale aziendale: forme testuali e flussi comunica-tivi;13. la lingua «vincolata»: la scrittura burocratico-amministrativa;14 la lingua «vincolata»: la comunicazione pubblica e istituzionale; tentativi e direzioni di sem-plificazione della comunicazione pubblica e istituzionale;15. la lingua «vincolata»: i testi giuridici e il testo normativo.
Testi di riferimentoPer i frequentanti:
● F. Sabatini, Rigidità/esplicitezza vs. elasticità/implicitezza: possibili parametri massi-mi per una tipologia generale dei testi, in, Linguistica testuale comparativa. In me-moriam Maria-Elisabeth Conte, a cura di Gunver Skytte – Francesco Sabatini, Cope-
183
naghen, Museum Tusculanum Press, 1999, pp. 141-172;● F. Sabatini, Il traduttore e la dimensione testuale dell’italiano, in «Rivista di psicolin-
guistica applicata», I (2001), pp. 111-132;● D. Proietti, Saggio, in Le Muse. Dizionario enciclopedico, X, Novara, De Agostini,
2004, pp. 342-347.● dal Manuale della comunicazione, a cura di S. Gensini, Roma, Carocci, 1999, i capi-
toli: ● La comunicazione pubblica e istituzionale, di M.E. Piemontese, pp. 315-342;● La comunicazione pubblicitaria, di F. Iannucci, pp. 363-389; ● La comunicazione politica, di P. Desideri, pp. 391-418;● da La lingua italiana e i mass media, a cura di I. Bonomi – A. Masini – S. Morgana,
Roma, Carocci, 2003, i capitoli:● La lingua dei quotidiani, di I. Bonomi, pp. 127-164;● La lingua della pubblicità, di R. Giacomelli, pp. 223-248;● dal Manuale di scrittura amministrativa (scaricabile in rete all’indirizzo: www.gover-
no.it/GovernoInforma/Dossier/manuale_scrittura), i capitoli:● La sintassi nei testi amministrativi, di S. Gigli, pp. 131-151;● Il rapporto tra testi legislativi e testi amministrativi, di S. Brunamonti, pp. 181-200;● C. Robustelli, La scrittura professionale, L’italiano professionale: linee di ricerca e
applicazioni didattiche’, in Uno sguardo alle lingue professionali. Atti del XII Incontro del Centro Linguistico dell’Università Bocconi (Milano, 8-11-2003), a cura di G. Belli-ni, L. Merlini, S. Vecchiato, Milano, Egea, 2005, pp. 183-195.
N.B.: dei testi dei punti 1,2, 3, 4, 5 e 7 può essere richiesta fotocopia presso l’Ufficio Informa-zioni in Facoltà
FrequenzaFacoltativa, ma vivamente raccomandata, dato il carattere teorico-applicativo del Corso. Si considera frequentante chi ha partecipato almeno al 75% delle lezioni.
Programma per i non frequentantiAgli studenti che non possono frequentare il corso è richiesto, oltre alla preparazione di quan-to indicato nel Programma per i frequentanti, lo studio, a scelta, di uno dei seguenti testi:
● F. Bruni - S. Fornasiero - S. Tamiozzo Goldmann, Manuale di scrittura professionale, Bologna, Zanichelli, 1997;
● M.A. Cortelazzo - F. Pellegrino, Guida alla scrittura professionale, Roma-Bari, Later-za, 2003;
● T. Raso, La scrittura burocratica, Roma, Carocci, 2005;● S. Ondelli, La lingua del diritto, Trieste, Università degli Studi di Trieste, Centro lin-
guistico di Ateneo, 2005 (scaricabile in rete all’indirizzo: www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/983/1/La+lingua+del+diritto+-+On-delli.pdf)
Modalità d’esameOrale
ValutazioneGrado di conoscenza, comprensione e capacità di esposizione-rielaborazione dei testi indicati nel programma. Capacità di analizzare e commentare linguisticamente esempi di testi reali.
184
Analisi dei generi e tipi testuali e Modulo di comunicazione interculturale – Lingua Spagnola
Prof. Marco CipolloniCFU 4 + 4 – 30 + 30 ore
“Buñuel, Almodóvar y los “Otros”: identità e sistema dei generi nel cinema spagnolo, dal surrealismo alla pop art”
Programma del corsoIl corso, partendo dalla presenza di echi buñueliani nei film di Almodóvar, analizza i muta-menti di prospettiva che, nel sistema dei generi del cinema spagnolo, ha caratterizzato il gio-co, l’uso e il riciclo degli stereotipi identitari.
Testi di riferimento
● Isabel Santaolalla, Los “Otros”: Etnicidad y “raza” en el cine español contemporá-neo, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.
● AAVV, Cartapacio: Buñuel en Almodóvar, in “Turia”, 76, febrero 2006, pp. 161-277.● Barry Jordan & Rikki Morgan-Tamosunas, Contemporary Spanish Cinema,
Manchester University Press, 1998.● Maurizio Fantoni Minnella, Trasgressione e Hispanidad. Il cinema di Pedro Almodó-
var, Tarab, Firenze, 1998.
Ulteriori indicazioni, bibliografiche e filmografiche, verranno fornite durante il corso.
Analisi dei generi comunicativi - lingua tedesca
Prof.ssa Antonie HornungCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiConoscere alcuni modelli di comunicazione ed essere in grado di adoperarli per l'analisi di di-versi generi comunicativi, ad es. dei siti WEB con particolare riferimento alle diversità culturali tedesco-italiani.
Prerequisiti Livello di tedesco B2/C1
Programma del corsoIl modello "organon" di Karl Bühler - analisi della comunicazione nei contesti istituzionaliLa contestualizzazione della comunicazione secondo R. Jakobson - analisi della comunica-zione medialeL'uso legittimo della lingua - Pierre Bourdieu - analisi della comunicazione nei contesti di for-mazione
Testi di riferimento● Auer, Peter (1999): Sprachliche Interaktion. eine Einführung anhand von 22 Klassi-
kern. Tübingen, Niemeyer. (Ne sono presenti in biblioteca 3 esemplari.)● Bühler, Karl (1992). Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache.
Stuttgart/New York: Fischer.● Bourdieu, Pierre (1982; dt. 1990): Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachli-
chen Tausches. Aus dem Französischen von Hella Beister. – Wien: Braumüller.
185
● Jakobson, Roman (1974): Form und Sinn. Sprachwissenschaftliche Betrachtungen. Wilhelm Fink Verlag, München.
● Jakobson, Roman (2005):Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921-1971.(Hrg. von Elmar Holenstein und Tarcisius Schelbert). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
FrequenzaE' richiesta la frequenza di almeno il 75% delle lezioni.
Modalità d’esamescritto: Verbale di una lezioneorale: Presentazione orale (al minimo 10 minuti) di un'analisi contrastiva di due siti WEB ba-sata su una delle teorie discusse
ValutazioneIl voto finale si compone dai voti per il verbale, la presentazione e il lettorato.
Comunicazione Interculturale – Lingua francese
Prof.ssa Chiara PreiteCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiLa riflessione mira a mettere in rilievo le sfaccettature delle realtà insite nei concetti di civiltà e di intercultura, per giungere successivamente alla presa di coscienza delle problematiche le-gate alla comunicazione tra culture diverse, e alle molteplici varietà linguistiche frutto dell’in-contro di culture della francofonia, nonché all’analisi delle varietà sociali che compongono la lingua francese dell’Esagono. L’attenzione si concentrerà infine sui parler giovanili (argot, ver-lan, ecc.) e sul franglais o frenglish.
Prerequisiti Il corso si svolge il lingua francese.
Programma del corsoIl corso vuole mettere in evidenza le ricadute linguistiche del contatto culturale che si produce non solo a livello “interculturale”, ma anche nell’ambito della francofonia e all’interno dello stesso francese di Francia. La riflessione, accompagnata da una serie di testi originali tratti da fonti diverse, che mettono in luce elementi legati alla variazione linguistica e culturale, segue quindi un percorso che, partendo dall’analisi della comunicazione interculturale tra gruppi di etnia e lingua differente, si sofferma poi sull’“utopia” del francese standard, sulla variazione linguistica diatopica della francofonia, per concludersi con l’analisi delle variazione diastratica e diafasica in Francia.
Testi di riferimento● Un dossier sarà messo a disposizione degli studenti all’inizio del corso.● DE CARLO M., L’interculturel, Cle International, Paris 1998.● GADET F., La variation sociale en français, Ophrys, Paris 2003 (chap. 4-5-6)● MERLE P., Argot, verlan et tchatches,Milan eds. «Essentiels Milan», Toulouse,
nouvelle éd. 2006.
NB: La bibliografia potrebbe essere oggetto di modifiche, la versione definitiva sarà comun-que inserita nel dossier.
FrequenzaLa frequenza è considerata fondamentale; gli studenti impossibilitati a frequentare un ade-guato numero di lezioni (75%) dovranno integrare il programma.
186
Il corso ufficiale sarà completato da un ciclo di esercitazioni tenuto da collaboratrici di madre lingua. Per un iter formativo completo ne è fortemente consigliata la frequenza.
Programma per i non frequentantiIntegrazione del programma con la lettura di tre articoli (da concordare con il docente) conte-nuti nel seguente volume:
● PAULIN C. (dir.), Multiculturalisme, multilinguisme et milieu urbain, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2005.
Modalità d’esameL’esame consiste in un colloquio orale in francese sui contenuti del corso.
ValutazioneLa valutazione in trentesimi si basa sui voti ottenuti a colloquio.
Comunicazione interculturale – Lingua inglese
Prof.ssa Franca PoppiCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiIl corso prende in esame il fenomeno denominato EIL (English as an International Language), cercando di mettere in luce i modi e le modalità in base alle quali l’inglese è stato adattato lo-calmente e istituzionalizzato così da dare vita a differenti varietà o Englishes, nel tentativo di verificare se e in quale misura è possibile parlare di ‘nuove’ norme relative alla performance. In particolare, le lezioni si propongono di fornire spunti per una discussione critica in merito alle conseguenze della sempre più rapida diffusione dell’inglese come lingua per la comuni-cazione interculturale ed internazionale. Prerequisiti “Nessuno”
Programma del corsoPartendo da una tassonomia sviluppata da Quirk nel 2003 che individua l’utilizzatore (user) e l’uso (use) come i due spartiacque per la definizione delle diverse varietà dell’inglese, si pren-deranno in esame le varietà prodotte da ciascun parlante e le si analizzeranno da un punto di vista linguistico. Successivamente ci si soffermerà sulla differenza tra varietà native e non-na-tive, considerate come performance varieties (Quirk, 1981). Nel tentativo di fornire una rispo-sta al quesito formulato da Kachru a proposito dell’esistenza di una codificazione a livello in-ternazionale di una lingua come l’inglese, che ha oltre 700 milioni di utilizzatori in tutto il mon-do, si prenderanno in esame le origini coloniali di EIL; il post-colonial English; e si metteranno a confronto diversi punti di vista, quali ad esempio quelli relativi all’heterogeny position vs. world Englishes.
Testi di riferimento● Burns and C. Coffin (eds.) (2001), Analysing English in a Global Context, New York,
Routledge.● D. Crystal (2002), The English Language, London: Penguin Books.● Mair (ed.) (2003), The Politics of English as a World Language, Amsterdam: Rodopi. ● M. Bondi, and Maxwell, N. (eds.) Cross-cultural Encounters: Linguistic Perspectives,
Roma, Officina, 2005.● Pennycook (1994), The Cultural Politics of English as an International Language,
Edinburgh: Pearson Education Limited
Frequenza
187
La frequenza alle lezioni è considerata un presupposto della organizzazione didattica.
Programma per i non frequentantiTutti gli studenti (sia frequentanti, sia non frequentanti) sono tenuti a prendere in analisi il te-sto:
● M. Bondi, and Maxwell, N. (eds.) Cross-cultural Encounters: Linguistic Perspectives, Roma, Officina, 2005.
In aggiunta a quanto sopra, gli studenti che non potessero frequentare il modulo di Comuni-cazione Interculturale potranno sostituire gli appunti delle lezioni con l’analisi di un testo a scelta tra quelli indicati in bibliografia.
Modalità d’esameTutti gli studenti devono superare una prova scritta, che si svolgerà al termine del modulo di ‘Varietà della lingua’. In alternativa, è possibile sostituire la prova scritta con l’elaborazione di una tesina di analisi di un piccolo corpus, da concordare con la docente, che sarà poi oggetto di discussione, in occasione dell’esame orale.
ValutazioneE’ ammesso a sostenere la prova orale chi ha superato la prova scritta riportando un voto di almeno diciotto/30. Il voto conseguito nella prova orale fa media col voto della prova scritta e costituisce il voto finale.
Comunicazione interculturale - lingua tedesca
Prof. Ernst KretschmerCFU 8 - 60 ore
Obiettivi formativiL’obiettivo del corso è quello di trattare, nelle 30 ore previste, le possibilità di definire il con-cetto della cultura umana e di paragonare le diverse manifestazioni di essa nel contesto della comunicazione: quali difficoltà comunicative – ma anche quali stimoli – nascono dalle diffe-renze culturali?
Prerequisiti Il corso si tiene in lingua tedesca.
Programma del corsoSi parte dall’interpretazione di alcuni testi basilari sul concetto della «cultura» (Windelband, Rickert, Simmel, Weber, Cassirer, Assmann), per prendere poi in considerazione diverse si-tuazioni della comunicazione quotidiana, verbali e non-verbali, gli ostacoli dei pregiudizi e de-gli stereotipi, nonché le prospettive di un loro superamento. In particolare si prenderanno in considerazione gli aspetti interculturali nei campi dell’economia e della pubblicità, della comu-nicazione scientifica e quella giornalistica.
Testi di riferimento● Bolten, Jürgen und Ehrhardt, Claus (Hrsg.) (2003), Interkulturelle Kommunikation.
Texte und Übungen zum interkulturellen Handeln, Sternenfels: Wissenschaft und Praxis
● Fauser, Markus (2004), Einführung in die Kulturwissenschaft, Darmstadt: Wissen-schaftliche Buchgesellschaft.
● Heringer, Hans Jürgen (2004), Interkulturelle Kommunikation, Tübingen, Basel: Francke (UTB 2550).
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è normalmente presupposta. In casi motivati, lo studente può chie-
188
dere, all’inizio del corso, di essere dispensato dalla frequenza concordando un programma per non-frequentanti con il docente. Si considerano frequentanti gli studenti che seguono al-meno il 75% delle lezioni.
Modalità d’esame Tesina scritta.
Diritto delle Istituzioni culturali
Prof.ssa Ivana Palandri – Prof. Federico CasolariCFU 8 - 60 ore
Obiettivi formativiScopo del corso è l’analisi delle principali organizzazioni internazionali universali e regionali e dei più significativi strumenti di cooperazione internazionale che si occupano della gestione, valorizzazione e protezione delle attività e dei beni culturali. Tale analisi verrà preceduta da una necessaria introduzione sui soggetti e le fonti del diritto internazionale pubblico.Sarà infine analizzato il ruolo e le funzioni degli organi dello Stato italiano chiamati ad intera-gire con il piano internazionale.
Prerequisiti Nessuno.
Programma del corso Lineamenti di diritto internazionale pubblico: i principali soggetti del diritto internazionale (gli Stati sovrani ed indipendenti, le organizzazioni internazionali, la soggettività degli individui) – le principali fonti del diritto internazionale pubblico (il diritto internazionale generale, il diritto internazionale pattizio, gli atti previsti da accordi internazionali).Le principali organizzazioni internazionali operanti in ambito culturale: L’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’UNESCO – il Consiglio d’Europa – la Comunità europea e l’Unione europea.I principali strumenti di cooperazione elaborati per la protezione, la gestione e la valorizzazio-ne dei beni e delle attività culturali: la Convenzione UNESCO del 1972 sulla tutela del patri-monio mondiale culturale e naturale; la Convenzione UNESCO del 2003 sulla tutela del patri-monio culturale immateriale; la Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o il-lecitamente esportati; la Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; le Convenzioni europee del 1969 e del 1992 per la tu-tela del patrimonio archeologico; la Convenzione europea del 1985 per la tutela del patrimo-nio architettonico; la Convenzione europea del 2000 sul paesaggio; il trattato istitutivo della Comunità europea e gli atti di diritto comunitario derivato adottati a tutela dei beni culturali; i programmi comunitari relativi alle attività culturali (in special modo il programma d’azione Cul-tura – 2007/2013).Il governo delle attività e dei beni culturali nell’ordinamento italiano: il ruolo dello Stato e degli enti territoriali.
Testi di riferimentoGli studenti frequentanti, cioè coloro che abbiano frequentato almeno il 75% delle lezioni, po-tranno preparare l’esame sugli appunti delle lezioni e sul materiale distribuito dai docenti nel corso di esse.
FrequenzaFacoltativa
Programma per i non frequentantiGli studenti non frequentanti dovranno preparare l’esame sui seguenti testi:
189
● Domenico Amirante e Vincenzo De Falco (a cura di), Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati, G. Giappichelli editore, Torino, 2005, pp. XIV-278;
● materiale relativo alla parte sui lineamenti di diritto internazionale pubblico disponibili in portineria di Facoltà.
Modalità d’esameL’esame finale consisterà in un colloquio orale avente ad oggetto il programma del corso.
ValutazioneLa valutazione si focalizzerà in gran parte sulle conoscenze acquisite dallo studente. Si terrà altresì conto delle sue capacità critiche, di approfondimento ed espositive.
Economia della cultura
Prof.ssa Stefania SaltiniCFU 8 - 60 ore
Obiettivi formativiIl corso di Economia della cultura ha come obiettivo l'analisi del settore artistico culturale e delle organizzazioni che lo compongono. L'attenzione verra' concentrata in particolare sull'offerta di spettacoli dal vivo - performing arts - e sul settore museale e dei beni culturali - visual arts. Sarà inoltre proposto un approfondimento sulle “imprese culturali” attraverso l’analisi del mer-cato dell’arte riproducibile.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso di economia della cultura propone un’analisi approfondita delle diverse forme di intrat-tenimento attraverso l'esame degli aspetti economici della cultura, quali il circuito di produzio-ne e scambio di beni ed attività culturali (formazione della domanda e dell'offerta), le forme or-ganizzative adottate dalle istituzioni che operano nel settore, le tipologie di finanziamento, le politiche di marketing ed i processi di comunicazione, le competenze e professionalità richie-ste nelle imprese dello spettacolo. Il corso ha inoltre l'intenzione di prendere in esame alcuni aspetti particolari del settore artistico culturale, l'analisi dei quali fornisce una visione più spe-cifica dell'ambiente, del mercato e delle dinamiche che lo caratterizzano. Ci si soffermerà ad analizzare le strutture di governo e decisionali, i meccanismi di finanziamento che modellano il sistema all'interno del quale le organizzazioni culturali operano, nonchè l'impatto dello svi-luppo politico, socio-culturale e tecnologico sull'attività delle stesse e sul funzionamento del-l'intero settore. Verrà introdotto il tema delle politiche culturali, con accenni alla loro formula-zione ed implementazione. Particolare enfasi verrà data all'analisi della domanda ed all'attivi-tà di marketing.Infine un approfondimento particolare viene riservato alle “imprese culturali”, ed in generale al mercato dell’arte riproducibile come ad esempio l’industria musicale, radiofonica, multimedia-le ed in particolare il mercato cinematografico (ed i festival e i musei ad esso collegati), il mer-cato del libro (ed il tema dei festival della letteratura, ecc.), il mercato del disco: ciascuno di questi analizzato nei diversi aspetti della produzione, distribuzione, finanziamento. Sono inoltre previsti interventi di esperti ed operatori del settore per l'approfondimento di temi specifici.
Testi di riferimentoPer gli studenti frequentanti:Testi obbligatori:
190
● David Throsby “Economia e cultura”- Bologna : Il mulino, 2005● Michele Trimarchi “Economia e cultura : organizzazione e finanziamento delle istitu-
zioni culturali” - 3.ed. – Milano, FrancoAngeli, 2002. Un testo a scelta fra i seguenti:
● Alberto Bentoglio, “L’attività teatrale e musicale in Italia. Aspetti istituzionali, organiz-zativi ed economici” Roma, Carocci, 2003.
● M. De Luca, F. Gennari, B. Pietromarchi, M. Trimarchi (a cura di), “Creazione con-temporanea. Arte, società e territorio tra pubblico e privato”, Roma, Sossella, 2004.
Alcuni articoli verranno consigliati e distribuiti durante le lezioni per l’approfondimento dei temi trattati.
FrequenzaLa frequenza è obbligatoria. Si considera frequentante chi ha partecipato almeno al 75% delle lezioni.
Programma per i non frequentantiGli studenti non frequentanti sono pregati di mettersi in contatto con la docente.
Modalità d’esameE’ previsto un colloquio orale.
Geografia del turismo
Prof.ssa Anna Maria SalaCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di fornire le conoscenze di base per comprendere l'evoluzione del fenome-no turistico, un'attività che presenta forti valenze economiche, ma che appare sempre piu' connessa alla percezione personale e collettiva del tempo e luogo del non-lavoro. Alla lettura delle caratteristiche tipologiche con le quali si esprime l'offerta, sarà affiancata quindi l'analisi delle motivazioni che inducono la domanda di spazi turistici in quanto e' sotto questo aspetto che possono essere interpretate le politiche di settore intraprese a livello nazionale ed inter-nazionale.
Prerequisiti Aver sostenuto un esame di Geografia nel triennio
Programma del corsoIl concetto di risorsa turistica; turismo e loisir; i luoghi e le tipologie dell'offerta consolidate e nuove forme di turismo; le motivazioni economiche, sociali e psicologiche sottese alla doman-da; il ruolo dei trasporti nella determinazione dei flussi nazionali ed internazionali; gli effetti territoriali delle politiche turistiche ; i sistemi locali turistici e loro individuazioneIl turismo come consumo dello spazio; il turismo sostenibile quale strumento di valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale e culturale; la promozione turistica
Testi di riferimentoBagnoli Lorenzo, Manuale di geografia del turismo, UTET, 2006
FrequenzaAlmeno il 75% delle lezioni
191
Programma per i non frequentantiUna lettura aggiuntiva da concordare col Docente
Modalità d’esameEsame scritto
Laboratorio/Modulo di scrittura in italiano
Prof. Domenico ProiettiCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativifornire agli studenti le nozioni scientifiche e tecnico-operative per la comprensione, l’analisi e la schematizzazione di testi (in particolare dei testi di studio), avviandoli alla redazione di testi argomentativi e saggi brevi, anche in prospettiva della stesura della dissertazione di laurea (specialistica).
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso sarà costituito da lezioni ed esercitazioni sul modo di leggere, riassumere e schema-tizzare testi di tipo saggistico e manualistico (abilità di lettura) e sul modo di stendere brevi saggi, relazioni, dissertazioni, ecc. (abilità di scrittura). Tali attività saranno affiancate e inte-grate da una serie di lezioni ed esercitazioni sulle strutture generali della lingua italiana, allo scopo di rinforzare le conoscenze di base nel campo della morfosintassi, dell’ortografia e del-la punteggiatura, e di fornire le cognizioni elementari sulla dimensione testuale della lingua e la tipologia dei testi. Alla parte teorica, in ogni incontro, seguirà una parte di esercitazione su testi forniti dal docente (inseriti anche nello spazio condiviso nel sito Internet di facoltà) e/o su materiali prodotti dagli studenti. Le 30 ore di corso sono così divise: 8 ore sulla lettura e le connesse operazioni di scrittura (glossa, parafrasi, riassunto, schema-tizzazione, riscrittura, scheda/recensione di testi); 10 ore sulla struttura del verbo e della frase, sulla tipologia dei testi (in partic. sui testi manua-listici, su testi saggistici e giornalistico-informativi), su altri aspetti del sistema linguistico e su-gli usi della punteggiatura: in questa parte del corso le “informazioni” e i “rafforzamenti” di lin-guistica prenderanno spunto dalle pratiche di lettura e scrittura già svolte nel Corso di laurea di base e dalle carenze emerse nell’esame della produzione scritta degli studenti; 10 ore: elaborazione di testi originali degli studenti;2 ore prova scritta finale del Laboratorio/Modulo.
Testi di riferimento● F. Sabatini, L’“italiano dell’uso medio”: una realtà tra le varietà linguistiche italiane, in
Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart, a cura di G. Holtus – E. Radtke, Tübingen, Narr, 1985, pp. 154-184;
● F. Sabatini, Lingua e comunicazione, in Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua ita-liana. Guida all’uso del Dizionario, Milano, Rizzoli-Larousse, 2003, pp. 5-30 e 42-47;
● F. Sabatini, Lettera sulla grammatica, in «La Cruscaper voi», 2004;● B. Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, Bari, Laterza, 2003.● N.B.: dei testi di Sabatini è stata depositata, a cura del docente, fotocopia presso
l’Ufficio Informazioni della Facoltà
FrequenzaIl Laboratorio/Modulo ha carattere pratico-applicativo, pertanto la frequenza è obbligatoria: saranno considerati frequentanti gli studenti che avranno partecipato ad almeno il 75% degli
192
incontri in cui il Laboratorio/Modulo è articolato.
Programma per i non frequentantiAgli studenti che non possono frequentare il corso è richiesto, oltre alla preparazione di quan-to indicato nel Programma per i frequentanti, lo studio dei seguenti testi:
● P. D’Achille, L’italiano contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2006, capp. 7 (Sintassi, pp. 155-175) e 9 (Le varietà scritte, pp. 203-223);
● F. Sabatini, Il traduttore e la dimensione testuale dell’italiano, in «Rivista di psicolin-guistica applicata», I (2001), pp. 111-132 (fotocopie fornite dal docente: in distribu-zione presso l’Ufficio Informazioni in Facoltà)
Modalità d’esameper i frequentanti: scritto e orale; per i non frequentanti: orale.
ValutazionePer lo scritto: correttezza e adeguatezza dell’elaborato alle richieste formulate nella traccia; per l’orale: grado di conoscenza, comprensione e capacità di esposizione-rielaborazione dei testi indicati nel programma.
Laboratorio di Progettazione Web e Multimediale (LPW)
Prof. Paolo DavoliCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiMostrare e sperimentare servizi di rete avanzati. Fare maturare la sensibilità necessaria per potere fornire un contributo di idee e di progetta-zione, in “contaminazione” tra persone con competenze umanistiche, organizzative, informati-che.Conoscere tecnologie per l'accesso a basi di dati e alla loro presentazione su WebConoscere l'uso dei Content Management Systems.
Prerequisiti Prerequisito del corso è che gli studenti possiedano le conoscenze tecnologiche di base sulla struttura della rete Internet, sul linguaggio HTML, e sulla multimedialità acquisite nei corsi di “Sistemi di Elaborazione dell’Informazione” e "Tecnologie di Internet ed Editoria multimediale" o equivalenti
Programma del corsoBasi di dati e sistemi informativi. Architettura a tre livelli di un DB. Figure professionali. Pro-gettazione di modelli Entity-Relationship e relazionale. Interrogazioni delle basi di dati in SQL. Sviluppo di applicazioni Web. I software open source e la suite LAMP (Linux, Apache, MySql, Php) per le applicazioni Web. Content Management SystemsSviluppo di brevi video in formato DVD. Editing video, gestione delle tracce audio, effetti spe-ciali, creazione del menu del DVD.
Testi di riferimento● Dispense del docente e link a risorse in rete disponibili sul portale di e-learning
http://dolly.lettere.unimo.it● Lorenzi, Cavalli: Informatica, le basi di dati e il linguaggio SQL – Atlas (“Lorenzi 1”)
FrequenzaLa frequenza è fortemente consigliata. Si considera frequentante chi ha partecipato almeno al 75% delle lezioni. Gli studenti non frequentanti trovano sul portale ad accesso riservato tutte
193
le lezioni ed i compiti assegnati, insieme ad eventuali indicazioni specifiche (dolly.lettere.unimore.it).
Programma per i non frequentantiLo stesso dei frequentanti
Modalità d’esameL’esame finale consisterà in un test e nella discussione di un progetto sviluppato dallo studen-te in piccoli gruppi. Tale progetto verterà su un “servizio di rete avanzato” per una organizza-zione, o un progetto video DVD.
ValutazioneVerrà valutato l'esito del test; il lavoro di progetto finale contribuirà fino a 3 punti.
Laboratorio di strumenti e metodologia di analisi dei mercati culturali
Prof.ssa Stefania SaltiniCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiIl corso di “Laboratorio di strumenti e metodologia di analisi dei mercati culturali” ha l’obiettivo di indurre gli studenti a sviluppare una capacità critica e di analisi del settore culturale e delle istituzioni che vi operano, attraverso la lettura e l’elaborazione di informazioni e di dati raccolti da testi, articoli, report e altri documenti. In particolare è prevista la partecipazione attiva degli studenti, coinvolti attraverso sessioni di lettura, rielaborazione e discussione in aula di articoli e case study proposti dalla docente.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso si basa prevalentemente sulla lettura ed esame di articoli attraverso i quali approfon-dire temi specifici quali i processi di produzione, organizzazione e scambio dei prodotti cultu-rali, offerta e domanda nel settore culturale, il finanziamento alla cultura, le politiche culturali ed il quadro istituzionale ed economico di riferimento, il rapporto cultura-impresa ed il tema della privatizzazione, il marketing nel settore culturale, i distretti culturali, il rapporto tra cultu-ra-territorio e qualità della vita, il tema cultura e società multietnica, cultura e disagio, cultura e inclusione sociale, cultura e rigenerazione urbana.Ciascun tema viene introdotto con una presentazione teorica attraverso la lettura di articoli e studi tratti dalle principali riviste nazionali ed internazionali del settore, ed una successiva analisi di case study che permettono un ulteriore approfondimento dei singoli argomenti. Gli studenti sono tenuti a svolgere lavori di gruppo su temi specifici concordati con la docente. Ciascun lavoro verrà presentato in aula e costituisce materiale di valutazione ai fini dell’esa-me finale.Interventi di esperti ed operatori del settore sono inoltre previsti per l’approfondimento di temi specifici.
Testi di riferimentoBibliografia ed articoli di riferimento verranno comunicati durante la prima giornata del corso.
FrequenzaLa frequenza è obbligatoria. È richiesta la presenza ad almeno il 75% delle lezioni.
Programma per i non frequentantiGli studenti non frequentanti sono pregati di mettersi in contatto con la docente.
194
Modalità d’esameL’esame finale prevede due prove: una prima prova consiste nello svolgimento di un lavoro di gruppo, su temi specifici concorda-ti con la docente, presentato in aula dagli studenti;la seconda prova riguarda la presentazione di un elaborato scritto compreso tra le 2500 e le 3500 parole su un tema concordato con la docente del corso inerente i temi trattati durante le lezioni.
Letteratura francese
Prof.ssa Giovanna BellatiCFU 4 - 30 ore
″Le théâtre français au XXème siècle: un parcours historique et textuel″
Obiettivi formativiLe cours vise à sensibiliser l’étudiant par rapport aux problématiques concernant la conception et la création de l’oeuvre théâtrale, en tant qu’expression culturelle qui a intéressé les hommes de toutes les époques et de tous les pays.Tel qu’il est connu et envisagé dans notre culture, le théâtre est l’une des formes artistiques les plus ambiguës. Cette ambiguïté tient à la nature même de l’art théâtral, qui repose sur la dualité de l’écriture et de la représentation : suivant que l’on se situe du côté du texte ou du côté de la scène, le point de vue et le discours sur le théâtre peuvent changer radicalement.Le programme présentera quelques moments-clé de l’évolution du théâtre français du XXème
siècle autour de l’opposition texte-représentation, focalisant d’un côté les débuts de la mise en scène entre la fin du XIXème siècle et le commencement du XXème, et de l’autre côté quelques points de vue des dernières décennies.Une exploration du «théâtre de texte» est envisagée à travers la lecture d’œuvres du «théâtre engagé» et du «nouveau théâtre», qui se succèdent autour du milieu du siècle.
Programma del corso1) L’avènement de la mise en scèneOn voit traditionnellement l’acte de naissance du théâtre du XXème siècle dans l’ouverture du Théâtre-Libre d’André Antoine, à la fin des années 1880, qui donne naissance à la fonction du metteur en scène. Une innovation semble s’accomplir, fondatrice d’une conception contemporaine du théâtre: l’autonomie de la représentation par rapport au texte théâtral; la dichotomie texte/mise en scène sera au cœur d’un débat qui ne cessera d’intéresser les hommes de théâtre du XXème, et qui sera traitée et résolue de manière différente, de Copeau au groupe du Cartel, jusqu’à Artaud et aux expériences du Théâtre National Populaire.2) Le théâtre engagéLe théâtre engagé utilise le texte et la représentation théâtrale pour proposer un message, faire passer une idéologie, ou plus simplement pour faire réfléchir sur des interrogations et des problèmes sociaux, philosophiques, moraux. En France il est représenté par plusieurs écrivains tout au long du siècle; nous nous intéresserons essentiellement à Jean-Paul Sartre et à Albert Camus, qui à travers leurs pièces ont posé les problèmes de l’identité, de la liberté et de la responsabilité de l’individu et de son rôle dans le contexte social et historique.
3) Le Nouveau Théâtre Le Nouveau Théâtre continue une analyse et une description de la condition humaine telle que l’avait esquissée la philosophie existentialiste, mais son originalité consiste dans la création d’une écriture et d’une mise en scène nouvelles qui tournent le dos à la tradition. Les personnages, l’action, les structures spatio-temporelles, le langage même sont remis en cause et subissent des transformations radicales; une conception essentiellement tragique de
195
l’existence s’exprime souvent par un mélange d’éléments sérieux et comiques. Les principaux représentants de ce courant sont Eugène Ionesco et Samuel Beckett.
4) Les tendances de la mise en scène après 1968Des expériences et des styles particuliers de troupes et de metteurs en scène caractérisent le panorama théâtral des dernières décennies, qui se signale par une recherche esthétique souvent axée sur une relecture et une réactualisation des classiques, ainsi que sur des styles de jeu qui intègrent les techniques des clowns, des acrobates et de l’ancienne Commedia dell’Arte; on retiendra, en particulier, l’expérience d’Ariane Mnouchkine avec le Théâtre du Soleil.
Travaux dirigés: Le texte théâtral et ses composantes linguistiques et structurales (Joséphine Baglio)
Comment est conçue une oeuvre théâtrale? Quelle est sa vocation ultime: est-ce un texte «à lire» ou «à dire»? Bref, comment la langue et ses codes se font-ils l’instrument discret, mais précieux, de la pensée dans le langage théâtral? Voilà les questions auxquelles ces rencontres tenteront de répondre. C’est à travers l’approche directe, pragmatique et collective des travaux dirigés que l’étudiant découvrira les composantes linguistiques, langagières et structurales de la communication théâtrale. Ce travail de sensibilisation au langage théâtral contemporain portera l’apprenant à repérer les principales caractéristiques des genres auxquels appartiennent les oeuvres du corpus. Les textes de lecture seront indiqués au début des cours.
Testi di riferimento● M.-C. Hubert, Le théâtre, Colin (chap. 5, La pièce contemporaine, pp. 140-181)● S. Jouanny, La littérature française du XXème siècle, tome 2 : Le théâtre, Colin
Deux pièces au choix dans la liste suivante :● Camus, Le malentendu● Camus, Les justes● Sartre, Les mouches● Sartre, Le diable et le bon Dieu● Sartre, Huis clos● Beckett, En attendant Godot● Ionesco, La cantatrice chauve● Ionesco, Rhinocéros
Modalità d’esameL’examen final consistera en un colloque visant à vérifier la compréhension et l’acquisition, de la part de l’étudiant, des contenus et des thématiques au programme, ainsi que d’une compétence de lecture personnelle des textes choisis.Letteratura Inglese
Prof. Marc SilverCFU 4 - 30 ore
“Border Crossings: Constructing Personal and Social Identity in Film”
Obiettivi formativiLa funzione di questo seminario è di stimolare una riflessione su come identità - personale, sociale, sessuale e politica - viene costruita e negoziata attraverso il film. Attraverso l'analisi di un numero di film contemporanei, si spera di aprire dei percorsi interpretativi su come ven-gono raffigurate l'individuo e la società, per poter interrogare come i film - intesi come sistemi semiologici complessi - comunicano e vengono letti dal loro pubblico. Dal momento che tutti i film in questione o provengono da registri statunitensi o rappresentano aspetti della cultura
196
americana, il problema della costruzione di miti degli americani o riguardante l'America sarà trattato.
Prerequisiti Per poter accedere al Corso, occorre un'ottima conoscenza sia parlata che scritta della lingua inglese.
Programma del corsoDopo una discussione teorica dei modi e metodologie col quale si può indagare il problema di “border crossings” si proporrà un’interpretazione di quattro film per discutere come essi tra-smettono sensi di identità attraverso lo spostamento/scivolamento di confini. Si concentrerà l’attenzione su come questi film, presi come sistemi semiologici complessi, co-struiscono e smentiscono tali confini, giocando tra i dialoghi, il suono, l’illuminazione, le tecni-che di ripresa e quelle di montaggio per costruire delle posizioni soggettivi credibili e fornire una visione culturalmente decifrabile.
Testi di riferimentoI seguenti film verranno discussi durante il corso:
● The Village - M. Night Shyamalan● Blue Velvet - David Lynch ● Lone Star - John Sayles ● Jungle Fever - Spike Lee
Letture secondarie verranno messe a disposizione tramite dispensa
FrequenzaE’ richiesta la frequenza di almeno il 75% delle lezioni.
Programma per i non frequentantiIl Programma per i non frequentanti dovrà essere concordato individualmente con il docente.
Modalità d’esameIl requisito per il corso è un tema di circa 10 pagine, ed una breve discussione orale del tema ed i contenuti affrontati. Se non con l'espressa volontà dello studente, il tema scritto dovrebbe essere un tentativo personale di lettura e di interpretazione di due film in termini del tema principale del corso: Attraversamento di Confini. Tutti i temi dovrebbero essere comparativi, contrastando uno dei film discusso in classe con un altro film dall'elenco sottostante. Fonti se-condari di lettura dovrebbero essere consultati nella preparazione del tema.
● Pulp Fiction - Quentin Tarantin● Paris, Texas - Wim Wenders ● Apocalypse Now - Francis Ford Coppola ● Blade Runner - Ridley Scott● My Beautiful Laudrette - Stephen Frears● The Matrix - Andy and Larry Wachowski
ValutazioneLa tesina conta per circa 80% del voto finaleLa discussione orale conta per circa 20% del voto finale
Letteratura spagnola
Prof. Guillermo CarrascónCFU 4 - 30 ore
197
“Sociedad y política en el teatro de Buero Vallejo”
Obiettivi formativiIntrodurre alla riflessione sul teatro come modalità letteraria e come pratica spettacolare e so-ciale nella Spagna della seconda metà del XX secolo.
Prerequisiti La bibliografia del corso e le opere teatrali devono essere lette in spagnolo, per cui si richiede un buon livello di conoscenza della lingua.
Programma del corsoUn percorso attraverso i principali testi teatrali del drammaturgo spagnolo Antonio Buero Val-lejo, con attenzione sia agli aspetti sociopolitici, sia a quelli scenici, di produzione e di allesti-mento, fornirà le basi per una riflessione sulla funzione del teatro, in concorrenza con cinema e televisione, come pratica sociale attuale e permetterà pure di affacciarsi ai grandi mutamen-ti subiti dalla società spagnola dal 1939 alla fine del XX secolo. Sarà anche presa in conside-razione la ricezione di questo autore in Italia.
Testi di riferimento● Tadeusz Kowzan, El signo y el teatro, Madrid, Arco Libros, 1997.● Cesar Oliva, El teatro español desde 1936, Madrid, Alhambra, 1989● Javier Huerta (Dir) Historia del teatro español, vol II, Madrid, Gredos, 2003,● Antonio Buero Vallejo, Obras completas, II vol., ed. de L. Iglesias Feijoo e M. de
Paco, Madrid, Espasa Calpe, 1998.● Mariano de Paco, ed., Creación escénica y sociedad española, Murcia, Universidad
de Murcia, 1998.● Catherine O’Leary, The Theatre of Antonio Buero Vallejo. Ideology, Politics, and
Censorship, London, Tamesis, 2005.
FrequenzaLa frequenza è vivamente consigliata. Si considera frequentante chi ha partecipato almeno al 75% delle lezioni.
Programma per i non frequentantiGli studenti non frequentanti dovranno mettersi d’accordo con il docente per stabilire gli stru-menti bibliografi e l’argomento per la tesina finale.
Modalità d’esameRelazione scritta in spagnolo su uno o vari aspetti di uno dei drammi di Buero Vallejo.
ValutazioneLa valutazione terrà in considerazione la effettiva capacità di analisi dell’opera teatrale, la cor-retta comprensione delle qustioni drammaturgiche e sociopolitiche studiate duarnte il corso e la sua adeguata applicazione al lavoro di interpretazione della piéce scelta.
Letteratura tedesca
Prof. Cesare GiacobazziCFU 4 - 30 ore
“La forza dell’eroe debole”
Obiettivi formativiTra gli aspetti più significativi della letteratura del 20. secolo vi è la trasformazione della figura dell’eroe: da personaggio centrale che nel bene e nel male determinava il corso degli eventi,
198
diventa figura imprigionata in una complessa rete di relazioni che non riesce né a dominare né a controllare; da eroe attivo padrone del proprio destino muta dunque in eroe reattivo che deve venire a patti con forze che lo sovrastano. Più che nella realizzazione di progetti in gra-do di trasformare la realtà, appare impegnato nel difficile compito di compensarne i deficit. La lettura e il commento di brani da opere che presentano un “eroe debole” si prefigge, tuttavia, lo scopo di metterne in risalto le virtù nascoste e di considerare l’eventualità che la sua posi-zione di emarginazione o di inferiorità costituisca un punto di vista privilegiato su uno squarcio di realtà altrimenti invisibile.
Testi di riferimento● Franz Kafka,DieVerwandlung● Günter Grass, Die Blechtromme● Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein● Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns● Robert Schneider, Schlafes Bruder
Mediazione e trattativa – Francese
Prof. Aleardo TridimontiCFU 8 - 60 ore
Obiettivi formativi- Perfezionamento della capacità di comprensione, sintesi e riformulazione di eventi o scambi comunicativi orali e scritti dal francese verso l’italiano e dall’italiano verso il francese di diffi-coltà crescente.- Progressivo approccio ai linguaggi settoriali (turismo, import-export, gestione eventi culturali). - Pratica della mediazione scritta durante ateliers di scrittura, di trattamento testi, di traduzio-ne.- Pratica della mediazione orale attraverso esercitazioni che preparano alla formulazione con-secutiva verso l’italiano e il francese, nonché alla formulazione simultanea verso l’italiano.- Potenziamento della capacità di elaborare in maniera autonoma un'architettura dinamica delle conoscenze.- Conoscenza delle regole etiche, comportamentali e tecniche di un mediatore linguistico.
A scanso di ogni equivoco,lo scopo di questo corso non è quello di formare dei traduttori o degli interpreti. Per queste figure professionali, esistono altre sedi altamente qualificate. Agli studenti che frequentano il nostro corso, vorremmo non solo fornire quegli strumenti e quei contenuti che consentono loro di sviluppare ulteriormente le conoscenze culturali e linguisti-che sia orali che scritte, attive e passive da e verso il francese che già possiedono, ma anche far loro acquisire alcune competenze funzionali all’attività di mediazione interlinguistica, spen-dibili in vari ambiti. Per fare questo, ricorreremo ad alcune attività e strategie in uso per la for-mazione dei traduttori e degli interpreti perché le riteniamo adatte ed efficaci non solo per l’ar-ricchimento delle abilità linguistiche di studenti a livello di specialistica, ma anche per una ef-fettiva operatività in campo lavorativo.
Prerequisiti Possedere una solida base culturale e linguistica (italiano e francese);possedere, in lingua francese, sicure competenze linguistico-culturali orali e scritte (pari al li-vello C1 o C2 del Common European Framework of Reference).
Programma del corso Il corso si articola in due moduli:
a) Modulo scritto: le esercitazioni si svolgono in laboratorio di informatica.
199
Uso delle risorse della rete per la comunicazione e la gestione dell’informazione: impostazio-ne di una ricerca documentaria mirata ed efficace; uso dei corpora paralleli; dizionari, glossa-ri, banche terminologiche on-line; acquisizione di lessico tecnico specifico con elaborazione di glossari funzionali nelle due lingue. Avviamento al trattamento verso il francese, di alcune ti-pologie di testi scritti e alla traduzione di documenti di natura commerciale, turistica, culturale, riguardanti scambi situazionali di comunicazione riguardanti gli ambiti di cui sopra.
b) Modulo orale: le esercitazioni si svolgono in laboratorio di lingue.
Potenziamento delle capacità di attenzione, di concentrazione, di memorizzazione e di comu-nicazione interpersonale. Padronanza di una efficace tecnica della presa di appunti. Capacità di preparare un’attività di mediazione e trattativa su una tematica specifica: approfondimento delle conoscenze sull’argomento con elaborazione di una rete o mappa concettuale; capacità di gestire un evento comunicativo simulando una situazione di mediazione linguistica in simul-tanea e/o consecutiva; abilità del parlare in pubblico e capacità di trasmettere con rigore, pre-cisione e naturalezza messaggi via via più complessi nel pieno rispetto del registro e della specificità del lessico.
Considerata la sua particolare finalità, il corso si svolge, a seconda della situazione, sia in lin-gua francese che in lingua italiana.
Testi di riferimento● Josiane Podeur: La pratica della traduzione: dal francese in italiano, dall’italiano in
francese, Napoli, Liguori, 1993● Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite dal docente durante il corso.
FrequenzaLa partecipazione alle lezioni non è da intendersi come mero assolvimento di un obbligo for-male, ma risulterà essenziale in vista delle finalità formative del corso e dell’esame previsto. Le lezioni sono delle esercitazioni pratiche o “ateliers” che si svolgono alternativamente in la-boratorio di informatica (per consultazione, ricerca documentaria e terminologica, corpora pa-ralleli, attività scritte) e in laboratorio linguistico per la parte orale.
Programma per i non frequentantiTrattandosi di esercitazioni in laboratorio, è difficile programmare attività per non frequentanti.
Modalità d’esame(con riserva di modifica che verrà comunicata in itinere): - una prova scritta in francese (in laboratorio informatica, con possibilità di sfruttare tutte le ri-sorse fornite dalla rete), riguardante un evento o scambio comunicativo trattato durante il cor-so (a partire da precise consegne, redazione di un documento in lingua: rapporto, sintesi, in-formativa. traduzione …)- una prova di mediazione/interpretazione simultanea orale (in laboratorio linguistico), dal francese verso l’italiano di un evento o scambio comunicativo trattato durante il corso;- una prova di mediazione/interpretazione consecutiva orale (in laboratorio linguistico), dall’i-taliano verso il francese, a partire da appunti presi durante l’ascolto di un evento o scambio comunicativo pre-registrato e trattato durante il corso.
ValutazionePer ogni candidato, la scheda di valutazione delle sue prove comporta le seguenti voci:Per la parte scritta: correttezza formale, coesione, contenuto, pertinenza, efficacia della pro-duzione secondo le consegne fornite;Per la parte orale: a) francese - italiano: capacità di concentrarsi, di seguire il ritmo della fonte emittente, di memorizzarne il contenuto,
200
di restituirlo in l’italiano, nonché di gestire la comunicazione. livello di completezza, chiarezza, precisione dell’informazione ed efficacia della riformulazio-ne.proprietà di linguaggio; pertinenza del lessico; correttezza della costruzione; adeguatezza del-lo stile; coesione.
b) italiano-francese: qualità dell’esposizione; capacità di gestire la comunicazione; naturalezza e “fluency”.contenuti; capacità di sintesi; completezza e chiarezza; efficacia dell’informazione.proprietà di linguaggio; pertinenza del lessico; correttezza della costruzione; adeguatezza del-lo stile; coesione.pronuncia.
N.B: La prova scritta è propedeutica all’orale. Pertanto, per essere ammessi a sostenere le prove orali, occorre aver conseguito una valutazione minima di 18/30 allo scritto.
Mediazione e Trattativa - Inglese
Prof.ssa Laura GavioliCFU 8 - 60 ore
Obiettivi formativiIl corso di mediazione inglese intende sviluppare una capacità avanzata di interazione in si-tuazioni che richiedono la conoscenza dell’inglese e dell’italiano e di mediazione di rapporti cross-culturali in ambiti aziendali e istituzionali. Ha inoltre i seguenti obiettivi:
1) Migliorare le capacità d’uso della lingua orale e della partecipazione al parlato;2) Promuovere una capacità di osservazione delle dinamiche del parlato in modo da
rendersi conto di strategie comunicative di parlanti di diversi background culturali;3) Migliorare la consapevolezza delle dinamiche interazionali della conversazione e
della costruzione congiunta dei ruoli personali, professionali e culturali dei parteci-panti all’interazione;
4) Promuovere una consapevolezza di differenze culturali e dinamiche linguistiche che permettano di facilitare la comunicazione fra culture diverse in interazioni istituzionali di diverso tipo (di affari, presso servizi sociali, ecc.)
5) Riflettere sulle caratteristiche dell’inglese usato in ambito internazionale.
Prerequisiti Si consiglia di avere sostenuto l’esame di inglese del primo anno e la certificazione C1 (o pari livello) per la lingua inglese prima dell’esame
Programma del corsoIl corso si concentra su alcuni concetti dell’Analisi della Conversazione e delle strategie di-scorsive che possano servire a chiarire l’idea del parlato come interazione fra i partecipanti. Si focalizza sulle dinamiche che emergono in interazioni di tipo istituzionale o aziendale e mo-stra come tali dinamiche tengano conto non solo del messaggio da trasmettere, ma anche dei ruoli istituzionale e/o personali dei partecipanti. Si discute il ruolo dell’interprete-mediatore non solo legato alla sua funzione di traduttore, ma anche alla funzione di coordinatore dell’in-contro e di partecipante all’interazione e si nota come tale partecipazione possa avere valen-ze importanti nell'interazione cross-culturale. In particolare si intende sottolineare il modo in cui il parlato (conversazionale o meno) si verifica come co-gestione dei partecipanti all’intera-zione e come continua negoziazione.La didattica mira a far raggiungere gli obiettivi proposti attraverso una partecipazione attiva degli studenti alle attività proposte. Da un punto di vista metodologico, si integrano attività vol-
201
te a sviluppare capacità operative nella lingua attraverso la creazione di situazioni comunicati-ve, ad attività volte a sviluppare consapevolezza linguistica e capacità critiche attraverso una riflessione sulla lingua e sulla cultura. Un ruolo importante assume anche la dimensione del-l'apprendere ad apprendere e dello sviluppo della capacità di formazione autonoma. Un ruolo altrettanto importante avrà la riflessione sulla propria produzione verbale.L'esame si articola in due parti: una prova in laboratorio di ascolto e traduzione orale di un te-sto le cui caratteristiche verranno definite nel corso delle lezioni e un colloquio che compren-derà un’analisi di una conversazione registrata e trascritta e una discussione della bibliogra-fia.
Testi di riferimentoGli studenti devono mostrare di conoscere i seguenti testi (reperibili presso la biblioteca):
● Hutchby, I. and R. Wooffitt 1998. Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press.● Mason, I. 1999. Dialogue Interpreting. Manchester: St. Jerome.
Devono inoltre scegliere di discutere 2 dei testi elencati qui sotto (e contenuti in questa di-spensa) illustrando i punti principali sulla base di analisi di trascrizioni (distribuite a lezione, ri-portate nelle letture o raccolte individualmente dagli studenti)
● Bolden, G. 2000. “Toward understanding practices of medical interpreters’ involve-ment in history taking”. Discourse Studies 2/4: 387-419.
● Cronin, M. 2002. “The empire talks back: orality, heteronomy and the cultural turn in interpreting studies. In F. Pöchhacker and M. Schlesinger (eds) The Interpreting studies reader. London/ New York: Routledge. 386-397.
● Davidson, B. 2000. “The interpreter as an institutional gatekeeper: The social-lin-guistic role of interpreters in Spanish-English medical discourse. Journal of Sociolin-guistics 4/3: 379-405.
● Gavioli, L. and N. Maxwell, in stampa. Interpreter intervention in mediated business talk. H. Bowls and P. Seedhouse (eds.) Conversation and ESP. Peter Lang.
● Mason, I. 2006. On mutual accessibility of contextual assumptions in dialogue inter-preting. Journal of Pragmatics, 38. 359-373.
● Mulholland, J. 1997. “The Asian connection: business requests and acknowledg-ments”. In F. Bargiela and S. Harris (eds) The languages of business. Edinburgh: Edinburgh University Press. 94-114.
● Roy, C. 1993/2002. “The problem with definitions, descriptions and the role meta-phors of interpreters”. In F. Pöchhacker and M. Schlesinger (eds) The Interpreting studies reader. London/ New York: Routledge. 344-353.
● Wadensjö, C. 1993/2002. “The double role of a dialogue interpreter”. In In F. Pöch-hacker and M. Schlesinger (eds) The Interpreting studies reader. London/ New York: Routledge. 354-371.
FrequenzaLa frequenza è data per presupposta. Sono considerati studenti frequentanti coloro che han-no seguito indicativamente almeno il 75% delle lezioni
Programma per i non frequentantiGli studenti devono mostrare di conoscere i seguenti testi (reperibili presso la biblioteca):
● Hutchby, I. and R. Wooffitt 1998. Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press.● Mason, I. 1999. Dialogue Interpreting. Manchester: St. Jerome.
Devono inoltre preparare i seguenti saggi con l’esclusione di:1 studenti di Comunicazione nell’Impresa e nelle Organizzazioni Internazionali:
§ Bolden 20002 studenti di Progettazione e Gestione di Attività Culturali
§ Mulholland 1997
202
● Bolden, G. 2000. “Toward understanding practices of medical interpreters’ involve-ment in history taking”. Discourse Studies 2/4: 387-419.
● Cronin, M. 2002. “The empire talks back: orality, heteronomy and the cultural turn in interpreting studies. In F. Pöchhacker and M. Schlesinger (eds) The Interpreting studies reader. London/ New York: Routledge. 386-397.
● Davidson, B. 2000. “The interpreter as an institutional gatekeeper: The social-lin-guistic role of interpreters in Spanish-English medical discourse. Journal of Sociolin-guistics 4/3: 379-405.
● Gavioli, L. and N. Maxwell, in stampa. Interpreter intervention in mediated business talk. H. Bowls and P. Seedhouse (eds.) Conversation and ESP. Peter Lang.
● Mason, I. 2006. On mutual accessibility of contextual assumptions in dialogue inter-preting. Journal of Pragmatics, 38. 359-373.
● Mulholland, J. 1997. “The Asian connection: business requests and acknowledg-ments”. In F. Bargiela and S. Harris (eds) The languages of business. Edinburgh: Edinburgh University Press. 94-114.
● Roy, C. 1993/2002. “The problem with definitions, descriptions and the role meta-phors of interpreters”. In F. Pöchhacker and M. Schlesinger (eds) The Interpreting studies reader. London/ New York: Routledge. 344-353.
● Wadensjö, C. 1993/2002. “The double role of a dialogue interpreter”. In In F. Pöch-hacker and M. Schlesinger (eds) The Interpreting studies reader. London/ New York: Routledge. 354-371.
Modalità d’esameprova di traduzione orale (in laboratorio) e colloquio
ValutazioneLa valutazione si basa sulle prove previste per l’esame. Tutte le prove devono essere suffi-cienti per contribuire alla valutazione.
Mediazione e trattativa – Spagnolo
Docente da definireCFU 8 - 60 ore
Obiettivi formativiL'obiettivo del corso è collegare operativamente le competenze ottenute nella lingua straniera e nella lingua madre, collocando le conoscenze acquisite in un contesto comunicativo, di me-diazione linguistica e culturale, specificamente orientato all’interpretazione di trattativa/comunità e alla sottotitolazione.
Programma del corsoModulo 1 (30 ore): Il mestiere di sottotitolareDopo un excursus sulla traduzione audiovisiva in Italia e il preponderante utilizzo della moda-lità traduttiva del doppiaggio, verranno introdotte problematiche traduttologiche relative al pro-cesso di sottotitolazione, sia in termini teorici che pratici. Il corso sarà affiancato da momenti di attività pratica di sottotitolazione su testi audiovisivi di diverso genere.
Modulo 2 (30 ore): Introduzione all’interpretazione di trattativa/comunitàIn questo modulo verrà fornito un quadro storico-culturale relativo al settore e alla sua orga-nizzazione professionale e verrà favorita l'acquisizione di microabilità fondamentali per l'inter-pretazione di trattativa. Si porrà inoltre l'accento sul ruolo comunicativo dell'interprete come
203
operatore sociale e come mediatore in vari settori della cultura, nelle istituzioni internazionali e nelle imprese. Le esercitazioni prevedono l'analisi e il riconoscimento delle diverse tipologie testuali, la tra-duzione a vista, la memorizzazione, il riassunto e la parafrasi; prevedono inoltre la rielaborazione ora-le di brevi testi scritti con cenni sulla presa di note, esposizioni libere e preparate, per passare successivamente all'assistenza linguistica e all'interpretazione di trattativa vera e propria, con la compresenza di interlocutori italofoni e ispanofoni.
Testi di riferimento● Baigorri Jalón, J., La interpretación de conferencias: el nacimiento de una profesión.
De París a Nuremberg. Granada, Comares, 2000 ● Collados Aís, A.; Fernández Sánchez, M. (a cura di), Manual de interpretación
bilateral, Editorial Comares, 2001 ● Kelly, D. (ed.), La traducción y la interpretación en España hoy: perspectivas
profesionales, Granada, Editorial Comares, 2000 ● Russo, M.; Mack, G. (a cura di), Interpretazione di trattativa, Hoepli, 2005
Ulteriore materiale verrà fornito agli studenti durante le lezioni.
FrequenzaAltamente consigliata. Si considera frequentante chi ha partecipato almeno al 75% delle le-zioni.Gli studenti non frequentanti sono pregati di contattare il docente.
Modalità d’esamePer il modulo 1: tesina e discussione dell’elaboratoPer il modulo 2: una breve simulazione di interpretazione dialogica
ValutazioneLa valutazione verterà sulla prova d’esame e sulla tesina.
Mediazione e trattativa - Tedesco
Prof. Antonie HornungCFU 8 - 60 ore
Obiettivi formativiConoscere i concetti-chiave della mediazione nonché le teorie attualmente in discussione nei paesi di lingua tedesca; conoscere gli ambiti nei quali si praticano la mediazione e il linguag-gio specifico; essere in grado di analizzare i testi specialistici e di tradurli adeguatamente in italiano.
Prerequisiti Livello B2o più alto in tedesco
Programma del corsoIl corso si terrà in tedesco. Verranno usati diversi metodi di insegnamento in aula per coinvol-gere gli studenti nella discussione. Si studieranno testi specialistici sulla mediazione, selezio-nati con particolare riferimento al rispettivo lessico, alla terminologia e alla fraseologia. L'anali-si dei testi affronterà la questione della traduzione prendendo in considerazione il livello ma-cro, meso e micro dei testi nonché la loro specificità culturale. Si eserciteranno inoltre diverse metodologie di mediazione per approfondire le competenze linguistiche orali.
204
Testi di riferimentoIndirizzi internet rilevanti:
Zur Einführung in den Begriff:http://de.wikipedia.org/wiki/Mediation
Homepage des "Bundesverband Mediation":http://www.bmev.de/www/(La rivista del "Bundesverband Mediation" è a disposizione in biblioteca)
"Interkulturelle Mediation":http://www.bmev.de/www/documents/mediation-interkulturell.pdf
Libri e saggi● Altmann, Gerhard/Fiebiger, Heinrich/Müller, Rolf (1999): Mediation. Konfliktmanage-
ment für moderne Unternehmen. Weinheim/Basel: Beltz.● Besemer, Christoph (1993): Mediation. Vermittlung in Konflikten. Königsfeld/Heidel-
berg/Freiburg: Stiftung Gewaltfreies Leben/Werkstatt für Gewaltfreie Aktion, Baden.● Breidenbach, Stephan (1995): Mediation. Struktur, Chancen und Risiken von Ver-
mittlung im Konflikt. Köln: Schmidt.● Geißler, Peter (Hrsg.) (2000): Mediation - die neue Streitkultur. Kooperatives Kon-
fliktmanagement in der Praxis. Gießen: Psychosozial-Verlag.● Klammer, Gerda (Hrsg.) (1999): Mediation. Einblicke in Theorie und Praxis profes-
sioneller Konfliktregelung. Wien: Falter. EUV: 321/PG 470 K63.Ladmiral, Jean-René (2000): Interkulturelle Kommunikation: Zur Dynamik mehrsprachiger Gruppen. Frankfurt am Main: Edmond Marc Lipiansky.
● Liebe, Frank/Haumersen, Petra (1998): "Interkulturelle Mediation. Empirisch-analyti-sche Annäherung an die Bedeutung von kulturellen Unterschieden". In: Breidenstein, L./Kiesel, D./Walther, J. (Hrsg.): Migration, Konflikt und Mediation. Zum interkulturel-len Diskurs in der Jugendarbeit. Frankfurt/Main: Haag und Herder: 135-155.
● Luchtenberg, Sigrid (1999): Interkulturelle Kommunikative Kompetenz: Kommunikati-onsfelder in Schule und Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag.
● Müller-Jacquier, Bernd/ten Thije, Jan D. (2000): "Interkulturelle Kommunikation: in-terkulturelles Training und Mediation". In: Becker-Mrotzek, Michael/Brünner, Gisela/Cölfen, Hermann (Hrsg.): Linguistische Berufe. Ein Ratgeber zu aktuellen lin-guistischen Berufsfeldern. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York, Ox-ford, Wien: Lang: 39-59.
● Schramkowski, Barbara (2001): Interkulturelle Mediation: Mediation als eine Metho-de des konstruktiven Umgangs mit interkulturellen Konflikten in Städten mit hohem multikulturellen Bevölkerungsanteil. Konstanz: Hartung-Gorre.
FrequenzaÈ richiesta la frequenza per approfondire le competenze linguistiche. Si considera frequentan-te chi ha partecipato almeno al 75% delle lezioni.
Modalità d’esameScritto: Tesina Orale: Discussione della tesina
ValutazioneVoto sulla tesina (contenuto, struttura, linguaggio e livello di competenza linguistica) + voto sulla discussione (argomentazione e livello di competenza linguistica).
205
Seminario di museologia
Prof.ssa Elena CorradiniCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiIl corso fornisce gli strumenti di base per conoscere i principali aspetti e le finalità della disci-plina, ne delinea la storia culturale, i fondamenti ma in particolare gli ambiti applicativi, esami-na gli strumenti per la ricerca e per l'attività museologica.Una parte propedeutica definisce l’identità di museo fornendo orientamenti sulla storia del col-lezionismo, con excursus sugli allestimenti delle più importanti strutture museali internaziona-li.
Una parte interdisciplinare esamina ruolo e significato dell’istituzione museale come servizio pubblico, caratterizzato da missione educativa, in cui convergono funzioni di acquisizione, conservazione, esposizione e comunicazione del patrimonio culturale, delineando competen-ze e attività necessarie per chi opera nell’ambito dell’istituzione museale in base a un aggior-nato profilo giuridico-istituzionale fondato sui rapporti con il pubblico, con il territorio, con le istituzioni. Fornisce indicazioni su sbocchi professionali per attività nell’ambito della valorizza-zione del patrimonio culturale.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoSi articola in tre moduli:
1) L’organizzazione del museoL’International Council of Museums (ICOM) e le organizzazioni internazionali.per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.Le tipologie di museiGli standard museali. Lo statuto/regolamento.La conservazione nei musei: la manutenzione e il restauro dei materialiIl pubblico dei musei e delle mostre: indagini e valutazioniL’educazione permanente nel museo: - la programmazione culturale - il recupero dei contesti storici (edifici monumentali e raccolte)- i progetti culturali- l’attività didattica La qualità dei museiLe professionalità del museoMultimedialità e musei: la qualità dei siti web museali e il progetto MinervaLa catalogazione del patrimonio culturale.Le reti di musei: i sistemi museali.
2) Storia del collezionismoIl collezionismo tra Quattrocento e Seicento: dallo studiolo alle raccolte enciclopediche, alle gallerie, alle raccolte eclettiche; Il museo come modello istituzionale del Settecento erudito e riformatore; il museo dell’Ottocento tra identità civica, cultura collezionistica alto-borghese e risposta all’industrializzazione (musei civici, case-museo, musei di arte industriale); il museo del NovecentoIl museo del terzo millennio: dai nuovi musei di arte moderna e contemporanea ai musei come espressione di identità di un territorio.
3) Gli allestimenti museali permanenti e temporanei e la conservazione nei musei: il rapporto tra oggetti/collezioni e contenitori/edifici storici e moderni in Italia, Europa, Stati Uniti con spe-
206
cifica attenzione ai musei scientifici..
4) I musei universitari modenesi tra storie antiche e nuove progettualitàwww.musei.unimo.it.
Nel corso delle lezioni verranno fornite indicazioni su siti web aggiornati sui temi specifica-mente trattati.
Testi di riferimento● M. V. Marini Clarelli, Che cos’è un museo, Carocci, Roma 2005● Capire l’Italia. I musei, Touring Club Italiano, Milano 1980: un articolo a scelta da
studiare e il resto da consultare per le immagini● Mottola Molfino, Il libro dei musei, Torino, Allemandi, 1998: un capitolo a scelta da
studiare e il resto da consultare per le immagini.● Lugli, Museologia, Milano, Jaka Book 2001● Mottola Molfino, L’etica dei musei. Un viaggio tra passato e futuro dei musei alle so-
glie del terzo millennio, Torino, Allemandi 2004, pp. 1-94 o 95-175● La qualità nella pratica educativa al museo, a cura di Margherita Sani e Alba Trombi-
ni, Materiali e ricerche dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regio-ne Emilia Romagna, Bologna 2003: J. Caton, L’apprendimento degli adulti al museo: l’esperienza anglosassone, pp. 147-152
● S. Bagdadli, Le reti di musei. L’organizzazione a rete per i beni culturali in Italia e al-l’estero, Milano 2001 : Presentazione e introduzione, pp. 1-14: Il sistema museale della provincia di Modena, pp. 35-49; Conclusioni e postfazione, pp. 165-193
● M. L. Tomea, Manuale di museologia, Milano, Etas Libri, 2003, cap. 5, pp. 81-130
FrequenzaIn considerazione del fatto che nel corso delle lezioni frontali sono previsti approfondimenti ed esercitazioni sulle attività di valorizzazione del patrimonio culturale finalizzate anche alla rea-lizzazione degli elaborati per la prova di esame è richiesta una frequenza minima del 75% delle lezioni,
Programma per i non frequentantiPer i non frequentanti è richiesta la lettura per intero dei testi presenti in bibliografia.E’ altresì necessario che contattino il docente per la definizione degli elaborati da presentare per l’esame.
Modalità d’esame e ValutazioneL’esame prevede un colloquio che si baserà sulla realizzazione da parte degli studenti, indivi-dualmente o in gruppo, di un elaborato su supporto informatico, organizzato in due sezioni 1) una riflessione storico-critica su una tipologia di musei prescelta e su alcuni allestimenti signi-ficativamente rilevanti; 2) l’individuazione di proposte progettuali per valorizzazione di una col-lezione o di un nucleo di oggetti significativi appartenenti a uno dei musei trattati nella sezione 1.
Seminario orientativo di Storia dell’arte
Prof.ssa Elena FumagalliCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiIncentrato sull’analisi di alcune mostre d’arte temporanee in corso – analisi condotta nelle le-zioni frontali, attraverso gli incontri con i curatori e le visite sul posto –, il seminario mira a svi-luppare la capacità dello studente di leggere in maniera critica gli eventi espositivi, valutando-
207
ne diversi aspetti: la portata scientifica, la posizione all’interno di una tradizione di mostre su temi analoghi e nell’ambito della più larga offerta nazionale, l’allestimento, il catalogo, la co-municazione pubblicitaria, ecc.
Prerequisiti È auspicabile una conoscenza di base della storia dell’arte moderna, in particolare dei secoli XVI-XVII. L’eventuale lacuna può essere colmata attraverso lo studio del manuale di P. De Vecchi, E. Cerchiari, Arte nel tempo, Milano, Bompiani, 1991, rist. 2005, volume 2, tomi I e II.
Programma del corsoNell’anno accademico 2007-2008 saranno prese in particolare considerazione due iniziative: - il programma “Firenze 2007 un anno ad arte”, frutto della politica espositiva del Polo Musea-le Fiorentino (nel periodo in cui si svolgerà il seminario saranno visitabili le seguenti mostre: Il giardino antico da Babilonia a Roma. Scienza, arte e natura, Limonaia del giardino di Boboli; Meraviglie sonore. Strumenti musicali del Barocco italiano, Galleria dell’Accademia; “filosofico umore” e “maravigliosa speditezza”. Pittura napoletana del Seicento dalle collezioni medicee, Galleria degli Uffizi) - l’esposizione Cosmé Tura e Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’età di Borso d’Este (Ferrara, palazzo dei Diamanti).
Testi di riferimentoPer la storia e la critica del fenomeno delle mostre d’arte di “Antichi Maestri”:
● R. Longhi, Mostre e musei (un avvertimento del 1959), in R. L., Critica d’arte e Buongoverno 1938-1969 (‘Opere complete’ XIII), Firenze, Sansoni, 1985, pp. 59-74.
● F. Haskell, The Ephemeral Museum. Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition, New Haven, Yale University Press, 2000.
Per le mostre oggetto del corso, oltre ai cataloghi, ulteriore bibliografia utile verrà indicata e discussa a lezione.
FrequenzaTrattandosi di un seminario a scelta, la frequenza è altamente consigliata. Si considera fre-quentante chi ha partecipato almeno al 75% degli incontri.
Programma per i non frequentanti● R. Longhi, Mostre e musei (un avvertimento del 1959), in R. L., Critica d’arte e
Buongoverno 1938-1969 (‘Opere complete’ XIII), Firenze, Sansoni, 1985, pp. 59-74.● F. Haskell, The Ephemeral Museum. Old Master Paintings and the Rise of the Art
Exhibition, New Haven, Yale University Press, 2000.
Modalità d’esameL’esame sarà orale e riguarderà i temi discussi a lezione, le mostre visitate e la bibliografia in-dicata dal docente.
ValutazioneIl candidato dovrà dimostrare di aver acquisito una qualche capacità di lettura critica delle esposizioni nei loro aspetti di contenuto, presentazione e promozione.Sistemi di Elaborazione dell’Informazione (SEI)
Prof. Paolo DavoliCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiL’elaboratore sta mostrando sempre più le sue caratteristiche di sistema di comunicazione multimediale, soprattutto se inserito all’interno dei sistemi di rete locale delle organizzazioni (Intranet) e di rete geografica (Internet).
208
Il corso non si incentra sulle tecniche, ma sulle tecnologie (tekne+logos = l’intelligenza delle tecniche), cercando di coglierne anche le implicazioni culturali e civili, ed esaminandone sia i fondamenti teorici-metodologici che alcuni aspetti applicativi.L’obiettivo del corso non è quindi quello di formare tecnici esperti nella disciplina informatica, ma di fornire ai laureandi della facoltà umanistica consapevolezza degli strumenti e delle loro vischiosità e potenzialità, per metterli in grado di interagire criticamente con i tecnici nella ge-stione di strumenti ed applicazioni.
Prerequisiti Prerequisito del corso è che gli studenti possiedano le conoscenze di base di utilizzo del com-puter e di navigazione Internet.
Programma del corsoModulo 1 Architettura delle reti - Informatica distribuita, modello client-server. LAN e WAN, protocolli, canali analogici e digitali, pacchetti, larghezza di banda. Compressione lossy e losslessModulo 2Architettura di Internet – Protocolli TCP e IP. Indirizzi IP e routing. IP privati e dinamici. DNS. Gli strumenti organizzativi di Internet e standardizzazioni. Il software open sourceModulo 3I servizi di Internet – Il Web come “killer application”. Struttura di un documento HTML, tag e attributi principali. Retorica e servizi dei portali. Posta e newsgroups. Autenticazioni LDAP e uso di Moodle.
Testi di riferimento● Dispense del docente e link a risorse in rete disponibili sul portale di e-learning
http://dolly.lettere.unimo.it● Lorenzi. Informatica: sistemi operativi e reti per il sistema informativo aziendale –
Atlas● Calvo, Ciotti, Roncaglia, Zela: Internet 2004, Laterza, disponibile free su www.later-
za.it/internet/leggi/internet2004/online/
FrequenzaLa frequenza è fortemente consigliata. Si considera frequentante chi ha partecipato almeno al 75% delle lezioni. Gli studenti non frequentanti trovano sul portale ad accesso riservato tutte le lezioni ed i compiti assegnati, insieme ad eventuali indicazioni specifiche (dolly.lettere.uni-more.it).
Programma per i non frequentantiLo stesso dei frequentanti
Modalità d’esameL’esame finale consisterà in un test scritto, a domande chiuse ed aperte. Durante il corso si dovranno produrre materiali intermedi attraverso la piattaforma di e-learning dolly.lettere.uni-more.it (in caso contrario il voto finale potrà essere penalizzato di uno o due punti).
ValutazioneVerrà valutato l'esito del test ed i materiali intermedi prodotti.
Tecnologie di Internet ed Editoria multimediale (TIEM)
Prof. Paolo DavoliCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativi
209
Un progetto culturale deve oggi prevedere servizi informatici che ruotano attorno ad alcuni aspetti interagentiutilizzo di documentazione digitale in molti formati (testo, immagini, audio, video)accesso e condivisione dell’informazione attraverso la rete ed il Websistemi di community per lo scambio di informazioni ed esperienze Il Web e la rete sono ormai i fattori unificanti, ed hanno avuto una evoluzione da sistema di presentazione dell’attività attraverso un sito Web (sito vetrina) a sistemi per l’accesso ai beni e servizi delle organizzazioni, per passare poi alla fornitura di servizi di valore aggiunto strut-turati intorno alla rete e la creazione di comunità di utenti. Il corso si propone di fornire le competenze macro-tecnologiche e culturali per comprendere l’architettura dei servizi avanzati forniti oggi sui sistemi Web anche attraverso strumenti multi-mediali.
PrerequisitiPrerequisito del corso è che gli studenti possiedano le conoscenze tecnologiche di base sulla struttura della rete Internet e sul linguaggio HTML, acquisite nel corso di “Sistemi di Elabora-zione dell’Informazione”. Il corso di “Tecnologie di Internet” è (in linea di massima) in alternati-va a “Comunicazione Web”, e propedeutico a “Laboratorio di Progettazione Web”.
Programma del corsoModulo 1Multimedialità - Codifica digitale di immagini, grafica, animazioni, audio, video. Strumenti di gestione e di produzione.Modulo 2Ripresa delle tecnologie standard del Web. CSS e XML. Modulo 3Ipertesti, sviluppo storico e problematiche. Usabilità dei siti Web: pagine, contenuto, naviga-zione. Valutazione della qualità. Internazionalizzazione. Accessibilità e normative collegate. Sviluppo e gestione di un sito Web.
Testi di riferimento● Dispense del docente e link a risorse in rete disponibili sul portale di e-learning
http://dolly.lettere.unimo.it● Tay Vaughan - Muiltimedia: Making It Work, Osborne McGraw-Hill ; in alternativa:
Chapman, N & J, Digital multimedia, Wiley. ● Jakob Nielsen - Designing Web Usability: The Practice of Simplicity - New Riders
(ed. it. Apogeo)● Lorenzi. Informatica: sistemi operativi e reti per il sistema informativo aziendale –
Atlas● Guide HTML, CSS, XML disponibili on line su HTML: http://www.html.it/
FrequenzaLa frequenza è fortemente consigliata. Si considera frequentante chi ha partecipato almeno al 75% delle lezioni. Gli studenti non frequentanti trovano sul portale ad accesso riservato tutte le lezioni ed i compiti assegnati, insieme ad eventuali indicazioni specifiche (dolly.lettere.uni-more.it).
Programma per i non frequentantiLo stesso dei frequentanti
Modalità d’esameL’esame finale consisterà in un test scritto, a domande chiuse ed aperte. Durante il corso si dovranno produrre materiali intermedi attraverso la piattaforma di e-learning dolly.lettere.uni-more.it (in caso contrario il voto finale potrà essere penalizzato di uno o due punti).
Valutazione
210
Verrà valutato l'esito del test ed i materiali intermedi prodotti.
Teoria e Metodi della Progettazione Culturale
Prof. Vittorio IerveseCFU 8 - 60 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di affrontare il rapporto tra Cultural Planning e Cultural Diversity nelle sue diverse sfaccettature. Si cercherà in questa prospettiva di fornire strumenti per: 1. individuare gli elementi di alcuni tra i principali processi culturali in corso; 2. concepire forme di intervento su questi processi; 3. Prevedere forme di gestione complessa degli interventi; 4. approntare un piano di valutazione e controllo dell’intero ciclo di progettazione. Prerequisiti Agli studenti è richiesta una conoscenza preliminare dei principali concetti utilizzati negli studi culturali e in particolare di quelli relativi ai processi di costituzione e diffusione della cultura. A questo scopo, si invitano gli studenti che non hanno dimestichezza con questi argomenti a contattare il docente per farsi consigliare dei materiali introduttivi. Programma del corsoIl corso procederà secondo un metodo abduttivo e partecipativo, delineando un ideale percor-so circolare. Agli studenti saranno inizialmente proposti alcuni esercizi di progettazione da realizzare mediante lavori di gruppo in aula. Da questi lavori verranno tratte alcune indicazioni sui principali procedimenti e significati della progettazione. Si procederà quindi alla discussio-ne di alcune teorie e metodi di progettazione culturale e in particolare si introdurrà al Project Cycle Management (PCM) e alle sue diverse applicazioni, in particolare quelle di tipo parteci-pativo. Gli approfondimenti tematici saranno affidati alla testimonianza di alcuni esperti di set-tore e all’analisi di alcuni casi esemplari di progetti formulati in passato. Infine, gli studenti sa-ranno nuovamente invitati ad elaborare loro proposte all’interno di un progetto quadro comu-ne. Testi di riferimentoDi seguito alcuni testi consigliati per approfondire i temi affrontati a lezione. Il docente fornirà durante le lezioni indicazioni più specifiche su questi materiali e sulle modalità d’esame.
● Amari, M. Progettazione culturale. Metodologia e strumenti di cultural planning. An-geli, 2006.
● Iervese, V. (2007). La cultura del Progetto. Forme e processi di progettazione cultu-rale (dispense disponibili in forma cartacea in biblioteca o scaricabili dagli “spazi condivisi”)
Frequenza “Facoltativa”
Programma per i non frequentanti● Amari, M. Progettazione culturale. Metodologia e strumenti di cultural planning. An-
geli, 2006.● Argano, L. (1997) La gestione dei progetti di spettacolo. Elementi di project manage-
ment culturale, Milano, Franco Angeli.● Iervese, V. (2007). La cultura del Progetto. Forme e processi di progettazione cultu-
rale (dispense disponibili in biblioteca o scaricabili dagli “spazi condivisi”)● Leone, Prezza (1999), Costruire e valutare i progetti nel sociale. Angeli,
Milano
211
Modalità d’esamePer i frequentanti:Per coloro che frequenteranno saranno previsti dei lavori di gruppo in aula da completare in forma di tesina ai fini dell’esame. I lavori riguarderanno la progettazione e la valutazione di specifiche attività culturali.Per i non frequentanti:E’ previsto un esame orale sui testi sopra indicati. Il docente è però disponibile a concordare programmi alternativi.
ValutazioneLa valutazione sarà finalizzata a verificare le capacità degli studenti di interpretare le questio-ni culturali più rilevanti, di tradurre l’analisi in interventi coerenti e originali, di cogliere la com-plessità delle variabili della progettazione culturale e dei processi che questa innesca.
212
Laurea Magistrale in Teoria e Metodologia della Ricerca Antropologica sulla Contem-poraneità
Antropologia delle religioni
Docente da definireCFU 4 - 30 ore
Programma da definire
Antropologia Economica
Prof. Gino SattaCFU 4 - 30 ore Obiettivi formativiScopo del corso è di permettere agli studenti di:conoscere i concetti di base e i principali elementi del dibattito teorico nel campo della discipli-na;conoscere i principali indirizzi e ambiti della ricerca in antropologia economica;approfondire il tema delle interpretazioni antropologiche del dono e dei sistemi di scambio ce-rimoniale (potlatch, kula, etc.).
PrerequisitiNessunoProgramma del corsoIl corso sarà suddiviso in due parti: una introduzione all’antropologia economica, nel corso della quale verranno illustrate le problematiche della disciplina, i dibattiti tra le diverse scuole di pensiero, i principali approcci teorici; una seconda parte, monografica, nella quale sarà pro-posto un percorso di letture sulle teorie e interpretazioni antropologiche del dono. Il percorso partirà dal celebre Saggio sul dono di Marcel Mauss, punto di riferimento ineludibile delle in-terpretazioni antropologiche del dono, si soffermerà sulle interpretazioni dei sistemi di scam-bio cerimoniale competitivo, per giungere alle più recenti rivisitazioni del pensiero di Mauss sul dono, in particolare da parte del Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales (MAUSS), e al tema emergente della “proprietà culturale”.
Testi di riferimento● Satta, G. (a cura di), Introduzione all’antropologia economica, dispensa con antolo-
gia di saggi.● Mauss, M., Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, in
Teoria generale della magia e altri saggi, Einaudi, Torino 1991: 153-292. (Nel 2002 lo stesso editore ha pubblicato il Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche come volume a se stante. L’originale francese è scaricabile gratuitamente in vari formati testuali presso il sito dell’Université du Quebec, nella collana Classiques des sciences sociales Essai sur le don)
un testo a scelta tra i seguenti:● Brown, M. F., Who owns native culture?, Harvard University Press, Cambridge
(Mass.) 2003.● Godelier, M., L’énigme du don, Flammarion, Paris 1996.
213
● Grendi, E. (a cura di), L’antropologia economica, Einaudi, Torino 1972.● Polanyi, K., Economie primitive, arcaiche e moderne. Ricerca storica e antropologia
economica, a cura di George Dalton, Einaudi, Torino 1980● Sahlins, M., Cultura e utilità, Anabasi, Milano 1994.
ulteriori testi a scelta (sostitutivi di quelli riportati sopra) potranno essere concordati il docente durante lo svolgimento del corso.
FrequenzaFacoltativa
Programma per i non frequentanti● Satta, G. (a cura di), Introduzione all’antropologia economica, dispensa con antolo-
gia di saggi.● Mauss, M., Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, in
Teoria generale della magia e altri saggi, Einaudi, Torino 1991: 153-292. (Nel 2002 lo stesso editore ha pubblicato il Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche come volume a se stante. L’originale francese è scaricabile gratuitamente in vari formati testuali presso il sito dell’Université du Quebec, nella collana Classiques des sciences sociales Essai sur le don)
un testo a scelta tra i seguenti:● Brown, M. F., Who owns native culture?, Harvard University Press, Cambridge
(Mass.) 2003.● Godelier, M., L’énigme du don, Flammarion, Paris 1996.● Grendi, E. (a cura di), L’antropologia economica, Einaudi, Torino 1972.● Polanyi, K., Economie primitive, arcaiche e moderne. Ricerca storica e antropologia
economica, a cura di George Dalton, Einaudi, Torino 1980.● Sahlins, M., Cultura e utilità, Anabasi, Milano 1994.
Modalità d’esameEsame finale orale. Su richiesta della/o studente la parte dell’esame finale che verte sui due testi a scelta può essere sostituita dalla discussione di una tesina (20.000-30.000 caratteri) precedentemente concordata con il docente.
ValutazioneL’esame finale orale (eventualmente integrato dalla stesura di una tesina su argomento con-cordato con il docente) costituisce la base della valutazione per gli tutti gli studenti. L’attiva partecipazione alle attività didattiche costituisce, per i frequentanti, ulteriore elemento di valu-tazione.
Antropologia Politica
Prof. Stefano BoniCFU 4- 30 ore
Obiettivi formativiIl corso intende avviare gli studenti ad una riflessione sul concetto di ‘potere’; le varie forme che questo assume nella organizzazione sociale; e le dinamiche di accentramento e diffusio-ne della sua distribuzione. Questo processo di riflessione, critico e comparativo metterà a confronto illustri scienziati sociali (storici, antropologi, filosofi, sociologi) che hanno contribuito a mettere a fuoco – da prospettive diverse - il configurarsi sociale della costrizione, del domi-nio, del condizionamento, della legge, della parola legittima. Al contempo, il corso introdurrà nozioni di base dell’antropologia politica.
214
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoTeorie e immagini del dominio e della resistenza culturaleIl corso propone, partendo dall’analisi comparativa dei resoconti etnografici, una riflessione sulle nozioni di autorità, valore, dipendenza, disuguaglianza e potere; sulle forme di organiz-zazione politica nelle società preindustriali - statuali o acefale -; sulla stratificazione sociale e gerarchica; sull’autorità etnografica come forma di potere. Particolare attenzione verrà dedi-cata al rapporti tra cultura, dominio e resistenza. Il corso avrà carattere seminariale e impe-gnerà gli studenti in letture settimanali seguite da relazioni e discussioni in classe, introdotte dal docente.
Testi di riferimentoIl programma di esame prevede la preparazione di una dispensa e di una monografia.
● La dispensa “Teorie e immagini del dominio e della resistenza culturale”, con testi scelti dal docente, raccoglie i contributi che verranno discussi in classe. Tra gli altri F. Engels, M. Fortes e E.E. Evans-Pritchard, E. De Martino, P. Clastres, M. Augé, M. Foucault, P. Bourdieu, J.C. Scott, R. Guha, J. Clifford
Oltre la dispensa, il programma deve essere completato con un testo, di approfondimento monografico, da scegliere tra i seguenti.
● M. Augé 2003 Potere di vita potere di morte, Milano, Cortina.● S. Boni, 2006. Vivere senza padroni. Antropologia della sovversione quotidiana, Mi-
lano, Eleuthera● Béteille, 1981. La Diseguaglianza tra gli uomini, Bologna, Il Mulino.● D. Donham, 1990. History, Power, Ideology, Cambridge, Cambridge University
Press.● N. Elias e J.L. Scotson 1994. Strategie dell’esclusione, Bologna, Il Mulino (2004).● M. Fortes e E.E. Evans-Pritchard, 1940. African Political Systems, Oxford, Oxford
University Press.● D. Graeber, 2001 Toward an anthropological theory of value, Palgrave.● R. Guha 1998 Dominance without Hegemony. History and Power in Colonial India,
Harvard University Press, Londra.● D. Kertzer, 1981. Comunisti e Cattolici, Milano, Angeli.● M. Harnecker 1995. Haciendo camino al andar. Experiencias de ocho gobiernos
locales de America Latina, Monte Avila, Caracas● M. Herzfeld, 2003. Intimità Culturale, Napoli, L’Ancora.● E. Leach, 1954. Sistemi Politici Birmani, Milano, Angeli.● Lenz, 2005. Land Rights and the Politics of Belonging, Leiden, Brill● Meillassoux, 1973. Donne, Granai e Capitali, Bologna, Zanichelli.● J.C. Scott 1990. Il dominio e l’arte della resistenza. I verbali segreti dietro la storia
ufficiale, Eleuthera, Milano, 2006.● P.G. Solinas (ed.), 2005 La Dipendenza: antropologia delle relazioni di dominio, Lec-
ce, Argo● F. Viti, 1998. Il potere debole, Milano, Angeli.● F. Viti, 1993. Sistemi politici africani (dispensa con raccolta di testi).● F. Viti, 2004. (ed.), Guerra e violenza in Africa Occidentale, Milano, Angeli.● F. Viti, 2006 (ed.), Antropologia dei rapporti di dipendenza personale, Il Fiorino, Mo-
dena,
In alternativa possono essere scelti due dei seguenti testi (più brevi).
● S. Boni 2006. Vivere Senza Padroni, Antropologia della sovversione quotidiana,
215
Eleuthera, Milano.● D. Graeber. 2004 Frammenti di Antropologia Anarchica, Eleuthera, Milano, 2006.
J. Zerzan. 1994 Primitivo Attuale, Viterbo, Stampa Alternativa, 2004.● M. Abélès, 2001. Politica, Gioco di Spazi, Roma, Meltemi.
FrequenzaFacoltativa
Programma per i non frequentantiIl programma di esame prevede la preparazione di una dispensa e di una monografia.
● La dispensa “Teorie e immagini del dominio e della resistenza culturale”, con testi scelti dal docente, raccoglie i contributi che verranno discussi in classe. Tra gli altri F. Engels, M. Fortes e E.E. Evans-Pritchard, E. De Martino, P. Clastres, M. Augé, M. Foucault, P. Bourdieu, J.C. Scott, R. Guha, J. Clifford
Oltre la dispensa, il programma deve essere completato con un testo, di approfondimento monografico, da scegliere tra i seguenti.
● M. Augé 2003 Potere di vita potere di morte, Milano, Cortina.● S. Boni, 2006. Vivere senza padroni. Antropologia della sovversione quotidiana, Mi-
lano, Eleuthera● Béteille, 1981. La Diseguaglianza tra gli uomini, Bologna, Il Mulino.● D. Donham, 1990. History, Power, Ideology, Cambridge, Cambridge University
Press● N. Elias e J.L. Scotson 1994. Strategie dell’esclusione, Bologna, Il Mulino (2004).● M. Fortes e E.E. Evans-Pritchard, 1940. African Political Systems, Oxford, Oxford
University Press.● D. Graeber, 2001 Toward an anthropological theory of value, Palgrave.● R. Guha 1998 Dominance without Hegemony. History and Power in Colonial India,
Harvard University Press, Londra.● D. Kertzer, 1981. Comunisti e Cattolici, Milano, Angeli.● M. Harnecker 1995. Haciendo camino al andar. Experiencias de ocho gobiernos
locales de America Latina, Monte Avila, Caracas.● M. Herzfeld, 2003. Intimità Culturale, Napoli, L’Ancora.● E. Leach, 1954. Sistemi Politici Birmani, Milano, Angeli.● Lenz, 2005. Land Rights and the Politics of Belonging, Leiden, Brill.● Meillassoux, 1973. Donne, Granai e Capitali, Bologna, Zanichelli.● J.C. Scott 1990. Il dominio e l’arte della resistenza. I verbali segreti dietro la storia
ufficiale, Eleuthera, Milano, 2006.● P.G. Solinas (ed.), 2005 La Dipendenza: antropologia delle relazioni di dominio, Lec-
ce, Argo.● F. Viti, 1998. Il potere debole, Milano, Angeli.● F. Viti, 1993. Sistemi politici africani (dispensa con raccolta di testi).● F. Viti, 2004. (ed.), Guerra e violenza in Africa Occidentale, Milano, Angeli.● F. Viti, 2006 (ed.), Antropologia dei rapporti di dipendenza personale, Il Fiorino, Mo-
dena,
In alternativa possono essere scelti due dei seguenti testi (più brevi).
● S. Boni 2006. Vivere Senza Padroni, Antropologia della sovversione quotidiana, Eleuthera, Milano.
● D. Graeber. 2004 Frammenti di Antropologia Anarchica, Eleuthera, Milano, 2006.● J. Zerzan. 1994 Primitivo Attuale, Viterbo, Stampa Alternativa, 2004.● M. Abélès, 2001. Politica, Gioco di Spazi, Roma, Meltemi.
216
Modalità d’esameOrale
ValutazioneIn base al suddetto esame orale. I criteri di valutazione sono i seguenti: capacità dello studen-te di riassumere in maniera chiara e sintetica i contenuti dei libri letti; capacità di svolgere confronti e analisi dei testi; di esprimere le proprie opinioni e chiavi di lettura dei suddetti testi.
Antropologia delle società complesse
Docente da definireCFU 6 – 40 ore
Programma da definire
Culture dei Paesi islamici contemporanei
Prof. Demetrio GiordaniCFU 8 - 60 ore
Obiettivi formativiL’obiettivo del corso è quello far conoscere agli studenti alcuni particolari aspetti della storia e della cultura musulmana del XIX e del XX secolo. Attraverso l’approfondimento dei principali eventi politico-culturali, l’analisi delle idee di qualcuno tra i più importanti riformatori religiosi e di alcune scuole di pensiero, si cercherà di comprendere la cultura contemporanea dei musul-mani, le loro convinzioni e l’atteggiamento verso le trasformazioni sociali introdotte dalla mo-dernità e dalla secolarizzazione.
Prerequisiti Conoscenza dei fondamenti della civiltà dell’Islâm. Buona conoscenza dell’inglese.
Programma del corsoIl corso si divide in due parti: nella prima si analizzeranno le cause e l’evoluzione della deca-denza del mondo islamico a partire dal XVIII secolo, la risposta che il mondo islamico ha op-posto al colonialismo e all’occidentalizzazione attraverso le fasi della rinascita, del riformismo e del radicalismo. Nella seconda parte si prenderà in esame la nascita e l’affermazione della madrasa di Deoband nel contesto dell’India coloniale, e si analizzerà un testo particolare di questa scuola, il Bahishti Zewar, “L’Ornamento del Paradiso” manuale religioso di scuola ha-nafita rivolto alle donne del XX secolo.
Testi di riferimento● Pier Giovanni Donini: Il Mondo Islamico. Breve storia dal Cinquecento a oggi. Later-
za, Roma-Bari 2003. In particolare la parte III: I musulmani nell’étà dell’imperialismo.● Youssef Choueiri: Il fondamentalismo islamico. Origini storiche e basi sociali. Il Muli-
no, Bologna 1993.● Barbara Daly Metcalf: “The Madrasa at Deoband. A Model for Religious Education in
Modern India”, in: Islamic Contestation. Essays on Muslims in India and Pakistan, Oxford University Press, 2004, pp. 29-56.
● Barbara Daly Metcalf: ‘Traditionalist’ Islamic Activism. Deoband, Tablighis, and Talibs, in: Islamic Contestation. Essays on Muslims in India and Pakistan, Oxford University Press, 2004, pp. 265-284.
● “Maulana” Ashraf ‘Alî Thanâwî: Bihishti Zewar (Heavenly Ornament); traduzione inglese di Muhammad Masroor Khan Saroha, New Delhi, 2001.
217
FrequenzaAltamente consigliata
Programma per i non frequentantiPer i non frequentanti è possibile sostituire gli articoli di B.D. Metcalf e il libro di “Maulana” Ashraf ‘Alî Thanâwî con il seguente testo a cura di Adriana Piga: Islam e città nell’Africa a Sud del Sahara tra Sufismo e Fondamentalismo. Napoli 2001.
Modalità d’esameEsame orale
Demografia
Prof. Luciano NicoliniCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiScopo del corso è, in primo luogo, fornire ai partecipanti gli strumenti indispensabili per com-prendere l’esatto significato degli indicatori forniti dai demografi ed interpretarne correttamen-te le variazioni; in secondo luogo metterli in grado di realizzare autonomamente ricerche sulla popolazione, con particolare riferimento alle popolazioni del passato e a quelle sprovviste dei moderni sistemi di rilevazione dei fenomeni demografici.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso si articolerà in tre parti rispettivamente dedicate a: indicatori, fonti e teorie.Durante la prima parte saranno introdotti i concetti che stanno alla base della demografia. Verranno quindi illustrati i principali indicatori utilizzati nello studio dell’ammontare della popo-lazione, della sua distribuzione sul territorio, della struttura per sesso ed età, della mortalità, della fecondità, del movimento migratorio, della nuzialità, dell’endogamia e della consangui-neità. Si accennerà inoltre ai principali sistemi di classificazione delle famiglie e delle convi-venze utilizzati in demografia. Nello sviluppare la seconda parte saranno analizzate le fonti statistiche e le fonti amministrati-ve ma anche, in considerazione degli obiettivi formativi dei corsi di laurea in cui è inquadrato l’insegnamento, le fonti per lo studio della demografia storica, della paleodemografia e delle popolazioni sulle quali maggiormente si concentra l’interesse dell’antropologia. Ci si sofferme-rà poi sui metodi di proiezione della popolazione, accennando anche alle proiezioni derivate e alle proiezioni inverse, particolarmente utilizzate nel campo della demografia storica.La terza parte, infine, sarà dedicata alle più accreditate teorie formulate per spiegare le tra-sformazioni demografiche che hanno accompagnato la diffusione della pratica dell’agricoltura e dell’allevamento e, soprattutto, in epoca contemporanea, i fenomeni costituiti dall’industria-lizzazione e dall’urbanizzazione. Di tali mutamenti si prenderanno in considerazione anche gli effetti sulla biologia delle popolazioni umane, introducendo alcuni elementari concetti di ecolo-gia e di genetica delle popolazioni.
Testi di riferimentoIl testo consigliato per lo studio è:
● Massimo Livi Bacci, Introduzione alla demografia, Loescher, Torino, 1999 (limitata-mente agli argomenti trattati durante il corso).
Utile la lettura di ● L. Del Panta e R. Rettaroli, Introduzione alla demografia storica, Laterza, Roma-
Bari,1994 (con riferimento al primo capitolo, dedicato alle fonti) e, per quanto riguar-
218
da l’immigrazione più recente, Dominutti G. e Jahier F (a cura di), Presenza stranie-ra in Italia. Ricognizione delle principali fonti informative, CISIS, Roma, 2001 (scari-cabile dal sito www.cisis.it).
Saggi a carattere storico-demografico, dei quali prendere visione come esempi di ricerca nel settore, sono reperibili in
● L. Del Panta, L. Pozzi, R. Rettaroli, E. Sonnino (a cura di), Dinamiche di popolazio-ne, mobilità e territorio in Italia, secoli XVII-XX, Forum, Udine, 2002 e, con riferimen-to alle popolazioni montane, in A. Fornasin, A. Zannini (a cura di), Uomini e comuni-tà delle montagne, Paradigmi e specificità del popolamento dello spazio montano (secoli XVI-XX), Forum, Udine, 2002.
FrequenzaFacoltativa
Programma per i non frequentantiE’ consigliata la frequenza al corso; i non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente per concordare il programma in modo più dettagliato.
Modalità d’esameColloquio
ValutazioneVoto finale
Etnografia
Prof. Fabio VitiCFU 8 - 60 ore
Obiettivi formativiL’insegnamento di Etnografia si configura come una introduzione alla ricerca demo-etno-an-tropologica. Particolare attenzione sarà quindi rivolta agli aspetti metodologici, alla costruzio-ne dell’oggetto della ricerca e al suo svolgimento empirico, sul campo. Una seconda accezio-ne del termine Etnografia, inteso come scrittura dell’etnologia e dell’antropologia, è stato più recentemente rivalutato, sull’onda della più generale riflessione sulle strategie propriamente narrative messe in campo delle scienze umane e sociali. Nel corso saranno quindi affrontate anche le tematiche relative alla accresciuta consapevolezza critica attorno alle retoriche di-scorsive e alla scrittura etnografica intesa come genere.
PrerequisitiNessuno
Programma del corsoIl corso comprende una introduzione storica e critica alla nozione di campo in etnologia e in antropologia. Saranno in particolare prese in considerazione le prime esperienze di ricerca a distanza (uso di fonti prodotte da terzi), indiretta (ricorso a corrispondenti, uso del questiona-rio) e estensiva (il sorvolo, la spedizione), oltre a quelle che hanno progressivamente costitui-to il modello della cosiddetta “osservazione partecipante”, fino ai ripensamenti critici più re-centi.La metodologia della ricerca sarà affrontata attraverso le sue tappe canoniche della costruzio-ne dell’oggetto, dell’osservazione, del rilevamento e del trattamento dei dati costituiti dal ricer-catore sul campo e infine della descrizione etnografica e dell’interpretazione.Gli studenti dovranno familiarizzarsi – anche attraverso la pratica diretta – con le principali tecniche di rilevamento (l’osservazione diretta, il dialogo, l’intervista, la ricostruzione genealo-
219
gica, la registrazione video e audio, la fotografia, la cartografia, il disegno) e con la produzio-ne e l’archiviazione di documenti etnografici
Testi di riferimentoL’esame prevede la preparazione di quattro testi (cinque per i non frequentanti) scelti nelle seguenti liste:
1. Un testo generale a scelta:● Carla Bianco, Dall’evento al documento. Orientamenti etnografici, Roma, Cisu, 1988
(2° edizione 1994).● La ricerca sul campo, dispensa didattica a cura di Fabio Viti (con scritti di M. Busoni,
E.E. Evans-Pritchard, M. Kilani, V.L. Grottanelli, E. Leach, B. Malinowki, S.F. Nadel, G.W. Stocking Jr.).
2. Un testo a scelta:● James Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX
[1988], Torino, Bollati Boringhieri, 1993.● James Clifford, George E. Marcus (a cura di), Scrivere le culture. Poetiche e politi-
che in etnografia [1986], Roma, Meltemi, 1997.● Clifford Geertz, Opere e vite. L’antropologo come autore [1988], Bologna, Il Mulino,
1990.
3. Due testi a scelta:In questa lista figurano (in ordine cronologico) monografie etnografiche pionieristiche, classi-che, esemplari o sperimentali. Altri testi potranno essere aggiunti alla lista.
● Lewis Henry Morgan, La Lega degli Ho-de’-no-sau-nee, o Irochesi [1851], Roma, Cisu, 1998.
● Franz Boas, L’organizzazione sociale e le società segrete degli indiani Kwakiutl [1897], Roma, Cisu, 2001.
● Bronislaw Malinowski, Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidia-na nella società primitiva [1922], Roma, Newton Compton, 1978.
● Edward E. Evans-Pritchard, I Nuer. Un’anarchia ordinata [1940], Milano, Angeli, 1975 (e successive ristampe).
● Marcel Griaule, Dio d’acqua [1948], Como, Red, 1998 (anche Torino, Bollati Borin-ghieri, 2002).
● Claude Lévi-Strauss, Tristi tropici [1955], Milano, Il Saggiatore, 1960 (e successive ristampe)
● Ernesto de Martino, La terra del rimorso [1961], Milano, Il Saggiatore, 1994● Ettore Biocca, Yanoama, Bari, Leonardo da Vinci, 1965● Vincent Crapanzano, Tuhami. Ritratto di un uomo del Marocco [1980], Roma, Melte-
mi, 1995.● Marshall Sahlins, Isole di storia. Società e mito nei mari del Sud [1985], Torino, Ei-
naudi, 1986.● Marc Augé, Un etnologo nel metro [1986], Milano, Elèuthera, 1992.● Patrick Williams, Noi, non ne parliamo. I vivi e i morti tra i Manus [1993], Roma,
CISU, 1997.● Stefano Boni, Vivere senza padroni. Antropologia della sovversione quotidiana, Mila-
no, Elèuthera, 2006.
FrequenzaIl corso di Etnografia presuppone la partecipazione attiva degli studenti, che potranno interve-nire con discussioni di argomenti stabiliti, esposizioni di letture e ricerche personali progettate e svolte sul campo.Gli studenti non frequentanti (coloro cioè che non raggiungono almeno il 75% delle presenze a lezione) dovranno integrare l’esame con lo studio di un testo supplementare da scegliere in
220
una qualsiasi delle liste precedenti.
Modalità d’esameL’esame è orale.
ValutazioneL’esame intende valutare la preparazione dello studente, le sue capacità espositive, la sua padronanza dei concetti della disciplina. La valutazione si basa sulla verifica della conoscen-za critica dei testi prescelti.
Etnolinguistica
Prof. Augusto Carli8 CFU - 60 ore
Obiettivi formativiRiconoscere, analizzare, interpretare e comprendere i rapporti fra gli usi linguistici e le intera-zioni comunicative nelle loro realizzazioni concrete e simboliche all’interno di singole comuni-tà che usano delle lingue storico-naturali. Prerequisiti È indispensabile disporre delle comuni “abilità di studio universitario”, come il saper redigere e gestire relazioni orali e/o scritte su argomenti circoscritti derivanti da letture specifiche dei testi consigliati. Questi possono essere scritti in lingue anche diverse dall’italiano, ma comun-que a scelta dello studente.È auspicata una conoscenza di base delle problematiche e dei metodi di indagine della lingui-stica generale.
Programma del corsoIl programma affronta i rapporti fra lingua e cultura, intesi in senso antropologico come un in-sieme delle conoscenze, delle regole di comportamento e delle categorie di analisi delle real-tà che formano le “visioni del mondo” o “ideologie” condivise da determinate comunità o da loro gruppi o classi sociali. Il programma tiene conto della complessità delle problematiche, degli approcci teorici e delle metodologie di ricerca connaturata alla disciplina stessa. Il lega-me epistemologico privilegiato resta comunque quello dai fenomeni, problemi e metodologie investigative della ricerca linguistica.I principali argomenti del corso scaturiscono dai seguenti ambiti: Rapporto fra lingua e cultura e i suoi legami con l’antropologia culturale e l’etnolinguistica; Riflessi dell’“ideologia” (individuale o sociale) negli stili linguistici individuali e sociali: analisi della comunicazione politica, massmediale, istituzionale, pubblicitaria e affini;Tassonomie linguistiche relative al mondo animale e vegetale; Sistemi terminologici relativi ai rapporti di parentela;Norme sociali e codici comunicativi disponibili.
Testi di riferimentoI seguenti due testi sono obbligatori:
● Giorgio Raimondo Cardona, Etnolinguistica. Torino, UTET 2006 (ma anche edizioni precedenti della casa editrice “Il Mulino”).
● Alessandro Duranti, Etnopragmatica. La forza nel parlare. Roma, Carocci 2007.
A scelta uno dei seguenti testi:● Alessandro Duranti, Antropologia del linguaggio. Roma, Meltemi (edizione del
2000).● Romano Lazzeroni, La cultura indoeuropea. Roma, Laterza.● Bruno Moretti, Ai margini del dialetto. Varietà insviluppo e varietà in via di riduzione
di “inizio di decadimento”. Locarno, Osservatorio linguistico Svizzera Italiana 1999.
221
● David Nettle e Suzanne Romaine, Voci del silenzio. Sulle tracce delle lingue in via di estinzione. Roma, Carocci.
● Elinor Ochs, Linguaggio e cultura. Lo sviluppo delle competenze comunicative. Roma, Carocci 2006.
È sempre possibile concordare una bibliografia sostitutiva a scelta individuale, anche in lingue diverse dall’italiano.
FrequenzaLa frequenza è in generale obbligaroria, almeno in una percentuale minima del 60% di pre-senza alle lezioni.
Programma per i non frequentantiIl programma per i non frequentanti viene concordato individualmente attraverso un colloquio in orario ricevimento del docente.
Modalità d’esameLa valutazione finale avviene attraverso un colloquio orale su singoli aspetti collegati ai conte-nuti svolti.
Etnologia delle culture mediterranee
Docente da definireCFU 6 - 60 ore
Programma da definire
Filosofia morale
Prof.ssa Vallori RasiniCFU 6 – 60 ore
Obiettivi formativiil corso di Filosofia morale intende fornire agli studenti la conoscenza di alcuni strumenti con-cettuali e critici che consentono un orientamento nell’ambito della valutazione del comporta-mento umano e favoriscono la capacità di un confronto autonomo con posizioni e principi di-versi.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoEtica e tecnologia
Il corso si divide in due parti. La prima, avente carattere propedeutico, sarà dedicata all’intro-duzione di alcuni concetti e idee fondamentali per affrontare le questioni della filosofia morale contemporanea; la seconda sarà invece dedicata alla “questione tecnologica”, al modo in cui alcuni importanti esponenti del pensiero filosofico hanno cercato di affrontare i molteplici pro-blemi implicati dall’imponente sviluppo tecnologico cui abbiamo assistito negli ultimi decenni. In particolare, verranno considerati i punti di vista di Günter Anders e di Hans Jonas.
Testi di riferimentoPer gli studenti frequentanti
222
● J. Russ, Etica contemporanea, Bologna, il Mulino, 1996 ● M. Nacci, Pensare la tecnica, Roma-Bari, Laterza, 2000 (parte I)● G. Anders, L’uomo è antiquato, Torino, Bollati Boringhieri, 2003 (vol. 1, pp. 29-120)● H. Jonas, Il principio responsabilità, Torino, Einaudi, 1990 (prefazione dell’autore e
cap. 1● H. Jonas, Sull’orlo dell’abisso, Torino, Einaudi, 1990 ● J.B.S. Haldane, B. Russell, Dedalo o la scienza e il futuro; Icaro o il futuro della
scienza, Torino, Bollati Boringhieri, 1991
FrequenzaObbligatoria
Programma per i non frequentantiIn base alla normativa stabilita dalla Facoltà, coloro che si dichiarano non frequentanti o che comunque non raggiungono la quota del 75% delle frequenze delle lezioni, dovranno portare un programma alternativo da discutere e adattare in accordo con la docente.
Modalità d’esameOrale.
Sociologia dei conflitti interculturali
Prof. Claudio BaraldiCFU 8 - 50 ore
Obiettivi formativiIl corso ha l’obiettivo di creare conoscenze inerenti ai significati dei conflitti, con riferimento alle ideologie ad essi retrostanti, con particolare riferimento ai conflitti interculturali, e alle pos-sibili forme della loro gestione nel quadro di una società multiculturale complessa. PrerequisitiNessuno
Programma del corsoModulo A
Il modulo A (30 ore) tratta i temi dei conflitti e delle ideologie. L’analisi viene condotta anzitutto attraverso una revisione critica della letteratura sociologica su questi temi, considerando in particolare le teorie classiche (Marx, Weber, Scuola di Francoforte), le analisi del discorso ideologico (Foucault, Bourdieu), le teorie interazioniste (Goffman, Garfinkel), la teoria struttu-ral-funzionalista (Durkheim, Parsons), la teoria dei sistemi sociali (Luhmann), alcune teorie in psicologia sociale (Tajfel, Moscovici, Doise e Mugny). Il modulo intende evidenziare: 1) le ori-gini storiche e le caratteristiche delle ideologie e dei conflitti che hanno assunto forme etno-centriche, accomunate dall’interpretazione della contraddizione come contrapposizione tra portatori simbolici di forme culturali diverse, sgradite o considerate minacciose; 2) il passag-gio evolutivo per il quale il conflitto assume nuove forme culturali, più sottili e più variamente gestite.
Modulo B
Il Modulo B sarà incentrato sul tema delle modalità di gestione dei conflitti, con particolare ri-ferimento ai conflitti interculturali (Gudykunst, Ting-Toomey). Il modulo analizzerà le diverse forme di gestione dei conflitti intesi come particolari sistemi di comunicazione, utilizzando ri-ferimenti concettuali di varia provenienza disciplinare ed analizzando conflitti specifici. I mate-riali ed i testi presentati saranno inclusi in percorsi personalizzati e valorizzeranno l’autonomia dei percorsi di studio delle studentesse e degli studenti, pur nel quadro del coordinamento di-
223
dattico della laurea.
Testi di riferimentoLe letture per l’esame potranno essere scelte tra i seguenti testi:
Modulo A● Perre Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 1983.● Michel Foucault, L’ordine del discorso, Einaudi, Torino.● Michel Foucault, Storia della follia nell’età classica, BUR, Milano, 2005● Erving Goffman, Giochi di faccia, in Il rituale dell’interazione, Il Mulino, Bologna,
1988● Erving Goffman, Asylums, Edizioni di Comunità, Torino, 2001.● Max Horkheimer e Theodor Adorno (a cura di), Ideologia, in Lezioni di Sociologia,
Einaudi, Torino, 1966. ● Niklas Luhmann, Struttura sociale e tradizione semantica, in Struttura della società e
semantica, Laterza, Roma, 1983● Niklas Luhmann, Antropologia della prima epoca moderna: soluzioni tecnico-teori-
che del problema della evoluzione della società, in Struttura della società e semanti-ca, Laterza, Roma, 1983
● Niklas Luhmann, Contraddizione e conflitto, in Sistemi sociali, Il Mulino, Bologna, 1992.
● Karl Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, Editori Riuniti, Roma, 1992● Karl Marx, Friedrich Engels, Manifesto del Partito Comunista (varie edizioni)● Serge Moscovici, Psicologia delle minoranze attive, Boringhieri, Bologna, capp. 4, 5,
6● Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Rizzoli, Milano, 2000● Theodore Zeldin, Storia intima dell’umanità, Donzelli, Roma, capp. VIII, IX, X, XI, XII,
XXIV
Modulo B● Kelman H. & Fisher R. (2003). Conflict analysis and resolution. In Sears D.O.,
Huddy L. & Jervis R. (Eds.), Oxford handbook of political psychology. Oxford: Oxford University Press, pp. 315-353.
● Gudykunst W., Bridging Differences. Effective Intergroup Communication, Sage, London, 1994, cap. X.
● Ting-Toomey S. & Kurogi A. (1998). Facework competence in intercultural conflict: An updated face-negotiation theory. International Journal of Intercultural Relations, 22, 187-225.
● Isajiw W.W. (2000) Approaches to ethnic conflict resolution: paradigms and prin-ciples. International Journal of Intercultural Relations, 24, 105-124
● Tjosvold D. & Sun H.F. (2002). Understanding conflict avoidance: Relationship, mo-tivations, actions, and consequences. The International Journal of Conflict Manage-ment, 13, 2, 142-164.
● DeChurch L. & Marks M.M. (2001). Maximizing the benefits of task conflict: the role of conflict management. The International Journal of Conflict Management, 12, 1, 4-22.
● Ayoko O.B., Härtel C.E. & Callan V.J. (2002). Resolving the puzzle of productive and destructive conflict in culturally heterogeneous workgroups: A communication acco-modation theory approach. The International Journal of Conflict Management, 13, 2, 165-195.
● Welsh N.A. & Coleman P.T. (2002). Institutionalized conflict resolution: Have we come to expect too little? Negotiation Journal, 18, 4, 345-350.
● Schoeny M. & Warfield W. (2000). Reconnecting system maintenance with social justice: A critical role for conflict resolution. Negotiation Journal, 16, 3, 253-268.
224
I testi del Modulo B potranno essere sostituiti o integrati da altri articoli su interviste interna-zionali, quali International Journal of Conflict Management, International Journal of Intercultu-ral Relations, Negotiation Journal, oppure da altri testi/articoli suggeriti dagli studenti, in ac-cordo con il docente.
Frequenza In base alla normativa stabilita dalla Facoltà, coloro che si dichiarano non frequentanti o che comunque non raggiungono la quota del 75% delle frequenze delle lezioni, dovranno portare un programma aggiuntivo.
Programma per non frequentantiIl programma per non frequentanti equipara il monte ore trascorso a lezione dai frequentanti. I non frequentanti sono pregati di contattare il docente per concordare programmi personaliz-zati
Modalità d’esame La valutazione finale sarà basato sulla stesura e la discussione di una relazione tra i 20.000 ed i 30.000 caratteri. La relazione può basarsi sui testi dai quali vengono tratti i concetti espo-sti nel corso ed altri articoli scientifici.
Sociologia delle relazioni interculturali
Prof. Claudio CernesiCFU 6 - 60 ore
Obiettivi formativiL’insegnamento del corso di Sociologia delle relazioni interculturali si pone obiettivi formativi volti a collegare la conoscenza dei concetti fondamentali con le metodologie connesse ai pro-cessi legati alla dinamica dell’incontro tra persone di eguale o diversa cultura.In tal senso fornisce conoscenze più specifiche nell’ambito della comunicazione e della comu-nicazione interculturale, in collegamento e come approfondimento dei temi generali affrontati in Sociologia e Sociologia dei processi culturali.Trattandosi di un corso del terzo anno, un obiettivo correlato è fornire un orientamento per la preparazione professionale (teorica e pratica) nel campo della mediazione interculturale. A tal scopo, il corso si integra con un’offerta complementare di tirocini in questo settore e indicazio-ni circa possibili percorsi formativi nell’ambito della tematica della educazione al dialogo e del-lagestione del conflitto.Il corso mira a presentare l’approccio interculturale come ricerca tesa alla valorizzazione della differenza dell’altro diverso da me.La relazione con l’altro viene considerata sia per persone della mia o di altra cultura di origi-ne.Verrà trattata la tematica dell’immagine dell’altro nella società occidentale, della comunicazio-ne come processo di ricerca di significati, il processo di apprendimento reciproco, la variabile dell’ascolto reciproco per un dialogo interculturale, alcuni riferimenti di teoria e metodo della progettazione.Sarà proposta un’analisi di casi sia inerenti all’immigrazione, sia a forme di cooperazione in-terculturale e di educazione interculturale.Potranno anche essere ripresi concetti legati all’incontro tra persone di diversa appartenenza culturale e i concetti di popolo, cultura, identità etnica ed identità personale con precisazioni complementari su alcuni concetti già esplorati nei corso di Sociologia e Sociologia dei proces-si culturali, quali i processi di colonizzazione, il neocolonialismo, le interdipendenze globali.Si potrà avere quindi un approfondimento dei rapporti tra struttura della società ed immagina-rio culturale, la produzione di differenti identità culturali attraverso il processo educativo, il
225
nesso tra cultura e memoria
PrerequisitiNessuno
Programma del corsocolonialismo e neocolonialismo (ripresi dagli insegnamenti propedeutici), identità etnica e identità personale (ripresi dagli insegnamenti propedeutici), presentazione, discussione e analisi di casi,immagine dell’altro e formazione del pregiudizio, immigrazione e comunicazione,comunicazione come processo di ricerca di significati condivisi,ascolto, parola, dialogo,rapporto tra cultura ed educazione,approccio interculturale come processo di apprendimento reciproco,mediazione e relazione d’aiuto,approccio alla progettazione Testi di riferimentoBibliografia per studenti frequentanti:
● Perotti; La via obbligata dell’interculturalità; EMI .● Favaro – Luatti; L’intercultura dalla A alla Z; FrancoAngeli.● D. Pennac; L’occhio del lupo; Salani.● Dispense fornite in aula.● Bibliografia per studenti non frequentanti:● Perotti; La via obbligata dell’interculturalità; EMI .● Favaro – Luatti; L’intercultura dalla A alla Z; FrancoAngeli.● E. Garcia; La comunicazione interculturale; Armando Ed.● R. Panikkar; Pace e intercultura; Jaca Book.● D. Pennac; L’occhio del lupo; Salani.
Modalità d’esameLa prova d’esame orale prevede lo studio dei seguenti testi:Come testo di orientamento generale per tutti gli studenti,
● K. D. Bracher, Il Novecento secolo delle ideologie, Roma-Bari, Economica Laterza, 2002 (la Introduzione e le prime due parti), che sarà affiancato da un altro testo a scelta per gli studenti frequentanti, e due a scelta, per i non frequentanti, tra quelli sotto indicati:
● O. Bauer, La questione nazionale, a cura di N. Merker, Roma, Editori Riuniti, 1999: le due Prefazioni e il Cap. I, La nazione.
● R. Brubacher, I nazionalismi nell’Europa contemporanea, Roma, Editori Riuniti, 1998: Parte I, Cap. 3, Minoranze nazionali, Stati nazionalizzatori e patrie nazionali esterne nella nuova Europa; Parte II, Cap. 1, Stati nazionalizzatori nella vecchia “Nuova Europa” e nella nuova.
● Campi, Nazione, Bologna, il Mulino, 2004: Premessa e Cap. V, Novecento.● E. Gentile, La Grande Italia, Milano, Oscar Saggi Mondadori, 1999: Parte II, Quale
Italia? (cap. IV-VII)..● G. Haupt, L’Internazionale socialista dalla Comune a Lenin, Torino, Einaudi, ultima
edizione: gli ultimi due capitoli (Guerra o rivoluzione? L’Internazionale e l’Union sa-crée nell’agosto del 1914; Guerra e rivoluzione in Lenin).
● Th. Herzl, Lo stato ebraico; Genova, Il melangolo, 2003● E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi, Torino, Einaudi, ultima edizione: Cap. V,
L’apogeo del nazionalismo.● Ž. e R. Medvedev, Stalin sconosciuto, Milano, Feltrinelli, 2006: Cap. 13, Stalin nazio-
nalista russo e Postfazione, Stalin e i suoi interpreti
226
● G. L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, Bologna, il Mulino, ultima edizione: Cap. VII, Il contributo dei lavoratori; Cap. VIII, I gusti di Hitler; Cap. IX, Il culto politi-co.
● Panaccione, Socialisti europei, Milano, FrancoAngeli, 2000: Cap. 1, La trasformazio-ne dell’internazionalismo socialista dalla prima guerra mondiale; Cap. 5, Crisi della democrazia, antifascismo, Unione Sovietica.
● Z. Sternhell, La nascita di Israele, Milano, Baldini & Castoldi, ultima edizione: Intro-duzione. Nazionalismo, socialismo e socialismo nazionalista.
● M. Weber, La scienza come professione. La politica come professione, Milano, Oscar Mondadori, 2006.
● H.-U. Wehler, Nazionalismo. Storia, forme, conseguenze, Torino, Bollati Boringhieri, 2002: Cap. 7, Tipologie del nazionalismo; Cap. 8, La storia dello sviluppo del nazio-nalismo.
FrequenzaConsigliata
ValutazioneGli studenti frequentanti dovranno rispondere per iscritto ad alcune domande che permettono di focalizzare alcuni aspetti centrali del percorso.La prova orale integrerà quanto necessario per la valutazione finale.Gli studenti non frequentanti vengono valutati con le stesse modalità ma si ampliano i testi da preparare (vedi bibliografia).Sia i frequentanti che i non frequentanti potranno concordare percorsi di ricerca specifici o svolgere relazioni su alcuni temi trattati, in modo tale da sperimentare concretamente gli stru-menti teorici e metodologici messi a disposizione durante il corso.
Storia delle dottrine politiche
Prof. Andrea PanaccioneCFU 4 - 30 ore Mutuato da Analisi dei conflitti, delle ideologie e della politica nel mondo contemporaneo)
Obiettivi formativiIl corso dovrà fornire agli studenti un orientamento generale sulla storia del pensiero politico dell’età contemporanea e permettere l’acquisizione di strumenti e metodi di ricerca e di appro-fondimento sul processo di trasformazione delle idee politiche in ideologie dei movimenti di massa, sul ruolo degli intellettuali in questo processo, sulla funzione svolta dalle ideologie nei processi di Nation- e di State-building.
PrerequisitiNessuno
Programma del corsoSocialismi e nazionalismi nella storia del ’900Il corso sarà articolato in una parte di riferimenti generali sulle principali correnti del pensiero politico nell’età contemporanea e in una parte più specificamente dedicata alle ideologie e culture politiche dei movimenti di ispirazione socialista, nazionale e nazionalista, attraverso l’esame sia degli elementi di contrapposizione ideale e politica tra questi movimenti sia dei loro intrecci e contaminazioni in alcune congiunture della storia del ’900 (le questioni nazionali e le forme della mobilitazione politica, i socialismi nazionali, i passaggi di campo da un movi-mento all’altro, l’idea di patria nel movimento operaio, ecc.) sia del ruolo delle ideologie nei processi di Nation- e di State-building. Uno specifico approfondimento sarà dedicato al ruolo degli intellettuali nei movimenti politici di massa e alla questione dell’impegno degli intellettuali
227
nel ’900. L’analisi dei testi di riferimento indicati sarà integrata da alcuni materiali e documenti messi a disposizione dal docente. Gli studenti interessati saranno guidati nella stesura di un elaborato scritto nell’ambito dei contenuti del corso.
Testi di riferimentoCome testo di orientamento generale per tutti gli studenti,
● K. D. Bracher, Il Novecento secolo delle ideologie, Roma-Bari, Economica Laterza, 2002 (la Introduzione e le prime due parti),
che sarà affiancato da un altro testo a scelta per gli studenti frequentanti, e due a scelta, per i non frequentanti, tra quelli sotto indicati:
● O. Bauer, La questione nazionale, a cura di N. Merker, Roma, Editori Riuniti, 1999: le due Prefazioni e il Cap. I, La nazione.
● R. Brubacher, I nazionalismi nell’Europa contemporanea, Roma, Editori Riuniti, 1998: Parte I, Cap. 3, Minoranze nazionali, Stati nazionalizzatori e patrie nazionali esterne nella nuova Europa; Parte II, Cap. 1, Stati nazionalizzatori nella vecchia “Nuova Europa” e nella nuova.
● Campi, Nazione, Bologna, il Mulino, 2004: Premessa e Cap. V, Novecento.● E. Gentile, La Grande Italia, Milano, Oscar Saggi Mondadori, 1999: Parte II, Quale
Italia? (cap. IV-VII)..● G. Haupt, L’Internazionale socialista dalla Comune a Lenin, Torino, Einaudi, ultima
edizione: gli ultimi due capitoli (Guerra o rivoluzione? L’Internazionale e l’Union sa-crée nell’agosto del 1914; Guerra e rivoluzione in Lenin).
● Th. Herzl, Lo stato ebraico; Genova, Il melangolo, 2003.● E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi, Torino, Einaudi, ultima edizione: Cap. V,
L’apogeo del nazionalismo.● Ž. e R. Medvedev, Stalin sconosciuto, Milano, Feltrinelli, 2006: Cap. 13, Stalin nazio-
nalista russo e Postfazione, Stalin e i suoi interpreti.● G. L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, Bologna, il Mulino, ultima edizione:
Cap. VII, Il contributo dei lavoratori; Cap. VIII, I gusti di Hitler; Cap. IX, Il culto politi-co.
● Panaccione, Socialisti europei, Milano, FrancoAngeli, 2000: Cap. 1, La trasformazio-ne dell’internazionalismo socialista dalla prima guerra mondiale; Cap. 5, Crisi della democrazia, antifascismo, Unione Sovietica.
● Z. Sternhell, La nascita di Israele, Milano, Baldini & Castoldi, ultima edizione: Intro-duzione. Nazionalismo, socialismo e socialismo nazionalista.
● M. Weber, La scienza come professione. La politica come professione, Milano, Oscar Mondadori, 2006.
● H.-U. Wehler, Nazionalismo. Storia, forme, conseguenze, Torino, Bollati Boringhieri, 2002: Cap. 7, Tipologie del nazionalismo; Cap. 8, La storia dello sviluppo del nazio-nalismo.
FrequenzaConsigliata
Modalità d’esameLa prova d’esame è orale.
ValutazioneAttraverso la prova finale, ma tenendo conto anche di eventuali elaborazioni scritte presenta-te durante il corso
228
Storia della filosofia (Teorie della pace e della guerra)
Prof. Antonello La VergataCFU 8 - 60 ore
Mutuato da Analisi dei Conflitti, delle Ideologie e della Politica nel Mondo Contemporaneo
Obiettivi formativiIl corso intende offrire un panorama delle immagini e delle dottrine della guerra e della pace nella cultura contemporanea (grosso modo a partire dalla Rivoluzione francese), prendendo in esame testi di filosofi, scienziati, sociologi, psicologi, antropologi e scrittori. L’impostazione è quella interdisciplinare della storia delle idee.
Prerequisiti Nessuno
Programma del corsoIl corso è articolato in moduli. A 20 ore di lezioni di argomento generale seguiranno 20 ore di analisi e discussione dei testi di riferimento. Le ultime 20 ore saranno dedicate a esercitazioni in forma di seminario, in cui gli studenti svolgeranno relazioni su argomenti specifici concor-dati con il docente.
Testi di riferimento● N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, Il Mulino, 1991.● R. Crépon, Le religioni e la guerra, Genova, Il Melangolo, 1991.● I. Eibl-Eibesfeldt, Etologia della guerra, Torino, Bollati Boringhieri, 1983.● A. La Vergata, Guerra e darwinismo sociale, Soneria Mannelli, Rubbettino, 2005.● A. La Vergata, Pace e guerra, in A. La Vergata, F. Trabattoni (a cura di), Filosofia e
cultura, Firenze, La Nuova Italia, 2007, vol. 3b, pp. 676-686.● D. Pick, La guerra nella cultura contemporanea, Bari, Laterza, 1994.
A scelta, uno dei seguenti:● M. Isnenghi, Il mito della Grande Guerra, Bologna, Il Mulino, 1997; sesta ed. 2007.● P. Fussell, La Grande Guerra e la memoria moderna, Bologna, Il Mulino, 1984; nuo-
va ed. 2000.
Per un inquadramento generale e per supplire a eventuali carenze delle proprie informazioni di base sulla storia della filosofia e della cultura dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri, lo studente è invitato a servirsi delle parti che riterrà utili di A. La Vergata, F. Trabattoni (a cura di), Filosofia e cultura, Firenze, La Nuova Italia, 2007.
FrequenzaFacoltativa
Programma per i non frequentantiI non frequentanti dovranno portare all’esame entrambi i testi di Isnenghi e Fussell sopra in-dicati e uno a scelta fra i seguenti:
● M. Harris, Cannibali e re. Le origine delle culture, Milano, Feltrinelli, 1988.● M. Sahlins, The use and abuse of biology. An anthropological critique of sociobio-
logy, London, Tavistock Publications, 1977; trad. it. Critica della sociobiologia, Tori-no, Loescher, 1985.
● K. Lorenz, L’aggressività, Milano, Il Saggiatore- Bruno Mondadori● C. Vogel, Anatomia del male. Natura e cultura dell’aggressività, Milano, Garzanti,
1989.
229
● E.J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 1985.
● Gibelli, L’officina della guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo men-tale, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.
● M.K. Gandhi, Teoria e pratica della non violenza, scritti scelti a cura di G. Pontata, Torino, Einaudi, 1997
● D. Losurdo, La comunità, la morte, l’Occidente. Heidegger e l’”ideologia della guer-ra”, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.
● Kant, Per la pace perpetua, a cura di N. Bobbio, Roma, Editori Riuniti, 1992 (o altre edizioni, purché integrali).
● S. Freud, Il disagio della civiltà, Torino, Bollati Boringhieri, varie edizioni.● W.B. Gallie, Filosofie di pace e di guerra, Bologna, Il Mulino, 1993.
Modalità d’esameRelazioni orali o scritte durante il corso (v. sopra) ed esame orale finale
ValutazioneIl candidato dovrà dimostrare nelle relazioni e nel colloquio finale 1) una conoscenza appro-fondita dei testi letti, 2) capacità di esporre i contenuti in modo chiaro, rigoroso e conciso e di analizzarli criticamente inserendoli in un contesto storico-culturale problematico.
Storia delle teorie antropologiche
Prof.ssa Valeria Ribeiro CorossaczCFU 4 - 30 ore
Obiettivi formativiIl corso si propone di fornire agli studenti un quadro complessivo della formazione e delle evoluzioni della disciplina antropologica. A questo scopo si presenteranno le più significative teorie e scuole di pensiero antropologiche a partire dalla fine del XIX secolo fino agli orienta-menti contemporanei situandole nella loro epoca storica.
PrerequisitiNessuno
Programma del corsoA partire dalle origini del tardo XIX secolo, saranno esaminati i principali autori e orientamenti che hanno caratterizzato la storia dell'antropologia: le correnti evoluzioniste (Tylor, Morgan), il “particolarismo storico” di Boas, le prime esperienze di ricerca sul campo, la scuola “sociologi-ca” francese (Durkheim, Mauss), l’antropologia “culturale” americana, l’antropologia funziona-lista britannica (Malinowski, Radcliffe-Brown), l’intreccio tra ricerca sul campo e colonialismo, lo strutturalismo (Lévi-Strauss), l’antropologia marxista, l’antropologia in Italia, e i più recenti orientamenti dell’antropologia femminista e post-moderna.
Testi di riferimentoProgramma obbligatorio per tutti.
● Ugo Fabietti, Storia dell’antropologia, Bologna, Zanichelli, 1991 [seconda ediz., 2001].
● Nicole-Claude Mathieu, “Critiche epistemologiche sulla problematica dei sessi nel di-scorso etno-antropologico”, in dwf, Donne Ritrovate, numero 10-11, 1989, pp. 8-54.
● Mila Busoni, “Etnografia e genere”, in Genere, Sesso, Cultura, Uno sguardo antro-pologico, 2000, Roma, Carocci , pp.133-163.
● James Clifford, “Introduzione: verità parziali”, in James Clifford e George Marcus (a
230
cura di), Scrivere le culture. Poetiche e politiche in etnografia, Roma, Meltemi, 1997, pp. 23-52
Il testo di Mathieu sarà messo a disposizione dalla docente.
FrequenzaLa frequenza alle lezioni è altamente consigliata. Si considera frequentante chi ha frequentato il 75% delle lezioni.
Programma per i non frequentantiGli studenti non frequentanti dovranno aggiungere alla bibliografa d’esame un saggio a scelta tra i seguenti:
● Mila Busoni, “Contro l’androcentrismo. Il progetto critico femminista in antropologia”, in Genere, Sesso, Cultura, Uno sguardo antropologico, 2000, Roma, Carocci , pp.97-132.
● Sandra Puccini, “Evoluzionismo e positivismo nell’antropologia italiana (1869-1911)”, in L’antropologia italiana. Un secolo di storia, 1985, Roma-Bari, Laterza, pp. 97-148.
Modalità d’esameEsame orale.
ValutazioneLa valutazione si baserà sull'esame orale e sulla partecipazione alle attività didattiche.
Teoria e metodi del dialogo e della mediazione
Prof. Claudio BaraldiCFU 6 - 60 ore
Mutuato da Scienze della CulturaObiettivi formativiIl corso si propone di fornire le competenze teoriche e pratiche per (1) la progettazione, (2) la metodologia di realizzazione e (3) l’analisi valutativa di interventi dialogici e di mediazione, realizzati in organizzazioni complesse (come scuole, organizzazioni per la cooperazione, coo-perative, associazioni, imprese, organizzazioni internazionali) e su uno specifico territorio (in paesi europei o in aree nelle quali si richiede cooperazione per lo sviluppo), con particolare ri-ferimento alla dimensione interculturale.Il corso mira a fornire competenze di ricerca e competenze professionali utili per l’inserimento in équipe di progettazione ed intervento dialogico e di mediazione, con particolare riferimento alle relazioni interculturali, in Italia, in Europa ed in Paesi extra-europei.
PrerequisitiPer studentesse e studenti del corso di laurea di Scienze della Cultura: è possibile sostenere l’esame soltanto dopo aver sostenuto gli esami di Sociologia e Sociologia dei processi cultu-rali.
Programma del corsoIl corso è suddiviso in tre moduli. Il primo modulo (20 ore) tratta il tema della progettazione e della realizzazione di interventi dialogici e di mediazione: in particolare, vengono illustrate le componenti metodologiche delle “buone pratiche” di progettazione e di intervento, confrontan-do diversi approcci teorici e metodologici. Il secondo modulo (10 ore) è dedicato alle metodo-logie e alle tecniche di osservazione e di analisi valutativa dei processi e dei risultati degli in-terventi. Il terzo modulo (30 ore) presenta una serie di casi specifici di analisi del dialogo e della mediazione e consente di confrontare pratiche diverse, con particolare riferimento al-l’ambito interculturale. Saranno presentati materiali sui temi fondamentali del corso, introdu-cendo e commentando esperienze di progettazione ed intervento interculturale in Italia (edu-
231
cazione interculturale, mediazione linguistico-culturale, educazione alla pace) e nelle aree di cooperazione e negoziazione internazionali (in particolare, Organizzazioni non Governative per lo Sviluppo e Nazioni Unite). Nel complesso, il corso intende articolare concetti teorici ed analisi di esperienze empiriche, discutendo metodi e strumenti per realizzare progetti, inter-venti ed analisi valutative. Il corso può essere raccordato allo svolgimento di tirocini proposti dal docente (secondo un programma che sarà illustrato all’inizio delle lezioni), oppure suggeriti dagli studenti.
Testi di riferimento ● Lorenzo Luatti (a cura di), Atlante della mediazione linguistico-culturale, FrancoAn-
geli, Milano, 2006. ● C. Baraldi (a cura di), Il dialogo in classe, Donzelli, Roma, 2007
Come integrazione di uno dei testi o in alternativa ai testi proposti, è possibile concordare pro-grammi ad hoc sulla base delle esigenze specifiche delle studentesse e degli studenti.
Frequenza In base alla normativa stabilita dalla Facoltà, coloro che si dichiarano non frequentanti o che comunque non raggiungono la quota del 75% delle frequenze delle lezioni, dovranno portare un programma aggiuntivo.
Programma per non frequentantiIl programma per non frequentanti equipara il monte ore trascorso a lezione dai frequentanti (equivalenti a 60 ore di frequenza). Il programma è il seguente:
● Lorenzo Luatti (a cura di), Atlante della mediazione linguistico-culturale, FrancoAn-geli, Milano, 2006.
● C. Baraldi (a cura di), Il dialogo in classe, Donzelli, Roma, 2007.
Uno a scelta tra i seguenti:● C. Rogers, Terapia centrata sul cliente, La Nuova Italia, Firenze, 1997 (capp. I, II, III,
IV e VI) + T. Gordon, Relazioni efficaci, Meridiana, Bari, 2005.● Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruono Mondatori, 2003● Daniel Goleman, Intelligenza sociale, Rizzoli, 2006.
Modalità d’esame Per l’esame finale, sono disponibili due opzioni: 1) esame orale; 2) relazione (tra i 20.000 ed i 30.000 caratteri a stampa) contenente un’analisi valutativa di un progetto o di un intervento di mediazione, sulla base di testi e materiali concordati con il docente.
232