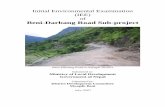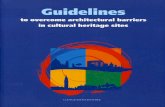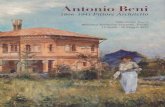UMAN Linea guida per la corretta manutenzione di estintori ...
TECNOLOGIA GIS PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI BENI CULTURALI
Transcript of TECNOLOGIA GIS PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI BENI CULTURALI
PPC Conference 2014
1
TECNOLOGIA GIS PER LA MANUTANZIONE PROGRAMMATA DEI BENI CULTURALI
Laura Baratin*, Sara Bertozzi*, Elvio Moretti* * Scuola di Conservazione e Restauro, DiSBEF - University of Urbino, “, Piaz-za della Repubblica, 13 - 60129 Urbino, Italia, [email protected]; [email protected]; [email protected]
Abstract La conservazione dei beni culturali, in particolare architettonici ed
archeologici, non può prescindere da una gestione integrata di tutti gli aspetti che li riguardano e che possono susseguirsi nel tempo. Tra gli strumenti informatici, sempre in continua evoluzione, ArcGIS di ESRI è il software per l’analisi e la elaborazione dati che può offrire le più svariate e complesse potenzialità, riunite e organizzate per la gestione dati in ambito 2d (ArcMap) e 3d (ArcScene) applicabili in genrale a contesti urbani storicizzati per la documentazione e la gestione di infromazioni di diversa natura sul patrimonio. A partire da questi strumenti si propone, quindi, una metodologia basata su una sequenza logico-operativa di azioni mirate all’acquisizione di dati di rilievo geometrico-formale, al loro inserimento, alla loro organizzazione, all’analisi qualitativa e quantitativa nelle diverse scale di dettaglio. Tutti gli elementi architettonici e/o archeologici in pianta e in prospetto vengono gestiti contemporaneamente nella loro conformazione reale, georeferenziati e resi interrogabili. I software di modellizzazione tridimensionale sono sempre più diffusi ma ciò che ancora in ambiente GIS non è stato sviluppato, in modo esauativo, è la possibilità di organizzare, gestire e interrogare gli elementi reali delle strutture architettoniche, come direttamente rilevate sul terreno e rappresentate graficamente, mantenendo la loro posizione corretta in ambiente tridimensionale. In questo lavoro non si vuole affrontare il problema della modellizzazione ma piuttosto quello della gestione dei dati bidimensionali e tridimensionali, da una parte planimetrie associate a modelli morfologici del terreno attraverso TIN e dall’altra prospetti e seszioni, elaborate, organizzate e georeferenziate in 2d tramite Arcmap per poi essere visualizzate e interrogate in ambiente 3d tramite Arcscene. Si raccolgono così tutte le informazioni quali-quantitative di un’opera legate principalmente allo stato di conservazione dei materiali costitutivi, alla localizzazione e tipologia degli interventi eseguiti, al controllo dello stato complessivo del manufatto, per una stima del grado di urgenza di eventuali interventi e per una loro programmazione, ottenendo così
A cura dell’editore
2
una efficace gestione integrata del bene. Il complesso geodatabase creato deve essere implementato nel tempo con rilievi periodici, per consentire di valutare le trasformazioni diacroniche dello stato di conservazione e di altri fenomeni monotorati. Diversi casi di studio sono stati sviluppati per verificare l’applicabilità del metodo, sia come beni architettonici è il caso del Portico di San Francesco a Urbino, sia come beni archeologici nell’esempio dell’arco romano di Tiro in Libano.
GIS e beni culturali: problematiche generali Le attività di manutenzione e di conservazione programmata fanno
riferimento ad una vasta letteratura a studi approfonditi ed esperienze condotte, in questi ultimi anni, in diverse parti d’Italia dove la manutenzione è vista “non tanto come preventiva definizione di un modello astratto, ma come pragmatica possibilità di trovare risposte efficaci al problema della tenuta in esercizio del patrimonio edificato, sia alla scala edilizia che alla scala territoriale. Dal punto di vista organizzativo ma anche da quello operativo, infatti, le attività di manutenzione, se attuate secondo adeguate strategie, sono in grado di massimizzare i risultati in termini di conservazione, fruizione e valorizzazione del costruito in relazione ai diversi casi applicativi ..” (Gasparoli 2011)
A partire dal “restauro preventivo” di Cesare Brandi, Giovanni Urbani mise a punto una tecnica che chiamò “conservazione programmata”, che propone il controllo sistematico delle condizioni in cui versa l’ambiente di conservazione, “per rallentare quanto più possibile la velocità dei processi di deterioramento, intervenendo in pari tempo e se necessario con trattamenti manutentivi appropriati ai vari tipi di materiali”, fino ad arrivare alle recenti sperimentazioni della regione Lombardia e agli scritti di Stefano della Torre.
La conservazione programmata, in sintesi, mira ad arginare le emergenze dei danni sui monumenti, tramite azioni di prevenzione, che vanno valutate di volta in volta, studiando i materiali che costituiscono il monumento, nella loro interazione con i fattori di deterioramento ambientale. Attraverso controlli programmati e periodici, si valuta la validita delle misure adottate nella fase di programmazione, e si registrano le eventuali trasformazioni subite dal manufatto analizzato nel suo contesto. Si parla anche in termini normativi di “Piano di Manutenzione” di “Programma di Conservazione” quali strumenti di raccolta dei dati e delle valutazioni necessarie all’elaborazione di un programma vero e proprio, che deve contenere informazioni sulle modalità e sulla tempistica dei controlli da eseguire per assicurare che le riparazioni avvengano in tempo utile per minimizzare i danni.
PPC Conference 2014
3
Conservazione, pianificazione, gestione, focus fondamentali rivolti al patrimonio storico da preservare e valorizzare. L’Information Technology sta facendo continui passi avanti in questa direzione tentando di giungere ad una restituzione il più possibile conforme alla realtà rappresentata, nell’ottica di un’analisi approfondita delle caratteristiche di un bene per una programmazione di breve, medio e lungo periodo finalizzata alla conservazione, al restauro e conseguentemente alle politiche e alle pratiche di utilizzo, di fruizione e di valo-rizzazione. In questo contesto la terza dimensione rappresenta una delle sfide della cartografia moderna se associata ad un uso non soltanto “scenico”, ma a supporto della conoscenza e alle pratiche di tuela.
In questa ricerca è stata utilizzata una piattaforma ArcGIS di ESRI, per l’organizzazione, l’elaborazione e la gestione dei dati caratterizzanti sia un bene architettonico è il caso del Portico di San Francesco a Urbino, sia un bene archeologicio complesso prendendo ad esmepio i siti archeologici di Balbeeck e Tiro in Libano ed in particolare l’arco romano di Tiro.
Lo scopo è quello di creare un unico “contenitore” che riesca ad immagazzinare una grande mole di dati riguardanti un determinato sito o bene culturale, rilievi, database relazionali, fotografie, ortofoto, cartografie storiche analisi scientifiche, ecc.., ma soprattutto si vuole giungere a una gestione integrata e contemporanea di tutte le infromazioni sia in planimetria che in altimetria.
Un'importante caratteristica dei GIS, resa evidente dall'esigenza di documentare i sempre più diffusi interventi di trasformazione urbana, è proprio quella di integrare le funzioni di rappresentazione e analisi tridimensionale del dato metrico ad un elevato livello di dettaglio compatibile con le esigenze di documentazione dei beni culturali. Non si può infatti esulare dalla fase di analisi anche della terza dimensione, ma non tanto, come sempre più spesso avviene, nel concetto di modellizzazione o ricostruzione virtuale, quanto piuttosto di analisi e gestione degli elementi planimetrici e altimetrici, nelle loro componenti compositive, nei fenomeni di degrado, nelle proposte di intervento e così via, con una particolare attenzione alla loro conformazione geometrica e areale.
Le problematiche affrontate pertanto spaziano dalla definizione degli standard cui il modello deve rispondere, all'integrazione di differenti tecnologie, dalla determinazione del livello di dettaglio, alla definizione di procedure di importazione, alla struttura del database.
GIS alcuni aspetti di metodo: i due casi analizzati
A cura dell’editore
4
Tutte le caratteristiche rappresentative di un sito e/o di un manufatto architettonico vengono organizzate in progetti separati, ma integrabili, identificabili in due moduli, uno di rappresentazione territoriale (MRT) e l’altro di rappresentazione architettonico/archeologico (MRA). Tutte le tipologie di attributi alle diverse scale vengono implementate nella loro collocazione geografica, creando un completo Geodatabase in grado di inglobare tutta la cartografia e la documentazione del sito in un unico Modello Dati, in cui vengono memorizzate anche regole e relazioni (sulle features o sugli attributi). Il GeoDB offre svariate potenzialità, permette di creare regole per l’inserimento guidato degli attributi (Domini e sottotipi, i classici “menù a tendina”), regole di validazione topologica per quanto riguarda l’editing delle features, consente di avere un oggetto scalabile, sia Personal (file ACCESS .mdb) che Enterprise o multiutente e infine l’editing multiutente permette a due o più utenti di editare sulla stessa feature class segnalando ad entrambi eventuali operazioni conflittuali. Nella gestione di un bene culturale questo processo consente di riunire tutte le informazioni, definendone le caratteristiche topologiche e, in caso di necessità, di associare delle immagini in tabella degli attribuiti a ogni record. In questo modo, andando a selezionare un determinato elemento, si potranno immediatamente visualizzare le informazioni geografiche, geometriche, alfanumeriche e documentali.
A questo scopo sono stati definiti una serie di passaggi metodologici in grado di standardizzare le varie fasi di acquisizione e di organizzazione dei dati relativi ad un bene archeologico o architettonico fino a giungere alla gestione con relative analisi ed interrogazioni dei dati esistenti. Sono stati integrati i diversi software offerti dalla piattaforma ArcGIS di ESRI per elaborare dati planimetrici e altimetrici, arrivando a una loro integrazione nell’ottica della conservazione e valorizzazione
Si è partiti dalla definizione del sistema di georeferenziazione da utilizzare, punto di partenza basilare nell’organizzazione di un qualunque GIS, identificando il più appropriato nel WGS84 con proiezione UTM. La scelta è dettata dal fatto che il WGS84 è l’unico sistema basato su un ellissoide globale, riconosciuto internazionalmente, elemento che consente di superare la settorialità del lavoro su scala nazionale, consentendo una fondamentale interoperabilità e possibilità di scambio di dati. Essendo però questo un sistema geografico, opera con coordinate decimali che non consentono elaborazioni areali sugli elementi, per questo si è deciso di utilizzare un sistema di proiezione metrico basato sempre sullo stesso ellissoide, l’UTM, sicuramente il più conosciuto a scala internazionale.
PPC Conference 2014
5
Il metodo prevede una prima fase di elaborazione di tutti i dati di input in due progetti separati, uno per le planimetrie, ed uno per le rappresentazioni in alzato, nel software base della piattaforma ESRI, ArcMap. Vengono quindi importati, processati e georeferenziati tutti i dati disponibili, riportanti le geometrie di rilievo, carte topografiche, ortofoto, cartografie storiche, carte tematiche ecc.. La diversa tipologia di dati subisce un certo processamento, soprattutto nel caso di file *.dwg, che devono essere trasformati in shapefile, riorganizzati geometricamente, con trasformazioni in termini topologici da polyline a poligoni, la definizione di tutte le regole sulla disposizione degli elementi e a livello di tabelle degli attributi, l’inserimento di tutte le informazioni nei diversi campi. Si ottiene in questo modo una cartografia dinamica che mantiene tutte le caratteristiche degli elementi che compongono l’ogggetto: fenomeni di degrado, datazioni specifiche, interventi puntuali e qualsiasi altra informazione riguardante un certo elemento; tutto viene inserito e gestito da un’unica tabella degli attributi e si possono ottenere mappe con diverse colorazioni e simboli selezionati, semplicemente inserendo il campo di interrogazione tramite apposite Query e salvando le diverse scale di colore in formato lyr. Per concludere il lavoro di elaborazione sulle planimetrie sono stati creati modelli digitali del terreno, DEM e TIN, a partire da reti di punti quotati e isoipse, che potranno poi essere utilizzati nel progetto 3D come base morfologica, Base Height, di tutta la cartografia in pianta, vettoriale (shapefile e dwg) o raster (ortofoto, carte storiche ecc.).
Sistemato il progetto per la parte planimetrica, in ambiente bidimensionale, si procede con l’elaborazione degli alzati, il cui formato è per la maggior parte in file .dwg. si sottolinea che in questa fase non si agisce all’interno di un progetto georeferenziato, ma si utilizza semplicemente il sistema di coordinate cartesiane XY, definendo le unità di misura utilizzate in ambiente CAD ricorrendo se necessario ad eventuali scalature. Il concetto base in ambainte GIS è che anche un prospetto si trova su un piano bidimensionale, semplicemente posizionato verticalmente. Si utilizza perciò il piano XY come fosse un ipotetico piano XZ, su cui si trova posizionato il nostro rilievo; si effettuano tutte le elaborazioni necessarie per questo passaggio per poi poterlo georeferenziare, visualizzare ed interrogare nella sua configurazione e posizione corretta in ArcScene. I file in formato .dwg sono esportati come shapefile e trasformati in poligoni, vengono poi traslati fino a livello di uno shapefile di base corrispondente all’asse X, per consentirci di attribuire le altezze relative necessarie per il posizionamento dell’elemento sul piano verticale, organizzando adeguatamente anche le tabelle degli attributi come per le piante. Le fasi
A cura dell’editore
6
successive sono gestite attraverso un apposito strumento creato tramite un’applicazione di ArcGIS chiamata ModelBuilder, in grado di definire una serie di passaggi ripetibili per casi definiti evitando operazioni che devono essere ripetute in serie, come nei nostri casi, ad esempio lo split dei vertici degli shape (uno “spezzettamento” in piccolissimi elementi definiti dai nodi dei poligoni o delle polilinee), l’attribuzione automatica delle altezze riferite all’asse X, la trasformazione in elementi 3D e la costruzione dei relativi poligoni. Questi ultimi andranno poi controllati nelle loro caratteristiche di attributi per assicurarsi una corrispondenza nella tabella e procedere in caso a operazioni di Spatial Join per ottenere le informazioni dagli shape sottostanti.
In questa fase gli elementi così trasformati avranno al loro interno le informazioni tridimensionali per poter essere visualizzati in ambiente 3D, anche se non ancora con una corretta georeferenziazione.
Prima di passare all’ultima fase è importante effettuare una serie di analisi statistiche sull’occupazione areale e le caratteristiche composizionali dei vari elementi, sia in pianta che in prospetto per poter sfruttare nel progetto GIS la possibilità di un contemporaneo utilizzo delle funzionalità connesse agli attributi degli oggetti rispetto al loro posizionamento spaziale. Attraverso appositi tools è possibile ad esempio indagare come i valori degli attributi siano distribuiti e la presenza di eventuali tendenze o modelli spaziali dei dati; a differenza delle query, che consentono semplicemente di identificare o selezionare un dato, l’analisi statistica rivela le caratteristiche di un insieme di oggetti nel suo complesso. L’analisi statistica è spesso utilizzata per esaminare la distribuzione dei valori di un attributo particolare o per individuare valori anomali, definire classi e intervalli su una pianta o un prospetto, ricercare errori nella digitalizzazione degli oggetti o nella costruzione del database. È inoltre possibile creare “riepiloghi spaziali”, come ad esempio il calcolo della media della dimensione delle pietre o il numero delle patch che costituiscono una certa area di indagine, utili per giungere a una migliore comprensione delle condizioni di degrado di un bene e per valutarne i tempi e i costi di eventuali interventi di restauro.
Ultimo passaggio importante in Arcmap, ancora in ambiente 2D, sarà la le georeferenziazione dei prospetti già trasformati in feature 3D; l’attribuzione delle coordinate avviene andando a rilevarle direttamente sulle piante già georeferenziate. Vengono quindi identificati 4 punti posti molto vicini a due a due ai lati della retta priettata in piano identificandone le coordinate da attribuire, tramite Spatial Adjustment ai quattro vertici di ogni prospetto. Effettuata questa operazione, il file sarà trasformato in quella che in ambiente
PPC Conference 2014
7
2D apparirà semplicemente come una linea di proiezione con un tratto molto marcato, ma posizionata correttamente geograficamente; la corretta visualizzazione può avvenire solo in ArcScene, visualizzatore 3D di ArcGIS. Tutte le altezze relative attribuite precedentemente sono registrate nel file ma attraverso il software di visualizzazione e gestione tridimensionale ArcScene si può far coesistere l’informazione geografica connessa al sistema di riferimento e quella altimetrica di ogni elemento. Le feature class 3D così create andranno a coesistere con gli elementi planimetrici, anch’essi nella loro corretta posizione morfologica grazie al TIN di base, consentendo visualizzazioni dinamiche e interrogazioni dirette sugli elementi tridimensionali.
Un altro fattore importante in ambiente GIS è l’attribuzione dei Metadati, ovvero metainformazioni, informazioni su tutti i dati che costituiscono il geodatabase, per consentire uno scambio di dati standardizzato. ArcGIS prevede l’attribuzione di queste informazioni tramite format preimpostati basati sulle principali direttive esistenti e attribuibili attraverso l’applicazione ArcCatalog, tra cui prevale INSPIRE (acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), Direttiva Europea che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea. Per ogni layer presente nel progetto sono previsti una serie di campi informativi da compilare e validare riguardanti la provenienza dei dati, chi li ha creati, chi ci ha lavorato, descrizioni e parole chiave, informazioni di georeferenziazione ecc.
All’interno di un vasto progetto di intervento di restauro condotto dal Council for Development and Reconstruction Cultural Heritage & Urban De-velopment libanese per le aree archeologiche di Baalbek e Tiro, eseguito per fasi da uno studio di fattaibilità sviluppato nel 2002, alla prima fase di interveti nel 2008, è stata acquisita un’enorme quantità di dati, elaborati e rappresentati graficamente per la maggior parte tramite CAD. Accanto alle mappe classiche utilizzate per le rappresentazione in pianta, per alcuni monumenti di particolare importanza è stato applicato un approccio di gestione dei dati nella loro conformazione tridimensionale, cercando di sperimentare un utilizzo dei rilievi e dei progetti presentati nelle diverse fasi nella loro consistenza 3D in un processo di gestione integrata. Lo stesso lavoro è stato eseguito, a scala architettonica, su una struttura storica di pregio, quale il portico della Chiesa di San Francesco a Urbino, in modo da evidenziare l’applicabilità del metodo.
Le principali problematiche affrontate sono state: da un lato la definizione degli standard dei modelli (ci si riferisce, in particolare, a quelli tridimensionali) da importare all’interno del Geodatabase rispetto alle diverse esigenze da un lato del contesto territoriale, dall’latro alle scale più prettamente urbanistico-
A cura dell’editore
8
achitettoniche, rispetto agli output da ottenere. La progettazione del database, è stata progettata nel primo caso a partire delle schede messe a punto dalla CDR libanese per gli itnerventi di restuaro previsti nei due siti, dall’altra facendo riferimento alle schede dell’ISCR per la costruzione della Carta del Rischio del Patrimonio Culturale. Tali aspetti sono stati a loro volta legati dalla corretta definizione di procedure di importazione, in ambiente GIS, per la creazione di modelli 3D interrogabili direttamente.
Le mappature derivate dai diversi passaggi, sopra descritti, sono state sviluppate per rappresentare esaustivamente tutti gli elementi, nelle loro componenti geometriche e areali, ed i contenuti archeologici, storici e artistici, quali attributi connessi a definirne gli aspetti culturali.
Questo tipo di struttura permette di disporre, all’interno del progetto GIS based, di un collegamento dinamico tra geodati e la loro rappresentazione cartografica, arrivando a una vera e propria cartografia dinamica. Unico rischio che il responsabile della ricerca deve sempre valutare attentamente è la ridondanza dei dati, fenomeno piuttosto usuale che si manifesta con il trascorrere del tempo e che se non contrastato tende a ridurre notevolmente l’efficacia del sistema.
Il percorso della ricerca in quest’ambito tende a spostarsi, dal terreno dell’impostazione generale a quello del raffinamento degli strumenti informatici, sia in termini di sistema che d’interfaccia utenti. Si tratta di un passaggio necessario che potrà condurre, come è già accaduto nel caso di molte altre procedure informatizzate, ad una semplificazione delle procedure e ad una migliore razionalizzaione dei diversi processi per la tutela e la valorizzaione dei beni culturali.
Riferimenti bibliografici Baratin, L., Bertozzi, S. and Moretti, E. (2013). Gis-based archaeological recording
in Lebanon. In: 6th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin", Athens, Greece, October 22 – 25, 2013, Proceedings.
Baratin, L., Bertozzi, S., Moretti, E. and Spinella M. (2012). Gis and 3D models as support to documentation and planning of the Baku Historical Centre (Republic of Azerbaijan). International Journal of Heritage in the Digital Era, Vol.1, pp 71 - 76. EUROMED 2012, Lemessos, Cyprus, October 29 -- November 3, 2012, Proceedings.
PPC Conference 2014
9
Baratin L., Moretti E. and Bertozzi S. (2012). Tyregis: un gis per il restauro e la valorizzazione del sito archeologico di Tiro in Libano. In: Atti della 13 Conferenza Italiana Utenti ESRI. Roma, Auditorium del Massimo, 18-19 Aprile 2012.
Brusaporci, S., Centofanti, M., Continenza, R. and Trizio, I. (2012). Sistemi Informativi Architettonici per la gestione, tutela e fruizione dell'edilizia storica. In: Atti 16a Conferenza Nazionale ASITA, Fiera di Vicenza, 6-9 novembre 2012.
Bertozzi S., Moretti E., 2011. Metodologia GIS per il rilevamento dei Geositi. In: Atti 15° Conferenza Nazionale ASITA, 15 – 18 novembre 2011, Reggia di Colorno.
Bertozzi S. e Moretti E., 2010. Geographic Information System Instrument for Cul-tural Heritage Conservation and Valorisation. In L. Baratin (Ed): Instruments and Methodologies for Cultural Heritage Conservation and Valorization. First Level Master Course Methodology Notes, Ancona, Gabbiano s.r.l. ISBN 9788890534744.
Baratin L. , Survey and representation of architectural and archaeological assets: a sum-mary of methodologies and applications. L. Baratin (Ed) Instruments and Methodolo-gies for Cultural Heritage Conservation and Valorization. First Level Master Course Methodology Notes, Ancona, Gabbiano s.r.l., ISBN 9788890534744, pp. 85-90. Brusaporci S. (2010), a cura di, Sistemi informativi integrati per la tutela la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano, Gangemi, Roma. Trizio I. (2007), GIS-technologies and Cultural Heritage: stocktaking, documentation and managment, In: Rethinking Cultural Heritage. Experiences from Europe and Asia, TechnischeUniversität Dresden, Dresden, 75-91 Gasparoli, P. (2011), “La manutenzione preventiva e programmata”, in Cecchi, R. (2011), Roma archeologia. Interventi per la tutela e la fruizione del patrimonio archeolo-gico. III Rapporto, Electa, Milano. Della Torre, S. (2003), La Conservazione Programmata del Patrimonio storico-architettonico, Guarini, Milano.
Fig. 1 - Schema della struttura del progetto con il geodatabase che è in grado di gestire contemporaneamente i dati sulle planimetrie (Horrizontal) e sui prospetti (Vertiical) oltre che documenti di vario genere, tabelle, immagini, scehde e metadati
Fig. 2 - Visualizzazione del prospetto del portico della chiesa di San Francesco ad Urbino (Italia) con l'interrogazione e visualizzazione tramite istogramma dei materiali costitutivi (in alto) e dei problemi di degrado (in basso) la tabella mostra il numero delle patch e la sommatoria delle aree dei materiali costitutivi
Fig. 3 - Visualizzazione generale prospetttica tramite ArcScene di Esri del sito di Al Bass (Tiro - Libano) ottenuta utilizzando l'ortofoto e il DEM, con il posizionamento in pianta tramite cartografia vettoriale dei monumenti archeologici e la rappresentazione georeferenziata dei prospetti dell’Arco Romano. La finestra mostra l'interrogazione dell'elemento in pianta visualizzato in azzurro
Fig. 4 - Particolare dell’Arco Romano del sito di Al Bass (Tiro- Libano) con la rappresentazione dei prospetti sulla cartografia vettoriale della pianta del sito con l'interrogazione tramite linguaggio SQL dei problemi di degrado delle pietre che costituiscono il più importante elemento archeologico del sito
Fig. 5 - Ancora una visualizzazione del Portico della chiesa di San Francesco ad Urbino (Italia) con un esempio di interrogazione SQL dei dati presenti nella tabella degli attributi e la finestra di dialogo del Software (ArcScene di Esri) che consente di modificare le direzioni di illuminazione dell'oggetto rappresentato