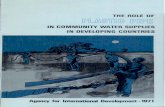Culture del mestiere e del lavoro artigiano a Firenze, in P. Causarano, P. Falossi, P. Giovannini (a...
Transcript of Culture del mestiere e del lavoro artigiano a Firenze, in P. Causarano, P. Falossi, P. Giovannini (a...
Mondi operai, culture del lavoroe identità sindacali
Il Novecento italiano
a cura diPietro Causarano, Luigi Falossi,
Paolo Giovannini
Il volume è tratto dal Convegno «Culture operaie e culture sindacali nel secolodel lavoro», svoltosi a Firenze il 18 e 19 gennaio 2007.
© Ediesse 2008Casa editrice Ediesse s.r.l.Via dei Frentani 4/A - 00185 RomaTel. 06/44870283-325 Fax 06/44870335
In Internet:Catalogo: http://www.ediesseonline.itE-mail: [email protected]
Progetto grafico: Antonella LupiIn copertina: Nello Leonardi, Operai, 1947, olio su tela,da Cgil. Le raccolte d’arte, a cura di Patrizia Lazoi e Luigi Martini,Roma, Ediesse, 2005
Il motivo per cui…Premessa di Pietro Causarano, Luigi Falossi 9
IntroduzionePaolo Giovannini 11
Parte primaCULTURE
La vicenda novecentesca del lavoroGiovanni Mari 35
Si può ancora scrivere storia del movimento operaio?Paolo Favilli 43
Le culture sindacali nel secolo industrialeGian Primo Cella 49
Culture di fabbrica e culture del territorioFilippo Buccarelli 63
Condizione operaia e identità femminili nella recente storiografiadel lavoroBarbara Curli 89
Il corpo al lavoro, il lavoro del corpo. Salute e lavoro nelle culturedei lavoratori e dei sindacatiFranco Carnevale 109
Il movimento operaio italiano tra Ottocento e Novecento e le illusionidel progressoMaurizio Antonioli 121
Parte secondaIDENTITÀ
Antropologia e culture operaie: un incontro mancatoFabio Dei 133
Campagna pluriattiva: la manovalanza rurale tra agricoltura e industriaMarco Fincardi 147
Indice
Identità metalmeccanicheRenato Lattes 171
Mestiere, professione o funzione? Gli insegnantiPietro Causarano 183
Il servizio pubblico: l’esperienza dei ferrovieriAndrea Giuntini 203
I nomi della CGILMyriam Bergamaschi 213
Parte terzaLUOGHI
Geografie delle culture del lavoro e delle culture politiche localiLorenzo Bertucelli 231
Poli industriali a confronto: Genova, Milano, TorinoStefano Musso 241
Poli industriali a confronto: NapoliDavide Bubbico 255
Culture del mestiere e del lavoro artigiano a FirenzeAnna Pellegrino 273
La centralità dei lavoratori periferici: i tessili pratesiGiuseppe Gregori 291
Fra terra e mare: lavoro, cultura, forme associative dei portualidi GenovaGiuliana Franchini 301
Dentro la terra: minatori e cavatori toscaniGiovanni Contini 311
TAVOLA ROTONDALa modernità del lavoro 319con Franca Alacevich, Carlo Ghezzi, Paolo Giovannini,Alessio Gramolati, Giovanni Mari
Ringraziamenti 349
273
Il mio intervento esamina il ruolo degli artigiani in un contesto urbano comequello fiorentino che a lungo è stato caratterizzato da una forte presenza arti-giana. Fra le varie città d’Italia Firenze anzi è stata probabilmente quella chepiù spesso è stata rappresentata come «città artigiana» per eccellenza. Ciò ponedunque questioni rilevanti dal punto di vista storiografico.
La prima, relativa alle cause e poi alle caratteristiche e modalità evolutive diuna persistenza accentuata, per tutto il XIX e parte consistente del XX secolo,di un tessuto produttivo artigianale in una serie di centri urbani. Firenze haun ruolo di rilievo assoluto a livello nazionale, ma il prototipo, a livello euro-peo, è senza dubbio Parigi. La seconda, è quella relativa al problema di comequesti insediamenti artigiani si pongono in rapporto con l’evoluzione contem-poranea della grande industria, e più specificamente di come le culture del la-voro e del mestiere artigiano si pongono in relazione con le culture del lavoroindustriale e operaio che in quel periodo storico stanno prepotentemente af-fermandosi.
Quest’ultimo punto è quello che interessa in questa occasione; e tuttavial’analisi del rapporto (da intendersi in termini di passaggio, continuità, rottura,o altro) fra culture del lavoro artigiano e operaio non è possibile se non si fa uncenno alle questioni strutturali poste in precedenza.
Grande industria e tessuto artigiano
Un ruolo fondamentale hanno avuto in questo senso alcuni studi che hannoriconsiderato in maniera del tutto diversa le fasi recenti dello sviluppo indu-striale contemporaneo, respingendo in primo luogo la visione tradizionale se-condo cui la transizione al sistema di fabbrica viene presentata come un proces-so di violenta affermazione di nuove regole e procedure da parte di un capitali-smo dotato di una forza e razionalità storica che lo mette in grado di superareogni ostacolo. Questi studi hanno messo conseguentemente in discussione l’idea
Culture del mestiere e del lavoro artigiano a FirenzeAnna Pellegrino
ANNA PELLEGRINO
274
di una classe operaia monolitica e omogenea sul piano delle determinazioni so-ciologiche e reattiva in modo altrettanto univocamente determinato.
Come è stato affermato, troppo spesso le domande di cambiamento socialeda parte del capitalismo industriale «are taken as unquestioned givens; in theface of these demands, worker and peasant practices are considered merely interms of their degree of adaptation or resistance to change»1. Questa prospetti-va è stata recentemente rafforzata da studi di natura propriamente storico-economica che tendono a mettere in questione l’idea di uno sviluppo linearedei sistemi produttivi, e di una transizione progressiva e inevitabile da una fasetradizionale legata alla piccola dimensione delle imprese e della produzione fi-no alla produzione di massa della grande fabbrica capitalistica.
Studiosi come Sabel, Zeitlin, Landes, hanno sollevato la questione della im-portanza, nel processo di industrializzazione del mondo occidentale, di formedi produzione diverse dalla produzione di massa della grande azienda capitali-stica. In questo quadro, le doti di flessibilità, adattabilità al mercato, ed anche dicapacità di innovazione e adeguamento in campo tecnologico della piccola im-presa2, che la porta non solo a sopravvivere, ma ad assumere talora un ruolocompetitivo, sono state ampiamente messe in rilievo. In particolare è stato sot-tolineato il ruolo degli attori e dei protagonisti di questo processo, cioè dei pic-coli imprenditori, visti come soggetti attivi e capaci di sfruttare le possibilità of-ferte dal contesto con doti di intelligenza e capacità di intervento mirato chel’analisi storiografica centrata sui grandi complessi produttivi e sui grandi mo-vimenti di mercato non riusciva a cogliere3. Come hanno osservato Sabel e Zei-tlin, oggi si deve invece sottolineare l’estrema
recombinability and interpenetration of different forms of economic organisation: therigid and the flexible, the putatively archaic and the certifiably modern, the hierar-chical and the market conforming, the trusting and the mistrustful.
1 A. Cottereau, The Distinctiveness of Working-Class Cultures in France, 1848-1900, in Working-ClassFormation. Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and the United States, edited by I. Katznelson,A.R. Zolberg, Princeton, PUP, 1986, p. 112.
2 Cfr. ad esempio sul tema I. Inkster, Finding Artisans. British and International Patterns of Techno-logical Innovation circa 1790-1914, in Artisans, industrie. Nouvelles révolutions du Moyen Age à nos jours,actes du colloque international (7-9 juin 2001), Paris, Conservatoire national des Arts et Métiers,2001, pp. 102-116.
3 Il dibattito è iniziato con un articolo pubblicato su «Past & Present» nel 1985 (C.F. Sabel, J.Zeitlin, Historical Alternatives to Mass Production: Politics, Markets, and Technology in Nineteenth-CenturyIndustrialization, in «Past & Present», 1985, n. 108, pp. 133-176), a cui ha fatto seguito una discus-sione in cui sono intervenuti alcuni dei maggiori storici economici; cfr. A che sevono i padroni? Le al-ternative storiche dell’industrializzazione, a cura di D.S. Landes, Torino, Bollati Boringhieri, 1987. Suc-cessivamente gli stessi Sabel e Zeitlin hanno in parte ripensato le loro ipotesi nel saggio Stories,Strategies, Structures: Rethinking Historical Alternatives to Mass Production,,in World of Possibilities. Flexi-bility and Mass Production in Western Industrialization, Paris-Cambridge, MSH-CUP, 1997.
CULTURE DEL MESTIERE E DEL LAVORO ARTIGIANO A FIRENZE
275
In questo quadro, diventa estremamente interessante studiare i modi in cui leidentità sociali e le culture del lavoro e della solidarietà tipiche del modo diproduzione tradizionale, coesistono e si innestano nelle nuove culture e nellenuove forme identitarie che si affermano in relazione alla trasformazione deimodi di produzione e alla modernizzazione generale della società.
Sul terreno della storia sociale e della storia delle culture operaie la sensibi-lità verso le componenti artigianali si è mossa, negli ultimi decenni, con risultatimeno rilevanti, ma comunque non inconsistenti, a livello internazionale; ilruolo degli artigiani nella formazione dei movimenti sociali e politici che dannorappresentanza al mondo del lavoro è stato per molto tempo al centrodell’attenzione e del dibattito degli storici: dai classici studi di Thompson fino aldibattito sul ruolo degli artigiani tedeschi nella costruzione di forme organizza-tive politiche e sindacali nella Germania dell’Ottocento4. Ma mentre sulle cultu-re del lavoro, sulla fierezza del mestiere, sui linguaggi di classe, su alcune parolechiave del lessico del mondo del lavoro, vi sono ormai studi che costituisconopunti di riferimento ineludibili5, il delicato problema del passaggio dal modo diproduzione artigianale al modo di produzione industriale costituisce un nodoproblematico aperto, anche a livello internazionale, soprattutto per quanto ri-guarda i riflessi e le contemporanee evoluzioni delle culture del lavoro e deimodelli associativi, le forme della identità sociale e della cittadinanza6.
In questo ambito, il ruolo delle componenti artigiane è stato spesso messo inombra dall’attenzione della storiografia che ha per contro privilegiato la storiadel movimento operaio industriale più «moderno»: solo negli ultimi anni si è in-vece proposto con crescente insistenza, anche se ancora con poche approfonditeverifiche di ricerca effettiva, il nodo del ruolo svolto dalle componenti artigianenel lungo processo di transizione dal mondo del lavoro preindustriale fino allapiena affermazione del modo di produzione industriale. Un ruolo che, se è im-portante per gli aspetti economici e sociali, lo è ancora di più per gli aspetti
4 Cfr. in particolare E. Thompson, The Making of the English Working Class, London-New York,Pantheon Books, 1963; J. Kocka, Craft Traditions and the Labour Movement in the Nineteenth-CenturyGermany, in The Power of the Past. Essays for Eric Hobsbawm, edited by P. Thane, G. Crossick, R. FloudCambridge, CUP, 1984, pp. 95-117; S. Volkov, The Rise of Popular Antimodernism in Germany. The Ur-ban Master Artisans, 1873-1896, Princeton, PUP, 1978; Lonharbeit und Klassenbildung. Arbeiter und Ar-beiterbewegung in Deutschland, 1800-1875, edited by P. Thane, G. Crossick, R. Floud, Berlin, J.H.W.Dietz, 1983. F. Lenger, Beyond Exceptionalism. Notes on the Artisanal Phase of the Labour Movement inFrance, England, Germany and the United States, in «International Review of Social History», 1991, n.1, pp. 1-23.
5 G. Stedman Jones, Languages of Class. Studies in English Working Class History, 1832-1982, Cam-bridge, CUP, 1983; E. J. Hobsbawm, Worlds of Labour, London, Weidenfeld and Nicolson, 1984.
6 The power of the Past, cit.; F. Lenger, Tradizioni artigiane e origini del movimento operaio. Alcune ri-flessioni sulla recente letteratura tedesca, in «Movimento operaio e socialista», 1985, n. 3, pp. 477-485;C. Behagg, Ch. Eisenberg, Artigiani e movimento operaio: un confronto interpretativo?, ivi, 1986, n. 3,pp. 489-501; M. Cattaruzza, Tradizioni artigiane e resistenza alla modernizzazione, ivi, 1987, n. 1-2, pp.141-150.
ANNA PELLEGRINO
276
culturali: il mondo artigiano appare infatti in questa ottica come il tramite fon-damentale di passaggio di linguaggi, culture, comportamenti dal mondo del la-voro della tradizione corporativa a quello delle moderne società industriali7.
Infine, è da notare che in tutto questo dibattito, che ha prodotto a livello eu-ropeo diversi studi di carattere comparativo, il caso italiano risulta fra i menostudiati, mentre potrebbe essere di estremo interesse sotto questo aspetto, siaperché tutto lo sviluppo dell’apparato produttivo nazionale è caratterizzato dauna forte tensione fra piccola e grande dimensione aziendale, sia perché la ca-pillare e caratteristica articolazione dei centri urbani nella penisola presente-rebbe molti aspetti interessanti per quanto riguarda i diversi caratteri degli in-sediamenti produttivi e le modalità del passaggio dal tessuto produttivo artigia-nale a quello industriale.
L’artigianato e il contesto urbano
La «territorialità» molto accentuata degli insediamenti artigiani ci riporta allaprima questione enunciata all’inizio: la necessità per lo storico di ricorrereall’analisi delle relazioni con il particolare contesto urbano per spiegare ragionie caratteri specifici della persistenza di tali insediamenti.
Da questo punto di vista il caso francese riveste come è noto una importanzafondamentale. Se viene infatti facilmente riconosciuto nel modello inglese ilprototipo di un tipo di industrializzazione basato sul sistema di produzione difabbrica (pur con all’interno di essa un forte ruolo dei lavoratori specializzati edegli artisans inseriti nella catena produttiva industriale), il caso francese è percontro il modello di un tipo di industrializzazione nel quale il ruolo dei piccoliproduttori indipendenti, degli artigiani, è fondamentale e caratterizzante.Inoltre all’interno del caso francese il ruolo predominante spetta al modello disviluppo della capitale. Nel caso parigino infatti la lentezza dell’affermazione diun moderno assetto capitalistico industriale, definita a suo tempo da Hobsbawmcome «un gigantesco paradosso», è dovuta alla persistenza durante tutto il corsodell’Ottocento di una struttura produttiva basata sul lavoro artigiano (pur sta-volta con una chiara evoluzione operata dal mercato in direzione di una specia-lizzazione e in certi casi parcellizzazione del mestiere dei singoli artigiani). Que-
7 W. H. Sewell jr., Work and Revolution in France. The Language of Labor from the Old Regime to1848, Cambridge, CUP, 1980; Id., Artisans, Factory, Workers, and the Formation of the French WorkingClass, 1789-1848, in Working Class Formation, cit., pp. 45-70; A. Cottereau, The Distinctiveness ofWorking-Class Cultures in France, cit., pp. 111-155; alcune osservazioni in questo senso anche nel vol-ume di J. Rancière, La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Paris, Fayard, 1981; cfr. anche B.H.Moss, Les origines du mouvement ouvrier français. Le socialisme des travailleurs qualifiés, 1830-1914, Paris,Les Belles Lettres, 1985 (éd. or. 1976), e la sintesi di G. Noirel, Les ouvriers dans la société française,XIX-XX siècle, Paris, Seuil, 1986.
CULTURE DEL MESTIERE E DEL LAVORO ARTIGIANO A FIRENZE
277
sta specificità del contesto produttivo parigino è stata osservata da molti studi, apartire dalla imponente thèse, recentemente ripubblicata, di Jeanne Gaillard daltitolo «Paris la Ville»8.
Parigi offre quindi un modello di riferimento per altre città che, sia pure suscala minore, condividono alcuni caratteri della capitale francese, come il casodi Firenze. Inoltre, anche da questo punto di vista, è necessario abbinare agliaspetti più propriamente economico sociali, che definiscono i modelli di svilup-po di alcuni centri urbani, i fenomeni di ordine sociale e culturale che dannoloro forma e rappresentazione. Sotto questo aspetto particolare attenzione me-rita il fenomeno dei reticoli associativi, che, prima ancora di arrivare alle mo-derne forme di rappresentanza sindacale, costituiscono parte importante dellaformazione di una identità sociale e di una cultura delle classi lavoratrici urba-ne. Naturalmente per tutto il problema del passaggio dagli ordinamenti corpo-rativi ai reticoli associativi tipici del liberalismo ottocentesco, la rottura operatadalla Rivoluzione francese è fondamentale; e non a caso il più importante stu-dio finora apparso sui contenuti e sui riflessi sociali e culturali del passaggio dalmondo artigiano d’Ancien régime a quello dei sistemi liberali ottocenteschi,quello di William Sewell jr., si fonda appunto sul caso francese fra la secondametà del Settecento e il 18489. Più in generale si può dire che tutta la storiogra-fia francese sulla sociabilité ha avuto un ruolo fondamentale nel ridefinire alcunedelle coordinate di fondo della storiografia contemporaneista, soprattutto inrelazione al rapporto reciproco fra società civile e sistema politico10.
8 Cfr. E.J. Hobsbawm, L’ère des révolutions, Paris, Fayard, 1969, p. 228; J. Gaillard, Paris la ville(1852-1870), Paris, L’Harmattan, 1997; cfr. anche L.R. Berlanstein, The Working People of Paris,1871-1914, Baltimore-London, The John Hokpins UP, 1984; M.P. Hanagan, The Logic of Solidarity.Artisans and Industrial Workers in three French Towns, 1871-1914, London-Chicago, Urbana UP, 1980;per un quadro internazionale, Shopkeepers and Master Artisans in Nineteenth Century Europe, edited byG. Crossick, H.-G. Haupt, London-New York, Methuen, 1984; per il periodo successivo cfr. S.M.Zdatny, The Political of Survival. Artisans in Twentieth Century France, New York-Oxford, Oxford UP,1990.
9 W.H. Sewell jr., Work and Revolution in France, cit.; cfr. anche F. Lenger, Beyond Exceptionalism,cit., pp. 1-23; sull’eredità del compagnonnage e sulle culture artigiane in Francia, cfr. anche S. Kap-lan, Réflections sur la police du monde du travail, 1700-1815, in «Revue Historique», 1979, n. 261, pp.17-77; C.M. Truant, Solidarity and Symbolism among Journeymen Artisans: the Case of Compagnonnage, in«Comparative Studies of Society and History’, 1979, n. 21, pp. 214-226.
10 Fra gli studi più significativi ricordiamo, M. Agulhon, La sociabilité méridionale. Confréries etassociations en Provence Orientale dans la deuxième moitié du XVIII siècle, Aix en Provence, La PenséeUniversitaire, 1966 (ed. ciclostilata in 2 voll. della tesi di terzo ciclo, poi edita a Parigi nel 1968 daFayard col titolo Pénitents et Francs-Maçons de l’Ancienne Provence. Essai sur la sociabilité méridionale, ed.riv. poi nel 1984); Id., La République au village. Les populations du Var de la Révolution à la SecondeRépublique, Paris, Plon, 1970; Id., Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848. Étude d’une mutationde sociabilité, Paris, Colin 1977. Per una riflessione metodologica, con una ricostruzione accuratadelle derivazioni e dei rapporti della storiografia della sociabilité con altri settori disciplinari, cfr.Forme di sociabilità nella storiografia francese contemporanea, a cura di G. Gemelli, M. Malatesta, Milano,Feltrinelli, 1982; per un quadro internazionale e comparato, gli atti del convegno Sociabilité et société
ANNA PELLEGRINO
278
Le associazioni appaiono in questa ottica come un importantissimo veicolo ditrasmissione di idee, mentalità, modelli di comportamento: all’interno dellastruttura associativa le pratiche e le aspirazioni comunitarie si definiscono, siprecisano, divengono esigenza sociale prima e rivendicazione poi. Le associa-zioni dunque sono alla base, in quanto forme della rappresentanza degli inte-ressi, della nascita di aggregazioni sociali e culturali che daranno poi forma aifuturi sindacati e partiti; è proprio all’interno di queste strutture che si formauna prima embrionale coscienza della appartenenza e cittadinanza sociale. Èl’appartenenza a queste associazioni oltre e più che il mero dato sociologicodella collocazione sociale di status che pare determinare le forme dell’identità edel riconoscimento sociale. Per queste ragioni la mia analisi dell’artigianato aFirenze terrà conto in particolare del particolare contesto urbano e delle reti as-sociative che in esso si sviluppano.
Gli artigiani a Firenze
Il momento culminante della caratterizzazione di Firenze come città artigiana siè avuto durante il fascismo, quando Alessandro Pavolini definendola «la cittàpiù artigiana d’Italia», e facendone la sede della Mostra mercato nazionale del-l’artigianato, ne sancì e incentivò questa vocazione11. Ma già da molto tempoera in atto un processo di costruzione di una serie di rappresentazioni della ca-pitale toscana come «Atene d’Italia», come luogo privilegiato di attività artisti-che, intellettuali e culturali, all’interno delle quali il ruolo dell’artigianato, ri-chiamandosi alla tradizione delle antiche arti medievali, veniva ad essere forte-mente integrato12. Si trattava di una vera e propria reinvenzione di una tradi-zione ormai lontana nei secoli, che però attorno alla metà del XIX secolo co-minciò a delinearsi chiaramente, interessando direttamente i ceti sociali coin-volti13. Nel 1861 venne fondata a Firenze la principale associazione democraticadei lavoratori italiani, su scala nazionale e con l’intervento dei maggior leader
bourgeoise en France, en Allemagne et en Suisse (1750-1850), sous la direction de E. François, Paris, ed.Recherches sur les Civilisations, 1986.
11 M. Palla, Firenze nel regime Fascista (1929-1934), Firenze, Olschki, 1978, pp. 236-239, in parti-colare la parte «La rifondazione turistica e artigiana della ‘capitale dell’intelligenza italiana’» (pp.230-292); si veda anche, A. Pavolini, Viva L’Artigianato, in «Il Bargello», 22 marzo 1931.
12 Il protagonista principale del rilancio artistico-artigiano della città era stato già dai tempi di Fi-renze capitale il sindaco Ubaldino Peruzzi; cfr. in tal senso R. Melchionda, Firenze industriale nei suoi in-certi albori. Le origini dell’associazionismo imprenditoriale cento anni fa: esplorazioni e materiali di ricerca, Firen-ze, Le Monnier, 1988, p. 88; per il periodo successivo, cfr. L. Cerasi, Gli Ateniesi d’Italia. Associazioni dicultura a Firenze nel primo Novecento, Milano, Franco Angeli, 2000, in particolare pp. 31-32; più in gene-rale sulla figura di Peruzzi, cfr. Ubaldino Peruzzi. Un protagonista di Firenze capitale, a cura di P. Bagnoli,atti del convegno di studi (Firenze, 24-26 gennaio 1992), Firenze, Festina Lente, 1994.
13 Su questo tema cfr. la raccolta di saggi pubblicata a cura di E.J. Hobsbawm e T. Ranger con iltitolo L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1983.
CULTURE DEL MESTIERE E DEL LAVORO ARTIGIANO A FIRENZE
279
politici del movimento, da Mazzini a Montanelli, da Guerrazzi a Mazzoni, cheprese il nome di Fratellanza artigiana d’Italia14.
Vi è quindi una continuità di lungo periodo nelle rappresentazioni di Firenzecome città artigiana per eccellenza nell’Italia Unita; ma non ci possiamo na-scondere che lungo questo filo di continuità si notano anche profondi cambia-menti e differenze. Ad esempio, per Pavolini gli artigiani rappresentavano unceto sociale intermedio, che riusciva ad attutire il conflitto sociale e a conciliaregli interessi della manodopera e della parte imprenditoriale, sulla stessa lineadel rilancio, che aveva anch’esso il suo cuore in toscana, della mezzadria comerapporto di produzione privilegiato per quanto riguardava il lavoro agricolo.Nel caso della Fratellanza artigiana i leader democratici del movimento inten-devano proporre, accanto ad una componente interclassista sempre presente,un punto di riferimento «alto» a tutto il mondo del lavoro, comprendendovitutti lavoratori manuali che esercitassero «arte o industria», al di là della loroposizione nel processo lavorativo15.
Ma alla base delle varie rappresentazioni, quale era la reale consistenza equali i caratteri dell’insediamento artigiano fiorentino? Negli anni scorsi, nelcorso di una tesi di dottorato presso l’Istituto Universitario Europeo, ho con-dotto una ricerca approfondita su Firenze artigiana dall’Unità al fascismo. Cer-cherò di esporre in maniera estremamente sintetica i risultati di questo lavoro16.
Dall’analisi puntuale delle statistiche ministeriali, di quelle della Camera dicommercio, dai censimenti della popolazione e dalle altre fonti disponibili, ri-sulta che in realtà Firenze non aveva alla metà del XIX secolo un carattere net-tamente più «artigiano» rispetto ad altre città consimili italiane per quanto ri-guardava la composizione sociale della popolazione lavoratrice17. Alla fine del
14 Fra le opere storiografiche che sottolineano il ruolo «politico» della Fratellanza, il primo rife-rimento va fatto senz’altro all’opera di N. Rosselli, Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento operaioin Italia (1860-1872), Torino, Bocca, 1927 (poi presso Einaudi nel 1967). Cfr. inoltre E. Conti, Leorigini del socialismo a Firenze, 1860-1880, Roma, ed. Rinascita, 1950; G. Manacorda, Il movimento ope-raio italiano attraverso i suoi congressi (1853-1892), Roma, ed. Rinascita, 19743 (ed. orig. 1953); E. Ra-gionieri, Mazzinianesimo, garibaldinismo e origini del socialismo in Toscana, in «Rassegna storica tosca-na», 1963, n. 2, pp. 143-158; R. Composto, I democratici dall’Unità ad Aspromonte, Firenze, Le Mon-nier, 1967; A. Salvestrini, Giuseppe Dolfi: un capopopolo nella rivoluzione dei signori, in «Rassegna stori-ca toscana», 1969, n. 2, pp. 221-232; L. Tomassini, Associazionismo operaio a Firenze fra Ottocento e No-vecento. La Società di mutuo soccorso di Rifredi, 1883-1922, Firenze, Olschki, 1984. Da un punto di vistapiù organizzativo e istituzionale si veda ora A. Pellegrino, ‘Patria, Umanità e Progresso’. Le origini dellaFratellanza artigiana d’Italia, in «Ricerche Storiche», 2003, n. 2-3, pp. 305-336.
15 Cfr. Capitoli di una Fratellanza artigiana, preceduti dal Rapporto della Commissione incaricata dellarevisione dei medesimi ed illustrati dal Bilancio Centenario della proposta Fratellanza, Firenze, tip. Giusep-pe Mariani, 1861.
16 Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla tesi di dottorato, A. Pellegrino, ‘La città più arti-giana d’Italia’: Firenze (1861-1929), Firenze, IUE, 2004.
17 Al momento dell’Unità d’Italia la situazione toscana non è dissimile da quella di altre regioniitaliane, anzi per alcuni settori che si possono considerare tipicamente artigiani la presenza dellacittà toscana è addirittura inferiore a quella registrabile in altri centri. Dall’analisi della Popolazione
ANNA PELLEGRINO
280
periodo considerato invece una connotazione artigiana della città è chiaramentevisibile18. Si deve notare però che lo sviluppo dell’artigianato fiorentino in que-sti anni segue una linea complessa e per certi versi contraddittoria, per cui lanotevole presenza artigiana su cui Pavolini fondava le sue affermazioni all’iniziodegli anni Trenta era profondamente diversa dalla popolazione e dalla presen-za artigiana a cui facevano riferimento Mazzini, Montanelli e i fondatori dellaFratellanza artigiana19.
Questo pone un primo problema di interpretazione storiografica. Com’ènoto negli studi sul movimento operaio gli artigiani sono stati visti tradizional-
operaia secondo i varii compartimenti territoriali del Regno risulta che la Toscana si colloca esattamentesulla media generale del Regno per quanto riguarda la percentuale di lavoratori del settore artigia-no-industriale. Si pone invece al primo posto per quanto riguarda il rapporto fra i soli lavoratorimaschi e la popolazione: se ne potrebbe ricavare l’indicazione di una maggiore presenza di mestieriartigiani, dato che all’epoca l’occupazione femminile era sinonimo di lavorazioni poco qualificate odi attività industriali nel settore tessile. Tuttavia si tratta di dati troppo poco sicuri ed affidabili, edanche troppo poco disaggregati per trarne qualcosa di più che non qualche generica indicazione.Impressione che non cambia se si osservano gli stessi dati ripartiti per categorie professionali. An-che dall’analisi delle Principali categorie di arti e mestieri distribuite secondo i varii compartimenti territorialidel regno risulta che la Toscana non si distingue in modo particolare rispetto agli altri comparti-menti. Per tutti i mestieri presi in considerazione, la regione si colloca in posizioni vicine alla media,spesso anzi inferiori, e solo nel caso dei fornai e prestinai presenta una percentuale di occupati, inrapporto alla popolazione del compartimento, che è particolarmente alta, ma non comunque la piùalta in assoluto. Per il resto, e in particolare per quelle categorie che rappresentano l’artigianato piùtradizionale e insieme in via di trasformazione, come i sarti e i calzolai, la Toscana presenta dellequote di occupati che sono solo leggermente superiori alle medie nazionali, e viene comunque die-tro molte altre regioni. Anche in questo caso è difficile trarre conclusioni veramente affidabili, mapare confermarsi l’impressione di una realtà manifatturiera artigiana e industriale che non è sensi-bilmente diversa o originale rispetto alla media nazionale. Dopo l’Unità, la creazione di un mercatonazionale portò ad una profonda crisi del modello di sviluppo economico tradizionale delle antichecittà capitali, obbligandole ad un confronto del tutto inedito con il nuovo mercato che in molti casi,ed anche in quello toscano, significò un radicale reindirizzamento delle correnti di scambio e dellepolitiche di sviluppo e di gestione delle risorse. Nel nostro caso il trasferimento della capitale daTorino a Firenze determinò un profondo cambiamento dell’economia cittadina con un rapido svi-luppo di una serie di settori che non si possono classificare come artigiani (a partire dal settoredelle costruzioni e dei lavori edilizi, che fu di gran lunga quello più importante) e ad un consistentesviluppo anche di attività e produzioni artigianali di alto livello qualitativo destinate a soddisfare larichiesta dei ceti dirigenti del nuovo Stato.
18 Il confronto pavoliniano si basava su fonti che erano indicate in maniera del tutto generica edindeterminata. Se però si effettua una verifica sui dati del censimento industriale del 1927, il più vi-cino alla data delle dichiarazioni di Pavolini, e probabilmente la fonte delle sue elaborazioni, si vedeche in effetti la città ha un insediamento produttivo che si distingue – seguendo il criterio del nu-mero degli addetti – per la piccola taglia delle imprese. Il numero medio degli addetti è infatti di7,2 per esercizio. Alla stessa data, Milano, che appare come seconda città subito dopo Firenze nellagraduatoria di Pavolini, ha una media di 11,2 addetti per esercizio, cioè proporzionalmente unapercentuale di addetti per esercizio superiore del 56%; cfr. a proposito l’articolo La prova delle cifre,in «Il Bargello», 1930, n. 24.
19 Per Pavolini la soglia per qualificare una attività come artigiana era di 5 addetti per esercizio;per i fondatori della Fratellanza, artigiano era chiunque esercitasse arte o industria al di là della po-sizione nel processo lavorativo.
CULTURE DEL MESTIERE E DEL LAVORO ARTIGIANO A FIRENZE
281
mente come una componente in progressivo declino, che aveva un proprioruolo peculiare all’interno del movimento dei lavoratori, ma che era inesorabil-mente destinata a scomparire di fronte ai progressi dell’industria moderna. Vi-ceversa, interpretazioni più recenti di storici economici e sociologi come Sabel eZeitlin hanno messo in luce la capacità di persistenza delle piccole lavorazionidi tipo artigiano, accanto ed in alternativa all’industria di massa, poggiandosulle doti di flessibilità e di adattamento che sono proprie del modello della pic-cola produzione, nonché dei fattori culturali che condizionano le scelte economi-che e di lavoro. L’analisi del caso fiorentino mostra che la sopravvivenza ed anzila relativa espansione di un tessuto artigiano secondo il modello delle «alterna-tive storiche all’industrializzazione di massa», è in realtà del tutto verificabile20.L’analisi mostra nel contempo però che questo sviluppo riguarda solo alcunecomponenti dell’artigianato locale caratterizzate da precisi requisiti e da precisevocazioni merceologiche e di mercato, e coesiste con un fortissimo e irreversi-bile declino di altre componenti, che potremmo definire più tradizionali21.
20 Cfr. C.F. Sabel, J. Zeitlin, Stories, Strategies, Structures, cit.21 Dall’analisi delle statistiche e dei censimenti della popolazione dal 1865 al 1911 il settore più
importante a livello quantitativo risulta essere quello del vestiario e dell’arredamento domestico. Inquesto settore sono comprese attività decisamente artigianali come quelle dei sarti, dei cappellai,dei tappezzieri, ma anche delle lavoratrici a domicilio che si pongono ai margini del lavoro artigia-nale, come le cucitrici e le ricamatrici. Si tratta di un settore dalle caratteristiche complessivamenteancora molto legate ad una antica tradizione tipica della città. Il secondo settore per importanzaquantitativa è quello delle produzioni legate alla lavorazione del ferro e dei metalli che raddoppia ilnumero degli addetti tra il 1881 e il 1911. Un settore che segue un andamento particolare è quellolegato alla lavorazione della pietra e dei minerali. Il numero degli addetti infatti resta statico fra il1881 e il 1901 e ha poi un balzo veramente accentuato fra il 1901 e il 1911 con un incremento dicirca il 150% (contro un incremento della popolazione che è nel periodo solo del 17,4%: evidente-mente in questo caso anche l’aumento del mercato interno non è sufficiente a spiegare questo tipodi sviluppo e si deve pensare a una produzione direttamente o indirettamente rivolta verso un mer-cato non locale). Dalle fonti qualitative abbiamo una conferma precisa di questo sviluppo e della suacaratteristica di lavorazione artigianale altamente qualificata, anche se in parte serializzata. Il terzogrande settore produttivo è quello del legno, che si aggira in tutti i censimenti considerati (1881-1901-1911) attorno al 10% del totale degli addetti in tutte le attività produttive. Il numero degli ad-detti cresce regolarmente e proporzionalmente per tutto il periodo per cui sono disponibili i dati(+10% nel primo ventennio, fra il 1881 e il 1901; +19% nel decennio successivo, quindi in com-plesso con un aumento che non tiene neppure il passo dell’incremento demografico nel primo pe-riodo ed è di poco superiore nel secondo). Un settore che appare del tutto statico nei tre censimentiè quello del cuoio. In questo settore, destinato a diventare successivamente uno dei settori caratte-rizzanti dell’artigianato fiorentino di qualità, in questo primo periodo vi è un predominio nettissi-mo di artigiani che producono oggetti di uso comune, in diretta concorrenza quindi con le produ-zioni industriali che si vanno affermando nel contempo. Sono soprattutto i calzolai e i ciabattini in-fatti ad avere una presenza estremamente rilevante, coprendo nelle tre rilevazioni quasi l’80% deltotale degli addetti. Infine tra gli altri settori che conoscono un incremento rilevante tra il 1865 e il1911 c’è da annoverare quello poligrafico. A Firenze quest’ultimo settore conobbe ovviamente unosviluppo estremamente rapido e intenso durante il periodo della capitale. Si trattò di uno sviluppoin buona parte dovuto all’arrivo nel capoluogo toscano di una serie di imprenditori che seguivano iltrasferimento degli uffici ministeriali e delle importanti attività di stampa ad essi connesse. Le tipo-
ANNA PELLEGRINO
282
In questo processo il ruolo dei fattori culturali si è rivelato molto utile perorientare la ricerca, dato che i processi di sviluppo e di declino venivano condi-zionati, nei percorsi individuali e nelle scelte degli attori sociali, da concezioni,modelli comportamentali e culture del lavoro pregresse. Tuttavia è emersa an-che una questione di fondo relativa alla definizione della figura sociale dell’ar-tigiano e ai caratteri e ai modelli del mestiere. L’artigiano dell’Ottocento che siiscrive alla Fratellanza artigiana è essenzialmente un lavoratore manuale, im-piegato secondo l’accezione di Sylos Labini in settori produttivi tradizionali, ecioè in settori sostitutivi della produzione industriale, che sono inevitabilmentedestinati a scomparire22. Nel corso della seconda metà dell’Ottocento emergonouna serie di settori nuovi, ovvero di trasformazioni radicali all’interno dei setto-ri esistenti, che danno luogo ad un artigianato di tipo nuovo, con produzioniserializzate ed un tipo di sbocco diverso sul mercato, legato al «prodotto fioren-tino» ovvero a quella particolare declinazione del fenomeno generale della dif-fusione in Europa delle cosiddette «arti industriali», strettamente connesso allavocazione turistica, al mercato della moda e alla vocazione artistica e culturaledella città23.
Questo nuovo tipo di artigianato vede modificarsi i processi lavorativi tradi-zionali in rapporto alle tecnologie ed al mercato, implicando anche una tra-sformazione sul piano dei rapporti di lavoro all’interno dell’unità produttivaartigiana. Non solo all’interno della bottega cambiano i rapporti rispettivi framaestri e lavoranti, ma le funzioni e il carattere del «mestiere» ne risultanoprofondamente modificate. Alla fine di questo processo si può notare un sin-golare ma rivelatore slittamento semantico. Il termine artigiano, che venivausato subito dopo l’Unità per dare una copertura unitaria «alta» alla enorme va-rietà di figure professionali del lavoro manuale, ora tende a scomparire comeconnotazione della figura sociale del lavoratore e a spostarsi in direzione delprocesso e dell’unità produttiva e infine del prodotto stesso. Mentre nel 1861Mazzini tendeva a definire tutti i lavoratori come artigiani, ma nessuno pensava
grafie arrivate sull’onda di questo evento e quelle più strettamente legate alle attività amministrativee governative (come Botta, Paravia, Voghera e altre) abbandonarono dopo il 1870 il capoluogo to-scano che tuttavia restò sede di importanti attività (come la pubblicazione della «Bibliografia Italia-na») e che cominciò a denotare i segni di una ripresa già a partire dagli anni Ottanta.
22 Cfr. sull’argomento, P. Sylos Labini, Saggio sulle classi sociali, Bari, Laterza, 1974.23 Anche Firenze non fu esente dal richiamo degli Arts and Crafts Movements. Venne a crearsi in-
fatti nel capoluogo toscano, verso la fine del secolo XIX, una articolata rete di collaborazioni moltosimile a quella auspicata dal Movimento. Ciò si avvertiva non solo nelle scelte stilistiche ma anchenelle scelte dei materiali. A quelli costosi e contraffatti, si preferivano materiali poveri e di prove-nienza locale: nell’edilizia dominava quindi il mattone e il travertino; le pavimentazioni in ceramica,decorazioni murarie a graffito e si fa largo uso del ferro. Nella mobilia si utilizza il massello di nocelavorato ad intaglio o intarsiato e lasciato di colore naturale. Le botteghe dei doratori recuperanoinvece antiche tecniche, in alcuni casi abbandonate da secoli e introducono la lavorazione della pa-stiglia. Cfr. S. Chiarugi, Botteghe di mobilieri in Toscana, 1780-1900, Firenze, S.P.E.S., 1994, p. 312.
CULTURE DEL MESTIERE E DEL LAVORO ARTIGIANO A FIRENZE
283
a definire i loro manufatti come prodotti artigianali, all’inizio del nuovo secoloil termine artigiano viene usato soprattutto come attributo di qualità del pro-dotto (nel senso che le merci delle botteghe fiorentine sono pubblicizzate evendute sempre più spesso come prodotti «artigianali»).
Inoltre, si apre nello stesso tempo un divario molto forte, all’interno dei varisettori produttivi, fra la componente imprenditoriale e i detentori del mestiere.Accanto alla diffusione di forme di sweating system a Firenze si registra una crisievidente di piccole e piccolissime aziende e esercizi legati al mercato locale etradizionale24. Il mestiere in queste condizioni si decompone in una serie dielementi parziali, perde la sua localizzazione nella bottega trasferendosi, sia pu-re provvisoriamente, nella fabbrica o nella lavorazione a domicilio. Anche se unpittore ceramista della Ginori o un abile artigiano ebanista lavoratore a domici-lio potevano guadagnare più di un piccolo artigiano titolare di bottega, il trendè ormai segnato, e il problema appare casomai quello di registrare il patrimo-nio di pratiche, di culture, di saperi, di modelli comportamentali che gli arti-giani portano in fabbrica o nei nuovi luoghi di lavoro, formando quelle figuresingolari di «operai intellettuali» di cui tratterò in seguito.
In parallelo a questa trasformazione, il mestiere perde la sua forte capacità diconnotazione rispetto al modo di produzione artigiano. Certamente, anchenell’artigianato tradizionale del periodo preindustriale esisteva una netta diffe-renza fra il maestro e il lavorante, dovuta al possesso della bottega; ma il me-stiere era comunque un elemento molto forte di identità, personale e sociale.Ora, nelle piccole imprese artigiane che si sviluppano nella Firenze dell’epoca,il maestro tende a divenire non più solo colui che è in grado di padroneggiaretutti i segreti del mestiere e tutte le fasi della lavorazione (anche se esegue ma-terialmente solo le più complesse e delicate), ma colui che è anche in grado digestire l’unità produttiva artigiana in maniera adeguata, cioè non solo concompetenza professionale, ma con capacità gestionale, amministrativa, com-merciale. Proprio nell’unità produttiva artigiana si condensano a mio parere al-cuni dei risultati più nuovi di questa analisi. La vecchia bottega artigiana, la «ta-berna», il locale di vendita con annesso laboratorio, si sviluppa e si specializzacon l’ingresso di macchine e motori, con l’introduzione di capacità amministra-tive e di gestione commerciale a largo raggio, con la qualificazione dei locali e
24 Cfr. sull’argomento nelle monografie di F. Le Play, P. Du Maroussem, Ebénistes du Fauboug St.Antoine. Grands magasins, ‘sweating system’, in «La question ouvrière», tome 3, Paris, A. Rousseau,1892, pp. 202-204 ; dello stesso autore, nel medesimo volume, Le jouet parisien. Grands magasins,‘sweating system’, Paris, A. Rousseau, 1894. Più in generale sulle monografie della scuola di F. La Playsi veda Les Monographies de famille de l’école de le Play, in «Les Etudes Sociales», 2000, n. 131-132.Sulla diffusione di forme di «sweating system» in Francia e Inghilterra si veda più in generale A.Cottereau, Problèmes de conceptualisation comparative de l’industrialisation: l’exemple des ouvriers de lachaussure en France et en Grande Bretagne, in Villes ouvrières, 1900-1950, sous la direction de S. Magri,C. Topalov, Paris, Edition l’Harmattan, 2001.
ANNA PELLEGRINO
284
degli arredi che giungono, se non al «lusso» quasi «asiatico» denunciato da al-cune fonti, ad un decoro e ad una ricercatezza nella presentazione dei prodottie degli ambienti del tutto nuova rispetto alla tradizione, e nel contempo deltutto in linea con il cambiamento del tessuto urbano complessivo25.
Questo processo implica un cambiamento importante della figura del maestroe del lavorante, che sempre più tendono ad avvicinarsi alle figure corrispondentidel settore industriale. Si pone quindi in un certo senso la questione del confinefra artigianato e piccola industria26. Una distinzione difficile e incerta, così comedifficile e incerta era la demarcazione del mestiere. Naturalmente, non è neces-sario e anzi sarebbe sbagliato cercare di stabilire rigidamente dei confini teoriciassoluti. Storicamente quello che appare evidente è che in questo processo ditrapasso e di transizione, i confini si intrecciano continuamente. I casi misti o checambiano ed evolvono nel tempo dall’uno all’altro polo sono frequenti. Tuttavia,proprio per poter determinare questa complessità e variabilità, è necessario ave-re un punto di riferimento che stabilisca un modello rispetto al quale definire di-stanze e corrispondenze. A questo fine si è rivelato particolarmente utile perl’analisi il concetto di «bottega», o se vogliamo quello di unità produttiva artigia-na. L’unità produttiva artigiana si differenzia dal semplice laboratorio così comedal negozio o dalla stessa piccola industria per un dato fondamentale del tuttotipico e caratterizzante, cioè per la sua struttura verticale. Il sapere del maestroartigiano, caratterizzato dalla padronanza di tutte le fasi della lavorazione, ha ilsuo corrispettivo nella capacità della bottega di gestire completamente il proces-so produttivo, dalla materia prima alla vendita.
Questo processo permette di mettere in discussione l’impostazione tradizio-nale che definisce la figura sociale dell’artigiano come figura intermedia, chequindi assume i suoi contorni in relazione sia ai rapporti con le figure socialicollocate più in basso, sia con quelle collocate ai gradi superiori. In questa nuo-va prospettiva quindi, anche se all’interno della bottega artigiana si verificanoprocessi di ristrutturazione delle figure sociali che riproducono in certa misura iprocessi in atto nel settore industriale, non è tuttavia possibile assimilare sem-plicemente l’artigianato alla piccola dimensione industriale, come invece si usaspesso fare attualmente.
L’artigianato mantiene una sua specificità, che si esprime in maniera emble-matica nel rapporto che esso intrattiene con il contesto urbano. Dalle mie ricer-che sistematiche sulla geografia degli insediamenti artigiani si ricavano alcunielementi che caratterizzano l’evoluzione di questa presenza. In un primo perio-do gli artigiani, ovvero le botteghe e i piccoli insediamenti produttivi, sono
25 La citazione è tratta dal fondo Tribunale di Firenze, Atti in materia di commercio. Fallimenti: fasci-coli 1866-1928. Questo fondo ricco di informazioni qualitative biografiche e individuali sugli arti-giani fiorentini è quello su cui ho basato grande parte della mia ricerca.
26 Cfr. sull’argomento A. Colli, I volti di Proteo, Storia della piccola impresa in Italia nel Novecento,Torino, Bollati-Boringhieri, 2002.
CULTURE DEL MESTIERE E DEL LAVORO ARTIGIANO A FIRENZE
285
sparsi in tutto il tessuto urbano27; anche se con una logica di raggruppamentomerceologico per singole strade, secondo quella situazione tradizionale, de-scritta da Jeanne Gaillard per quanto riguarda la Parigi del XIX secolo, per cui«più l’industria è piccola, più la fabbrica è dispersa più il raggruppamento ter-ritoriale si impone per facilitare le transazioni»28. Alla fine del periodo, invecegli artigiani fiorentini seguono le linee della ristrutturazione urbana di Firenze,ovvero un netto spostamento delle nuove attività artigianali, legate al prodottofiorentino, alla moda e al mercato turistico, verso le zone più centrali ed ele-ganti della città con una significativa gerarchizzazione degli spazi occupati, an-che questa del tutto analoga a quella del caso parigino. Si può pensare che av-venisse anche a Firenze lo stesso fenomeno segnalato dalla Gaillard per la Pari-gi del XIX secolo: nelle zone più centrali e qualificate, in seguito alle ristruttu-razioni haussmaniane, trovarono posto le maggiori attività commerciali ma, ac-canto ad esse, magari in strade adiacenti di minor pregio, delle quali il tessutourbano parigino come quello fiorentino era ancora largamente dotato, si trova-vano consistenti insediamenti artigiani o di piccole imprese, spesso, anche senon necessariamente in settori attinenti a quelli delle attività commerciali svoltenelle zone contigue: «chassé par les démolitions, écarté des maisons neuves parle niveau des loyers, l’artisan cherche refuge dans le vielles rues dont sonindustrie valorise les immeubles»29.
Un fenomeno analogo si nota per quanto riguarda i singoli lavoratori arti-giani. Le loro abitazioni sono in un primo periodo totalmente immerse nel tes-suto abitativo popolare della città. In un secondo momento si assiste ad un li-mitato processo di spostamento delle componenti che si vanno specializzando insenso imprenditoriale, che mantengono pur sempre un attaccamento ai simboli eai valori della tradizione. Entrando nelle loro abitazioni attraverso una fontedescrittiva come gli inventari dei registri del tribunale fallimentare si nota che,come nel caso parigino, accanto a simboli evidenti di una volontà di ascesa so-ciale e di imborghesimento, permangono spesso simboli altrettanto evidenti diattaccamento al mondo del lavoro manuale30. Lo stretto intreccio fra insedia-
27 Per questa parte dell’analisi mi sono valsa delle fonti di Ugo Giusti e degli annuari statistici delComune di Firenze. Cfr. in particolare U. Giusti, Demografia Fiorentina, 1862-1914, in Monografie e studidell’Ufficio di Statistica, a cura del Comune di Firenze, vol. VI, Firenze, Tip. Barbera, 1916; Id., Il Comu-ne di Firenze e la sua popolazione al 10 Giugno 1911. Studi demografici sul V Censimento generale della popola-zione, Firenze Tip. Barbera, 1912; Id., I primi risultati del censimento industriale e commerciale dell’ottobre1927, in «Economia. Rivista mensile di politica economica e di scienze sociali», n.s., 1928, n. 5, p. 308.
28 Cfr. J. Gaillard, Paris la ville, cit., p. 316.29 Ivi, p. 315.30 Come ha scritto Pierre Bourdieu la casa «en tant que bien matériel qui est exposé à la
perception de tous (comme le vêtement), et cela durablement, cette propriété exprime ou trahit, demanière plus décisive que d’autres, l’être sociale de son propriétaire, ses ‘moyens’, comme on dit,mais aussi ses goûts»; cfr. P. Bourdieu (con la collaborazione di S. Bouhedja, R. Christin, C. Givry),Un placement de père de famille. La maison individuelle: spécificité du produit et logique du champ de produc-
ANNA PELLEGRINO
286
mento artigiano e contesto urbano si ritrova anche ad un livello più alto. Lapresenza artigiana in città non è solo un dato economico oggettivo legato alparticolare mercato cittadino, ma è nel contempo perfettamente funzionale aidisegni delle classi dirigenti liberali moderate che in questo periodo hanno unaegemonia quasi ininterrotta a livello politico cittadino31. Per i moderati fioren-tini la presenza di un artigianato di qualità è perfettamente consona alla ri-strutturazione del centro urbano e alla riqualificazione politica e culturale del ca-poluogo toscano che intendono perseguire. Paradossalmente il punto più bassodi attenzione ai temi della promozione delle attività artigiane in città si avrà conl’amministrazione «popolare» che vede al suo interno la partecipazione dei so-cialisti e persegue una politica di modernizzazione sensibilmente diversa32.
In questo contesto, qual è il ruolo delle specifiche culture del lavoro che ori-ginano dal mondo artigiano?
«Fierezza del mestiere» e lavoro operaio
Date queste premesse evidentemente non si può parlare di una linea continuadi declino o di trasformazione di culture del lavoro tradizionale a favore diculture del lavoro più moderne. All’interno del mondo artigiano elementi ditradizione e di innovazione coesistono e si mescolano continuamente, e lo stessoavviene sul terreno delle culture del lavoro.
A mio parere è però possibile rintracciare un elemento unificante su questoterreno, dato dal set di concezioni relative al mestiere. Sotto questo aspetto esi-ste un trasferimento e un passaggio evidente di concezioni e di culture ancheall’interno delle trasformazioni di cui ho appena parlato. Proverò a fare una
tion, in «Actes de la recherche en sciences sociales», 1990, n. 81-82, p. 6; sulla casa e sui valori cheessa rappresenta si è espresso anche Daniel Roche: «la casa è […] un capitale, una merce, una sceltadi investimenti, l’incarnazione di valori rappresentativi e distintivi»; cfr. D. Roche, Storia delle cosebanali: la nascita del consumo in occidente, Roma, Editori Riuniti, 1999, p. 129. Si veda più in generalesulla casa e su ciò che rappresentava per le classi popolari e quelle borghesi nell’Ottocento il riccosaggio di M. Perrot, Modi di abitare, in La vita privata. L’Ottocento, a cura di Ph. Ariès, G. Duby, Ro-ma-Bari, Laterza, 2001, pp. 243-257: più specificamente rivolte all’universo borghese e piccolo bor-ghese sono le considerazioni sulla casa come «quintessenza del mondo borghese» di E.J. Hobsbawm,Il trionfo della borghesia, 1848-1875, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 284-285.
31 Cfr. sull’argomento, A. Salvestrini, I moderati toscani e la classe dirigente italiana (1859-1876), Fi-renze, Olschki, 1965; S. Timpanaro, Sui moderati toscani e su certo neomoderatismo, in Id., Antileopar-diani e neomoderati nella Sinistra italiana, Pisa, ETS, 1982; vedi anche G. Mori, Toscana addio? 1861-1900, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. La Toscana, a cura di G. Mori, Torino, Einaudi,1986; E. Ragionieri, I moderati toscani e la classe dirigente italiana negli anni di Firenze Capitale, in Id.,Politica e amministrazione nell’Italia unita, Bari, Laterza, 1967.
32 L. Piccioli, I ‘Popolari’ a Palazzo Vecchio. Amministrazione, politica e lotte sociali a Firenze dal 1907 al1910, Firenze, Olschki, 1989; per il periodo successivo cfr. Id., Il ceto politico amministrativo fiorentinodal 1910 al 1926, in «Rassegna storica toscana», 1985, n. 1, pp. 87-119.
CULTURE DEL MESTIERE E DEL LAVORO ARTIGIANO A FIRENZE
287
esemplificazione su tre punti relativi alle culture della solidarietà, alle identitàprofessionali, ai rapporti con l’innovazione tecnologica e il progresso.
Le culture della solidarietà che caratterizzano il mondo del lavoro artigianosono difficilmente distinguibili da quelle che caratterizzano il mondo operaio33,anche perché in parte sono comuni: si originano in un contesto originaria-mente indistinguibile e quindi una parte consistente di queste ultime derivadalle prime. Il primo insediamento associativo artigiano a Firenze, la Fratellan-za artigiana, da una parte si richiama esplicitamente, nella terminologia, allatradizione corporativa, dall’altra introduce tutta una serie di elementi nuovi chepoi serviranno da modello o trapasseranno direttamente nella tradizione dellenascenti organizzazioni operaie. La Fratellanza infatti è la prima associazione dimutuo soccorso ad introdurre forme di cooperazione di consumo e di lavoro eforme di attività protosindacali al suo interno. In realtà le forme di solidarietàche propone si estendono su un arco molto più ampio di quello che sarà poiproprio delle organizzazioni operaie, giungendo a forme di cooperazione sulpiano del credito, alla gestione cooperativa degli acquisti degli strumenti per laproduzione, fino a forme di tutela categoriale-professionale. Inoltre e soprat-tutto, la Fratellanza teorizza come suo punto qualificante e primario nello sta-tuto quello dell’istruzione e quindi dell’elevamento «intellettuale e morale»della classe lavoratrice34. Una vena pedagogica che sarà poi in larga parte rece-pita all’interno delle culture associative operaie.
D’altra parte esistono però anche una serie di elementi che solo in parte oper nulla si trasferiscono nella cultura del lavoro operaio. Ad esempio il ruolodella famiglia all’interno dell’unità produttiva, con il connesso forte paternali-smo che caratterizza i rapporti di lavoro, il ruolo delle reti di relazione legate alcredito e alle reti commerciali e professionali di cui gli artigiani entrano a farparte. Esistono infine anche elementi che si pongono in contraddizione conogni etica della solidarietà per la tendenza molto accentuata ad adottare strate-gie individuali, e non collettive, per muoversi sul terreno della concorrenza, an-che a danno dei competitori.
Un altro punto nevralgico in cui si può notare un trapasso e una circolazionedi concezioni e di culture fra il mondo dell’artigianato e quello del lavoro ope-raio è legato alla progressiva diversificazione delle posizioni relative all’internodei processi produttivi, quindi alla determinazione di diverse identità sul pianolavorativo e professionale. Nel corso della seconda metà dell’Ottocento si com-pie, all’interno dell’artigianato fiorentino, una progressiva divaricazione dellemansioni, delle competenze, delle funzioni, che giunge a differenziare sempre
33 Per una riflessione generale sul concetto di solidarietà nella sua evoluzione storica fra XIX eXX secolo, cfr. A. Lay, Un’etica per la classe: dalla fraternità universale alla solidarietà operaia, in «Rivistadi storia contemporanea», 1989, n. 3, pp. 309 e ss.
34 Cfr. Capitoli di una Fratellanza artigiana, cit.
ANNA PELLEGRINO
288
più la figura del maestro-imprenditore da quella del lavorante-operaio. Questoprocesso si riflette non solo nella determinazione delle identità professionali alivello individuale, ma anche a livello collettivo. Si assiste, all’interno delle retiassociative che contribuiscono a determinare le identità professionali collettive,ad un fenomeno per cui da una iniziale indifferenziata appartenenza ad orga-nizzazioni comuni (nel caso specifico soprattutto la Fratellanza) si passa ad unaproliferazione di strutture associative professionali. Queste nuove strutture, cheprecedono le organizzazioni sindacali vere e proprie si articolano distinguendoed in certi casi contrapponendo una componente professionale legata al lavoroindipendente e alle funzioni direttive e imprenditoriali, ad una componente le-gata al lavoro dipendente e a funzioni di protezione sociale e categoriale35. Inquesta stessa ottica vanno collocati i molteplici elementi che indicano la tenden-za della Fratellanza a farsi carico delle nuove problematiche poste dalla diffu-sione del lavoro operaio. Tali problematiche sono tali da provocare una crisid’identità piuttosto profonda all’interno dell’associazione, che porterà addirit-tura a progettare il cambiamento del nome in Fratellanza operaia.
In questo contesto vorrei sottolineare un ultimo elemento relativo alle conce-zioni del mestiere in rapporto allo sviluppo tecnologico e all’ideologia del pro-gresso che caratterizza il periodo considerato. Mentre da una parte i maestriartigiani e i proprietari di bottega tendono sempre di più a specializzare le fun-zioni imprenditoriali e commerciali, senza peraltro abbandonare le competenzee l’etica del mestiere, dall’altra i lavoratori dipendenti vanno incontro ad unatrasformazione analoga, ma anche in questo caso con una forte persistenza dellacultura e dell’etica del mestiere, che rappresenta a mio parere un elemento im-portante nel trasferimento di concezioni e modelli dal mondo artigiano a quellodel lavoro operaio. Per osservare questo fenomeno ho esaminato un campionerappresentativo dei lavoratori di mestiere fiorentini dell’epoca, attraverso lerelazioni individuali prodotte in occasione delle visite collettive organizzate inoccasione delle Esposizioni universali36.
35 Sulle eredità corporative all’interno dell’associazionismo operaio, fra gli altri, cfr. A. Guenzi,Arte, maestri e lavoranti. I calzolai di Modena dalla corporazione alla Società di mutuo soccorso (secoli XVII-XIX), in «Quaderni Storici», 1991, n. 80, pp. 399-414; D. Robotti, Dalle corporazioni alle società dimutuo soccorso: l’associazionismo professionale torinese nel XIX secolo, in Storiografia francese ed italiana aconfronto sul fenomeno associativo durante XVIII e XIX secolo, a cura di M.T. Maiullari, atti delle gior-nate di studio promosse dalla Fondazione Einaudi (Torino, 6-7 maggio 1988), Torino, FondazioneEinaudi, 1990, pp. 93-106; L. Trezzi, L’eredità corporativa nella cooperazione di produzione industriale enel sindacato, ivi, pp. 137-159; il tema era già stato trattato anche da G.M. Bravo, Torino operaia.Mondo del lavoro e idee sociali nell’età di Carlo Alberto, Torino, Fondazione Einaudi, 1968, in particolarepp. 163 e ss; cfr. inoltre A. Pellegrino, Al di là della corporazione: beccai e macellai a Firenze dall’Unità alFascismo, in L’Europa della carne: storie e cultura di mercati e macellai, a cura di F. Mineccia, A. Zagli, Fi-renze, Polistampa, 2003, pp. 75-116.
36 Cfr. A. Pellegrino, ‘Il gran dimenticato’: lavoro tecnologia e progresso nelle relazioni degli ‘operai’ fio-rentini all’Esposizione di Milano del 1906, in «Memoria e Ricerca», 2004, n. 3, pp. 165-190.
CULTURE DEL MESTIERE E DEL LAVORO ARTIGIANO A FIRENZE
289
Le relazioni degli operai mostrano in primo luogo, il bagaglio culturalecomplessivo all’interno del quale si collocano gli specifici saperi professionali,che è molto alto ed è ciò che determina da parte delle classi dirigenti l’appel-lativo di «operai intellettuali». Da una serie di elementi indiretti quali il lin-guaggio, la terminologia, i riferimenti di contesto, si percepisce chiaramentequella che Duccio Bigazzi ha definito come «fierezza del mestiere»; ma si posso-no cogliere anche gli elementi su cui si basa questa connotazione identitaria: lecompetenze, le conoscenze tecniche e teoriche, la capacità di analisi critica e diflessibilità e adattamento creativo rispetto ai processi produttivi e all’innovazio-ne tecnologica. Gli operai fiorentini attraverso questi documenti si mostrano ingrado di apprezzare la tecnologia e il progresso, ne condividono i valori positi-vi, ma nel contempo mantengono un’attenzione critica verso i caratteri qualita-tivi del prodotto finito: sono frequenti le osservazioni che riconoscono rapidità,affidabilità, basso costo delle produzioni, ma vengono fortemente criticati, i la-vori dozzinali, le imperfezioni, le carenze che rendono ancora superiore il lavo-ro realizzato dal lavoratore di mestiere.
Questo atteggiamento che unisce ad un forte orgoglio e ad una sviluppataetica del mestiere un’esplicita accettazione dell’ideologia del progresso e dellosviluppo tecnologico, fa sì che essi manifestino una sostanziale adesione al pro-cesso di modernizzazione in atto. Questa adesione è temperata, ma in ultimaanalisi rafforzata, da una serie di considerazioni relative alla necessità di tutela,di protezione sociale, ma anche dal riconoscimento del valore positivo dellemacchine e della tecnologia per il miglioramento della condizione dell’operaio.Nel caso fiorentino quindi non si assiste ad una emarginazione progressivadella figura sociale dell’artigiano tradizionale, ad un suo spostamento verso po-sizioni radicali, antagoniste, ma si manifesta un insieme di concezioni aperte aiprocessi di trasformazione e di graduale miglioramento delle condizioni di vitae di lavoro. Il fatto che all’interno di questo campione di «operai intellettuali» siritrovino alcuni noti esponenti del riformismo cittadino, come il vicesegretariodella Camera del Lavoro, mentre com’è noto a Firenze esisteva una forte com-ponente di intransigentismo rivoluzionario37 (probabilmente legato alle com-ponenti popolari, sotto-proletarie, del particolare tessuto urbano della città cheè città artigiana, ma anche città di servizi), aggiunge a mio parere un elementodi complessità, ma non contraddice affatto la tendenza sopra ipotizzata.
37 Cfr. sull’argomento, L. Tomassini, Associazionismo operaio a Firenze, cit. Si veda inoltre E. Conti,Le origini del socialismo a Firenze, cit.; E. Ragionieri, Mazzinianesimo, garibaldinismo e origini del sociali-smo in Toscana, cit.; N. Capitini Maccabruni, La Camera del lavoro nella vita politica e amministrativa fio-rentina (dalle origini al 1900), Firenze, Olschki, 1981, pp. 103-162. Cfr. per il periodo successivo Id.,Liberali, socialisti e Camera del Lavoro a Firenze nell’età Giolittiana (1900-1914), Firenze, Olschki, 1990.